“I giovani in una società post-industriale” (n. 61, pagg. 1-11)
“Cosa vuol dire vivere la vita?” (n. 60, pagg. 1-11)
Prima edizione in volume: Opuscoli provvisori, settembre 2009
Seconda edizione: giugno 2024
Alfredo M. Bonanno
I giovani in una società post-industriale
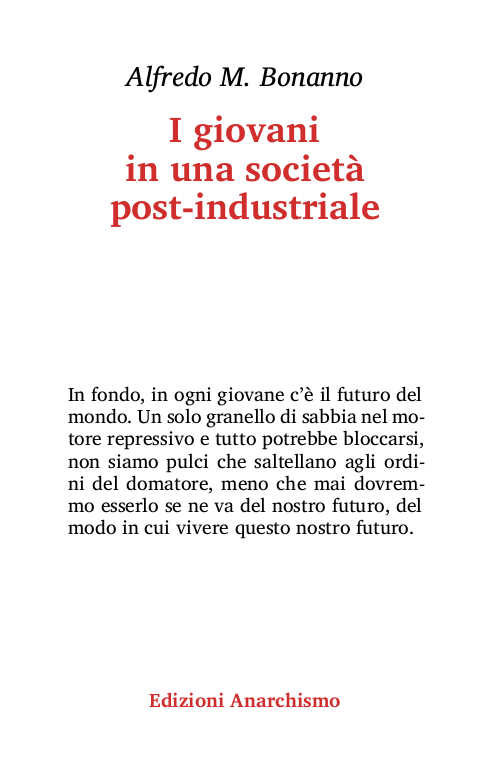
I giovani in una società post-industriale
Perdita di senso delle vecchie ripartizioni
Lontano dalla sicurezza oggettiva
La precarietà come scelta di vita
Il superamento dei vecchi progetti della lotta di classe
Cosa vuol dire vivere la vita?
Un campo d’indagine più ridotto
L’origine cristiana della concezione della vita come il bene più alto
Introduzione
Le condizioni che circondano ciò che resta dell’uomo diventano ancora più paradossali nei giovani, in chi è ancora in quella parte della vita che si apre al futuro, che guarda, deve per forza guardare, avanti non avendo, dietro di sé, l’abisso sempre pronto a spalancarsi che sta alle spalle del vecchio.
So bene che queste considerazioni possono muovere al riso, e mi farebbe piacere che a questa conclusione giungessero i giovani che mi leggeranno. Che farsene del discorso di un vecchio? Che senso potranno avere le mie parole per chi è remoto a ogni visione della vita storicizzante, racchiusa in un di già visto, e guarda con occhi attoniti alle meraviglie che l’attendono?
Dopo tutto le speranze e le forze giovanili sono proprio lì, quasi fatte apposta per essere sperperate, sempre alla faccia dei consigli e delle esperienze degli altri.
È così che va il mondo, e a me tocca il ruolo di chi parla a vanvera, per cui tanto vale che lo reciti fino in fondo.
I due testi che suggerisco alla lettura sono diretti a chiarire le condizioni di cui dicevo prima, specialmente il primo, la società post-industriale e i suoi servi sciocchi, da un lato, i giovani con le loro potenzialità ancora inespresse, dall’altro. Forse il primo di questi due più del secondo, ma si tratta di sfumature.
Eppure non è detto che tutto debba andare per come minaccia di andare. In quelle potenzialità c’è una zona d’ombra, un amalgama caotico che può sempre far venire alla luce l’imprevisto. Specialmente nel cuore di un giovane questo imprevisto dovrebbe essere sempre sul punto di venire fuori, se non è di già atrofizzato prima del tempo. Io mi illudo che non lo sia, sogno che le sue pulsazioni siano forti e sicure, in grado di accelerare di fronte all’ignominia e al sopruso, di fronte alle regole che la società ci impone e sulle quali cerca di modellare la nostra vita coatta.
In fondo, in ogni giovane c’è il futuro del mondo. Un solo granello di sabbia nel motore repressivo e tutto potrebbe bloccarsi, non siamo pulci che saltellano agli ordini del domatore, meno che mai dovremmo esserlo se ne va del nostro futuro, del modo in cui vivere questo nostro futuro.
Chi china il capo e acconsente di fronte al sopruso che irreggimenta è l’ultimo uomo, l’ultimo scarto di un’umanità dolorante, l’erede di millenni di schiavitù. Io mi auguro che questa eredità non sia stata riscossa dai giovani a cui idealmente mi riferisco, e mi auguro che non vogliano portarla proprio ora all’incasso. Altri dovrebbero essere i proventi dei loro prossimi anni.
Il desiderio, la creazione, il sogno, le remote e incomprensibili stelle, e perfino questa ormai piccola e agonizzante terra che ci ospita. Inventarsi la felicità, ecco un bel compito, non accettare livellamenti, neanche quelli che aiutano a passare il tempo trivializzandone il senso, banalizzandone il gusto. Ogni attimo della vita – un giovane difficilmente comprende l’importanza di vivere questo attimo – è degno di essere vissuto, non sprecato nella compassione di se stessi, nella esiguità dei bisogni di un essere amministrato ridotto a convivere con pregiudizi morali e rimpiccolimenti economici.
Vivere una vita da piccoli insetti saltellanti in barocche evoluzioni di sopravvivenza significa non guardare avanti, significa mettersi sempre le mani in tasca per fare i conti della spesa, per evitare i pericoli e le sofferenze, accettare le regole di un edonismo da pagliacci tristi e ben pasciuti, contenti del pezzo di pane che il padrone getta loro di tanto in tanto. Un giovane che vive come l’ultimo uomo, non c’è spettacolo più triste e avvilente. Lo stesso per un vecchio, ma almeno quest’ultimo ha dalla sua delle scusanti che se non lo mandano assolto lo coprono del manto della pietà, vergognosa coperta che nasconde le residue forze le quali potrebbero ancora fornirgli l’estro per un ultimo colpo di testa, un’orgogliosa impennata. Ma lasciamo i vecchi alle loro considerazioni riflessive e pensose, i giovani no. Perdio, no. Un giovane ultimo uomo o è uno scherzo della natura o è un imbecille.
Attenzione. Non voglio fare un discorso ortopedico. Non mi interessa raddrizzare le zampe dei cani, non voglio costruire l’uomo nuovo, mi riferisco a quello che sta davanti a me, sotto i miei occhi, a quella potenzialità che non può non trovarsi nel cuore del giovane, e che spesso trova mille rigagnoli fangosi dove indirizzare uno sfogo che altrimenti la farebbe scoppiare.
Lasciate perdere la garanzia, ogni garanzia è una palla al piede, ogni sicurezza del futuro, ogni futuro garantito è un’ancora pesante che si è impigliata in un basso fondale. E lasciate pure le piccole felicità giornaliere, il far contenti gli altri, i vostri debitori, genitori e modelli di comportamento, verso le cui aspettative non dovete avere altro che risposte di oltrepassamento. Quello che vi chiedono può essere soltanto una piccola briciola del vostro sogno – dopo tutto le loro pretese sono di bocca buona – voi dovrete andare talmente lontano che ogni traguardo (loro) dovrebbe essere soltanto un piccolo passo del lungo procedere che avete davanti. Che conta la riottosità, il ribellarsi da piccolo cabotaggio? Quello che conta è il grande rifiuto, che porta all’autorovesciamento della vostra essenza di uomini, di giovani (uomini e donne, per chi ha ancora di queste preoccupazioni da distinguo), giovani folli, ubriachi della propria vita, che non vogliono ancora determinarsi in questa o quella fattispecie sociale, ma che si aprono a ogni esperienza sensibile, a ogni traguardo non ancora stabilito e neppure pensato o supposto esistente.
Dovete buttare in faccia al mondo intero la vostra capacità di andare oltre, sputare sopra tutti gli ammiccamenti accomodanti che da ogni parte vi vengono suggeriti. La scuola, svuotata di contenuti. La cultura, ridicolmente in gestione a sicofanti. La politica, in mano a pagliacci. La società, organizzata da manutengoli della polizia. Il divertimento, codificato da laureati in economia. Non potete battezzare il vostro futuro in nome dell’apparenza, dell’esteriorità, della rappresentazione, della uniforme all’ultima moda.
Se volete vivere dovete scendere in lotta contro tutto questo incancrenirsi continuo, contro questo marcire che è spacciato per fioritura e gioiosità. E che questa lotta sia a vita o a morte, senza quartiere, sputando in faccia ai costruttori di accomodamenti, ai fabbricanti di morte in nome della pace perpetua, ai congressisti a pagamento delle opinioni garantite, ai tessitori di imbrogli e tranelli a poco prezzo. E che questo sputo non sia quello di una sapienza superiore che pretende insegnare qualcosa agli insegnanti di mestiere, ma sia il disprezzo sarcastico contro tutti i compromessi, le contraffazioni, le legalità che sanano e le illegalità che pretendono di conferire uno statuto di diversità in nome del codice penale. Non un aggirare la posizione io vi suggerisco, ma uno scontro frontale.
E preparatevi, preparatevi alla vendetta. Accumulate – questo sì – giorno per giorno la vostra rabbia e fatela esplodere al momento opportuno. Di fronte a voi sta il mucchio più vergognoso e vile che la storia ricordi, la somma delle somme di ogni nefandezza, non c’è pericolo di commettere errori su dove colpire, il bersaglio è tanto grande che qualora foste ciechi dalla nascita riuscireste lo stesso a centrarlo.
Trieste, 29 novembre 2008
Alfredo M. Bonanno
Possiamo distruggere tutto perché possiamo tutto rifare in quanto siamo noi che abbiamo fatto tutto.
(Motto attribuito a Buenaventura Durruti)
Dobbiamo distruggere tutto perché non potremo mai utilizzare in modo liberatorio quello che i padroni stanno costruendo oggi per garantire il loro dominio e perché si tratta di qualcosa che non potremmo mai conoscere restando all’interno di una dimensione di classe come quella odierna.
(Motto aggiornato)
I giovani in una società post-industriale
La ristruttuzione del capitale e dello Stato, per come viene realizzata oggi, propone una ridefinizione dei rapporti di classe attraverso nuove prospettive. Coloro che detengono e sempre di più conserveranno in futuro gli strumenti tecnologici avranno anche il potere e riusciranno a gestire il consenso. Questi saranno quindi “inclusi” in una realtà di dominio. Il resto saranno “esclusi”, condannati ad un utilizzo “passivo” della tecnologia. Il perfezionamento di questo processo passa attraverso la riduzione di quanto la classe degli esclusi possiede: in primo luogo la propria cultura. La fascia che subisce di più questa pressione è quella dei giovani. Qui si identificano i futuri inclusi ed esclusi. La selezione è certo sempre quella delle condizioni originarie di appartenenza, ma nuovi elementi si profilano all’orizzonte. Il presente scritto cerca di dare un quadro abbastanza approfondito di questi nuovi elementi di selezione di classe.
Le modificazioni di classe
Il riassetto del dominio in una società come la nostra, caratterizzata da violenti processi di ristrutturazione, passa attraverso una nuova definizione dei rapporti di classe.
Alle vecchie contrapposizioni del passato, rigide e rigidamente interpretate, si sovrappongono nuovi contrasti. Il panorama si frantuma ma non per questo perde la sua visione di scontro. Da un lato stanno i privilegiati, dall’altro coloro che mancano dei privilegi.
Sulla natura di questi privilegi c’è da discutere. Non si può più parlare in termini di mancanza, quanto in termini di possesso di cose diverse. Ecco, il privilegiato di oggi possiede qualcosa o, almeno, la speranza di qualcosa, che il diseredato non solo non possiede, ma nemmeno comprende, perché non la conosce, o sta per perdere la sua conoscenza.
La ridefinizione dei rapporti di classe passa, a mio avviso, attraverso questo processo di perdita progressiva della conoscenza, della padronanza di qualcosa che prima era pur anche indispensabile agli stessi sfruttatori. Questi ultimi, adesso, sono sul punto di ricostruire un assetto differente delle condizioni sociali (complessive), talmente differente da non avere più bisogno di quelle cose che gli sfruttati possedevano in passato (forza lavoro, in primo luogo). Ecco perché il nuovo assetto di classe si fonda sui processi innovativi della tecnologia, molto di più che in passato, anzi in un modo radicalmente diverso.
Il vecchio motto rivoluzionario: “Possiamo distruggere tutto perché possiamo tutto rifare in quanto siamo noi che abbiamo fatto tutto”, motto attribuito a Durruti ma che comunque circolava (e circola) all’interno della classe operaia tradizionale (la quale, sotto certi aspetti, persiste ancora, in quanto classe, nella difesa del salario, se non altro), non è più corretto. Oggi potremmo sostituirlo con un altro del tipo: “Dobbiamo distruggere tutto perché non potremo mai utilizzare in modo liberatorio quello che i padroni stanno costruendo oggi per garantire il loro dominio e perché si tratta di qualcosa che non potremo mai conoscere restando all’interno di una dimensione di classe come quella odierna”.
In passato, la distruzione poteva essere un “incidente”, comunque non grave, perché dalle rovine potevamo ricostruire il mondo della libertà. Oggi diventa un passaggio obbligato, perché solo attraverso la distruzione di tutto quello che i padroni stanno costruendo, almeno a partire dall’impiego delle tecnologie post-industriali in poi, potremo costruire la società libera di domani.
Perdita di senso delle vecchie ripartizioni
I processi violenti e rapidi di trasformazione dell’assetto sociale hanno ridotto l’importanza e il senso delle vecchie indicazioni di classe. In senso stretto, parlare di “proletariato”, di “sottoproletariato”, ha un significato molto riduttivo. Lo stesso dicasi per il termine “classe operaia”, che comporta, quest’ultimo, conseguenze notevoli nelle decisioni rivoluzionarie. Lo stesso, nuove perplessità sono sorte riguardo alla considerazione e al senso delle definizioni che concernono la classe dominante: capitalisti, politici, redditieri, impiegati, dirigenti, quadri, ecc. Il vecchio concetto di “borghesia” si è irrimediabilmente frantumato.
Per orientarsi meglio penso che si debba fare ricorso ad una maggiore concretezza ed evitare la banale sostituzione di nuove formule ideologiche alle vecchie. Mi accorgo, spesso, che molti compagni evitano con accuratezza di pronunciare o fare riferimento a concetti come “proletariato” o “borghesia” e, dal loro imbarazzo, traggo il significato di una coscienza delle profonde modificazioni che stiamo vivendo in questi anni. Ma la semplice messa al bando di una parola non basta, occorre un approfondimento della cosa, se si vuole evitare il rischio che, prima o poi, una nuova parola finisca per sostituire la cosa e per permetterci indisturbati di continuare a “sognare” la cosa invece di possederla.
Esclusi e inclusi
Tempo fa, ho proposto una distinzione basata su questi due concetti. Da un lato, gli “inclusi”, racchiusi nel loro castello teutonico, possessori della nuova tecnologia e, solo per questo, dominatori; dall’altro lato, gli “esclusi”, destinati ad un impiego passivo della tecnologia, spossessati di qualcosa che non sarà mai più la loro arma di “lavoro” e, proprio per questo, dominati.
Ho spiegato, a me sembra in modo esauriente, che questa distinzione si adatta a sufficienza (pur restando modello di ragionamento) alla realtà post-industriale. La tecnologia di oggi è la “ricchezza”, ben al di là del semplice “capitale finanziario”, che andrà a diminuire sempre di più. Questa tecnologia non potrà essere condivisa da tutti. I più (gli esclusi) saranno abilitati solo ad un utilizzo passivo e non comprenderanno nulla al di là del semplice pigiare qualche bottone. I meno (gli inclusi) elaboreranno le ricerche e gestiranno il potere attraverso un possesso loro esclusivo.
Per garantire la separazione netta e definitiva, per evitare che gli esclusi possano impadronirsi di questa tecnologia, si dovrà costruire un muro ben preciso, molto più efficiente dei vecchi muri del passato, delle casseforti, delle carceri o dei manicomi: questo sarà il muro della sempre più ampia mancanza di interesse. Non si può essere interessati a qualcosa che non si conosce, non si può lottare per avere qualcosa che è “altro” da noi, che non vogliamo possedere perché la sconosciamo. E, più saremo tagliati fuori dalla tecnologia, più finiremo per disinteressarcene (anche, e principalmente, in senso distruttivo), e questo processo di disinteressamento sarà parallelo al crescere della nostra ignoranza, della nostra lontananza progressiva, della diminuzione delle nostre capacità intellettive, conoscitive, volitive, ecc.
La logica delle cose
La diminuzione di contenuti cui viene sottoposta la vita degli esclusi non è la conseguenza di un’operazione sadicamente programmata dagli inclusi. Il processo di risistemazione di classe è nella logica delle cose, cioè nella logica della ristrutturazione del processo produttivo.
Passando dalla struttura industriale, fondata sui grandi investimenti fissi e sulla programmazione, alla struttura post-industriale – passaggio realizzato tramite l’intervento ordinativo dello Stato entrato in prima persona nel processo economico – struttura quest’ultima basata sulla flessibilità della produzione, flessibilità consentita dalle nuove tecnologie, si è dovuto affrontare il problema della riduzione di alcune capacità dell’individuo e dell’aumento di altre capacità. Ciò ha portato a profonde modificazioni culturali, realizzate attraverso la scuola, i grandi mezzi di informazione, lo spettacolo, il tempo libero, ecc. In questo modo, si sta costruendo un nuovo uomo, in grado di adattarsi, un essere duttile, con capacità medie, quindi né troppo basse né troppo alte, con una tendenza al lavoro di gruppo, senza una vasta cultura e senza prospettive di carriera o di scalata sociale. La quasi totalità dei giovani viene indirizzata verso queste prospettive. Mediamente sono più svegli, manualmente più abili (ma non troppo), culturalmente più modesti, hanno una preparazione meno intensa su singoli settori culturali, ma più allargata. Conoscono meno approfonditamente, ma conoscono più cose.
Per un’analisi di classe
Ripercorrere oggi tutti gli elementi di una analisi di classe significa rimettere insieme tutti i tasselli di un panorama che è stato sconvolto dall’accelerazione impressa dalle nuove tecnologie ai normali processi di ristrutturazione del capitale.
Di già, nella fase in cui il capitale chiamava all’interno del progetto di salvataggio lo Stato, diciamo intorno agli inizi degli anni Ottanta, abbiamo visto come i processi di legittimazione passassero non più attraverso il controllo e la repressione ma, primariamente, attraverso il reperimento del consenso.
Superata la fase di assestamento, trasformato lo Stato da semplice cassiere in banchiere del capitale, ci si accorse che non c’era poi tutta questa grande differenza tra capitale e Stato e che la socializzazione del capitale stava camminando di pari passo con la capovolta mercantilizzazione del cosiddetto capitalismo di Stato. Due grandi schieramenti storicamente antitetici, nell’affievolirsi delle capacità di supporto delle ideologie, si avvicinavano sempre di più sul piano pratico. La gestione della cosa pubblica si differenzia, adesso, sempre di meno da quella della cosa privata.
Battersi per un irrigidimento delle posizioni, come sembrerebbe vogliano fare i residui combattentistici di un certo lottarmatismo [scritto nel 1988], è fuori della storia (oltre che della logica). Il sogno di una cosa finisce ancora una volta per prevalere sulla cosa stessa.
Non si possono identificare i confini dello scontro di classe. Almeno, non con certezza matematica. Ma questo non lo si poteva fare nemmeno prima. Bisogna, quindi, andare a cercarli, per tentativi.
La strada che propongo qui è quella della riduzione del possesso della classe degli esclusi. Questa riduzione non passa, adesso, attraverso la classica appropriazione di quello che questa classe produce. L’accumulazione del capitale, da quella primitiva a quella avanzata, si basava sull’estorsione. Dopo una parentesi di “partecipazione”, ci si sta avviando verso l’esclusione. La tecnologia garantisce sempre di più la realizzabilità di un sistema produttivo in cui gli esclusi non contribuiranno che in maniera marginale, attraverso procedure semplificate – e comunque estranee alla natura sostanziale della produzione, – procedure che non consentiranno nessuna ricostituzione della situazione produttiva al di qua dell’universo degli inclusi. La tecnologia sarà esclusivamente di questi ultimi, ai primi toccherà un utilizzo passivo della medesima. Questo utilizzo non consentirà in alcun modo una padronanza tecnologica e, per come si stanno impostando le cose e i progetti di “riduzione”, non consentirà nemmeno il desiderio o il bisogno di questa padronanza.
Il luogo in cui questi processi di riduzione si stanno svolgendo adesso, in modo più evidente, è quello dei “giovani”. Si tratta di un ambito sociale che costituisce il serbatoio di identificazione dei futuri inclusi ed esclusi. La selezione è sempre quella delle condizioni di appartenenza originarie, ma queste condizioni sono appaiate da una più accentuata capillarità sociale. È possibile, più di una volta, che l’eccezionale abilità e l’intelligenza del singolo emergano, determinando un biglietto di accesso. Le necessità degli inclusi saranno sempre dettate dal bisogno di un ristretto numero di tecnocrati e non è detto che questo numero debba corrispondere, in futuro, con gli attuali detentori delle fortune economiche.
Lontano dalla sicurezza oggettiva
In una prospettiva di produzione che si basa sulla flessibilità, si rende necessaria una ideologia che proponga modelli di comportamento lontani dalla stabilità, quindi dalla certezza e dalla sicurezza.
Più che un discorso sul lavoro “sicuro”, per altro diventato ormai qualcosa di mitico e archeologico, ai giovani viene fatto un discorso sulle opportunità che, di fatto, sono aumentate. Si tratta di maggiori possibilità di fare esperienza, di conoscenze varie (e approssimative), di valori fluidi, di disimpegno, di individualismo. Il giovane viene spinto a costruirsi un modello di vita flessibile, che possa adeguarsi alle mutate condizioni del mercato del lavoro (non solo), ma anche della realtà nel suo insieme.
Ciò è una conseguenza di un certo fallimento ma è anche la causa (oggettiva, in termini di modificazione dei rapporti produttivi) di quel fallimento. L’allontanamento dagli interessi pubblici e politici, dilagante fra i giovani, è certo un fallimento ma solo di un modo di vedere la politica in termini autoritari (partito). In questo senso, il crollo dei valori tradizionali (famiglia) ha comportato anche quello dei valori politici tradizionali. Non poteva essere diversamente.
Proporre ai giovani un discorso “tradizionale”, poniamo il discorso sul sindacato “rivoluzionario”, diventa veramente fuori del mondo.
I giovani sono stati allontanati dal mito della sicurezza (lavoro, carriera, stabilità, famiglia, partito) non certo con lo scopo di farne dei rivoluzionari e, quindi, non bisogna cadere nell’equivoco di ritenere che il capitale lavori per il re di Prussia. Caso mai, le cose stanno al contrario. Ecco perché le nostre critiche al partito, di ieri, dovevano, come abbiamo fatto per tempo, essere condotte fino in fondo, fino allo stesso partito che è in noi, per non confonderci con la critica (apparente) dello Stato nuovo che vuole offrire un ordine nuovo nell’apparente mancanza di ordine. Difatti, la loro privazione di sicurezza (flessibilità) non è altro che la ricerca (per certi versi, realizzata) di una sicurezza (e quindi, di un controllo) più alta e significativa.
La vita
È questo il punto centrale degli interessi dei giovani. Vivere una vita accettabile. Ciò comporta il dislocamento degli obiettivi futuri in un presente precario e incerto. Le certezze di ieri scompaiono per lasciare il posto a mode e fluttuazioni che si propongono come “opportunità” mentre non sono altro che illusioni, come, sotto un altro aspetto, lo erano anche le certezze di ieri, illusioni anche loro, se collocate nell’ottica del partito o dello Stato operaio.
E poiché si fa presto a dimenticare, i giovani non considerano questa memoria nemmeno come oggetto di critica. Tutto ciò semplicemente non esiste. La sfera quotidiana, i rapporti personali, le opportunità del giorno per giorno, la sperimentazione, il rifiuto della politica (acritico), sostituisce inconsciamente l’armamentario del passato.
Che poi il quotidiano sia banale e ripetitivo, che i rapporti personali anneghino irrimediabilmente nella noia, che le opportunità si rivelino fittizie, che la sperimentazione sia semplicemente moda e che il rifiuto della politica sia effetto della semplice ignoranza e non prodotto di riflessione critica, tutto questo per il momento non può essere sottoposto ad approfondimento più significativo.
La risposta ai processi di riduzione è spesso voltata verso una rivalorizzazione di modelli del passato. Ad esempio, il capitale spinge verso la flessibilità, ma chi riceve il messaggio trasforma questo modello in adattabilità, quindi riscopre il valore del bricolage, della miseria dei piccoli bisogni soddisfatti attraverso una fittizia autonomia, della rinuncia ai desideri che poi diventa abitudine, del sacrificio come modello quasi ascetico di rarefazione del bisogno. Così, quasi per incanto, nella vita dei giovani, risorge accanto ai comportamenti dettati dalla modernizzazione (rifiuto del lavoro, della carriera, della gratificazione sociale, della stabilità), il surrogato dell’arrangiarsi, del lavoro nero, della pseudo-libertà del non-far-niente (che poi corrisponde spesso al non-sapere-cosa-fare). All’aggressività di una volta o, comunque, al desiderio di scalare la società, in un contesto a scarsa capillarità, si contrappone adesso la rinuncia, la permissività, l’orizzontalità, e ciò in un contesto certamente più permeabile. Ne risulta, a mio avviso, che le possibilità di cui si gratificava il singolo, mediamente dotato, all’inizio della sua vita sociale, possibilità di provvedersi di alcune opportunità, erano maggiori in un contesto in cui la disponibilità oggettiva delle medesime opportunità era minore. Oggi, per contrasto, con maggiori opportunità oggettive, abbiamo una minore disponibilità soggettiva verso queste opportunità, una rinuncia senza saperlo, un abbandono ad un ritmo di vita che si crede volontariamente scelto e invece viene programmato nei grandi laboratori del capitale.
La precarietà come scelta di vita
Considerando la cosa astrattamente, non c’è dubbio che il rifiuto dello status sociale fisso, della rigidità da tutti riconosciuta, della carriera, ecc., sia un valore positivo. Verso lo smantellamento dei ruoli fissi è andata tanta parte della critica anarchica contro la famiglia, la scuola, le istituzioni di ogni genere, lo Stato. Ma la precarietà che ne deriva, la provvisorietà, deve essere assistita da una forza intima, da un elemento della coscienza dell’individuo, capace di trasformare questa situazione instabile in qualcosa di più altamente stabile e ordinato, ben al di là dell’ordine provvisorio e carcerario imposto dalle istituzioni.
Tutto ciò va bene. Ma, quanto di ciò si realizza nella pratica? L’occasionale incontro del nostro progetto critico, diretto alla distruzione della stabilità, con il progetto statale, diretto a creare una situazione di instabilità perché questa e non un’altra è la migliore scelta per riorganizzare i processi di sfruttamento, è di certo un incontro funesto. Si tratta di due cose apparentemente simili, ma profondamente diverse.
Il capitale (e con esso lo Stato) ha dilatato al massimo le possibilità, proponendo orizzontalmente uno scenario che in precedenza aveva soltanto l’aspetto della piramide. Ma, anche in linea orizzontale è possibile fissare un limite insuperabile, tanto più insidioso, come limite, quanto meno visibile e comprensibile lo si riesce a fare. Il fascino della precarietà coinvolge adesso la quasi totalità dei giovani, ma è cosa ben diversa della precarietà di scelta che in altri tempi alcuni di noi hanno deciso di accettare come stile di vita. La precarietà obbligatoria è uno status altrettanto rigido di quello di una volta.
L’equivoco che si nasconde dietro questa propaganda sull’allargamento delle possibilità fornito dalla società post-industriale, si comprende meglio se si pensa al paragone che viene fatto spesso con un modo di vivere bohémien. La precarietà come scelta di gusto, come scelta artistica o intellettuale. Ora, è mai possibile pensare all’acquisizione di una mentalità del genere a livello di massa, a livello di ogni possibile lavoro? Certamente no. Almeno non in termini di creatività. Perché non è vera l’equazione che viene postulata tra precarietà e creatività, quando la prima è una scelta imposta da una routine che, bene o male, è sempre la stessa (qualche bottone in più o in meno, e quello che cambia è soltanto il luogo e il tempo della pigiata dei bottoni). Mancando la creatività – e questa manca, come ognuno vede, per definizione – manca anche la possibilità di stravolgere la routine, quindi manca anche la possibilità di sconvolgere lo status che, in questo modo, torna a cristallizzarsi.
La creatività non può esistere in assenza di una consolidata identità, in assenza di una personalità forte e volitiva. Occorre un senso di sicurezza che consente di potersi muovere dentro di sé agevolmente, pur con tutte le contraddizioni a volte lancinanti di un simile viaggio, anche in condizioni esterne di estrema precarietà e di estrema difficoltà anche a livello di sopravvivenza. Difatti, ci sarebbe molto da dire sulla creatività in condizioni coattive, come sono quelle della situazione mediamente diffusa fra i giovani. Anche gli stimoli alla socialità, alla orizzontalità delle decisioni, alla collettività delle esperienze, sono tutti elementi positivi che però hanno bisogno di essere prima filtrati attraverso la riduzione ad elementi della coscienza del singolo per potere emergere come stimoli alla creatività. Finché restano quello che oggi sono, almeno a grandi linee, impulsi delle condizioni generali del sistema, processi di moda e di accettazione incondizionata, il tempo per una loro trasformazione in elementi creativi è ancora lontano.
L’adattamento
I giovani si adattano. Questa è la realtà. E verso questa conclusione spingono gli interessi e le strategie della classe dominante. Al momento attuale non si può dire che ci siano programmi precisi in questo senso, cioè nel senso di una riduzione precisa, in ordine al tempo e ai mezzi impiegati, delle capacità dei giovani, ma c’è un andamento oggettivo degli interessi della produzione (quindi, in primo luogo, del mercato del lavoro) e c’è un rifiuto generalizzato che ha colpito la stessa capacità di orientarsi in modo autonomo.
La precarietà indotta spinge i giovani ad evitare ogni sforzo per trasformare questa situazione in precarietà scelta. Di più, dopo qualche tempo, si smarrisce persino la possibilità di fare una distinzione. Si è in una situazione precaria e si cerca di arrangiarsi. La perdita di punti di riferimento consolidati (qualcosa da desiderare come livello della scala sociale), cosa che prima spingeva alla lotta e, nel caso della presa di coscienza rivoluzionaria, anche alla alimentazione dello scontro di classe in termini di azione diretta e di attacco; adesso spinge – stiamo ragionando sempre in termini generali – a cercare una risoluzione del problema della vita quotidiana. E questa risoluzione non può essere cercata che ad un livello inferiore. Ci si guarda intorno e si accettano come ineluttabili modelli di compromesso a breve scadenza, nell’ottica di una visione individuale o, al massimo, di ghetto. Le potenzialità vengono immerse nel mare, indicato come vastissimo, delle possibilità, e finiscono per annegare nel bicchiere d’acqua dei compromessi con se stessi e con l’ambiente.
L’identità smarrita non viene più cercata in termini di conflitto e quindi di sofferenza personale – cosa che in passato spingeva alla ricerca e, perché no, all’utopia – ma viene cercata nella stessa irrisolutezza generalizzata. Ci si identifica con l’incertezza, con la parzialità, con quello che passa il governo, con l’immediatamente tangibile. È sconcertante la quantità di “buon senso” che si può raccogliere negli ambienti giovanili. Si tratta di un pragmatismo (che è stato scambiato, pensate!, per nichilismo) di bassa lega che taglia completamente i rapporti con la progettualità a medio e a lungo termine, con i grandi perché della vita, con gli sconvolgimenti sociali che è possibile realizzare, con il volontarismo se non rivoluzionario almeno radicale.
Proprio nel momento in cui il potere parla di allargamento all’infinito delle possibilità, i giovani, cogliendo il senso profondo di questa risposta, si racchiudono nell’appagamento minimo, nel fatalismo, nel realismo quotidiano, nella tensione ridotta e dimezzata, nel ghetto in cui è possibile sopravvivere.
La parte debole
La gran quantità costituisce la parte debole, quella che ha problemi di realizzazione. In una situazione di svuotamento generalizzato della scuola, sia a livello di contenuti che a livello di legittima accessibilità al mercato del lavoro, solo una ristretta minoranza, economicamente più forte ed anche più vicina socialmente ai centri di gestione del potere, solo questa minoranza può programmarsi, dentro certi limiti, l’accessibilità ai livelli post-scolastici di istruzione, i soli che garantiscono l’ingresso nel mondo degli inclusi.
Per la parte debole esistono surrogati che sono stati ritagliati apposta sugli antichi valori “contro”, quei valori per tanto tempo sostenuti dai rivoluzionari. Vi ricordate della “qualità della vita”? Basta questo esempio per capire di cosa stiamo parlando.
Il nuovo ghetto
Il giovane, tagliato fuori fin dall’inizio (salve le debite eccezioni) si indirizza non più verso i contenuti culturali, i soli che potrebbero garantirgli un accesso al mondo degli inclusi, ma verso il vasto campo dell’apparente. Il ghetto si chiude attorno alla parte debole con il sigillo dello spossessamento. Lentamente gli elementi sostanziali che consentivano l’uso degli strumenti culturali (anche in chiave rivoluzionaria, dopo avere preso coscienza della propria situazione di classe), vengono sostituiti da elementi relazionali, inter-relazionali, da contatti, conoscenze, opportunità, possibilità. Tutto si sposta nel settore del tempo libero, delle relazioni affettive, dei rapporti di amicizia, delle pratiche di vita quotidiana, degli hobby, del riflusso nelle pratiche religiose, misteriche, esoteriche, astrologiche, ascetiche. Lo stesso impegno “politico”, quando riemerge attraverso gli imbrogli del rifiuto delle ideologie, rifiuto imposto dalla stessa amministrazione del potere, lo stesso impegno politico si dirotta verso l’edulcorazione pacifista e nonviolenta, verso la condizione a priori di pratiche dissociative (nel senso di separate), di interventi di settore.
Il nuovo ghetto è quindi chiuso all’interno delle mura dell’accomodamento, del vivere quotidiano, della fuga nel misterico, della riduzione dell’impegno in questo o quel settore. Il resto, la società, l’azione rivoluzionaria, il sogno di un mondo migliore viene dimenticato, anzi è stato dimenticato su ordine espresso dell’oggettiva ragionevolezza delle cose.
La funzione dell’affettività
In una situazione che si centralizza nel compromesso e nell’accomodamento, di fronte al problema dell’impossibilità di costruire una corretta identità personale ma del vedersi costretti a retrocedere su posizioni minimali che sono le sole a garantire un possibile equilibrio, assume particolare importanza la funzione dell’affettività.
L’amicizia, il rapporto alla pari, la relazione amorosa, la frequentazione degli stessi luoghi, la codificazione degli stessi gesti, atteggiamenti, parole, ecc. A poco a poco, ci si affeziona alle stesse persone, alle stesse cose, alle stesse parole, agli stessi gesti e, pur nel continuo cambiamento, anche agli stessi vestiti. Tutto cambia perché nulla cambi. L’affetto sostituisce ciò che non esiste più: i condizionamenti ideologici, l’organizzazione del lavoro, gli squilibri sociali violenti, la struttura piramidale della società.
Si viene a creare un vortice riduttivo all’interno del quale si solidifica la chiusura del ghetto. La realtà propone le stesse esperienze del soggetto, quest’ultimo non riesce a viverne di diverse, pur nell’astratta massima potenzialità. C’è quindi un rinvio di staticità delle esperienze tra realtà esterna e individuo. Questo si modella su quella e quella riproduce i modelli di questo.
La realtà esterna viene vissuta come fatto lontano e incomprensibile, in fondo, poco interessante. Quello che si coglie sono gli elementi terminali di questa realtà: la vita quotidiana, con i suoi miti, il suo buon senso, i suoi luoghi comuni, lo sport, la musica, la moda, i simboli della bellezza, del possesso, della forza, ecc. Il resto, le cause ultime di questi simboli che sono a nostro contatto di pelle, nella vita di tutti i giorni, vengono considerati – e sono di fatto – lontani, poco incidenti e quindi, in sostanza, inesistenti. E siccome la vita è pur sempre azione e non semplice aspettativa, eccola che si trasforma in spettacolo. In questa zona, facoltosamente incrementata dal potere, i giovani possono ancora incidere, dire la loro, trovare la propria strada, la propria individualità.
Nel campo in cui si sentono più “loro stessi”, regnano leggi che, da per sé prese, sono la realizzazione della vecchia utopia: uguaglianza, fraternità, amicizia, affetto, amore, pace, nonviolenza. Solo che nel regno del fittizio tutte le vacche sono grigie.
La mancanza di identità
Abbiamo visto che tutto ciò rende difficile la costruzione della personalità o, almeno, favorisce condizioni di adattamento che sono produttrici di personalità flessibili, con scarsa identità di se stesse.
Non può essere altrimenti. In una situazione in cui aumentano le opportunità potenziali, per evitare la frustrazione assoluta (fuga nell’illusorio: droga, religione, misteri vari, culturismo fisico, ecc.) si deve necessariamente ripiegare su scelte opportuniste, pragmatiche. Ma l’identità non si costruisce su queste deboli basi.
Certo, anche il vecchio carrierista dalla identità “forte” faceva le sue prove nell’opportunismo e nella schiena flessibile. Ma il suo era un processo di decisioni, una strategia, se si vuole risibile e machiavellica, ma pur sempre una strategia. L’opportunismo di cui discutiamo è sostanza, non strategia, è contenuto, non scorza. Questo opportunismo è privo di identità (qualsivoglia identità, anche quella dello sfruttatore, che sempre identità resta).
Ed essendo privo di identità, va allo sbaraglio.
Così abbiamo che i giovani possono cercare il lavoro ma vivere la loro situazione (di disoccupati, di lavoratori in “nero”, di lavoratori) come “esterni”, come una situazione transitoria. Oggi qui, domani là, dopodomani in nessun posto. Lo stesso per la famiglia: possono viverci dentro ma non condividerne i valori, come possono abbandonarla ma non per questo acquisire o razionalizzare i motivi dell’abbandono. Lo stesso per un gruppo: i giovani possono fare parte di un gruppo ma non perdere altri livelli di relazione e ciò sorprende di fronte alla forte selettività delle antiche appartenenze ai gruppi d’impegno politico e rivoluzionario.
Ne deriva che i giovani trovano difficoltà a identificare una scala di valori nelle proprie relazioni sociali. Non sanno più se sia più importante il lavoro o la famiglia, l’attività associativa in un gruppo o l’impegno culturale in un altro, l’appoggio concreto di un’istituzione o la libera scelta al di fuori delle organizzazioni di partito.
Possiamo – come certamente ognuno ha sperimentato – vedere dei giovani, anche compagni, condurre una lotta con certi mezzi, controinformativi, di azione diretta, ecc., e poi, improvvisamente, proporre di mettersi d’accordo con un ente qualsiasi, poniamo con il Comune, per avere una qualsiasi concessione. Non si tratta di contraddizioni o di malafede, si tratta di mancanza di identità.
Dalla carenza di identità discende un comportamento indeterminato e imprevedibile.
L’imprevedibilità
Occorre fermarsi un attimo su questa deduzione. La formazione della personalità è fatto non solo soggettivo, ma anche oggettivo. L’ambiente concorre e trovando alcune componenti fisiche prevalenti su altre, finisce per determinare una certa costruzione della coscienza e dell’individuo.
Una realizzazione flessibile, con mancanza di progetti a lunga scadenza, con reazioni ridotte e con contenuti immiseriti, produce per forza una labilità non soltanto complessiva nei giovani, ma anche nella loro stessa capacità di scegliere un orientamento costante nell’ambito della vita quotidiana. La mancanza, o la forte riduzione, di grandi ideali, delle stesse utopie per cui oggi si grida allo scandalo, di convincimenti radicali, di coinvolgimenti, tutto ciò comporta anche una imprevedibilità nei comportamenti minuti. Oggi si è rassegnati, domani iperattivi, ora si è romantici, dopo si diventa scettici, da insicuri si passa all’ostentazione di indipendenza, dalla tolleranza all’insofferenza.
L’imprevedibilità trova, per altri aspetti, il suo riscontro nella fase di ristrutturazione che la formazione sociale sta subendo. Si trasformano i processi produttivi e questa trasformazione è talmente profonda e “rivoluzionaria” da causare una altrettanto violenta trasformazione dei valori e dei modelli di comportamento, oltre che delle condizioni e dei desideri sociali.
I giovani subiscono questa imprevedibilità del loro comportamento. Su questo non sembra possibile avere dubbi. Essi, allo stato attuale delle cose, appaiono travolti da un processo che non ammette alternative. Gli interessi sussistono, questo è vero, ma appaiono sfumati in possibili alternative dirette a soddisfare bisogni diametralmente opposti ma equivalenti sul piano del valore che il soggetto attribuisce loro.
I livelli di tensione
La contraddittorietà dell’individuo è fatto patologico e deve trovare uno sbocco se non proprio unitario, almeno transitoriamente unificante. Non si può restare perennemente in bilico tra più scelte. Ad un certo punto bisogna scegliere. Certo, anche l’assenza delle scelte può essere una scelta, oppure, se si preferisce, anche l’essere messo nella impossibilità di scegliere diversamente è una scelta, almeno una scelta in progressione in quanto diventa irreversibile solo dopo un certo livello.
Si può continuare a vivere le condizioni labili di una sopravvivenza anche per lunghi periodi, ma le conseguenze dell’incertezza si accumulano e pesano sull’individuo. Nell’assenza di un modello di valori gratificante, in condizioni di orizzontalità degli orientamenti, o ci si indirizza – e in fretta – verso una presa di coscienza, o si viene bruciati con grande facilità.
E i giovani corrono certamente un rischio del genere. La presa di coscienza della propria condizione di esclusi può avvenire in molti modi, finanche nei modi in cui avveniva in passato (quelli dell’alienazione), ma non è detto che da sola, specie nelle forme embrionali che se sono sufficienti a scatenare il senso di disagio non lo sono per fare trovare uno sbocco, possa, questa presa di coscienza, condurre ad un progetto. Diversamente da quanto accadeva una volta, quando la modificazione della personalità, a seguito di certe condizioni oggettive e soggettive, poteva trovare riscontro in una pratica ben visibile, in una mancanza materializzabile, sotto gli occhi di tutti. E da qui al desiderio violento della riappropriazione il passo era breve. Anche della mancanza di dignità ci si sentiva offesi e in nome di ciò ci si poteva battere ed anche morire. Ma oggi non è un problema di mancanza.
Nel misurarsi con una situazione contraddittoria, aperta a svariate possibilità, l’individuo si disvela contraddittorio a se stesso, si capisce mancante di un progetto, di un desiderio, di una volontà. E tutto ciò può avere conseguenze impensabili. Il comportamento imprevedibile resta tale fino in fondo.
La violenza che viene fuori da questo accumularsi di contraddittorietà non è traducibile immediatamente nel nostro codice impostato sui rapporti di produzione del passato.
Il progetto di dominio
Non è qualcosa di definito, comunque si basa, come abbiamo visto, sul canone indispensabile della flessibilità. Ciò comporta dei rischi. Al primo posto l’imprevedibilità di un potenziale conflitto di classe. Nello svolgersi degli ultimi cento anni, il capitale e lo Stato, insieme o separatamente, si erano persuasi che tutto poteva essere recuperato ma, in fondo, non si erano mai illusi sulla fondatezza della utopia del capitale, cioè di lasciare contenti tutti, sfruttatori e sfruttati.
Adesso, con le modificazioni radicali che sono avvenute in questo decennio, le aspettative sono sempre caute, per quanto anche noi ci sentiremmo di sottoscrivere che le possibilità che ha oggi questa duplice santa alleanza sono di gran lunga migliori di quelle di ieri. Eppure questa gente ci va cauta. Sa che ci sono spazi per l’emersione della conflittualità sociale, sia per l’impossibilità di realizzare un progetto sociale complessivo, sia per l’impossibilità per i giovani di realizzare singoli progetti di soddisfazione individuale. Ma i dominatori vogliono illudersi ancora una volta e sostengono che in ogni caso ci sono spazi per l’appagamento personale e che le contraddizioni sono sempre superabili attraverso atteggiamenti pragmatici.
Ognuno ha i suoi modi di illudersi. Anche fra coloro che combattono contro il dominio esistono illusioni di pari entità e gravità.
Il superamento dei vecchi progetti della lotta di classe
La formula aggregativa (partito, sindacati, gruppi, federazioni, ecc.), a prescindere dalle diverse connotazioni ideologiche e pratiche, dagli obiettivi e dalle utopie di fondo, nasceva in base al bisogno, oggettivamente visibile, di adeguare la resistenza dei lavoratori allo strapotere padronale. Di fronte alla monoliticità del capitale si aveva una originaria frammentarietà degli sfruttati. Da qui la primaria e indispensabile azione di unirsi per difendere i propri diritti (se non altro quello alla sopravvivenza, che in certe condizioni veniva anch’essa minacciata) e poi per attaccare allo scopo di realizzare altre conquiste.
La monoliticità del capitale era visibile non solo come forza finanziaria e possesso dei mezzi di produzione, ma anche come luogo fisico: le fabbriche. Non fu mai un caso che le fabbriche venissero costruite sugli stessi modelli architettonici delle carceri e delle caserme, come non fu mai un caso che vecchie caserme si adattassero in fabbriche, in carceri o in scuole (come accadde anche per i conventi). La destinazione delle istituzioni totali si equivaleva, quindi questi edifici erano intercambiabili. Per combattere in tali condizioni bisognava unirsi. Unendosi si profilavano strategie ed esiti che erano quelli del “contropotere”, cioè della sostituzione al vecchio di un nuovo potere. Non è qui il caso di discutere le tragiche conclusioni di queste prospettive. Quello che mi interessa approfondire è invece il cambiamento delle condizioni di monoliticità del capitale e dello Stato.
Diciamo subito che oggi non esiste più un “cuore” del capitale come non esiste più un “cuore” dello Stato.
I grandi centri industriali stanno esplodendo nel territorio internazionale e si stanno dividendo sempre più grazie alle possibilità di programmazione offerte dall’elettronica che lavora in tempo reale. Per fare un esempio, oggi, di già, non esistono più i magazzini di stoccaggio delle grandi industrie. I vari materiali sono distribuiti nel territorio, anche a grandi distanze e senza nemmeno una vera logica. Quando, in un qualsiasi punto del globo, serve un pezzo si legge sul computer dov’è il luogo più vicino e si fa venire il pezzo per aereo. Il sistema è meno costoso di quanto sembra perché non ci sono più i costi altissimi del magazzinaggio in grande quantità, della gestione di diversi magazzini distribuiti nel territorio e forniti di migliaia di pezzi, dei rischi relativi, ecc. Lo stesso dicasi per le catene di montaggio che essendo ormai robotizzate possono facilmente essere dimezzate prevedendo il trasporto dei semilavorati anche a grandi distanze. In ogni caso, la monoliticità fisica delle grandi industrie tende a scomparire e, con ciò, la stessa presenza degli operai all’interno delle fabbriche si sta riducendo drasticamente.
Per quanto riguarda la struttura dello Stato, già da molto tempo non esiste più il “cuore”. Nessuna componente del meccanismo statale è indispensabile, ma tutte sono facilmente sostituibili, sia a livello politico, sia a livello amministrativo. Da qua deriva il limite dell’azione dei marxisti autoritari, tipo Brigate Rosse e consimili, che su di un’analisi tanto vecchia e superata, hanno impostato la loro azione aspettandosi risultati che non potevano venire (ad esempio, il fatto Moro) se non in termini di minore o maggiore (ad esempio, il fatto Cirillo) contraddittorietà nelle risposte statali. I poteri decisionali dello Stato si stanno polverizzando nel territorio, distribuendosi in forma orizzontale, la più adeguata alla situazione post-industriale che si sta costruendo nella formazione economica.
Dobbiamo quindi considerare come inadeguati all’attuale situazione reale i vecchi modelli di organizzazione degli sfruttati.
Cosa suggerire: lo facciamo da tempo e lo riassumiamo qui, in poche righe. Le unità autonome di base, strutture autogestite che nascono secondo la situazione e che si richiamano alla conflittualità permanente, all’autogestione e all’attacco.
Per l’organizzazione specifica suggeriamo i gruppi informali che si riconoscono nella metodologia insurrezionale, cioè nella pratica costante di sensibilizzazione degli sfruttati per trasformare tutti gli istinti di ribellione e tutte le tendenze alla sommossa, per quanto possibile, in forme insurrezionali dotate di un minimo di organizzazione e di analisi politica.
Per l’attacco, ora e subito, e non da programmarsi per un futuro in cui i “tempi saranno maturi”, sosteniamo gli interventi diretti a distruggere le realizzazioni del capitale e dello Stato nel territorio. Sarebbero da privilegiare, a nostro avviso, le strutture minimali e ciò perché proprio su queste strutture si basa la diffusione nel territorio del capitale (ed anche, sebbene un po’ meno, dello Stato). I grandi centri, che ancora persistono, significano soltanto simboli di qualcosa che non c’è più o, se c’è, di qualcosa che deve essere assistita da una miriade di collegamenti terminali (cavi, fili, condotte, tubi, centraline, antenne, tralicci, pali, centri di smistamento, centri di ricerca, ecc.), senza i quali quei complessi diventano inutilizzabili.
Per questi motivi, con buona pace dei sordi che continuano a non voler sentire, sosteniamo che le strutture aggregative tradizionali (partiti e sindacati di qualsiasi tipo) e le strutture specifiche (gruppi e federazioni di sintesi), appartengono al passato e oggi non risultano più adeguate alle avvenute e in corso di realizzazione modificazioni della realtà.
La presenza rivoluzionaria
Per quanto il momento sia di riflusso e gli interessi del capitale e dello Stato ad un disimpegno generalizzato si stiano per sposare con un disinteresse voluto dai giovani come rigetto delle precedenti avventure ideologiche, penso che sia possibile la ricostruzione di una presenza rivoluzionaria.
Questa ipotesi la fondo su due argomenti. Primo, le situazioni in cui le grandi masse di giovani si trovano fin da ora e sempre di più si troveranno in seguito, sono tutt’altro che ottimali. Contraddittorietà e mancanza di identità finiranno per determinare (e di fatto determinano anche oggi) esplosioni di violenza non facili da capire e ancor meno facili da gestire. Secondo, è possibile affrontare criticamente gli errori del passato senza per questo fare come qualcuno che si trasforma in cantore funebre della rivoluzione.
Occorre apprestare una presenza che sia adeguata alla nuova situazione, cioè che si articoli con strumenti che possano diventare elemento e non ostacolo di quelle medesime esplosioni di violenza, per incanalarle dalla discontinuità e dalla confusione alla continuità e alla coscienza di classe. In altre parole, per trasformare le sommosse spontanee in insurrezioni coscienti.
Sarà possibile una cosa del genere? Pensiamo di sì e indichiamo come mezzi indispensabili a priori: il coraggio di affrontare situazioni nuove a cui non siamo abituati, la capacità di leggere motivazioni al dì là delle proprie esperienze del passato, la chiarezza dei propositi contro ogni mistificazione, l’isolamento di chi ama fare soltanto chiacchiere, l’apprestamento dell’azione anche minoritaria.
Tutto ciò, con buona pace dei riverniciatori di cadaveri, noi siamo disposti a farlo, anzi, lo stiamo facendo.
Cosa vuol dire vivere la vita?
La nascita del mito della vita come sommo bene è stata opera del cristianesimo sulla scia dell’ebraismo. Ciò ha distrutto l’unità del cosmo, all’interno della quale l’uomo trovava il proprio valore. La critica moderna distruggendo l’immortalità della vita, non ha distrutto il concetto della vita come sommo bene, per cui si è avuto il risultato di aumentare il taglio tra l’uomo e la natura. Il concetto di vita collettiva come insieme organico che fa affluire nell’individuo gli elementi costitutivi, istintuali della vita. I rapporti tra vita individuale e vita collettiva. Nell’individuo passa un flusso di vita collettiva, che non è un flusso esclusivamente storico, ma anche naturale nel senso più esteso del termine. Vita individuale e vita collettiva si ricongiungono attraverso due strade, da una parte gli istinti, le idee, le forme genetiche, i processi naturali si condensano nell’individuo; dall’altra parte, le esperienze, le contraddizioni, le ripresentazioni, le costanti si riportano alla vita collettiva. Il punto d’incontro, dalla parte dell’individuo, è la coscienza.
Gli elementi del problema
Mi accade sempre più spesso, in questi ultimi tempi, di leggere invocazioni alla vita, alla pienezza della vita, all’importanza di “vivere la vita”. (Ci sono poi quelli che parlano anche di un “viversi la vita”, ma il senso di questo riflessivo mi sfugge, senz’altro a causa della mia ignoranza, per cui tralascio di parlarne).
Sulle prime, davanti a questo tipo di argomenti, resto perplesso. Non sono difatti molto bravo a discernere subito di cosa si sta parlando: la vita è, come cercherò di far vedere con un minimo di chiarezza, un problema ambivalente. Ma le mie perplessità non sono tutte di questo tipo. In genere, non so a che cosa si rifanno queste invocazioni alla vita. La rivendicazione sembra, almeno si deve dare atto che Cesare è un uomo d’onore, riguardare la vita dell’uomo, nel suo senso e significato sociale, non la vita biologica in senso stretto. Ma il più delle volte il discorso non è chiaro. Le espettorazioni retoriche si mischiano alle geremiadi ecologiche sui mali del pianeta che sta andando in malora. La vita è minacciata, anche biologicamente (e questo lo sappiamo, per quanto si costruisca sulle manipolazioni genetiche più fantascienza che progetti di liberazione), ma è anche minacciata la vita dell’individuo in quanto somma delle sue esperienze, in quanto fatto sociale. Non sono riuscito a capire se le due cose vengono, da tanti esaltatori della necessità di salvare la vita, considerate insieme o separatamente, o se la prima è vista come semplice supporto della primarietà (e fondamentalità) della seconda. Arriverò mai a capire questo mistero? Ne dubito.
Penso che molte volte si trovi comodo fare riferimento alla vita per indicare quella somma di bene massimo che un intrigo internazionale di forze reazionarie ci sta sottraendo. La cosa non è chiara, e nemmeno corretta, ma funziona. L’appello alla vita ha sempre commosso i petti deboli e fatto tossire di commozione le vecchie signore. Continua a farlo anche oggi, in un clima che dovrebbe essere più disincantato. Il bello è che tossiscono e strabuzzano gli occhi anche vecchie pellacce, reduci dai combattimenti incruenti (o cruenti, a seconda dei punti di vista) del referendum sull’aborto, insieme ad antiche cariatidi anticlericali, antireligiose e atee, con pedigree e certificato di garanzia da vidimare prima dell’uso.
La vita è un ottimo mito popolare da sostituire, per la sua acriticità e la sua manegevolezza, ai vecchi ed ormai usati miti del passato. Fissa bene i limiti tra reazione e rivoluzione: i rivoluzionari sono sempre per la vita, i reazionari gridano “viva la morte”. Aiuta i deboli a darsi uno scopo (appunto, nella vita). Conforta gli indecisi. Fa da placebo per chi soffre d’insonnia e ci sono fondati motivi di credere che possa ottimamente sostituire l’azione vera e propria. Basta pensare alla vita, di tanto in tanto, anche mentre si va al lavoro, facendo un piccolo esercizio di concentrazione psicologica, e la cosa è fatta.
Ho personalmente sperimentato (piccola inchiesta, con piccoli dati empirici) che molti pensano realmente che la vita sia come un flusso (appunto, vitale), che si possa cogliere, se non proprio vedere o sentire, che si possa misurare, accrescere, affievolire, ecc. Di questo flusso si ha cognizione confusa e incerta, comunque lo si tiene presente come qualcosa di cui si fa parte quasi inconsciamente ma che occorre difendere a tutti i costi, come un bene assoluto.
Certo, anch’io colgo perfettamente la differenza (ma è poi così reale?) tra il militante di “Comunione e Liberazione” che mi frastorna con il suo discorso sulla vita, e il rivoluzionario che cerca di darmi indicazioni sempre sulla vita. Alla lettura ideologica, cui sono abituato, questi discorsi risultano diversi e diversi sono per una loro, presunta, voluta, diversa utilizzazione, ma, in pratica, sono essi diversi veramente? Quel minimo (o tanto che sia) di confusione che sta alla base del ragionamento sulla vita, non incide negativamente, come elemento pulsionale ed irrazionale, su di loro e così facendo non porta acqua soltanto al mulino del cattolico manganellatore che sa bene quanto partito si possa trarre dall’utilizzo dei miti e delle tante frastornature irrazionali?
Parlando continuamente di metropoli di morte, di industrie di morte, di strutture istituzionali di morte, ecc., si costruisce il fondamento acritico di un’accettazione della vita, almeno se non si sviluppa, nello stesso tempo, un’analisi che possa dare conto del concetto di vita che impieghiamo, e che possa fare ciò al di là degli schemi ideologici.
Un campo d’indagine più ridotto
Per amore di concretezza mi pare sia necessario ridurre qui il campo di discussione. Mi atterrò quindi ad una considerazione del problema soltanto dal punto di vista della vita come somma delle esperienze dell’individuo, come fatto sociale.
Nello stesso tempo cercherò di dimostrare come questo significato (qualche volta definito “storicistico”) non si regga se non si stabilisce (nei limiti e nelle possibilità di connessione) il rapporto che esiste tra la vita genetica (la vita in generale per come è conosciuta nel nostro pianeta) e la vita sociale, cui fa riferimento primario, nei suoi elementi coscienziali, l’esperienza dell’individuo.
Venendo fuori dalla rivoluzione industriale avanzata, l’uomo moderno aveva in possesso un patrimonio mai sognato di ingegnosità nella trasformazione della materia, sia nel campo del macrocosmo che in quello del microcosmo. Eppure, queste sue vastissime acquisizioni lo avevano impoverito di una cosa fondamentale, la cui mancanza si doveva fare sentire sempre di più in seguito: la capacità di considerarsi “altro” dal processo in corso, la possibilità di contemplare qualcosa che viene prima e oltrepassa il processo e la trasformazione del mondo. Non era tanto l’azione vera e propria, alla quale si affiancava il “lavoro” nella sua primitiva significatività, quanto la fabbricazione che vedeva scomparire questa capacita dell’uomo che impropriamente, spesso, viene definita “creativa”. I processi della fabbricazione vennero così a solidificarsi sempre di più come elementi strumentali diretti solo al raggiungimento di un fine. Ma questo fine non era più quello della più o meno immediata utilizzabilità, per cui l’azione (e finanche il lavoro) mantenevano la loro validità introspettiva (di coscienza ma anche di contemplazione); esso era diventato il fine della produzione di cose, un mondo di oggetti in cui l’uomo finiva per perdersi. In questo modo, il mondo viene coinvolto nella vicenda tragica dell’uomo, ma non come possibile elemento di trasformazione, bensì come insieme di risultati più o meno casuali di un processo di produzione. Lo scopo finale non è quindi più la costruzione di sé nella cosa, ma la costruzione della cosa fuori di sé, una cosa prodotta non più per il suo impiego ma per la produzione di qualche altra cosa, e così all’infinito.
Il produttore di valore d’uso doveva per forza “contemplare” la cosa e, in questa (cioè nel mondo della natura, anche se trasformato), identificare un se stesso diverso. In ciò c’era un valore che si identificava nella cosa, nell’atto del creare e nella contemplazione del “lavoro” e della cosa creata. La distanza tra natura e storia si riempiva, così, attraverso un passaggio interno. Invece, l’accidentalità della cosa prodotta nei riguardi della sua primaria destinazione alla ulteriore produzione, il suo marginale uso in termini di impiego, snatura il valore primario, se si vuole in termini di valore d’uso, portandolo alle leggi dello scambio. In questo modo, il taglio è irrimediabilmente eseguito. La natura resta indietro. Diventa elemento di sfruttamento, ulteriore arnese fra gli arnesi. Espulsa dal contesto vitale dell’uomo, quindi anche dal contesto storico, la natura trascina nella sua stessa espulsione l’uomo, che viene così snaturato della propria originaria identità.
Lo svilimento della cosa prodotta finì per determinare una modificazione nello stesso ragionamento fondato sul principio di causalità. Se ogni cosa deve avere una causa, si diceva, non è necessario che questa causa sia per forza più grande della cosa che determina. In questo senso la critica di Hume era stata decisiva ed aveva aperto la strada allo scetticismo e alla distruzione della giustificazione razionalista dell’esistenza di Dio, poi perfezionata da Kant. Il ragionamento evoluzionista, non tanto quello di Darwin, ma quello su cui Darwin basò le sue ricerche, non sarebbe stato possibile in caso contrario.
Poi, alla causalità evoluzionista, che afferma che da un essere inferiore può venire un essere superiore, si sostituì la causalità produttivistica, che è stata definita dell’“orologiaio”. Qui è il produttore dell’orologio che deve essere per forza superiore alla cosa prodotta.
In questa prospettiva di smarrimento non restava altra strada che il ripiego nell’introspezione (non più nella contemplazione della cosa fatta), ma nell’astrazione della introspezione. Il solo oggetto valido per l’individuo, in un mondo di oggetti privi di valore reale (fondato sulla utilizzabilità) era quindi l’individuo stesso, ma nella sua forma astratta o, se si vuole, munita della sola concretezza biologica. Certo, questa concretezza, in quanto processo metabolico uomo-natura, può costituire una forma rudimentale di coscienza umana, ma fissa un rapporto con il mondo esterno che ha bisogno di una reificazione mitica, cioè della trasformazione in cosa di una entità del tutto astratta, appunto la “sostanza vitale” dell’individuo stesso. In un mondo in cui era diventata, per le strane contingenze del capitale, di fatto, operante la distinzione cartesiana tra res cogitans e res extensa, cioè tra “cosa pensante” e “cosa estesa”, la rottura tra soggetto e oggetto era ormai definitiva. Il superamento illusorio era solo nell’oggetto vita, in cui si incorporano, apparentemente, processo e esistenza.
L’origine cristiana della concezione della vita come il bene più alto
Malgrado le profonde trasformazioni che la rivoluzione industriale impose all’assetto del mondo, la vecchia concezione cristiana della concezione della vita come il bene più alto, doveva restare valida. L’immortalità della vita umana era infatti un principio cristiano che si adattava perfettamente a quel processo a ritroso, di identificazione di un valore fittizio, che si andava sviluppando parallelamente alla perdita della produzione di utilizzabilità nel processo di fabbricazione.
Il mondo antico, al contrario dell’idea cristiana, collocava l’immortalità nel cosmo, e quindi aveva un’idea del rapporto tra uomo e mondo del tutto diversa da quella cristiana. Quest’ultima, capovolgendo i valori antichi, aveva dichiarato immortale quanto di più mortale c’era, proprio la vita umana. Certo, all’epoca di questo iniziale capovolgimento, le grandi masse sfruttate videro in questo mito un elemento di riscatto e fu questo uno dei motivi che concorsero alla caduta del mondo antico. Ma il rovesciamento stesso non mancò di avere conseguenze funeste per la struttura della società. Invece di condurre verso una sia pur progressiva liberazione, si arrivò ad una costruzione della società teocratica, poi statocratica, con un passaggio di idee e teorie che ancora oggi si considerano con stupore.
L’unione che l’uomo aveva con la natura, l’immortalità che riscontrava in questa unione, malgrado la riconosciuta limitatezza della propria vita, dava all’idea di totalità (o di cosmo) una forza e una capacità di analisi che non saranno più raggiunte in seguito. Ma la stessa capacità di affrontare la realtà andò decadendo, man mano che cresceva questo valore della vita come massimo bene.
“Il cristianesimo ci ha defraudato del raccolto della civiltà antica; e più tardi ci ha defraudato di quello della civiltà islamica”. (F. Nietzsche, L’anticristo).
Nell’idea cristiana è possibile identificare l’origine ebraica: il disprezzo del mondo pagano per le sofferenze (compreso il lavoro); l’elevato concetto del godimento, della gioia, come attitudine normale per gli dèi, ma anche per gli uomini forti; l’odio per tutto quello che è debole, malato, abietto, guasto, malriuscito, traviato; la considerazione positiva del suicidio come nobile gesto per sfuggire ad una vita ormai divenuta insopportabile; tutto questo era estraneo agli ebrei e lo fu anche ai cristiani. Ma c’è una differenza che fa diventare i cristiani disgregatori più potenti degli ebrei. Per questi ultimi l’immortalità era nel popolo (ebraico, naturalmente), contrariamente ai cristiani che la vedevano solo nella vita individuale. Ciò poneva gli ebrei a metà strada tra il mondo antico (che vedeva l’immortalità nel cosmo) e i cristiani. Con il dominio cristiano sopra tutta l’umanità dell’Occidente, la vita immortale dell’uomo finì per diventare il bene supremo.
Questo principio liberava il lavoro dall’antico disprezzo pagano. Lo schiavo non veniva più disprezzato, anzi esaltato a libero (nell’anima) ed uguale. Ma il disprezzo degli antichi pagani per lo schiavo non era per la sua condizione, ma per la sua mancanza di forza. Infatti, c’era un modo per non essere più schiavo: ribellarsi o morire. Il conservarsi in vita in tutte le circostanze, anche quelle degradanti di uno schiavo, era visto dai pagani come qualcosa di vergognoso, ed era questo che li portava a vedere nello schiavo una “cosa” da disprezzare. Con il cristianesimo il capovolgimento non poteva essere più completo: il riconoscimento del funerale veniva negato proprio al suicida, mentre veniva concesso anche all’assassino.
Comunque, per aversi una definitiva concezione positiva del lavoro, in termini moderni, cioè privi dell’elemento “contemplativo”, o creativo, se si preferisce, bisogna arrivare alla rivoluzione industriale. Per il cristianesimo precedente, il lavoro non divenne mai un “valore”, ma solo una necessità della vita da mantenersi dentro certi limiti. Per lo stesso Tommaso, il lavoro veniva in secondo luogo se si aveva modo di vivere diversamente, ad esempio chiedendo l’elemosina. Abbiamo così, che il principio della vita come bene più alto prepara la strada, ma solo il definitivo assetto moderno della società lo realizza appieno.
La comica conclusione, da cucire addosso a tanti critici moderni della religione, è che la distruzione quasi completa della credenza nella immortalità dell’anima non ha comportato la parallela (e logica) distruzione della credenza nella vita come il valore più alto.
L’uomo tagliato in due
La progressiva scomparsa dell’idea dell’immortalità della vita, come si è visto, non causò la scomparsa dell’idea della vita come sommo bene. Questo secondo assunto cristiano persistette, anzi si estese coprendo il territorio mitico lasciato scoperto dalla prima di queste idee.
L’individuo era ormai irrimediabilmente tagliato in due. La sua unità oggettiva con il cosmo, o se si preferisce in termini più attuali con la natura, era cosa ormai perduta. La vita individuale ridivenne mortale ma l’antica unità non si ricostituì. Anzi, l’individuo, invece di ripensare ai percorsi costruttivi che potevano riportarlo ad una diversa concezione del mondo, si limitò, il più delle volte, a negare l’esistenza stessa di questo mondo, con quella particolare presunzione borghese che si esprime nelle forme più raffinate della filosofia idealista. Sotto un aspetto diverso, anche la presunzione scientifica sulla iper-realtà del mondo risultò altrettanto distante da quell’unità cosmica che ormai era un ricordo lontano.
Dall’interno di questa sua frattura l’individuo cercò allora una strada diversa verso l’immortalità. Non più la vita, non più il cosmo, ma il processo vitale. In questo modo, si ricostituiva il fondamento filosofico (e quindi etico) che giustificava il valore supremo da dare alla vita stessa. Non la vita dell’individuo era eterna, ma il flusso complessivo di cui egli era pur partecipe. La realtà della natura, con la vita biologica in primo luogo, veniva messa tra parentesi per sostituirvi l’illusione di un flusso vitale, di uno slancio vitale, di una volontà della vita, di una pienezza delle forze vitali. Si tratta di formule che sostanzialmente si equivalgono.
Non bisogna pensare che questo concetto sia soltanto delle filosofie “vitalistiche” reazionarie, ad esempio la posizione di Bergson. Anche filosofie (per altro, altrettanto reazionarie, se non di più) come la posizione di Marx lo comportano. Nella società del capitale – secondo Marx – prevale un interesse solo, quello delle classi. Sotto un altro aspetto, per il materialismo dialettico l’interesse delle classi è quello stesso dell’umanità, anzi questo concetto non ha senso fuori dall’ipotesi di classe (cosa questa molto giusta ma per motivi diversi). Ma in nessun modo quell’interesse può essere quello dell’individuo, dell’uomo, degli uomini singolarmente presi. L’azione umana in questo modo si ritrae all’interno di un concetto di classe che viene imposto dall’esterno. L’interesse individuale, il desiderio, il bisogno, la stravaganza individuali, scompaiono e vengono appiattiti. Il diverso schiacciato, livellato, normalizzato. Resta soltanto la “forza naturale” (secondo Marx), lo “slancio vitale” (secondo Bergson), il flusso vitale di cui discutiamo. In questo processo tutti gli uomini e tutte le attività dell’uomo si eguagliano per sottomissione. Il pensiero diventa parte del processo vitale che ha soltanto lo scopo di assicurare la sopravvivenza dell’individuo e, quindi, della specie. Il lavoro diventa necessario per assicurare anch’esso la sopravvivenza della specie, attraverso quella dell’individuo: un elemento del processo naturale (e vitale).
L’uomo diviso dalla natura
Il risultato più evidente della separazione che si è vista fu la sempre maggiore lontananza della natura. Ciò malgrado le formule stantie di un desiderio di avvicinamento: “vivere secondo natura”, vecchia affermazione dei moralisti di ogni pelo.
“Immaginatevi un essere come la natura, dissipatrice senza misura, indifferente senza misura, senza propositi e riguardi, senza pietà e giustizia, feconda e squallida e al tempo stesso insicura, immaginatevi l’indifferenza stessa come potenza – come potreste vivere voi conformemente a questa indifferenza?”. (F. Nietzsche, Al di là del bene e del male).
Il rimprovero è giusto. Non si può essere separati, in un mondo di produzione, e desiderare un ricongiungimento che non si può realizzare se non con la negazione assoluta del mondo tagliato in due che invece si continua a sostenere. È questa la tragedia dei naturisti, dei vegetariani, degli ambientalisti, degli ecologisti di oggi. Per loro la natura è un obiettivo parziale, qualcosa da salvare, da difendere, da esaltare, da mitizzare, insieme ad altre cose, lasciando immobili gli elementi fondamentali di un sistema sociale che consente, come esercitazione retorica, il desiderio di salvare, difendere, esaltare, mitizzare, ecc. L’orgoglio di questa gente vuole imporre alla natura la propria dimensione di vita, la propria morale, il proprio ideale, che sono squallidamente conformisti – anche se alternativi – che sono acquiescenti, possibilisti, tolleranti. Mentre la natura è tutto l’opposto, esigente e intollerante, non ammette richieste ma esige una ricostituzione di unità. Ciò non vuol dire che qui si stia sostenendo un “ritorno alla natura” al posto di un “vivere secondo natura”. Le due cose si equivalgono. Caso mai, un ricongiungimento con quanto di naturale c’è nell’uomo, nei suoi desideri (bisogni), nelle sue diversità, nei suoi slanci, nelle sue malvagità. Attraverso questa strada si potrebbe ritrovare la “natura”, dentro di noi e fuori di noi. Altrimenti resta sempre il sogno di una cosa, cioè quello che della forza si fa un debole.
Il destino costante di ogni creazione intellettuale priva di forza, in quanto sradicata dalla realtà delle lotte, è sempre quello di creare qualcosa a propria immagine e somiglianza. Non può fare diversamente, l’immaginazione crea il mondo e lo fa sempre “rovesciato”.
Dovremmo prima o poi accorgerci di quanto sia ridicola la pretesa di regolamentare la realtà in base ai concetti. In base a questi ordiniamo, stabiliamo, disponiamo, diamo forma ai nostri istinti, ma così facendo li racchiudiamo, li costringiamo, li imprigioniamo all’interno della struttura dell’intelletto. Di questa “riduzione” d’intenti è testimonianza il “pensiero” finito, quello che riusciamo a comunicare. Ben povera cosa se lo paragoniamo, per quanto ciò sia possibile, alla vastità e all’inquietante indeterminatezza di quello che ci urgeva dentro al momento di desiderare la sua espressione. Quello era uno stimolo attivo, un desiderio violento di trasformazione (di noi stessi e del mondo), questo è qualcosa di limitato, di semplice, di ripetibile. È di questo che ci facciamo banditori, ma non possiamo negare che questo sia una più o meno bella maschera di quello, anzi che questa maschera sia tanto più efficace e impenetrabile, quanto più bella e colorita ed espressiva riesce ad essere.
Ed è giudicando da questi prodotti mascherati che non possiamo, assolutamente, giudicare delle differenze. Bisogna scendere al di sotto del semplice momento strutturale, del fatto comunicativo, se si vuole linguistico. E, scendendo, cogliere il tessuto vastissimo che produce quel breve momento di condensazione. L’asservimento cui siamo abituati ha tradotto questo processo in escavazione filologica ed erudita. Nulla di ciò, beninteso. Non è sospettando legami altrettanto costrittivi che si viene a capo del problema. Non è rintracciando discipline e regole che si smascherano i concetti cortigiani. La strada è quella della mancanza di paura. Della volontà che ferma non arretra davanti a quanto di violento, arbitrario, irragionevole, orribile c’è in noi stessi, mezzo anch’esso di azione e di espressione, elemento incontestabilmente costitutivo del concetto che ripuliamo e mascheriamo perché gli altri non si accorgano (e noi stessi con loro) di quanto di disdicevole c’era in fondo alla pentola. Ciò non vuol dire che possiamo rintracciare “tutta la natura” in questa parte conculcata di noi stessi, ma certo possiamo acquistarvi spregiudicatezza, forza, violenza, fermezza, schiettezza. Questo lo possiamo fare. E se da questo affievolimento della pietà e dell’ipocrisia che sono in noi dovesse cominciare a sorgere una qualche confusione nella stessa nitidezza dei concetti che andremo a formulare, non dobbiamo farci prendere dal panico. La realtà è sempre poco chiara. La chiarezza è sempre indice di elevata condensazione del processo di mascheramento. L’animale domestico è sempre prevedibile (ubbidiente). L’animale selvaggio ha scatti e bellezze che sono tutte da scoprire, non puoi mettergli la museruola. Puoi certo metterlo in gabbia. Ma così facendo non fai che mettere in gabbia te stesso. Chi racchiude, costringe o distrugge un altro essere contribuisce alla propria riduzione, al proprio progressivo annientamento.
La vita collettiva
Cerco qui di delineare brevemente alcuni punti di una concezione della vita come totalità, come una unità capace di comprendere l’individuo e la natura, al di là della frattura ontologica registrata dall’avvento della superiorità della fabbricazione.
Anche nelle formulazioni della parzialità esiste sempre, e non è facilmente nascondibile, il senso di un fluire esterno, complessivo, globale. Un fluire che comprende tutte le cose, la realtà nel suo insieme, le relazioni umane, la storia, la natura e l’individuo. Di questo fluire si coglie, a volte, il senso del movimento, più spesso si è portati a cogliere fenomeni periferici, spazi di specializzazione: le singole scienze, la morale umana (sociale), la poesia, gli stati sensibili dell’animo, i grandi bisogni (non solo il pane), la coscienza. Ma ogni cosa nell’ambito di se stessa, senza connessioni che non siano ipotesi di lavoro interdisciplinare.
A me sembra che questa totalità della vita sia ben altro che una visione di comodo, una sommatoria delle parzialità. Un insieme organico ha qualcosa di più della semplice somma delle parti che lo compongono. E, come nel nostro caso, quando questo insieme sia l’insieme di tutti gli insiemi possibili, l’organicità vitale raggiunta è la massima possibile. Ogni singolo individuo partecipa di questo insieme, lo voglia o no. Di esso è responsabile e ne sconta i difetti, i tagli, le approssimazioni. La sofferenza inflitta ad un singolo essere è così, e solo attraverso questo modo di vedere le cose, la sofferenza inflitta a tutti. La tolleranza, l’ignavia, la non azione, il girare la testa dall’altra parte, mentre gli uomini, alcuni uomini, sia pure una piccola parte dell’insieme degli uomini, degli animali e della vita stessa, vengono sfruttati, vilipesi, dileggiati, distrutti, è responsabilità che incombe sul singolo e non esiste scusa o mascheratura che potrà mai coprirla.
Certo, questa vita unitaria ha una sua autonomia individuabile, pensabile in forme cristallizzate intellettualmente, ma è, prima di ogni cosa, avvertibile, intuibile come sensazione, come sentimento, come fede, in ogni individuo che senta i bisogni dell’umanità, della natura, come bisogni suoi, individuali.
La formazione unitaria della vita sollecita gli elementi costitutivi, istintuali, dell’individuo vivente. Si riproduce in questo ma non perisce con questo. Da quella l’individuo riceve qualcosa che non è una “sostanza” nel senso della materia in generale, ma riceve una dimensione comune alla specie, un istinto di fondo (che poi sono una serie di istinti), un coordinamento naturale che è coglibile nell’individuo singolo, al di là delle mutazioni inferte da un sistema sociale più o meno cosciente delle proprie violenze. Ma questo qualcosa che viene ricevuto non si attinge da un fondo “passivo”, un più o meno esauribile patrimonio della specie, ma da un processo relazionale in cui si accumulano i contributi del singolo individuo e da cui questo trae le motivazioni di fondo della propria vita, gli elementi del proprio carattere e, perfino, le grandi linee parallele del proprio destino. Non si tratta di una vita “superiore”, per qualità, ma di una vita che è nella vita dei singoli esseri, al di là di questioni di scala di valore. Per questo, il sentimento di offesa che sentiamo davanti ad un albero abbattuto per i dissennati progetti del regno mercantile, davanti ad una collina saccheggiata dalle costruzioni, davanti ad un animale ferito, ad un uomo umiliato, è il nostro sentimento, per questo ci sentiamo offesi personalmente. Quel patrimonio comune non sta “sopra” di noi, ma noi stiamo in esso, siamo tutto il patrimonio. Per questo ogni singolo essere è tutta la vita nel suo insieme, in una inscindibile unità.
È questa vita collettiva che si tramanda, che si conserva, che si modifica e si riproduce nei singoli esseri. Un patrimonio di caratteri, anche organici, che viene continuamente rimandato e ripreso. Non è solo un percorso rintracciabile con quasi certezza nel mondo dell’immediatamente percepibile (la scienza, pensata, in questo senso deve fare ancora passi sorprendenti e demistificanti), ma anche e, perché no!, principalmente, nel mondo dell’uomo, nelle idee, nei sentimenti, i quali crescono, si modificano e si sviluppano collettivamente, ma vengono messi a punto e trovano la loro momentanea e sempre risorgente puntualizzazione, proprio nell’individuo.
La vita collettiva è quindi estensibile agli individui, li penetra. Chi legge di un periodo della storia, poniamo gli anni Cinquanta, che ha vissuto personalmente, si rende conto, negli elementi che la ricerca sottolinea e classifica, di due cose: a) che questa ricerca è fortemente riduttiva, in quanto notomizza un corpo che fu vivente e non può assurgere alla pretesa di riuscire a darne i significati più intimi; b) che al momento in cui quegli anni venivano vissuti, man mano che si andava avanti, con le esperienze, con le letture, con le conoscenze, con i sentimenti, le amicizie, gli amori, le delusioni, con tutto quello che costituisce la vita, si veniva in contatto con alcuni elementi più o meno costanti, le idee del tempo, i sentimenti, le sensazioni, la cultura del tempo; e questo non veniva colto, ma poi, sempre con il senno del poi, finiva per diventare addirittura ovvio.
Nell’individuo passa quindi un flusso della vita collettiva che, occorre ripeterlo, non è flusso esclusivamente storico, ma è flusso reale, quindi naturale nel senso più esteso del termine. Le caratteristiche della vita collettiva vengono quindi recepite dagli individui, diventano le loro tendenze, e ciò accade prima che i singoli possano percepirle come appartenenti ad un flusso collettivo.
La morale e la vita
Ogni considerazione etica sulla vita è fuor di luogo per il semplice motivo che non fa che rivolgersi ad una parzialità: la vita individuale e mai quella collettiva. Nel caso pretendesse rivolgersi a quest’ultima trasporterebbe in questa elementi che le sono estranei. Il trasferimento dei comportamenti dei singoli nella dimensione della vita collettiva, se avviene, realizza un passaggio che è compartecipazione, non trasferimento di elementi estranei. Condivisione e progetto comune, flusso di istinti, non decisioni che si accumulano. Il gruppo, la collettività sociale, è sempre un fatto individuale nei rapporti della vita collettiva. L’uomo media la dimensione sociale e la penetra con grande sforzo, ne accetta o ne rifiuta le determinazioni, ma non è compartecipe di un progetto comune. I singoli progetti umani possono essere, nella società, comuni solo per reciproca decisione, sommatoria discreta di un accadimento storico che è sempre legato a pericoli, turbative, sorprese, modificazioni, rotture, accordi. La libertà in questo campo è sempre elemento trasferibile. Dalla collettività sociale all’individuo e viceversa. Nel trasferirsi perde molto della sua intensità, ma non c’è altro modo di farla coesistere fra individui diversi, contrastanti, contraddittori.
La morale è indispensabile per il mantenimento dei confini del ghetto, per la rispettabilità dei pronunciamenti, dei destini accettati a forza ma mai condivisi fino in fondo. La collettività è conservata dalla morale. Il negatore della conservazione è amorale e pericoloso. Nessun rispetto formale per il pericolo interno. Nessuna equità. Distruzione e morte. La norma richiede la normalità. Il diverso è fuori della norma, quindi anormale, quindi pericoloso per la collettività. Quindi da reprimere e distruggere. Ma non solo il diverso, anche tutti gli istinti che fanno il “diverso”. E questi istinti non ha importanza che provengano da quella vita collettiva che tutti li contiene – buoni o cattivi che siano questi considerati nella prospettiva storica di una morale. Così, l’iniziativa, l’audacia, la sollecitazione degli altri, la vendetta, la forza, la sete di conoscenza, la competizione leale, vengono tutte schiacciate sotto infamanti accuse. Spesso la principale è quella del potere. Chi ha istinti del genere tende a prevaricare gli altri, a superarli, a schiacciarli o, qualche volta, semplicemente a vincerli e convincerli. Non ha occhio per la pietà, la tolleranza, l’amore, la nonviolenza, i sentimenti tenui, affievoliti, illanguiditi, come la dolcezza, la lentezza, la non resistenza, l’abbandono, l’estasi, il sogno, la fantasticheria. A parte che non è vero che le cose siano divise in modo così netto, per cui non si vede perché la forza non possa associarsi ottimamente con la dolcezza, l’audacia con l’amore, la competizione leale con l’abbandono, non si capisce perché quegli istinti vitali, certamente più vitali di quegli altri istinti che solo se ricondotti ai primi possono non considerarsi espressioni di profonde modificazioni nella vita collettiva (praticamente di vere e proprie degenerazioni), non si capisce dicevo perché questi istinti non siano naturali anch’essi, cioè facenti parte della vita anche dell’uomo e non si capisce perché la loro condanna, pronunciata da un tribunale di parte e non competente, debba avere valore assoluto.
Così la morale storica si è tristemente indirizzata verso una gradualizzazione della maggiore o minore pericolosità degli individui, dei loro istinti e delle loro azioni, nei confronti della collettività. È stata quest’ultima a diventare il metro di giudizio morale. Più grande era il pericolo, più grande la condanna morale (e giuridica, evidentemente). I comportamenti “diversi”, profondamente in contrasto con questo codice mettono in crisi l’istituzione ma non mettono in crisi la vita collettiva, che capisce perfettamente quei comportamenti perché è essa la depositaria (o, più precisamente, la codepositaria) di quegli istinti, come pure di quelle azioni e di quegli individui.
Su questa scala ogni educazione alla durezza, all’autodisciplina, al superamento dei propri limiti, viene confusa con l’educazione militarista, che nasconde solo la povertà e la miseria della paura dell’individuo che ha bisogno della protesi dell’arma per diventare coraggioso. La conquista di obiettivi non raggiunti dagli altri, obiettivi di idee, prima di ogni altra cosa, obiettivi di conoscenza, viene vista con occhio sospettoso, forse invidioso. Si consiglia la modestia, la mediocrità, l’insignificanza. Turbe di idioti si attaccano allora a tutti coloro che non sono d’accordo, che inseguono un sogno, che si impongono discipline durissime per raggiungerlo. E gli ricordano la sua origine “umana”, il suo dovere verso gli altri, il rischio di separarsi da loro, il pericolo dell’andare troppo avanti, del mettersi troppo in mostra, del risultare troppo bravo.
Su queste piccole cose si è costruita la morale. E la tragedia continua.
La vita individuale e la coscienza
“Se si trasferisce il centro di gravità della vita non nella vita, ma nell’“al di là” – nel nulla – si è tolto il contro di gravità alla vita in generale. La grande menzogna dell’immortalità personale distrugge ogni ragione, ogni natura nell’istinto – tutto quanto negli istinti è benefico, promotore di vita, mallevadore dell’avvenire, desta ormai diffidenza”. (F. Nietzsche, L’anticristo).
L’individuo è portatore degli istinti che nella coscienza diventano il rapporto più immediato con la circolazione della vita collettiva. Vita individuale e vita collettiva si ricongiungono attraverso due strade, da una parte gli istinti, le idee, le forme genetiche, i processi naturali si condensano nell’individuo; dall’altra parte, le esperienze, le contraddizioni, le ripresentazioni, le costanti, si riportano alla vita collettiva. Il punto d’incontro, dalla parte dell’individuo, è la coscienza.
“La vita appare globalmente come un’onda immensa che si propaga a partire da un centro e che, sulla quasi totalità della sua circonferenza, si ferma e si converte in oscillazioni sul posto: in un solo punto l’ostacolo è forzato, l’impulso passa liberamente. È questa libertà che fa sorgere la forma umana. Dappertutto, tranne che nell’uomo, la coscienza si è vista bloccare da un ostacolo; con l’uomo soltanto essa ha potuto seguire il suo cammino. L’uomo continua dunque indefinitamente il movimento vitale, per quanto non porti con lui tutto quello che la vita aveva con sé”. (H. Bergson, L’évolution créatrice).
Per quanto discutibile possa sembrare il passo di Bergson e per quanto necessaria di una spiegazione resti sempre la sua idea di “centro” (il punto del centro e quello della circonferenza, a mio avviso, si convertono reciprocamente, potendo essere, di volta in volta, centro e punto di circonferenza di altre innumerevoli circonferenze, e così via), c’è da dire che fa comprendere bene il passaggio tra vita e coscienza. La coscienza consente l’apertura alla libertà. Non quella della natura, ma quella dell’uomo. Libertà umana, che vuol dire coscienza di limiti, non sogno di illimitate possibilità. La vita ha perso per strada quelle illimitate possibilità. L’uomo conduce più avanti il flusso ma ne filtra una grossa parte. La coscienza procede oltre, verso un territorio sconosciuto, ma non per questo qualitativamente superiore. Un territorio che consente un diverso sviluppo delle relazioni, ma non identificabile come superiore al resto, a quello di già percorso dalla vita collettiva.
È quindi la coscienza il luogo della vita dell’individuo. È qui che si incamerano i processi vitali, anche quelli essenziali del livello biologico. È qui che la vita collettiva trova il suo fondamento. Una coscienza minima, ottusa, ridotta, portata al suo livello di sopravvivenza, una coscienza che nella quotidianità trova il suo standard normale, è una vita ridotta, ottusa, svilita. Le sensazioni stesse, quel livello primordiale di contatto con la realtà, vengono da questo generale svilimento ottuse. Non è quindi una qualità della vita quella che il capitale, nel suo processo di sfruttamento, sottrae all’individuo, ma è la vita stessa, la quale non può commisurarsi in pulsazioni o in processi albuminici (almeno, non soltanto), ma è fatto complessivo organico, nel senso più ampio della parola. L’impoverimento è, prima di tutto, impoverimento della coscienza, della capacità dell’uomo, in primo luogo, ma non dell’uomo soltanto, di mettere a profitto la vita collettiva, di entrare, come compartecipe e elemento portante di quel flusso che costituisce la vita (senza specificazioni).
Ma la coscienza non fa parte della vita collettiva. Cioè non può esserci una coscienza collettiva. Può esserci una coscienza individuale o, anche di componenti più ampie (quantitativamente) dell’individuo, come la coscienza che una classe ha di sé, ma non una coscienza collettiva. Ciò comporta di certo una differenza tra vita e coscienza, anche a livello dell’individuo. Ma solo nel senso che la coscienza è il luogo della vita nell’individuo, il punto di riferimento in cui i processi oggettivi della vita collettiva si incamerano nell’individuo. Ecco perché il singolo non può mai avere coscienza della vita, per cui accadrà sempre che questa gli sfuggirà per sovra o sottodeterminazione. Per eccessiva acutezza o per ottusità, il ricchissimo flusso della vita collettiva gli arriverà attutito. I grandi significati della vita della specie gli resteranno lontani, come appartenenti ad un livello di oggettività non raggiungibile dal singolo, dalla volontà del singolo. E questo è stato sempre un imperdonabile errore. Ma anche le grandi idee, i flussi di significati collettivi saranno attingibili solo attraverso sforzi difficili a realizzarsi. Un’oggettività da conquistarsi. In questo senso aveva ragione Nietzsche quando parlava della difficoltà di diventare quello che si è.
Ne deriva che abbiamo tutti una maggiore o minore coscienza di una parte della vita collettiva, quella parte che riusciamo a strappare attraverso il nostro impegno. Nessuno ha però la coscienza totale della vita collettiva. Se fosse possibile, qualcuno sarebbe egli stesso la vita collettiva, sarebbe cioè la sua coscienza. Quindi, la coscienza è un fatto dell’individuo e non esiste una coscienza collettiva, cosa diversa dalla vita.
Questa precisazione è importante. Se il singolo può sentire gli altri perché questi altri gli sono “comuni” in base al denominatore della vita, non può mai sostituirsi alla loro coscienza. Ecco perché la responsabilità resta dell’individuo, non per una questione “morale”, che sarebbe faccenda di valori, quindi artefatta storicamente, ma per un motivo reale, cioè naturale. La coscienza è individuale (e a questo livello essa è vita), non può essere però coscienza di un altro (perché manca una coscienza collettiva generale). La vita è certo individuale ma è anche collettiva, a quest’ultimo livello può essere sentita dal singolo, anzi è la condizione primaria perché egli, come si usa dire, possa vivere la propria vita.
Un discorso superfluo
Forse il mio si può considerare un discorso superfluo. Se la vita è percepibile solo come coscienza, è questa la strada verso la libertà, verso la rottura dei limiti della determinatezza. Ma se questa libertà è solo attingibile attraverso la vita, cioè attraverso la coscienza del singolo, attraverso la sua responsabilità, che senso ha un appello a “vivere la propria vita”, a non sprecarla?
Il solo senso che mi pare di vedere è quello di spostare l’accento dalla parola vita, cioè di spostare la nostra attenzione da questo concetto. Vivere la propria vita è quindi equivalente ad avere “coscienza di sé”, non come fatto determinato e quindi indiscussamente compiuto, razionale, ma come fatto critico, come flusso di contraddizioni, di significati, di polarizzazioni di significati, come flusso relazionale, come vita. Ecco, tornare il termine, questa volta come fatto critico, come fatto contraddittorio, come qualcosa che può acquistarsi e può perdersi, non come un bene assoluto, sigillato una volta per tutte dal fatto genetico e sacralizzato dal mito religioso. Noi possiamo perdere la nostra vita senza morire e possiamo morire continuando a vivere.
Questo sito, oltre a informare i compagni sulle pubblicazioni delle Edizioni Anarchismo, archivia in formato elettronico, quando possibile, i testi delle varie collane.
L’accesso ai testi è totalmente libero e gratuito, le donazioni sono ben accette e servono a finanziare le attività della casa editrice.
