Prima edizione italiana: Centrolibri, Catania 1985
Traduttore: Andrea Chersi
Seconda edizione italiana: Anarchismo, Catania 1989
Terza edizione italiana: Anarchismo, Trieste 2008
Quarta edizione italiana: Anarchismo, Trieste 2015 Biblioteca di Anarchismo — 15
Bernard Thomas
Jacob Alexandre Marius
detto Escande, Attila, Georges, Bonnet, Féran, Duro a morire, il Ladro
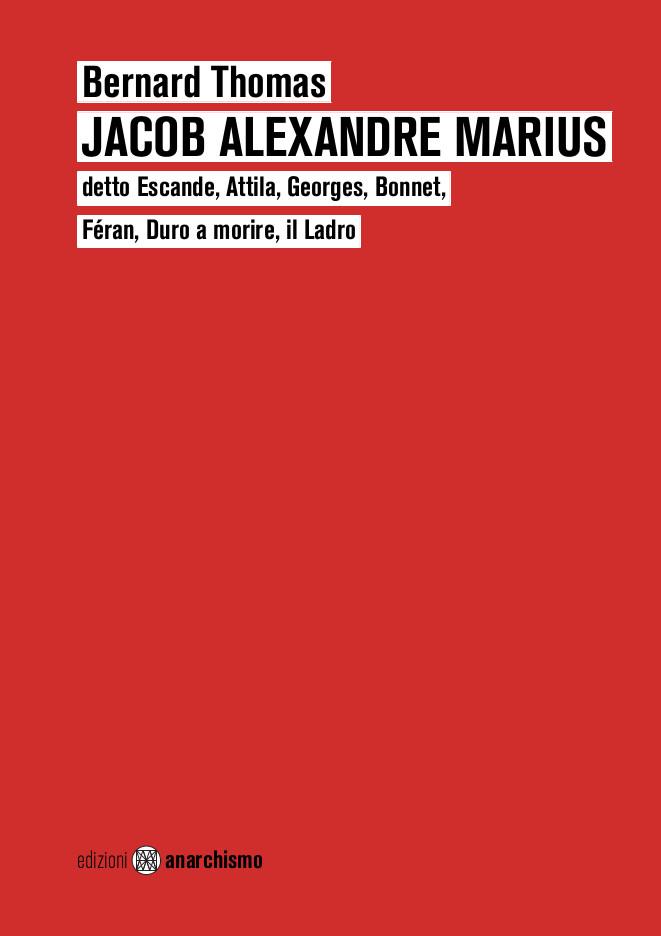
III. I centocinquanta “crimini” dell’altro Arsène Lupin
Introduzione
Sloggiati il rigore e la precisione dal campo delle umane attese di ogni giorno, riconosciuta l’impossibilità di una prospettiva pienamente organizzata in tutti i suoi dettagli, una prospettiva di vita capace di dare indicazioni operative sul che fare quotidiano, il bisogno di ordine e di sicurezza si è trasferito nella sfera dei desideri. Qui, costruita in tutta furia una roccaforte di ultima difesa, si è attestato per l’ultima battaglia. Il desiderio è sacro e inviolabile, è quello che alberghiamo nel cuore, il figlio dei nostri istinti e il padre dei nostri sogni. Su di lui possiamo contare, non ci tradirà mai.
Di questa fenomenologia irrazionale sono piene le fosse più recenti, quelle che riempiamo ai margini dei cimiteri di periferia. Diamo ascolto a fondamenti che prima ci avrebbero fatto ridere, assegniamo condizioni di stabilità e pulsioni che sappiamo, in fondo, non essere altro che il vago ricordo di un benessere passeggero, l’ala fugace di un gesto nella nebbia, il frullìo di ali mattutine che scomparvero ben presto di fronte alle necessità del ripetersi, del ripresentarsi ossessivo e irrispettoso del burocrate che si annida dentro di noi, in qualche angolo oscuro dove seleziona e codifica sogni come qualsiasi altro imbrattacarte nelle sale anatomiche della repressione.
Fugaci balenii attestano comportamenti eroici, di qualche compagno, di qualche ribelle, a volte sogguardato con sospetto prima che la storia non sigilli immota il suo marchio a fuoco nelle carni martoriate a puntino. Non siamo sbalorditi osservatori di televisioni inguardabili, non siamo lettori d’appendici ormai relegate nel polveroso catalogo delle biblioteche. Siamo vivi e per la vita, quindi ci cibiamo di esperienze dirette. Non appena un segno vitale appare qua e là, lo stacchiamo con la punta dell’unghia e lo collochiamo nel segreto portafogli del nostro cuore, dove ricaviamo una breve icona con cuoricini e nontiscordardime.
In fondo anche noi, i duri e gli impavidi della durezza refrattaria alle scelte di comodo, anche noi che non ci siamo scoraggiati né di fronte alle minacce delle istituzioni, né di fronte a quelle, ben più terribili, dell’imbecillità camuffata da ribellione, abbiamo bisogno di alimentare le nostre iconografie, ed è per questo che collezioniamo ricordi, simpatie, amicizie, semplici strette di mano, a volte, non più di questo, caricandoli nella memoria come condivisione e sostegno, quando non al di là, come partecipazione diretta. In questa fase allucinatoria, molti di noi hanno sfondato casseforti di banche e di ministeri del tesoro, realizzato effettivamente espropri radicali, tolto terre ai latifondisti e ucciso nemici in scontri a fuoco cruenti sul far della sera. E leggendo, e annotando emozioni di letture, e ricordando racconti attorno al fuoco, quando la vecchia nonna riportava nella giusta luce le gote arrossate di Cappuccetto Rosso, sviluppiamo per conto nostro, nell’ambito delle fantasie più accese, quei fatti realmente accaduti, di cui non siamo stati che compartecipi alla lontana (nel migliore dei casi), e vi collochiamo la parte più viva dei nostri desideri. E tanto ci è sufficiente. Mentre l’antica critica ad occhi aperti, quella che in fondo vedeva il lupo e non la bambina, e per il primo parteggiava e non per la seconda, se ne rimane in soffitta. Nessuna scienza rigorosa è possibile: non vi ricordate? Quindi perché dovrebbe essere possibile mettere un po’ di criterio nelle nostre fantasie? Ma lasciamole a briglia sciolta. Lontani dalla scepsi che ha frastornato a sufficienza nel passato più o meno recente, riscaldiamo il nostro cuore come pietanza fredda alla fioca sorgente di questi racconti d’avventure, di cui ne presentiamo uno, per altro neanche tanto mal fatto.
Questo racconto parla di un ladro. Un ladro con le sue illusioni egualitarie. Un anarchico con i suoi sogni. Ma con una particolarità: quest’uomo, insieme ai suoi compagni, apriva veramente le casseforti dei ricchi e con questo semplice fatto dimostrava realizzabile un attacco, sia pure parziale, alla ricchezza sociale.
Che questa sia la cosa più interessante di tutto il racconto potrà sembrare troppo poco, ma non è così. L’aspetto spettacolare dell’attività di Jacob e dei suoi compagni, l’inverosimile elenco dei loro furti, il modo in cui questi furono elegantemente perpetrati, non sono gli aspetti più importanti. Ma possono essere quelli che più colpiscono la fantasia del lettore, perfino di quello anarchico. In fondo chiediamo anche noi oggi, come ieri, che qualcuno costruisca per nostro conto l’iconografia di cui non riusciamo a fare a meno. Il paragone con Arsenio Lupin valga per tutti. Maurice Lebanc fu un noto scrittore d’appendice, Bernard Thomas è un giornalista d’appendice. I due generi vanno a braccetto.
Ma Jacob e gli altri erano qualcosa d’altro. Erano, prima di tutto, dei compagni. Ed è qui, in questo campo di scelta del loro agire, che dobbiamo cogliere il significato più profondo delle loro imprese. La descrizione, che nel racconto è implicita nel fascino di un fare al di là di quel livello quotidiano che tutti, più o meno, sopportiamo, non rende fino in fondo i livelli di coscienza che sono stati necessari, gli oltrepassamenti affrontati e condotti a termine, tutto quello che di straordinario, veramente e non come fatto mitico, Jacob e gli altri affrontarono per portare a compimento le loro azioni di attacco. Procedure e metodi, rigidità di comportamenti e morale anarchica nel rapporto con i rappresentanti della classe dominante, sono solo alcuni aspetti del racconto, al di là, volendo andare più a fondo, si deve mettere da canto la descrizione, quindi la favola d’appendice, e accedere alla riflessione.
Che vuol dire mettere le mani sulla proprietà altrui? Per rispondere a questa domanda, e quindi esaminare diversi errori che vengono sistematicamente commessi da molti compagni, oltre a quelli specifici attinenti alle illusioni di Jacob, occorre fare alcune riflessioni non proprio piacevoli. La prima di tutti è che il furto, l’appropriazione in genere, fatta con la forza o con l’astuzia, e non con la cessione della propria attività lavorativa, non può mai diventare arma di livellamento sociale. Per quanto ingenti siano queste appropriazioni, che possiamo definire “fuorilegge”, rimangono pur sempre una minima cosa di fronte all’accumulazione più o meno selvaggia che il capitale rende agevole ai padroni della finanza, ai possessori presenti della ricchezza, ai gestori delle grandi intraprese pubbliche, ai signori della guerra e della mafia di ogni genere. L’appropriazione di cui parliamo, che tanto ebbe a fare tremare i cuori dei pasciuti borghesi dell’impero francese, è semplicemente un mezzo da fare fruttare altrove, per mettere in moto quella generalizzazione dello scontro che resta per gli anarchici lo scopo principale di ogni attività rivoluzionaria. Ingenuità permettendo, credo che questo punto sia chiaro una volta per tutte.
Un altro luogo comune che bisogna sfatare è che queste azioni possano rappresentare un modello per gli oppressi, una maniera sbrigativa e semplice per rientrare in possesso di quello che è stato estratto con la forza dello sfruttamento e della repressione. Il concetto stesso di esproprio proletario, muovendo dagli iniziali e, in fondo, banali raid nei supermercati, non ha più senso di una sceneggiatura per film della vita di qualsiasi rivoluzionario espropriatore: da Durruti a Bonnot, da Sabate e Facerias, da Di Giovanni a Pollastro. La fruizione passiva di comportamenti eroici è sempre produttrice di miti, di favole per adulti, che condizioni di vita frustrante richiedono a getto continuo, protesi che aiutano a vivere allo stesso titolo dell’alcol o dei sonniferi. Le condizioni complessive dello scontro possono, in un dato momento, a certe condizioni specifiche di natura sociale ed economica, produrre movimenti di grandi masse all’interno dei quali gli espropri, generalizzandosi, finiscono per diventare pratica quotidiana, ma tutto ciò germina spontaneamente e non ha bisogno di modelli.
Per un altro verso, e riflettendo bene sulla realtà che sta di fronte al compagno anarchico che si pone il proprio che fare da un punto di vista rivoluzionario, il problema si pone con più ampi dettagli. Qui occorre risolvere nel modo più chiaro possibile il proprio rapportarsi con la realtà, e quest’ultima è rigidamente incarcerata in condizioni di vita che ritmano i tempi della produzione e del consumo. Certo, come tutti sappiamo, ci si può parzialmente chiamare fuori (fino ad un certo punto), racchiudersi nelle idilliache condizioni di una comune provvisoria, ricca di spaventevoli autosfruttamenti e di frustranti condizioni di vita all’aria libera sotto l’ombrello di una natura fittiziamente incontaminata. Oppure cercare, fino ad accoltellarsi, nel chiuso di un numero ragionevolmente grande di rapporti interpersonali, realizzando quelle condizioni soggettive e oggettive che permettano di uscire fuori dalle regole della comune convivenza, tristemente contrassegnata dai classici limiti della coppia. Tutto questo è possibile, e a volte è perfino bello, ma non è tutto. Procedendo oltre, al di là, sempre più in là, si trovano i primi segni del problema vero e proprio: che vogliamo fare della nostra vita? Vogliamo viverla interamente, per quello che ci sarà possibile fare, oppure vogliamo consegnarne una parte, una considerevole parte, in contraccambio di un salario più o meno velato, più o meno camuffato da prestazione economica?
Oggi esistono molti modi per camuffare questa contropartita: il volontariato è uno di questi. Gli impegni molteplici nel sociale, alla coda di nuovi modelli politici di intervento, diretti a garantire la pace sociale, abbondano, e tutti forniscono contropartite che lasciano una fascia a volte insospettabilmente consistente di “tempo libero”. Il potere si è reso conto che deve attirare nella fascia del controllo, con mezzi sempre più intelligenti, proprio quelle fasce di disadattati sociali che altrimenti in modo troppo violento reagirebbero alle condizioni classiche dell’utilizzo lavorativo. E, in questa direzione, molto stanno facendo per rendere più allettante il compromesso. Ma nessuna condizione di privilegio può renderci padroni di noi stessi. Il lavoro, anche quello volontario (si fa per dire), ci mangia l’anima, in breve diventiamo quello che facciamo, siamo quello che produciamo, e se produciamo accondiscendimento e accettazione, pace sociale in primo luogo, siamo noi stessi infettati di pace sociale, di accondiscendimenti e di accettazione. Siamo noi stessi il poliziotto che sta all’angolo della strada e perfino il torturatore in camice bianco o il custode delle carceri che stringe nella mano guantata il mazzo di chiavi.
Se non vogliamo farci mangiare l’anima, seguendo Jacob dobbiamo allungare la mano sulla proprietà altrui, non c’è altro da fare. Ma per allungare la mano dobbiamo portare chiarezza nella nostra coscienza, altrimenti faremo soltanto più o meno vistosi trasferimenti di ricchezza, nient’altro. Il ragionamento corretto diventa quindi quello che propone all’espropriatore, a colui che da un punto di vista rivoluzionario recupera mezzi per fare quello che va fatto, un maggiore spazio di libertà operativa. Non la libertà, che nessuna vera libertà potrà venire da una maggiore disponibilità di denaro, ma una maggiore capacità operativa, una maggiore disponibilità di tempo per realizzare il proprio progetto rivoluzionario. Tutto questo, come si vede, ha poco di mitico e di affascinante, si tratta semplicemente di rendere possibili progetti rivoluzionari che in caso contrario verrebbero tarpati da una scarsa disponibilità di mezzi. Il mondo in cui opero con la mia attività rivoluzionaria coinvolge tutto me stesso, non c’è, da un lato, il me stesso che vive la sua vita e, dall’altro lato, la mia attività rivoluzionaria. Per questo semplice motivo non posso che soffrire delle conseguenze di una dicotomia assurda quale è quella che mi dilacera come lavoratore e rivoluzionario, obbligato, da un lato, a produrre ricchezza per gli sfruttatori, dall’altro, a combattere questi ultimi e quindi quel flusso stesso che io, con il mio lavoro, contribuisco a produrre.
Una classica obiezione è quella che anche il furto è un’attività lavorativa, e quindi un produrre ricchezza, e anche Jacob e i suoi compagni cedettero a questa interpretazione definendosi “Lavoratori della notte”. Ma io ho sempre letto in chiave ironica questa etichetta, che contribuì ai suoi tempi a incutere maggior paura ai borghesi, che non avevano dimenticato i giorni del Settantuno. Invece l’obiezione in se stessa non manca di una certa fondatezza. Il fuorilegge, se non altro, produce il giudice, una parte considerevole del carcere, un gran lavorìo di avvocati e impiegati di tribunali, tutta una mentalità repressiva che dai depositari della ricchezza scende giù fino alla vecchietta che teme di essere scippata della sua piccola pensione. E tutto questo fa senza dubbio parte del gioco. Il furto costituisce, con tutti i suoi annessi, una attività lavorativa che impiega migliaia di operai dell’illegalità, i quali, sollevandosi appena dalla miseria, vengono sistematicamente derubati, a loro volta, da un sistema che li spinge verso un corteggio di brillanti proposte di consumo. Se il rivoluzionario dovesse (come sembra temere Malatesta) cadere in questa trappola, sarebbe un imbecille indistinguibile dal poveretto che riconsegna il proprio bottino, frutto di onestissime rapine, al primo concessionario di costose automobili. Non voglio nemmeno pensare a questa eventualità che, in ogni caso, per quel che può valere la mia personale esperienza, non è cosa molto comune.
Ma resta l’altro aspetto del problema. Il furto non è attività che s’improvvisa: richiede professionalità e impegno, puntualità, precisione e sangue freddo, conoscenza della psicologia umana e delle tecniche più avanzate di prevenzione e controllo. Richiede infine tempo. Non è pertanto né un generoso regalo, né un’avventura esaltante. Quasi sempre si trasforma in routine meticolosa che sfianca il migliore dei compagni. Spesso si commettono errori in un senso o nell’altro: nel presupporre quest’attività più facile di quanto sia, come nel presupporla più complessa e fantastica. Tenere fermo il complesso di problemi che la caratterizzano è importante, e nessuna narrazione agiografica può aiutarci in questo. Così, dopo una approfondita riflessione critica si può arrivare alla conclusione che questi sforzi possono, a certe condizioni e in certe situazioni, costituire la soluzione più efficace per portare a termine un progetto rivoluzionario.
So bene che queste conclusioni non soddisferanno molti compagni incapaci di cogliere quello che spinge molti ribelli verso l’identificazione del nemico. Mi dispiace, ma non essendo mai stato un ribelle, non saprei da dove cominciare. Spero solo che quei pochi rivoluzionari, ai quali queste considerazioni sono dirette, sappiano almeno leggerle per quello che sono: una riflessione critica e l’antefatto di un progetto operativo.
Catania, 10 ottobre 1999
Alfredo M. Bonanno
I. I banditi
Mercoledi 8 marzo 1905, l’indomani di Carnevale, si apre dinanzi alla Corte d’Assise della Somme, in un’atmosfera di sommossa, un processo straordinario, “uno dei più formidabili che la storia criminale abbia mai registrato”, dirà venti anni più tardi il grande giornalista Louis Roubaud.
Le strade adiacenti alla prigione di Bicêtre, dove alloggiano gli imputati, sono sbarrate. Il palazzo di giustizia di Amiens, accerchiato da tre compagnie di fanteria e da tutti gli effettivi di gendarmeria disponibili, si trova in stato d’assedio. Già dall’alba una folla considerevole, nervosa, fa ressa. Spie, inviate da Parigi dal capo della Sûreté, gironzolano, “facilmente riconoscibili”, secondo gli specialisti, “dalle loro facce losche e patibolari”. In alto non ci si nasconde che si temono incidenti. Un’evasione, forse.
Nei corridoi, ad ogni passo, si incrociano militari, pistola d’ordinanza al fianco o baionetta inastata. Per entrare nella sala d’udienza è necessario un lasciapassare. I curiosi dall’aria sospetta vengono duramente respinti. Hanno accesso al Sancta Sanctorum solo coloro la cui rispettabilità trasuda dall’abbigliamento: i benestanti, i possidenti, gli ufficiali, i funzionari. Degli agitatori potrebbero troppo facilmente mischiarsi con la plebe.
La grande stampa, “Le Figaro”, “Le Temps”, “Le Petit Parisien”; “L’Aurore”, “Le Matin”; “L’Eclair”; e quella meno grande, “Voix du Nord” o “Gil Blas” (dove lavora un figlio di armatori normanni, Maurice Leblanc, che tre mesi dopo inventerà il personaggio di Arsène Lupin), hanno inviato i loro migliori cronisti. Dieci corrispondenti dei maggiori giornali stranieri sono sul posto: “Un caso mostruoso”, “Centocinquanta delitti”, “Cinque milioni di franchi rubati”, “‘I Lavoratori della notte’. Un’incredibile organizzazione”. (È difficile calcolare il corrispondente in moneta d’oggi dei franchi-oro, in quanto i bilanci d’allora non hanno che un lontano riferimento con i nostri. Ma si può tentare un calcolo: 20 franchi valevano allora un luigi: un luigi nel 1969, epoca in cui è stato scritto questo libro, valeva all’incirca 60 franchi. Occorre quindi moltiplicare per tre. Si ottengono così 15 milioni di franchi pesanti. Un primo lavorante nella sartoria Worth guadagnava allora 250 franchi al mese; un bravo falegname, 300).
Fatti diversissimi che suscitano stupore.
Ventimila documenti nel dossier, che riempie centosessantuno pagine di una scrittura metodica. Centocinquantotto testimoni convocati. Una massa di prove schiaccianti.
Polizia e magistratura intendono mantenere il caso nello stretto ambito del diritto comune. I principali organi di informazione vi si sono prudentemente conformati. Tuttavia non si può impedire che certe voci percorrano la folla. Gli accusati sarebbero dei temibili anarchici. Degli anarchici! Un brivido serpeggia. Le bombe di Ravachol, di Emile Henry, di Auguste Vaillant sono nella memoria di tutti. I cicisbei fremono deliziati al pensiero di questi strani romantici che preparano l’esplosione della società dal fondo delle loro tenebrose officine. I benestanti, pure estasiati di vedere oggi ventiquattro dei loro nemici personali posti sotto giudizio, non nascondono la loro inquietudine: cinque briganti sono ancora latitanti. Dove complottano? Questa gente è capace di tutto. Non rispetta niente: né morale né religione né bandiera né governo. Né, soprattutto, la proprietà privata, che quelli proclamano, per giustificare i loro misfatti, sia un furto. Il tribunale, sperano, sarà senza pietà: bisogna punire severamente questi bricconi. Per dare l’esempio. Una debolezza colpevole rischierebbe di incitarne altri ad ingrossare le loro file. Persino gli apaches meritano maggiore indulgenza: almeno con loro si sa con chi si ha a che fare.
Voci subdole si intrufolano tra le persone “come si deve” del pubblico. Alcuni suppongono che la banda abbia immense ramificazioni in Francia, in Inghilterra, in Olanda, in Germania, in Italia, in Spagna. Gli imputati non sono che degli esecutori. I veri colpevoli sono quegli agitatori senza scrupoli al soldo dello straniero per indebolire la Repubblica, tutto quel marciume equivoco di pseudo-filosofi, di assassini, di ebrei, che prolifera nel paese, assecondato da un pugno di massoni infettati dal contagio della sovversione e che tenta di approfittare dell’ingenuità del popolo per instaurare una dittatura di briganti sanguinari. Ma gli operai non sono così stupidi. Essi sanno bene che la Francia è una democrazia, che hanno il diritto di voto come tutti e che le decisioni del governo non sono che l’espressione della maggioranza. La loro volontà. La minoranza deve piegarsi. Chiunque rifiuti questa regola rappresenta un pericolo per l’ordine costituito e si mette al bando della società. Il potere sta dando qui prova di eccessiva tolleranza. La “banda d’Abbeville” non dovrebbe trovarsi da sola sul banco dell’infamia. Tutti gli anarchici, tutti i rossi dovrebbero stare insieme ad essa.
I plebei che brulicano a migliaia lungo rue des Trois-Cailloux ascoltano con diffidenza questi cacciatori di streghe. L’abbigliamento, come il modo di parlare elevano una barriera. Istintivamente fiutano un inganno.
D’altro canto, ciò che i giornali continuano a ripetere è troppo semplice: se gli accusati sono dei volgari ladri, perché tante preoccupazioni? Perché un tale spiegamento di forze? C’è qualcosa di strano. Certo, un ladro è un malfattore. Certo, è normale punirlo. Ma non si sa cosa pensare.
È con curiosità, quasi con deferenza che gli sfaccendati pronunziano il nome del capo della banda, uno strano personaggio, avventuriero, mostro o apostolo, secondo le opinioni, un certo Alexandre Marius Jacob. Le persone colte lo paragonano a Robin Hood, a Cartouche, a Mandrin. Alcuni anglisti coniano persino l’espressione di “ladro-gentleman”. Ma l’accostamento delle due parole seduce senza convincere. Lupin non le ha ancora rese popolari. Le lingue lavorano a tutto spiano. Si dice che Jacob non rubava che ai ricchi, che non tratteneva per sé niente del frutto dei suoi misfatti, ma che redistribuiva tutto ai poveri. Si dice che Jacob aveva proibito ai suoi uomini di uccidere, eccetto in caso di legittima difesa e unicamente quando si trattava di poliziotti, battezzati da lui “cani da guardia della società”. Se non si può approvare apertamente tutto questo, ciò non impedisce che l’idea di far fuori uno sbirro in fondo a un vicolo buio non spiaccia a tutti: chi non ci ha mai fatto un pensierino (a condizione, beninteso di avere assicurata l’impunità) scagli la prima pietra. Insomma, questo fuorilegge affascina. Le donne sperano sia bello.
Si sa che Jacob è originario di Marsiglia, che ha appena ventisei anni. Si dice che ha gli occhi neri, che non ha paura di niente e di nessuno e che è una specie di genio. Ha amici dappertutto. Scappa tra le dita di “quelli”. Si volatilizza come per incanto. D’altra parte, la banda del “Germinal” spia la minima distrazione del servizio d’ordine per precipitarsi in suo aiuto.
“Germinal”, i meglio informati ricordano bene quel grido lanciato dall’adolescente Angiolillo dopo aver abbattuto a colpi di revolver, otto anni prima, nel 1897, Canovas, presidente del Consiglio spagnolo responsabile delle torture di Montjuich. Germinal, mese repubblicano del rinnovamento, della speranza: fu proprio in questo mese dell’anno III che scoppiò un’insurrezione nei sobborghi di Parigi per reclamare pane e l’applicazione della Costituzione del 1793, la sola veramente democratica ed anche la sola a non essere mai entrata in vigore; “Germinal”: “Le idee per le quali muoio, presto vivranno”; probabilmente diceva così il giovane giustiziere.
Un gruppo di anarchici francesi ha ripreso la parola come ci si passa un testimone in una staffetta, per farne il titolo di un giornale. La polizia di Amiens si è immediatamente interessata alle loro attività.
All’inizio si sono stabiliti al n. 69 di rue Saint-Germain, poi in rue Saint-Roch 26, quattro mesi fa, nel novembre 1904. L’editoriale del primo numero esprimeva chiaramente, se non moderatamente, il senso profondo dell’iniziativa.
«Lavoratori!
«Il vostro destino, malgrado tutte le promesse dei politicanti multicolori, diviene sempre più precario.
«La stampa non spende una parola sulle vessazioni di tutti i tipi cui gli sfruttatori vi sottopongono nelle loro moderne galere (...)
«Decisamente libertario, “Germinal” non si infilerà mai nella melma della politica, se non per smascherare i mistificatori e gli imbroglioni che vi pullulano. Nato dal popolo e fatto dal popolo, “Germinal” cercherà di diventare realmente il giornale del popolo di Amiens (...)
«Le innumerevoli vittime dei preti, della soldataglia, degli sputasentenze, dei poliziotti, dei padroni, potranno far sentire da qui il loro grido di rivolta senza timore d’esser scoperti. Abbiamo sufficiente energia rivoluzionaria per addossarci tutte le responsabilità davanti alle leggi che disprezziamo sommamente.
«Ognuno faccia il proprio dovere e “Germinal” vivrà per far morire di rabbia quelli con la pancia piena e i soddisfatti, preparando quella Rivoluzione sociale da cui nascerà finalmente la libertà».
Questa professione di fede non ha niente di religioso. Il giornale ha organizzato comizi, riunioni, conferenze, manifestazioni utilizzando tutti i pretesti. Ha messo su campagne per il minimo scandalo locale: gli orari di lavoro, da quattordici a quindici ore al giorno, dei ferrovieri che lavorano alle stazioni; le condizioni lavorative degli operai delle officine e del deposito ferroviario: dieci ore al giorno senza poter parlare, sotto la sorveglianza di ex-poliziotti; le felicitazioni del generale Nonancourt al tenente De la Roche, assolto dal tribunale correzionale di Toul malgrado il pugno che costui ha sferrato al redattore di “La Moselle”, che si era rifiutato di cedergli il passo: “Questo gesto imporrà e inculcherà ancor più il rispetto per gli ufficiali. Il timore è l’inizio della saggezza. Mi rivedo ancora a Parigi nel 1871, all’indomani della Comune. Tutti si scansavano davanti agli ufficiali”. (“Dopo i trentacinquemila morti che avevano appena fatto, vi era di che rispettare quei Signori”, commentò “Germinal”).
Ma, fra le numerose vittime “della soldataglia e degli sputasentenze” è sembrato che a qualcuno fosse riservato un posto privilegiato nelle colonne di quest’organo altamente sovversivo. Sin dal secondo numero, sono apparsi nella rubrica “Piccola Corrispondenza” degli annunci così concepiti: “Io la so lunga”. “Risposta: Utilizzeremo le vostre informazioni al momento opportuno, il caso del Signore in questione procede bene”. O ancora: “Il compagno che ci ha mandato informazioni sulla polizia si faccia vivo in modo da sveltire l’inchiesta che abbiamo intrapreso su questo soggetto”.
Chi è questo “Signore”? Qual è questo “soggetto”? Quelli addentro affermano che si tratta proprio di Alexandre Marius Jacob. La nascita del quindicinale a quattro mesi dal processo e nella stessa città in cui questo deve aver luogo non sarebbe una coincidenza. Avrebbe un duplice scopo: approfittare dell’attenzione che il caso Jacob non mancherà di destare sulla Causa per aumentare l’agitazione e la propaganda nella regione e tentare con tutti i mezzi di salvare il compagno in pericolo.
Un giornale fondato principalmente per difendere un ladro? Sì. Ed anche, dicono, il giornale di un ladro, in quanto Jacob sarebbe riuscito a far pervenire denaro ai suoi amici dalla prigione: i suoi ultimi risparmi. Jules Lemaire, Pacaud e Ouin, i fondatori del giornale, parlano apertamente delle collette che hanno effettuato; più discretamente nominano un certo “Alexandre” senza il quale non avrebbero potuto far nulla. Comprenda chi vuole.
Comunque sia, fin dal numero uno, del 3 gennaio, l’editoriale dal titolo “A Jacob ed ai suoi compagni” è interamente dedicato a lui:
«Giudici, funzionari, preti, soldati, gendarmi, poliziotti, gente di legge, uomini d’affari, tutti si coalizzano per affamare il popolo, per incarcerarlo nelle loro officine e ucciderlo nelle loro prigioni.
«Si tratta nei mercati, si specula, si accaparra, si fanno affari, si fanno crollare le azioni per acquistarle, le si fanno risalire per venderle; l’oro guida la politica, i banchieri dichiarano la guerra. È legale.
«Si sfrutta l’operaio; si approfitta della sua ignoranza e della sua rassegnazione; si costringe gli uni al fallimento e alla miseria, gli altri allo sciopero, alla rivolta, alla fame, altri ancora al furto, alla disperazione, al suicidio, all’assassinio. È ancora legale.
«Si incuba il tifo, la tubercolosi nelle fabbriche, nelle prigioni e nelle caserme. Si gettano per la strada i poveri. Si buttano in prigione i senzatetto. Le leggi sono strumenti di persecuzione. È sempre legale.
«Voi, Jacob, che rifiutate di essere schiavo del ricco e di sfruttare il povero,
«voi che rifiutate il suicidio del lavoro che abbrutisce e vi rivoltate contro una società criminale,
«voi infine che volete vivere,
«voi siete una vittima sociale!».
La parola “vittima” non era certamente fatta per piacere a Jacob proprio nel momento in cui teneva a rivendicare i propri crimini, considerati da lui come altrettanti atti di guerra. I suoi collegamenti con l’esterno non erano però illimitati e solo più tardi riuscì a farlo sapere. Ma per il momento poco importa: l’articolo dà l’idea. È seguito da un vero e proprio manifesto: «Lavorare secondo le proprie forze e le proprie possibilità; consumare secondo i propri bisogni; questa l’unica soluzione del problema sociale. E questo diritto che la società capitalista, rappresentata oggi dal ministro socialdemocratico Combes, si rifiuta di lasciarci conquistare e che strangola con la corda di leggi scellerate (...). Su quaranta milioni di persone, solo quattro milioni lavorano come operai. E producono troppo, come ammettono le stesse statistiche ufficiali, poiché vi è disoccupazione e sovrapproduzione.
«Dunque, se tutti quelli che possono producessero in modo redditizio, basterebbe che ognuno (non contiamo gli adolescenti, le donne e i vecchi) lavorasse una mezz’ora al giorno dai venti a cinquant’anni, ossia cinquecentoquaranta giorni di dieci ore per tutta la vita».
L’autore precisa che dal suo calcolo ha sottratto la parte di lavoratori il cui compito è di mantenere l’ordine o di reprimere il disordine, i funzionari, i burocrati di ogni risma, poliziotti, militari, magistrati, che rappresentano i due terzi dei salariati. Ecco dove può condurre un ragionamento portato avanti fino al suo limite: una gran parte di noi sarebbe costretta, se non vuole trovarsi disoccupata, a partecipare volente o nolente alla repressione degli altri. Non è un assurdo? In ogni caso, Jacob non ha sconfessato queste parole.
Numero cinque di “Germinal” del 17 gennaio: «Louise Michel, la nostra Louise, la “Vergine rossa” non è più. È un lutto per l’umanità». Quando gli hanno dato la notizia, nella sua cella Jacob sembra sia impallidito. La buona Louise, dicono, faceva parte della sua mitologia, dal tempo dell’adolescenza marinara, sin dal giorno in cui aveva sentito parlare di lei dai forzati di Numea. Ed egli l’ha conosciuta molto bene dopo, come tutti i grandi nomi del movimento libertario che firmano ora articoli in sua difesa su tutti i fogli anarchicheggianti: Sébastien Faure, Fortuné Henry, il conferenziere fratello del dinamitardo, Laurent Tailhade, il poeta che ha perso un occhio a causa di una bomba anarchica al ristorante Foyot e ancora Paraf-Javal, l’individualista, e Libertad. Oltre a tutti gli altri, quelli che non firmano, ma agiscono. I benestanti hanno dunque torto a spaventarsi? E se tutti questi “intellettuali” radunassero un’orda di uomini d’azione; se fomentassero concretamente un complotto per liberare il bandito?
Il tono della loro prosa fa temere il peggio. Sono degli ossessi. Perché non si mettono in stato di non nuocere?
«“Germinal” numero 7, primi di febbraio:
«Ora che la rivoluzione russa è domata, la prima norma del manuale del perfetto rivoluzionario deve essere questa: “Se vuoi essere libero, compra un fucile! Se non hai denaro, rubalo!”». Un vero appello all’assassinio. Jacob forse non ha mai ucciso personalmente, ma è della stessa risma di questi indemoniati. Avere come ideale quello di attaccare le casseforti è delitto gravissimo: deve pagare con la testa.
Nemmeno un mese dopo, il 12 febbraio, Sébastien Faure ha tenuto una conferenza all’Alcazar. Ha gettato fango, com’è sua abitudine, sull’esercito, sul corpo di spedizione che si copre di gloria nell’Estremo Oriente, poi sul clero, sulla polizia e sulla magistratura. Le spie che si trovavano nella sala ne hanno preso buona nota. Ma questa conferenza non era che una messinscena per riunire la folla più numerosa possibile. L’oratore era d’accordo. A piccoli gruppi, molte migliaia di persone si sono radunate in rue Delambre. L’Alcazar si è svuotato. Un corteo è partito verso rue de Bicêtre cantando l’Internazionale. Là si è scontrato con un forte distaccamento di militari, piazzato, per fortunato caso, davanti alla prigione. Il corteo è rimasto a lungo immobile schernendo i soldati e gridando “Viva Jacob! Viva la Rivoluzione! Viva l’Anarchia!”.
Poi, improvviso, l’incidente. Straboni, un secondino fatto venire da Rouen appositamente per Jacob, per paura che riuscisse a convertire alle sue idee i guardiani, com’era riuscito a fare una volta, Straboni, dunque, attirato dal chiasso, è uscito dall’osteria Lephay. Aveva senza dubbio bevuto uno o due bicchieri di troppo. In breve, ha estratto il revolver urlando che avrebbe sparato. I manifestanti si sono gettati su di lui, lo hanno disarmato e riempito di botte. I soldati hanno caricato. Si “deplora” una decina di feriti.
In seguito a questi tafferugli, il commissario Jénot ha convocato nel suo ufficio i caporioni individuati: Lemaire, gerente del “Germinal” e i suoi aiutanti Pacaud e Ouin.
Gli anarchici gli hanno risposto con questo biglietto:
«Signor Jénot, siete convocato per lunedì alle dieci del mattino nell’ufficio del nostro giornale, in rue Saint-Roch 26».
Jénot, sbalordito, ha deciso di recarvisi, accompagnato da dodici uomini, a mezzogiorno, è vero, invece che alle dieci, senza dubbio per fare notare che non è ai loro ordini. Beninteso, la perquisizione non ha sortito alcun esito. Come rivincita, “Germinal” ha avuto l’audacia di raccontare l’aneddoto nella sua completezza sul numero del 17 febbraio: non contenti di essere criminali, questi individui si mostrano anche bifolchi. Non ci si può aspettare da loro niente di buono.
Così, questo 8 marzo 1905, mentre sorvegliano i cellulari, i responsabili dell’ordine si sono preparati ad ogni eventualità. Oscillano tra l’“ottimismo prudente” e la “ragionevole prudenza” sforzandosi di non cedere al panico incontrollato, come la settimana prima, quando un apprendista idraulico che controllava perdite nelle grondaie, sui tetti della galleria Couvreur, vicino alla Bicêtre, si è visto due gendarmi saltargli addosso e serragli le manette ai polsi. Il disgraziato, sospettato di preparare l’evasione di Jacob, è stato interrogato un po’ brutalmente per tutta la notte da ispettori troppo zelanti. (Nulla prova del resto che non si trattasse davvero di un complice del Ladro).
Dall’alto dello scalone, il commissario tenta di indovinare le intenzioni della folla. Essa mormora. Si agita. Le spie, pronte ad intervenire, controllano i suoi ondeggiamenti. Si notano gli anarchici sparpagliati che distribuiscono pacchi di volantini tentando di organizzare un comizio. Subito, quattro ispettori in borghese innescano il contraddittorio. Si forma un capannello. Degenera quasi subito nella più grande confusione. Cinque file di fanteria proteggono il Palazzo, senza contare i soldati che si tengono di riserva. Gi ufficiali entrano tranquilli, mescolati ai borghesi venuti ad assistere allo spettacolo, sproloquiano sulla soglia. Forza! La sommossa non l’avrà vinta, questa volta!
Ma cresce il clamore proveniente dai viali. Si ode il rumore dei cellulari che rotolano sul selciato. Appare la scorta, uno squadrone del 30° reggimento di fanteria, preceduto da un generale in tenuta leggera. L’eco sorda di un canto copre tutto: la Carmagnole, intonata dai prigionieri ripresa da venti, da cento, da mille voci rauche della plebe. I furgoni si fermano sferragliando. I fanti respingono le file compatte della moltitudine. Le porte vengono aperte. Le prime a scendere sono quattro donne, incatenate due a due: la madre di Jacob, Rose, la sua compagna, ed altre due, pallide, magre, vestite con molta eleganza, nonostante le pellicce sgualcite. Il corrispondente del “Petit Parisien” e quello del “Gil Blas” non glielo perdoneranno nei loro resoconti: ma bisogna notare, a discolpa delle disgraziate, che, nei due anni che hanno marcito in prigione, non hanno mai avuto la possibilità di rinnovare il loro guardaroba da Paquin, Worth o dalle sorelle Callot.
Poi scendono gli uomini. È lui. Le guance scavate, lo sguardo di fuoco. «Un tipo veramente strano, bassino, sciolto ed agile come un marinaio», secondo Beau dell’Agenzia Havas. «Una testa strana, diabolica, nel mezzo della quale spuntano due puntini luminosi, di una vivacità straordinaria», secondo “L’Aurore”. «Una faccia pallida, naso forte e schiacciato, barba mal tenuta, labbra pallide e debordanti, orecchie a sventola», secondo il cronista del “Petit Parisien”; sicuramente poco affidabile. Sul capo ha una larga bombetta nera. Porta un soprabito nero con collo di astrakan, una cravatta rossa e un colletto dritto leggermente liso ai bordi. Ha in mano un’enorme borsa piena di carte. «Pare che in prigione abbia un segretario al quale detta il suo pensiero. Sua madre e la sua amante agiscono solo dopo il suo assenso», commenta “Le Petit Parisien”. Niente ha, in ogni caso, della canaglia dal berretto a larga visiera. Niente del mostro dalla faccia patibolare. Il suo atteggiamento è corretto, l’abbigliamento accurato, i baffi ben tirati, quasi appuntiti sotto il naso vigoroso. Di taglia media, ma tarchiato. L’aria di un funzionario, quasi di un professore, di uno scienziato. A coppie, i suoi diciannove complici si mettono in fila.
Il viso di Jacob si illumina di un largo sorriso quando nota la folla che lo guarda. Tenta di sollevare le braccia malgrado le catene. “Viva l’anarchia!” urla. “Viva l’anarchia! Viva Jacob” rispondono gli astanti in un fragore di applausi. I gendarmi intervengono; spingono i prigionieri con veemenza verso la scala. Jacob fa resistenza. Devono tirarlo per le braccia. I suoi occhi lampeggiano. Intona l’Internazionale. Il corteo, le donne, il pubblico, si uniscono a lui. Il canto si gonfia e sale verso il cielo basso. Gli imputati ed i loro guardiani, seguiti subito dopo dalle toghe nere dei loro avvocati, si riversano sotto la volta. Spariscono nei corridoi. I redattori del “Germinal” tentano di infilarsi dietro di loro. Jénot fa segno ai suoi uomini di fare barriera. L’alterco dura appena pochi secondi, poi gli anarchici rinunciano. Si disperdono fra la folla che staziona a piccoli gruppi attendendo non si sa cosa.
La sala delle udienze è misera, sudicia, buia, con affreschi scoloriti sulla parete di fondo. Banchi e una pedana supplementari sono sistemati per gli imputati. I corpi di reato, un vera montagna, debordano sui banchi della stampa: grimaldelli, accuratamente sistemati secondo la misura; trapani, punte, seghe di metallo, diamanti da vetraio; lampade Edison unite fra loro da cinque metri di filo; oliatori, scatole di sapone.
La borsa personale di Jacob, da lui chiamata “il contrabbasso” è una meraviglia del genere. I migliori esperti della polizia giudiziaria hanno rinunciato a capire il funzionamento di parecchi strumenti. Confessano di non avere mai visto niente di simile. Secondo loro, vi è materiale per almeno diecimila franchi. Sentiamo “Le Petit Parisien”: «Più di ottanta chiavi in acciaio nichelato, ognuna delle quali in realtà ne formava due, poiché erano provviste di una parte mobile, estremamente ingegnosa, che pare sia un modello americano. Ciascuna di queste chiavi presenta inoltre, in cima, una scanalatura di forma rettangolare che permette di adattare allo strumento un dispositivo speciale per aprire le serrature più complicate. Il malfattore era anche provvisto di lanterne elettriche, una delle quali, pieghevole e a riflettore, forniva una potente luce in grado di illuminare tutta la stanza. Possedeva anche uno strumento perfezionato destinato ad aprire casseforti, proveniente da una delle migliori ditte di New York; una scala di seta munita alle estremità di due solidi uncini adattabili ovunque e diversi altri accessori, tutti ugualmente perfezionatissimi». Il tutto raccolto in una borsa a tracolla di cuoio nero, lunga solo settanta centimetri e alta novantacinque.
A mezzogiorno entra la Corte. Presiede il consigliere Wehekind, che non ha affatto un’aria accomodante. Suoi aiutanti sono: Job Vaselle e Thorel. Il procuratore generale Regnault in persona occupa lo scanno del pubblico ministero, assistito dal suo sostituto, Pennelier.
Prima incombenza: il sorteggio dei giurati. Primo colpo di scena: di tutti quelli chiamati solo cinque sono presenti. Gli altri sono stati trattenuti da affari urgenti. Oppure da malattie: un’angina, coliche renali, bronchiti a bizzeffe. Un’epidemia sembra essersi abbattuta su Amiens. Il procuratore Regnault fa appello al senso civico, al senso di responsabilità, alla legge: perché offrirsi volontari per assentarsi adesso? Come risposta, certificati medici in piena regola.
In verità, i candidati alla giuria hanno avuto paura. Non vogliono entrare in una sporca storia. Essi sono volontari per gli assassini, per i ladri “normali”. Non per degli anarchici. È troppo pericoloso. I loro vicini glielo hanno detto. Le loro mogli li hanno supplicati in nome dei figli. E poi, cosa che non osano confessare, ognuno di loro ha ricevuto una lettera minatoria al vetriolo. Il presidente Wehekind, disorientato per un attimo, si riprende: si mandino i gendarmi, accompagnati da un medico, per verificare le giustificazioni e convincere i recalcitranti.
L’udienza è sospesa. Si va a pranzo. La truppa, approfittando dell’assenza dei giornalisti, ha lasciato le adiacenze del Palazzo che al momento sono deserte. Una cinquantina di soldati insonnoliti sulla scalinata, il cinturone slacciato, il fucile sulla pancia, in un’atmosfera di torpore. Si direbbe l’indomani di una battaglia. Migliaia di volantini coprono il selciato. Alle due, alla ripresa dell’udienza, viene finalmente nominata la giuria definitiva, uomini lividi, fronte inquieta, viso timoroso.
Quindi si procede con l’identificazione.
– Jacob, Alexandre, Marius – chiama Fischer, il cancelliere. – Presente – risponde quello.
È tranquillamente seduto, legato per le manette al suo gendarme-angelo custode. La bombetta ben calcata in testa. Un sorriso beato. Il presidente, che non aveva ancora girato lo sguardo nella sua direzione, sussulta.
– Alzatevi! – esclama.
– Ma voi siete seduto! – replica Jacob.
– E poi, toglietevi il cappello quando parlate con me! – La vostra testa è coperta!
– Siete qui per essere giudicato. Dovete conformarvi agli usi e osservare un certo comportamento!
– Questa è una mascherata! Una parodia di giustizia! Avrò riguardi nei vostri confronti solo quando voi ne avrete verso i lavoratori! (Così come gli episodi della vita straordinaria di Alexandre Marius Jacob sono stati scrupolosamente ricostruiti sulla base di testimonianze e documenti, anche le battute del processo sono autentiche).
Il gendarme che lo scorta gli strappa via il cappello. Il resto del discorso si perde nella confusione generale.
– Silenzio! – grida Wehekind – Silenzio! o faccio sgombrare l’aula.
Poi:
– Avete giurati da ricusare? – continua.
– Li ricuso tutti – risponde Jacob – poiché sono nostri nemici.
Tutti riprendono respiro. L’elencazione dei nomi, cognomi, età, professione, si svolge senza altri incidenti. Nessun articolo del codice può tuttavia impedire ai banditi di ostentare un’aria beffarda. In seguito il cancelliere comincia a salmodiare le centosessantuno pagine dell’atto di accusa. Il pubblico tenta di capire. Molti imputati escono con esclamazioni di sbalordimento a sentire certe prodezze della loro guida intellettuale, che essi ignoravano. Alle sei, dopo varie formalità, finisce la prima giornata. Quando Jacob esce, la folla è ritornata, trattenuta a stento dai cordoni dei soldati.
Dappertutto sgorgano canti rivoluzionari. Due anarchici che sono riusciti a penetrare nella sala malgrado il severo controllo predisposto dal commissario Jénot, si precipitano verso la tipografia di “Germinal”, nella botteguccia del calzolaio Jules Lemaire. Nel retrobottega, nel cortile e nel garage è stato installato un vecchio torchio a mano rabberciato e un’officina di composizione. Sui vetri bisunti della porta d’entrata, due scritte: “Germinal – Redazione – Amministrazione – Pubblicità” – “Risuolature (tacchi compresi): Uomini (inchiodati) 3 F; (cuciti) 4 F; Donne (inchiodati) 2,50 F; (cuciti) 3,25 F; pezze invisibili garantite: 0,30 F”. Due locandine pubblicitarie: “Basta con gli aborti! Metodi scientifici e pratici per limitare la fecondità della donna, scritto dal dottor Knowlton. Traduzione dall’inglese di Lennoz. Opuscolo incriminato e assolto dalla Corte d’Assise del Brabante. Prezzo 0,50 F. Rivolgersi qui”. E l’altra: “Levatrice. Guarisce tutte le malattie delle donne. Discrezione assoluta, riceve pensionanti in qualsiasi mese di gravidanza. Indirizzarsi alla signorina Berthe Leguillier, 388 route d’Abbeville, Montières. Riceve tutti i giorni dalle ore 1 alle ore 3”. Giacché gli anarchici, in anticipo di una sessantina d’anni sulla loro epoca, militano anche in favore della limitazione delle nascite, cosa, ovviamente, che procura parecchie noie.
Alle sette, la redazione, rinforzata da numerosi elementi venuti da Parigi, è riunita al gran completo fra suole, zoccoli, lesine, sgorbie, forme e chiodi. Febbrilmente, si mettono a preparare il numero speciale che hanno deciso di fare uscire il più presto possibile. Pacaud si incarica dell’editoriale:
«Raramente un processo ha fatto tanto clamore (...). La magistratura, l’esercito, la polizia sono sgomenti. Una gran fifa che si traduce in un dispiegamento di forze tanto inutile quanto grottesco si è impadronita dei difensori dell’ordine (...). Il palazzo di giustizia è trasformato in caserma (...). Ma la delusione dei giornali borghesi, araldi della mediocrità, è grande! Gran Dio! La sacrosanta proprietà attaccata. Visioni di saccheggi e di sommosse devono passare davanti agli occhi dei tremebondi borghesi: il fatto è che sono finite le manifestazioni di odio di coloro che non possiedono niente contro un riappropriatore come Jacob. Sono scomparsi i pregiudizi che sostenevano la vecchia società autoritaria. È la prova che la nostra propaganda funziona!».
Poi se la prende con la giuria: «I certificati dei medici sono compiacenti, a volte». Enumera per professioni, condendola di commenti personali, la “lista della sessione” dalla quale i giurati di Jacob sono stati sorteggiati.
Fra essi, nota, non un operaio, non un contadino, non un proletario. Perché? Perché se la giustizia fosse giusta e la giuria di Jacob fosse composta da dodici operai, egli verrebbe certamente assolto!
«Qual è dunque la differenza tra chi giudica e chi è giudicato? È che i ladri non sono quelli che vengono creduti tali!».
Ad un angolo del tavolo, Maurice Lucas butta giù un altro pezzo sullo stesso tono:
«Si erano ingegnati sin dall’inizio dell’istruttoria nell’ignobile tentativo di inoculare nella folla un dissimulato spirito di vendetta per spingerla al linciaggio di Jacob. La società intera aveva interesse, per la solidità delle sue basi, che uno spirito vendicatore rinfocolasse la stupidità delle folle. Per fare questo era necessario che il popolo scagliasse la sua folgore contro i demolitori della proprietà.
«Sforzo vano! Il popolo, oggi, malgrado gli ostacoli immensi che deve superare, è in stretto collegamento con questi eroi rivoluzionari! Errore e stupefazione! Gli imputati sono uomini di buona lega! Jacob, Pélissard, Augain, Chalus, Sautarel, Baudy, Charles sono menti istruite, cuori nobili, devoti alla causa dell’umanità.
«Come sarebbe possibile che le simpatie del popolo non arrivassero fino a loro, che pagano con la vita, con la libertà, l’enorme salasso che hanno prodotto nei massacratori del popolo?».
Jules Lemaire invece è nervoso; le manifestazioni di simpatia della folla non gli sono bastate: erano stati convocati per oggi tutti i militanti della regione; si attendeva una sommossa: ci si è accontentati di cantare l’Internazionale. Egli spera, si augura ancora un sussulto dell’opinione, un gesto, una reazione, qualcosa. Ma Souvarine, un emigrato russo sfuggito per miracolo all’Okhrana, non è soddisfatto della prosa di Lemaire. Non è con le manifestazioni che si fa la rivoluzione, ma con le bombe.
Souvarine ha preparato un testo che, secondo lui, dovrebbe soppiantare tutti gli altri.
«In questo momento, in cui dispacci ci informano che in Russia orde di mugik, bande di affamati composte da parecchie migliaia di contadini in piena rivolta percorrono il paese, saccheggiando castelli e case di proprietari terrieri, bruciando e devastando senza che alcuna forza possa fermarle, in questo stesso momento va in scena al palazzo d’Ingiustizia di Amiens una sinistra commedia tra ladri e derubati; commedia che ha avuto due anni di messa a punto.
«Bisogna credere che la paura è l’inizio della saggezza, visto che questa volta la costituzione della giuria non è stata senza problemi. Tuttavia, è di norma una gioia per dodici possidenti giudicare ventitré espropriatori. Che sia vero, come si dice, che Jacob ha ancora amici in libertà, che seguono con estrema attenzione i fatti e i gesti dei giurati e che si apprestano alla vendetta?
«Sarebbe senza dubbio spiacevole dovere impiegare mezzi di intimidazione come la bomba o il revolver, ma se questa paura salutare avesse come risultato di farli riflettere, si arrenderebbero almeno all’evidenza: Jacob in quanto anarchico non può essere capo. Dunque, la tesi di un’associazione a delinquere diretta da lui si sfalda. Il romanzo costruito dalla stampa venduta crolla.
«Per troppo tempo avete ingannato il popolo; per troppo tempo siete riusciti a fargli credere che il derubato era colui che rubava! La verità si apre agli occhi di tutti! Il proletario si sveglia, legge, ascolta, riflette, vede chiaro. Sa che la proprietà è il furto.
«E avete il coraggio di fare la parte dei giusti! Vili ipocriti, sapete bene che non vi è niente di giusto nella vostra marcia società. I vostri scienziati, i vostri professori, i vostri giornalisti devono confessare ad ogni occasione che l’ingiustizia e tutto quanto vi può essere di più spaventoso in campo morale e materiale, sono le regole della vostra bella società di marci e di invertiti.
«La rivolta popolare espropria i vostri colleghi in Russia. Una nuova aurora si leva infine, un’aurora in cui non vi saranno più né giudici né derubati né ladri!».
Dopo aver preso conoscenza uno dopo l’altro del testo di Souvarine, i compagni tacciono. Hanno forse paura? Sì, paura che quello voglia fare fuori uno di quei borghesi rapaci? Ma lui è pronto! Ed anche stasera stessa, se necessario. Per l’esempio. Per terrorizzare gli altri. La violenza è ancora atroce quando è al servizio del padrone. È sublime quando è al servizio dell’uomo libero! Forza! Cosa li trattiene?
Ma un uomo entra nel negozio, un tipo piccolo, barbuto, con naso arcuato, dallo sguardo d’aquila, vestito in modo quasi borghese, in confronto agli altri. Si scrolla levandosi l’impermeabile zuppo di pioggia. Il suo nome è Charles Malato. Uno dei più vecchi amici di Jacob. L’ha conosciuto a Marsiglia quando aveva diciassette anni. Lui ne ha quaranta. È ancora un uomo autorevole, si sa che non esita ad agire in prima persona, se occorre. Un anarchico insurrezionalista. È rispettato da tutti. È andato a cercare informazioni. Ha dappertutto contatti, noti solo a lui. Gli si stringono intorno.
– Allora?
– Allora è spacciato. Il secondino che era d’accordo con noi è stato trasferito ad un altro dipartimento. Jacob è stato nuovamente cambiato di cella. Bisogna ricominciare daccapo.
Un silenzio accorato accoglie la notizia.
Tuttavia, Malato è riuscito ad avere un messaggio da Jacob. Li ringrazia per tutto quello che fanno. Non pensa, però, che attualmente un’evasione sia possibile, né alla Bicêtre né al Palazzo: troppi soldati. Anche tentare un colpo di mano quando lo tirano fuori dal furgone sarebbe una follia. Bisogna cercare un’occasione favorevole e poi tentare di improvvisare qualcosa... Non si sa mai... In ogni caso, a qualsiasi inutile spargimento di sangue, Jacob preferisce essere ghigliottinato: spera, in tal modo, che la sua testa, cadendo, inzaccheri il nemico.
Tutti abbassano il capo; avrebbero lo stesso coraggio in circostanze simili? Non restano loro molte possibilità di farlo uscire di là.
– Forza! – riprende Malato – In un certo senso egli ha il ruolo migliore. Ha agito da uomo libero. Se dovesse accadere, morirà da uomo libero. E poi, via! In questo stesso momento in tutta la Francia, a Parigi, a Marsiglia, a Lione, a Perpignan, tutti volgono lo sguardo verso Amiens. Bisogna essere all’altezza. Non bisogna deluderli.
– Tenete — conclude dopo una pausa. – Vi ho portato questo. È Libertad che ve lo manda. L’aveva già preparato prima. Questo rimette le cose al loro posto... Dal nostro punto di vista, naturalmente. Si pubblicherà simultaneamente su “Germinal” e su “L’Anarchie”.
Libertad, il temibile storpio, l’animatore delle “Causerie du XVIIIe” , che ha appena fondato “L’Anarchie”, un settimanale libertario di tendenza individualista, è conosciuto da tutti. Domani sarà, suo malgrado, l’ispiratore della “Banda Bonnot”.
L’articolo passa di mano in mano. Lo leggono. Lo commentano. La vita ritorna poco a poco e anche la speranza, tenace.
«In questo momento, ad Amiens – scrive Libertad – due bande di individui si fronteggiano. L’una sembrerebbe avere la vittoria: non si batte più; essa giudica. Ha persino nominato delegati, che si fregiano di uniformi e ostentano nomi speciali: gendarmi, giudici, soldati, procuratori, giurati. Ma nessuno cade nell’inganno. Si riconoscono in loro gli alleati abituali contro la lotta sociale: ladri, falsari, assassini, secondo le circostanze.
«Tenuti saldamente, i membri della seconda banda sono attaccati, ma non vinti. E quando questi scuotono la testa, delegati e spettatori vorrebbero scappare.
«Quelli della prima banda chiamano la loro operazione rendere giustizia e dicono di perseguire il crimine. Non sono i rimorsi, in ogni caso, che portano i loro nemici davanti ad essi, ma le manette...
«Dalle dieci dita dei primi, siano essi giudici, vigili urbani, commercianti, controllori o amministratori, non è uscita alcuna opera utile. Essi non hanno fatto il pane che mangiamo né i castelli che abitano né i vestiti che indossano né le auto che li trasportano. Ciò di cui essi vivono lo hanno dunque rubato.
«In un’altra società, Jacob e i suoi amici potrebbero essere utilmente impiegati. La loro abilità, le loro cognizioni, la loro forza, il loro coraggio non ne fanno minimamente dubitare. Essi si sono messi a derubare la società per vivere, con la speranza, forse erronea, che questo avrebbe portato lo scompiglio all’interno del suo organismo. È il loro solo errore, se uno ne hanno commesso».
L’indomani, il servizio d’ordine è ancora imponente. Prima dell’inizio dell’udienza, Rose, trascinandosi dietro il suo sbirro, riesce a gettarsi nelle braccia del suo amante, che la stringe forte a sé. In un battibaleno, viene deciso di separarlo dalle donne e viene relegato nella quinta fila degli imputati invece che nella seconda dove si trovava ieri. Nondimeno egli continua a mandare baci a sua madre e a Rose.
Il cancelliere finisce di cantilenare l’atto d’accusa, poi comincia subito l’interrogatorio.
– Siete di Marsiglia?– domanda il presidente Wehekind a Jacob.
– E me ne vanto! – risponde lui con un sorriso, calcando sul suo accento.
– Avete compiuto gli studi elementari.
– Gratuiti ed obbligatori. Si è fatto credere al popolo che era per il suo bene e che è per il progresso sociale che lo si obbligava a istruirsi. Quale menzogna! Era per farne una scimmia ammaestrata, uno schiavo più perfezionato nelle mani dei padroni.
– Non vi ho chiesto il vostro punto di vista.
– Voi raccontate la mia vita davanti a tutti. Io ho da dire la mia.
– Poi siete stato marinaio. I certificati dei vostri ufficiali sono generalmente buoni.
– Ho visto il mondo: non era bello. Dappertutto, un pugno di malfattori della vostra risma sfrutta milioni di disgraziati.
Grida scandalizzate partono dall’uditorio. Il presidente agita il suo martello. Justal, l’avvocato di Jacob, si china su di lui per cercare di moderarlo; non è comportandosi così che il suo cliente salverà la testa.
II. L’agitatore
La famiglia di suo padre, venuta dall’Alsazia, era emigrata al Sud verso il 1850, prima nel Vaucluse, poi a Marsiglia. Joseph Jacob aveva cominciato come cuoco nelle Messaggerie marittime. Quando aveva iniziato a frequentare Marie Berthou, una ragazza della Crau, nel Var, aveva dovuto giurare di non ritornare mai più su una nave: non volevano avere un marinaio per genero. Per provare la sua buona volontà, si era trovato un posto di garzone in un panificio di rue Fontaine-Rouvière, al porto. Così aveva potuto sposare Marie. Ma la nostalgia dei mari del Sud aveva cominciato ad attanagliarlo nella panetteria, tanto che aveva cominciato ad annegarla nell’alcool. Nei bar, il pernod costava tre soldi e poiché non si beve mai da soli, ci si ritrova minimo in quattro o cinque compari e questo fa quattro o cinque giri.
Riprendere il mare sarebbe stato senza dubbio più logico. Ma Joseph era un velleitario. Mille ragioni, buone o cattive, lo trattenevano a terra. Non abbandonare Marie. Non tradiva il giuramento fatto davanti ad una bottiglia di vino rosé. E poi, non lasciare il marmocchio sulle spalle della madre.
In realtà, Marie aveva denaro. Quello che avrebbe ereditato dai suoi genitori. Non che quelli fossero molto ricchi. L’affitto del loro terreno alla Crau, un pezzo di campo verso Plan de Cuques, un cavallo per arare la terra e per portare le primizie al mercato: era tutto quello che possedevano. Ma avevano sempre lavorato sodo e vissuto al risparmio. Dovevano avere un bel gruzzolo. Da parte sua, egli non si aspettava un soldo.
Gli era più comodo minacciare una partenza senza ritorno (e lo faceva spesso) piuttosto che correrne il rischio. Graziosa com’era, a lei non sarebbe stato difficile trovarsi qualcun altro. Dopo una dozzina di false partenze, Joseph si lasciò prendere dall’acredine: le frasi sul sacrificio che aveva fatto per lei e le partite a carte all’osteria all’angolo.
Lei lo disprezzava. Soffocava. Sposata a diciotto anni, non aveva mai conosciuto altro orizzonte che il convento, i legumi della domenica e, dopo quel 29 settembre 1879 in cui Alexandre Marius era nato, le fasce del piccolo da cambiare e l’uncinetto per guadagnare qualche lira. Non gli avrebbe mai perdonato gli eroici racconti di navigatori senza paura e senza macchia grazie ai quali l’aveva sedotta. Divorziare: le leggi del tempo lo proibivano, in pratica. Sottomettersi, fare la passiva, non reagire più: impossibile. Lui l’avrebbe sperato. Si era ingannata nella scelta. In capo a tre anni non aveva che un unico desiderio: che lui se ne andasse, che sparisse, che la lasciasse tranquilla. Beninteso, più glielo diceva, più lui scopriva dei pretesti per impigrirsi.
Un giorno, lei saltò sull’omnibus per Plan de Cuques. Pretese, tempestò, fece le fusa: ottenne dai suoi un po’ della parte di luigi sui quali si supponeva dormissero per comprarle un negozio. Aprì infatti una panetteria, a cento metri da casa, nel centro del quartiere del Vecchio Porto, in una piazzetta in cima ad una scala semidiroccata, perduta in un dedalo di viuzze. Per contratto, il negozio venne intestato a lei. Joseph divenne il suo dipendente: lui fornaio, lei alla cassa. Egli non le perdonò mai quell’ultima umiliazione. Mentre lui inventava ricordi, lei agiva. Era la padrona. Per recuperare la sua autorità frustrata, egli prese presto l’abitudine di picchiarla. La prima volta le chiese perdono piangendo come un vitello. Era pieno di buoni propositi. Le settimane passarono. I suoi amici sghignazzavano della sua stupefacente sobrietà. E poi, in fondo, le donne sono come i tappeti: bisogna batterle.
Alexandre Marius cresceva come poteva tra questa madre bellicosa ma insoddisfatta e quel padre spodestato della sua virilità. Non era veramente un infelice. Non era un bambino martire. Il nome di antichi generali che Joseph gli aveva affibbiato in ricordo dell’Altro, il vero Napoleone, quello che avrebbe portato la Rivoluzione in tutta l’Europa, se l’Austriaco e il Britannico non si fossero immischiati, lo votavano certamente ai più alti destini. A diverso titolo ognuno contava su di lui.
Nella prospettiva di un grandioso avvenire, lo si iscrisse presso i Frati dell’Istruzione cristiana. Un pallino di Joseph che quadrava apparentemente poco con l’anticlericalismo che egli dichiarava e declamava tra il pastis e l’assenzio. Ma si può avere la trippa socialista e preoccuparsi dell’educazione dei propri figli: la scuola laica del quartiere era frequentata solo da mascalzoni. Marie, che a ricordo dei suoi anni trascorsi presso le monache, aveva conservato il dente avvelenato contro i portasottana, cedette sdegnosamente a questa nuova stranezza del suo signore e padrone.
D’altronde, Alexandre non stava mai in strada. Non era un “monellaccio”, come lei diceva. Preferiva fabbricarsi bambole di chiffon con le sue mani diabolicamente agili: “Tu farai il parrucchiere, un mestiere da donna!” gli disse una sera Joseph ghignando.
Quando gli amici del padre venivano a bere un bicchiere, egli amava soprattutto ascoltare fino a tardi i racconti del passaggio dell’equatore, quando tutto l’equipaggio si traveste da divinità marine, oppure degli scali fastosi in isole dai nomi esotici (Giava, Borneo, Celebes, le Figi, Sumbawa) dove soffiavano invariabilmente tifoni apocalittici, mentre meticcie lussuriose improvvisavano, solo per loro, lascive danze del ventre. Marie alzava le spalle a questi racconti che conosceva a memoria. Alexandre invece conservava avidamente quelle pseudo-epopee come tanti tesori nella memoria dove andavano a raggiungere le biografie di Ivanhoe, Ulisse, Jean Bart e del governatore di Suffren.
Sin dal giorno in cui aveva visto suo padre colpire la madre e i suoi occhi rossi di bestia inferocita, Alexandre lo odiava. Il che non impediva a Marie di affermare che suo marito era un brav’uomo. La sua collera durava poco. Una volta finita la crisi, egli si faceva in quattro per farsi perdonare.
Lei si sforzava invano di mostrarlo ad Alexandre sotto un velo incantatore. Alexandre ascoltava senza pronunciare parola. Aveva uno sguardo serio, a otto anni, come i bambini che ne hanno già viste troppe. Si sedeva sulle sue ginocchia. Le circondava il collo. L’abbracciava. Le raccontava come avrebbe costruito un impero in Cina, di cui lei sarebbe stata la regina. In Cina, perché spesso venivano missionari a tenere conferenze sui “selvaggi” che avevano evangelizzato. Egli non capiva affatto cosa di buono avessero potuto portare i santi sacramenti a pagani adoratori di Lao-Tse, ma si mostrava inesauribile in materia di giunche affondate, di Grande Muraglia assediata da orde manciù e di imperatori in portantina. Si era imbastito un mondo eroico, dall’altra sponda dei mari, ove l’assoluta bellezza, la radiosa perfezione dei giorni dorati si trovavano a portata di mano, contrariamente a quanto succedeva a Marsiglia. E dove, soprattutto, suo padre non era suo padre, ma un principe della Montagna che lo riconosceva piangendo.
– Mio figlio farà il prete! – esclamò un giorno Joseph con la sua abituale delicatezza quando sorprese Alexandre fare questo genere di discorsi a sua madre.
Prete, non si immaginava proprio. Missionario, piuttosto: per i viaggi. Del resto, la sua vocazione si arrestò in modo brusco al momento della prima comunione. Quel mattino, per provocazione, aspettandosi che una mano minacciosa si abbattesse sulla sua nuca, accompagnata da un fragore di tuono, masticò l’ostia. La delusione fu immensa: il buon Dio non intervenne. Dunque, non esisteva. I frati avevano mentito. Il problema fu risolto una volta per tutte: egli non aveva l’anima metafisica. Il suo spirito era portato soprattutto all’azione (cosa che non esclude la riflessione) più che alla contemplazione.
A undici anni e mezzo, fu presentato a un esame di licenza media, che superò brillantemente. I suoi professori contavano vagamente che proseguisse fino al diploma, anzi fino alla laurea. Ne parlarono con Marie. Ahimè! Joseph arricciava il naso. Una volta su due le infornate venivano bruciate. I clienti si facevano sempre più rari. Il denaro ancora di più. Questi studi erano senza dubbio un’ulteriore manovra dei frati per reclutare un cliente supplementare e ingrassare alla spalle dei poveretti. Lei che non mancava mai di imitare il grido del corvo tutte le volte che vedeva passare un prete per strada, era pronta ad attribuire loro i più machiavellici pensieri. Avevano un bel parlare della gratuità del piccolo seminario, lei diffidava. Quanto all’obbligo di andare a scuola sino all’età di tredici anni, la legge, appena votata nel 1883, restava per il momento lettera morta.
Alexandre, consultato da Marie, arrossì. L’insulto lanciato dal padre gli bruciava ancora. Il piccolo seminario significava diventare prete: qualcosa come un bue. Di fronte alla sua aria sgomenta, lei non insistette. Il virus delle scuole superiori non aveva ancora raggiunto quegli strati della società, a quel tempo. Quando si sa leggere, scrivere e far di conto, c’è sempre modo di sbrogliarsela, se si è seri. La pergamena è buona per i marmocchi dei ricchi. La decisione discese da un fatto preciso: il figlio di una vicina, che era diplomato, si trovava disoccupato.
Alexandre fu sollevato come qualsiasi ragazzo al suo posto nell’apprendere la notizia. Sebbene alunno eccellente, si annoiava troppo in classe. La messa ogni mattina, i corsi di catechismo, le vite dei santi, lo riempivano di ripugnanza. Per tre mesi rimase a casa. Scoprì Jules Verne e le darsene. Le darsene e Jules Verne instancabilmente: Il capitano di quindici anni, I figli del capitano Grant, il capitano Nemo, li incrociava a colpo sicuro dabbasso, nella Canebière, sul marciapiede del Canale, o verso la darsena della Joliette, pronti ad imbarcarsi per qualche favolosa spedizione. Quel che Pierre Loti definisce “il richiamo del mare”.
Fu così che quando un giorno vide un ufficiale ingombro di valigie scendere la scaletta di una nave da carico, si precipitò ad aiutarlo. L’uomo, credendo di avere a che fare con qualche poveraccio, volle dargli una piccola ricompensa alla fine del tragitto. Alexandre rifiutò con boria. Divertito, l’altro gli pose delle domande. Farfugliando, lui confessò la sua ambizione.
– Ah! Vuoi fare il marinaio? – disse l’ufficiale dandogli dei buffetti sulle guance. – Bene, passa a trovarmi da Freycinet uno di questi giorni. Chiedi del signor Martinaud, il capitano d’armamento.
Fu preso da capogiro. Una delle più grandi gioie della sua esistenza.
Di corsa, galoppò a raccontare l’incontro provvidenziale. Sua madre cominciò a stringerlo a sé singhiozzando, simile ad una cagna cui vogliono rapire il piccolo. Di contro, suo padre si felicitò con lui vacillando e lo costrinse a bere un bicchiere di vino per festeggiare. Freycinet era una delle più potenti compagnie insieme alla Transatlantique. Questo Martinaud era un tipo molto a posto. Aveva sentito parlare di lui. Il giro del mondo è la scuola della vita. Alexandre avrebbe visto la Stella del Sud e sarebbe uscito finalmente da sotto le gonne di sua madre. Prima o poi, in ogni caso, sarebbe partito; era destino. Avrebbe visto i paesaggi che lei s’era sognata. Non sarebbe ammuffito come lei nell’attesa della domenica. Forse sarebbe stato un bene.
Tre settimane dopo, esattamente il 22 febbraio 1890, a undici anni e cinque mesi, Alexandre s’imbarcava come mozzo sul Thibet avendo per tutto viatico, nascosti in fondo al suo sacco nuovo, i Jules Verne che l’avevano spinto a quel passo. Avrebbe sicuramente domato il timone nelle tempeste e, per l’audacia delle sue decisioni, avrebbe salvato equipaggi in pericolo. Sarebbe sicuramente cambiato.
Sveglia alle quattro. Lavare il ponte a secchiate, lucidarlo a colpi di spazzolone. Spazzare la tuga, tirare le amache, lucidare gli ottoni, cucire, servire gli ufficiali, subire le orribili ingiurie del nostromo, del capo. Jules Verne non aveva detto tutto questo.
Aveva omesso lo strofinaccio per i pavimenti, l’ago e il canovaccio, i crampi, il vomito, la disperazione, il sudiciume del quartiere dell’equipaggio, l’andirivieni senza scopo lungo le scalette, mentre i marinai si ubriacano con donne ignobili in sordide taverne.
Più si addentrava nel mestiere, più l’esotismo scemava negli attracchi lungo le coste africane. Orano, quindi Dakar, Conakry, Monrovia, Tabou, Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou, case basse, cieli pesanti, soffocamento. Negri scrofolosi, piedi torti, ilari, che fanno smorfie, divorati dalle mosche; ufficiali che si picchiano gli stivali con i frustini; borghesi arroganti, adiposi, fannulloni. Né tigri né leoni né ippopotami: nessuna possibilità di mostrare eroismo. Le nuvole d’Africa erano le stesse di quelle invernali a Marsiglia. Puzza, sudore, sudiciume: forse Alexandre non aveva senso poetico. Ma non era un passeggero di prima classe su un piroscafo di linea.
Dopo tre traversate consecutive sul Thibet, suo padre gli comparve sotto il suo vero aspetto: uno sbruffone da osteria, un fanfarone da caffè. Nulla di quanto aveva detto era vero.
A dodici anni cominciò a sentire responsabilità di capofamiglia: capì che sua madre l’aveva in qualche modo incaricato di vivere anche per lei. Di fare quel che lei non aveva mai osato perché donna, né potuto, per mancanza d’occasioni. Ad ogni ritorno a casa, lei condivideva i suoi stupori, le sue gioie, i suoi odi, le sue sofferenze, i suoi giudizi. Lei non pretendeva che una promessa: che lui seguisse lo slancio del suo cuore, non i calcoli del suo interesse. Un rimasuglio stantio di cattolicesimo, senza dubbio.
Quando lui seppe che a forza di pane andato a male per le ubriacature del padre, la panetteria era ipotecata fino al più piccolo cassetto, decise in segreto di prendersi cura di Marie. D’ora in avanti, avrebbe risparmiato soldo su soldo dalla sua paga per dargliene il più possibile.
Cosa che fece sin dal suo passaggio alle Messaggerie Marittime dove le sue buone referenze gli permisero di imbarcarsi sulla Ville-de-la-Ciotat come apprendista timoniere a 45 franchi al mese. Una fortuna, per lui. Per Marie, tutte le pepite della California: giacché, oltre alle piccole somme che le servivano a chiudere il suo bilancio largamente deficitario, lei ci vedeva una prova di amore filiale senza prezzo.
L’Egitto, il canale di Suez e le sue carovane di cammelli, Gibuti, il Mar Rosso, le Seychelles, Sydney e i suoi scogli di granito rosa, dove vide i suoi primi forzati, evasi che egli dovette riportare a Numea con i ferri ai piedi, in fondo alla stiva. Alexandre volle vederli da vicino. Passò loro il suo tabacco. Gli parlò. Non erano delle belve: piuttosto dei digraziati. O almeno a lui sembrarono tali. Criminali, certo. Ma quelli che, dai loro comodi uffici riducevano degli esseri umani a una abiezione così turpe, non erano forse altrettanto criminali? Al ritorno, Marie fu dello stesso avviso.
Fu là, all’isola di Nou che sentì parlare per caso di Louise Michel. Una vecchiaccia orribilmente sudicia, completamente pazza, una pétroleuse della Comune, che era stata amnistiata nel 1880 perché Victor Hugo aveva scritto poesie su di lei. Louise aveva avuto l’idea strampalata, durante il soggiorno al bagno penale, di fondare scuole per i Canachi nel folto della boscaglia. Alcuni di quei selvaggi avevano persino ottenuto il diploma. Una cosa abominevole: perché quelli, imbevuti di un sapere nuovo e derisoriamente inutile, avrebbero sicuramente finito per contestare il predominio dei bianchi. Una strana donna. Peccato fosse anarchica. Marie ebbe diritto ad un resoconto anche su questo. A proposito di anarchia, lei ci ricamò sopra una leggenda dorata, a base di generosità, di libertà e di fraternità, che Joseph intrise di divagazioni pastose sul fatto che bisognava diffidare della gente che non beve altro che acqua.
Alexandre lasciò la Ville-de-la-Ciotat per l’Alix. Questa, al largo della Siria, fu speronata da un cargo e colò a picco. Tutto l’equipaggio venne salvato, compreso l’apprendista che non ebbe neppure il tempo di avere paura. Quel che lo colpì di più in quell’occasione, fu un premio di 250 franchi. Destinati a Marie, naturalmente. Poi ci fu la Suzanne-et-Marie. Nemmeno lì per molto. Jules Verne aveva infatti dimenticato un altro capitolo essenziale della vita di bordo. Il pudico scrittore non aveva mai fatto cenno nei particolari ai costumi dei marinai. Ebbene, alcuni tra loro avevano un’incresciosa tendenza a confondere gli apprendisti con oggetti per i loro sfoghi sessuali. Passi anche sfacchinare giorno e notte, farsi trattare da pivello o da schizzinoso perché si infastidiva quando era costretto a gozzovigliare con loro perché questo ricordava fin troppo le sbronze paterne, ma subire gli assalti di un marinaio di coperta avvinazzato che sente il peso della forzata continenza, non c’era in tutto questo proprio nulla di romantico!
Il primo serio incidente a questo proposito avvenne alla fonda di Saint-Louis del Rodano. Alexandre si ribellò. L’invertito gli assestò un ceffone. Alexandre gli si scagliò contro e conobbe la pubblica umiliazione della sconfitta. Deciso a vendicarsi, s’arrampicò sul tetto di una capanna e aspettò il suo tiranno, con un sasso in mano. Per fortuna lo mancò. Il suo onore era salvo. Ma l’episodio gli costò il posto. Fece fatica a trattenere Marie che voleva vendicarlo a sua volta.
D’altronde, costei aveva moltissimo da fare. A forza di suppliche e di imprecazioni aveva ottenuto un’altra somma di denaro dai suoi genitori, l’ultima. Alcune settimane più tardi, il vecchio Berthou moriva. Si venne a conoscere l’effettivo ammontare della sua fortuna quando la nonna, non in grado di lavorare i campi da sola, dovette darli in affitto e andare in giro con un carretto a fare l’ambulante. Fu un colpo terribile per Marie: i debiti erano completamente saldati, venduto il panificio e acquistata una drogheria in rue Dragon; ma sua madre andava in giro come una mendicante. “I giovani con i giovani, i vecchi con i vecchi” diceva con ostinazione mamma Berthou che non amava affatto suo genero, quando sua figlia la supplicava di andare a stabilirsi con loro.
Alexandre ebbe diritto ad un resoconto particolareggiato e commentato. Ne dedusse che suo padre, non avendo più nulla da impastare, sarebbe stato meno temibile per i clienti con i fagioli verdi e l’insalata. Quanto a lui, quel posto non gli andava proprio: la coesistenza con papà Jacob sarebbe stata certamente difficile.
Ripartì. Stavolta sulla Armand-Béhic. Durante una nuova traversata per l’Australia, i tentativi di sodomizzazione ripresero. Lamentarsi presso il capitano? Questo genere di cose era talmente normale all’epoca che la maggior parte degli ufficiali preferiva chiudere gli occhi. Era considerato un piccolo favore che era più che naturale fare ai più vecchi. Con la massima sincerità, gli uomini non comprendevano perché mai Alexandre rifiutasse di partecipare ai loro giochi. Lo consideravano uno schifiltoso. La vita di bordo divenne un inferno. L’obbligavano ai servizi più massacranti. Con un colpo di testa, a Sydney, con due soldi in tasca, disertò. Aveva tredici anni. Là morirono gli ultimi resti di romanticismo.
Visse di espedienti, acquistò un tubo per innaffiare, vendette fruste (la prima delle quali fu fatta sparire ad un vetturino), lustrò scarpe, custodì foche, fino al giorno in cui incontrò un compatriota che gli propose un lavoro su una baleniera. E vada per la pesca alle balene! Con entusiasmo mise piede su quel nuovo battello. I componenti l’equipaggio avevano facce da pirati. Il capitano era un negro erculeo. Vide in tutti loro delle meravigliose facce da avventurieri.
Trascorse un mese: di balene neppure l’ombra. Invece, un giorno, un piccolo bastimento apparve all’orizzonte. Alexandre fu pregato di scendere nella stiva per cercare del materiale. Il quartiere di boccaporto fu tirato dietro di lui e bloccato. Gli giunse la voce del capitano che gli prometteva di liberarlo dopo un’ora o due. Strani rumori gli pervennero poi dal suo nascondiglio, dei grandi urli, poi come degli spari. E più niente.
Il boccaporto fu aperto. Egli risalì sul ponte.
I suoi compagni avevano fucili. Sulla nave di fronte, nessuno. O piuttosto dei corpi allungati in strane posizioni, come dormissero. Cadaveri. La baleniera era una nave pirata. Alexandre finalmente viveva l’Avventura con la A maiuscola che gli concedeva Jules Verne: il caso aveva fatto di lui un filibustiere.
Non avendo assistito al massacro, i morti non l’impressionarono, all’inizio. Tutto rimaneva astratto, confuso, esaltante. Non gli lasciarono del resto il tempo di meditare sui suoi stati d’animo: bisognava trasbordare il carico. Terminata anche quest’incombenza, sull’altro battello venne sistemato un barile di polvere da sparo. Un uomo accese la miccia, scappò via e ci fu l’esplosione. Un bellissimo fuoco d’artificio.
Quell’impresa gli valse una piccola fortuna: ottocento franchi che inviò immediatamente a Marie, con una lettera dai voli pindarici sul suo “nuovo lavoro” di cui tuttavia ritenne opportuno tacere alcuni aspetti.
All’uscita successiva, i corsari, ritenendolo ormai svezzato, lo lasciarono assistere all’operazione. L’avvicinarsi fiducioso della preda, le grandi segnalazioni, i richiami come se si avesse bisogno di aiuto, poi, all’improvviso, i fucili, l’espressione stupefatta delle vittime, la carneficina. Stavolta, Alexandre vomitò. I romanzi non descrivevano il sangue che sprizzava, gli spasimi dell’agonia, il rictus, gli urli, il terrore dei feriti finiti a bruciapelo. Intascò la sua parte di bottino, mille franchi, per sua madre e se la diede a gambe non appena la baleniera arrivò in porto. Aveva capito. Il delitto pagava. E pagava bene. Ma era spaventoso.
Otto giorni dopo, la baleniera, colta in flagrante, veniva fermata in mare da un guardacoste e tutto l’equipaggio impiccato all’istante. Se si fosse trovato a bordo, non sarebbe scampato al massacro: le leggi del mare non scherzavano con la pirateria. Per qualche tempo, le sue notti furono popolate d’incubi durante i quali enormi negri lo inseguivano per infilargli il cappio al collo. Quel sudore freddo gli servì da lezione: poteva ormai parlare della filibusta per conoscenza diretta ai suoi vecchi condiscepoli della scuola dei frati, ma non avrebbe ricominciato più.
Un posto libero come mozzo su un bastimento inglese, il Prince of Albert, lo riportò a Marsiglia via Liverpool. Marsiglia dove l’attendevano i gendarmi, per quella diserzione. Insomma, ignoravano le sue imprese australiane, ma lo sbattevano in guardina per avere rifiutato di lasciarsi sodomizzare. Alexandre era furioso. Sua madre lo calmò: sicuramente aveva ragione lui, ma se non si punivano i disertori, quante navi non sarebbero più potute ripartire da Tahiti? E quindi sarebbe andato sotto processo per la sua fuga. Non era il momento per una ribellione che avrebbe potuto facilmente passare per insubordinazione. Bisognava uscire da quella faccenda.
Ella mosse cielo e terra. Si fece rilasciare testimonianza dei vari comandanti che avevano avuto suo figlio ai loro ordini. Fece osservare la sua età: a tredici anni non si sa quel che si fa. Non potevano spezzare la sua carriera! Le risposte chiare e vivaci di Alexandre dinanzi al tribunale impressionarono favorevolmente i giudici. Gli fecero giurare sul suo onore di marinaio che la cosa non si sarebbe più ripetuta e passarono un colpo di spugna su tutta la faccenda.
Quella giustizia umana, così diversa dall’atmosfera che regnava a bordo dell’Armand-Béhic lo commosse. Le parole generose degli ufficiali lo commossero: uscendo dall’udienza piangeva. Aveva dignità pari a quegli uomini. Gli davano fiducia: egli l’avrebbe meritata. Anche lui, un giorno (lo giurò a se stesso) avrebbe indossato il berretto con i galloni.
Pieno di audacia, andò a trovare il capitano Martinaud. Lo mise a parte della sua disavventura così come del nuovo progetto che aveva in mente. L’ufficiale ascoltò, serio; verificò con lui “la possibilità per un marinaio senza formazione teorica di ottenere il brevetto di capitano di lungo corso”; sondò la sua sincerità, non gli nascose la fatica gigantesca, ingrata, deprimente che l’attendeva e per la quale non avrebbe beneficiato, non potendosela pagare, dell’emulazione che regnava nelle scuole propedeutiche. Alexandre aveva una risposta a tutto. Martinaud, vinto, gli prestò dei manuali di navigazione e di idrografia.
Nei quattro anni di navigazione che seguirono, dopo il suo quarto di guardia, a qualsiasi ora del giorno e della notte, mentre gli altri marinai, ad un metro da lui urlavano nel gioco delle tre carte, si prendeva la testa tra le mani, si tappava le orecchie, per digerire meglio quei libroni indigesti. Le correnti, i fondali, le maree, i segnali, la posa di boe lo ubriacavano come neppure Jules Verne. Alla fine di tutto ciò stava la salvezza: una vita da uomo libero, fiero ed onesto.
La maggior parte degli ufficiali lo aiutava con consigli. In verità, lo adoravano. Alcuni dei suoi compagni invece lo presero in antipatia: egli pretendeva di elevarsi al di sopra della loro condizione. Frequentava la “maestranza” di bordo: era dunque un firmaiolo. L’allinearsi delle lettere e delle righe li colpiva come una magia riservata al quadrato ufficiali ed a cui un semplice pivellino non poteva accedere senza commettere sacrilegio. Doveva controllare continuamente il suo linguaggio, in modo da non pronunciare parole che quelli non conoscevano. Inoltre, non scendeva quasi mai a terra. Non beveva; non fumava; non giocava; non si degradava con le puttane dei porti. Il suo apparente puritanesimo, che altro non era che disgusto per un decadimento osservato fin troppo da vicino in casa, dava loro fastidio come un rimprovero personale.
Nel lavoro non si tirava indietro; aiutava tutti quando poteva; prendeva sempre le difese dei compagni contro i capi, in caso di divergenza; scriveva per gli altri le lettere alle amichette o alle mogli; era leale, coraggioso e burlone secondo l’occasione, ma anche pronto ad uccidere se gli pestavano i piedi. Insomma, bisognava prenderlo com’era. Un ragazzo strano e sincero; tenero e violento; generoso e collerico; ottimo marinaio ma ingenuo come un bambino. Irreprensibile: era esasperante e disarmante.
Marie vedeva suo figlio cambiare ad ogni ritorno. Maturava. Prendeva l’aspetto di un uomo. Lei lo spingeva sulla strada che lui s’era scelto, triste solo perché non poteva aiutarlo di più; ma i debiti erano ricominciati, ineluttabilmente.
Lui, testardo, forgiava le armi che gli avrebbero permesso di evadere davvero (e non più nei sogni) dalla prigione del posto equipaggio: il braccio di leva grazie al quale avrebbe sollevato il mondo. Imparò ancora molto sugli uomini. Come su certe navi ad esempio, nel corso della traversata, ufficiali e marinai si mettevano in combutta per sostituire una parte del carico con dei pezzi di carbone di peso equivalente. Una volta scaricata la merce sulla banchina, i proprietari non avevano più diritto di reclamare: qualsiasi vagabondo poteva essere il responsabile del furto. Imbrogliare qualche commerciante già milionario aveva in sé qualcosa di divertente. Ma l’ipocrisia, la viltà, la furberia che stavano alla base del gesto erano per lui ripugnanti. I pirati della baleniera avevano almeno l’eleganza di rischiare la propria testa.
Scoprì anche l’esistenza di un vero e proprio traffico di bestiame umano. Ebrei, Greci, Armeni, imbarcati a Beirut, a Salonicco, a Batum, parcheggiati nell’interponte, ammucchiati, imbarcati, umiliati, colpevoli d’esser poveri, insultati, sfruttati e tuttavia felici d’esser là, prescelti da una famiglia, da un clan, da una tribù che s’era tassata per procurar loro il biglietto per il passaggio verso quell’Eldorado che era l’America. E poi la tratta dei negri, organizzata dal sultano di Zanzibar in persona a profitto dei potentati del Medio Oriente e che doveva durare a lungo, tollerata dagli occupanti inglesi che prelevavano una percentuale per ogni passaggio, messa in piedi da un barone ebreo di nome Hirsch che accumulò in tal modo vere fortune, praticata dalla Francia stessa, giacché la Guadiana, a bordo della quale lavorava Alexandre, batteva senza alcuna ombra di dubbio bandiera tricolore. E la Francia, lo sapevano tutti, non lasciava Zanzibar agli Inglesi se non in cambio dell’impunità in Madagascar.
Egli conobbe la vergogna, la disperazione, il risentimento. L’odio, una sera gelida a Londra dove il nostromo, per vendicarsi dell’irriducibile adolescente che osava avere un’opinione, che osava rifiutare di piegarsi ai costumi sessuali, lo spedì a raschiare l’artimone con una spugna e un secchio d’acqua gelata; e il nostromo dovette ringraziare solo il freddo che fece tremare la mano di Alexandre se non ricevette in pieno cranio la caviglia affilata che quello gli tirò da lassù.
Conobbe la donna a Sourabaya a 14 anni, nella persona di una battona creola che gli portò via i suoi risparmi. Ne conobbe altre, ad Amsterdam, a Caracas, a Tamatave, tutte fatte in serie, un incontro tre franchi, un passatempo, un rimedio contro la nostalgia, il viaggio al fondo della delusione. Lui cercava un cuore, quelle volevano soldi. Annusavano la Francia sul suo torace, con sogni di riscatto in rutti di rum; raccontavano la loro storia, sempre identica, pietosa e menzognera sogghignando di disperazione, tutte lacrime fuori, l’ombretto catramante le guance devastate dalla couperose. Le povere sgualdrine stupide e meccaniche gli davano ogni volta la tentazione di schiaffeggiare la moglie dell’armatore, piena di crinoline, intravista un giorno per caso dietro la stazione marittima sul suo calesse, lei e il suo sorriso angelico. Perché? Non lo capiva neppure lui.
Detestava i mercati di carne negoziati nelle case chiuse, la promiscuità dei coiti, lo sfacelo degli abbracci mercanteggiati, la fiacchezza delle risse a coltello, dopo le sbronze, quando gli occhi sono iniettati di sangue e si recita la propria decadenza congestionata. Suo padre gli aveva fornito il modello di tutti i fallimenti, di tutte le viltà. Egli li riconosceva giorno dopo giorno negli altri e li disprezzava. Che cosa avrebbe fatto lui, una volta divenuto capitano? Non lo sapeva. Un’unica certezza: sulla sua nave, non sarebbe stato così.
In quel pasticcio immenso che era la società, grassi trafficanti di legno d’ebano da un lato, marinai di coperta abbrutiti dalla fatica, rassegnati, scaltri, inaciditi, sconfitti, stremati, alcolizzati, dall’altro; per una moglie d’armatore, delle coorti di prostitute e se le donne non avevano la fortuna d’essere nate nelle belle case della Canebière, la loro dignità scrofolosa vegetava come quella di sua madre, nelle prigioni coniugali: il debole chiarore tenace che lo riportò sempre alla morale comune fu la speranza di far carriera.
Ma il braccio di leva (il corpo) tradisce. A Dakar si prese “le febbri”. Quali febbri? Non si sa. A forza di notti insonni, il primo virus capitato lo aggredì. Non riuscì più, nel ritorno, a compiere il suo turno di guardia. Quando la campana suonava l’ora, incespicava invano verso la timoneria, i polmoni squassati da una brutta tosse: bisognava allora riportarlo di peso alla sua amaca.
Venne sbarcato a Marsiglia su una barella, più morto che vivo. Uno specialista chiamato d’urgenza scosse la testa con aria pessimista. Se ne usciva, cosa niente affatto sicura, in ogni caso sarebbe rimasto minato. Neanche parlarne, di riprendere il mestiere di marinaio. Con due frasi distratte, l’uomo di scienza bruciò quattro anni di accanimento, di eroismo oscuro, trascorsi nella solitudine ottusa e brulicante del quartiere d’equipaggio. Chiese dieci franchi a Marie come parcella per la visita.
* * *
– Siete stato condannato una prima volta a sei mesi di carcere e cinquanta franchi di multa per fabbricazione di esplosivi il 13 ottobre 1897. Avevate diciassette anni.
– Un errore di gioventù, credetemi. Le mie bombe erano ridicole per distruggere un’associazione a delinquere di cui non immaginavo la potenza!
* * *
Gli occhi infossati sotto le sopracciglia cespugliose, smagrito, scheletrico, lottò a lungo contro i miasmi. Delirava. La malattia ringhiava dentro di lui, gorgogliava, come se avesse sofferto di una indigestione di prove, un miscuglio di esigenze confuse e contraddittorie alla ricerca di uno sbocco ignoto. La rabbia di vivere finì per prevalere. Uscì dal combattimento come purificato, ridotto all’essenziale; ma attanagliato da un vertiginoso senso di vuoto. Il mondo che s’era progettato era crollato. L’ostinazione dimostrata diveniva derisione.
Ma non aveva un temperamento tale da ricostruire la Storia: se suo padre non avesse bevuto, se avesse avuto denaro in casa da permettergli di proseguire gli studi, se avesse lavorato in modo meno sfiancante... con tutti questi se non si arriva a niente.
In seguito a chissà quale aberrazione, Joseph Jacob era stato nominato tutore di un lontano cugino rimasto orfano. Il giovane alloggiava provvisoriamente in una piccola stanza situata sullo stesso pianerottolo della camera di Alexandre. Venne a far visita al convalescente. Era un giovane con una gran barba, timido, che si dondolava da un piede all’altro mentre parlava. Dimostrò perentoriamente all’ex marinaio che:
1) L’uomo è un atomo nell’infinito. Obbedisce alle leggi che reggono il mondo. Una di esse fa di lui il prodotto dell’ambiente sociale nel quale vive.
2) Lui, Alexandre Jacob, era stato costretto a sovraccaricarsi di lavoro per sfuggire alla schiavitù e tentare di acquisire una posizione sociale decente giacché ad altri tutto era stato dato fin dalla loro nascita. Il vero responsabile della sua malattia non era un microbo, ma l’organizzazione detestabile della società. Giacché era l’ingiustizia che l’aveva messo nelle condizioni di minima resistenza fisica.
3) In una situazione come la sua, alcuni (la maggior parte) si rassegnerebbero o affonderebbero nel vizio; esempio: Joseph Jacob. Altri (pochi) utilizzerebbero l’avversità per conquistare la libertà interiore che non era un dono universale ma frutto di un paziente lavoro.
4) La sua avventura non era che un infimo esempio, un episodio ridicolmente banale nella gigantesca lotta che contrapponeva in tutti i paesi civili i possidenti agli spodestati, gli sfruttatori agli sfruttati.
5) Alexandre, preoccupandosi di far carriera, rischiava, inconsapevolmente, di finir male. Quella malattia quindi era un beneficio. Gli impediva di diventare forse un trafficante, un milionario, un industriale pescecane, un avventuriero delle finanze, un negriero, un re della tapioca, dell’oro o dello stagno. Finché tutti gli uomini non saranno liberi ed uguali, nessuno può pretendere di essere ricco se non a danno degli altri.
6) L’unico obiettivo degno di un uomo è di lavorare per trasformare la società. Lavorare a liberare i suoi simili e solo così poter liberare se stesso.
Per dare maggior peso alla sua argomentazione, il giovane libertario gli lasciò da leggere un’opera di Victor Hugo, uno dei suoi libri prediletti, che considerava veramente rivoluzionario malgrado alcuni passaggi deplorevoli sulla morale cattolica: Novantatrè.
L’incontro di Alexandre con Hugo ebbe effetti devastanti. Verne l’aveva fatto partire alla ricerca del Graal verso un altrove che s’allontanava sempre più. Dissolti i miraggi dell’esotismo, egli scoprì la possibilità di creare l’assoluto qui e subito. L’ultimo dialogo tra Cimourdain e Gauvain nella prigione, a due passi dalla ghigliottina, quando il primo fa ridere l’altro, quando l’allievo diviene maestro, fu per lui fulminante: «Voi volete il servizio militare obbligatorio. Contro chi? Contro altri uomini. Quanto a me, non voglio alcun servizio militare. Voglio la pace, io. Volete che i miserabili vengano soccorsi, io voglio che la miseria sia soppressa. Voi volete l’imposta proporzionale. Io non voglio alcuna imposta. Voglio che la spesa pubblica venga ridotta al minimo e pagata dal plusvalore sociale (...). Innanzitutto, sopprimete i parassitismi, il parassitismo del prete, il parassitismo del giudice, il parassitismo del soldato (...). Che ognuno abbia una terra e ogni terra un uomo. Centuplicherete il prodotto sociale. La Francia, attualmente, non dà ai suoi contadini che quattro giorni di carne all’anno; ben coltivata, nutrirebbe trecento milioni di uomini, tutta l’Europa (...). Volete la caserma obbligatoria, io voglio la scuola. Voi sognate l’uomo soldato, io sogno l’uomo cittadino... ».
Queste parole di Cimourdain si incisero profondamente in lui. Dunque bisognava agire. Ma Cimourdain era un utopista? No, lo affermava lui stesso: per realizzare il possibile, bisogna “cominciare con il non renderlo impossibile”.
Cimourdain moriva, vittima dell’ordine stabilito dai Robespierre e dai Gauvain? Non importa. Altri avrebbero raccolto (e altri in realtà avevano raccolto) la fiaccola. Anche lui voleva raccoglierla. Se necessario, sarebbe morto anche lui, con gli occhi aperti, sotto la macchina del signor Guillotin. Predeterminava il sacrificio della sua vita. Dove? Quando? Come cominciare?
Fu semplicissimo. Appena guarito, il suo giovane vicino lo trascinò nella sala sul retro della birreria di Noailles, dove il gruppo dei “Rinnovatori”, saputo che i socialisti locali dovevano tenere una conferenza, avevano deciso di intervenire per portare il contraddittorio.
Alcune centinaia di persone erano in piedi, ammassate attorno ad un podio improvvisato a cui era aggrappato un oratore. L’ambiente era soffocante. Bordate di esclamazioni esplodevano di continuo dalla folla, coprendo la voce del tribuno con un baccano indescrivibile. La riunione stava degenerando in violente discussioni personali finché, poco a poco, ritornò un po’ di calma.
Dopo un attimo di esitazione, i due giovanotti si intrufolarono, l’uno guidando l’altro, fino ad un gruppo compatto ai piedi della pedana. Ci furono strette di mano, qualche parola. Alexandre osservava con curiosità quelli che l’attorniavano. Erano operai, artigiani in camiciotto blu, in grembiule, in casacca, alcuni con larghe cinture da falegname attorno alle reni. Sotto una foresta di criniere irsute, barbe e baffoni, le facce furiose si tendevano verso l’oratore, infuocate della stessa passione. Delle invettive schizzavano dal gruppo in ruggiti:
– Venduto! Spione! Giuda!
Tra loro, cinque o sei donne, brutte, abbigliate orrendamente. Eccetto una, che si teneva in disparte e pareva non conoscesse nessuno, con un vestito chiaro appena scollato su una carnagione pallida, con un cappellino con veletta. Vi si scorgeva il portamento di una principessa smarrita tra il volgo. Spinto senza volere contro la sua schiena, ne respirava il profumo che stordiva. Ciocche di capelli neri e ricciuti si inanellavano sulla sua nuca. Una vita sottile sotto il bustino. Faceva caldo. Non assomigliava a nessuna di quelle che aveva conosciuto. Né alle baldracche dei bordelli d’oltremare. Né a Rolande, la figlia dell’impiegato delle poste che abitava di fianco a casa, con le sue risatine provocanti e i suoi sorrisi seduttori durante il passeggio, alla domenica, diverse volte, nei troppo brevi soggiorni a Marsiglia sotto lo sguardo profondo e ardente, curiosamente implorante. Alexandre non avvertiva più il baccano che lo circondava. Intontito, a bocca aperta, si perdeva nell’incantesimo. Voleva parlarle, dire qualcosa, una cosa qualunque. Un gran benessere lo pervadeva: galleggiava. Era un gigante onnipotente. Voleva stringerla tra le braccia; proteggerla dalle insidie... Ma lei arrossì, un’ombra di sorriso sfiorò le sue labbra pallide e si scostò un poco, imbarazzata dallo sguardo insistente di quell’adolescente che la fissava con tanta impudenza.
Alexandre abbozzò un gesto per avvicinarsi. Spalle si frapposero. Turbini agitavano la folla. Uno dei barbuti balzò sulla pedana, urtò l’oratore e si mise a parlare, curvo in avanti, le vene della fronte e del collo sporgenti, le mani convulse all’altezza delle ginocchia, le dita contratte, nervose in uno spasimo atroce, uno sforzo disperato per lanciare sulla folla la massa immensa fragile e vacillante di elettrizzanti verità.
– Chi se ne frega del finanziamento delle casse di risparmio per le case popolari! Chi se ne frega della lotta contro l’alcolismo! Chi se ne frega della giornata di otto ore! È tutta carità cristiana! Pietà! Paternalismo! Non ne vogliamo! Il compagno Rostand cerca di addormentarci con belle promesse! Non vogliamo l’elemosina! Vogliamo quanto ci spetta! Vogliamo la fine della schiavitù! Vogliamo la libertà! Vogliamo la Rivoluzione sociale subito!
Un ringhio sordo partì dal fondo della sala e penetrò tra gli astanti come un cuneo in un faggio: “A morte! Provocatori! Lasciate parlare Rostand!”. Il gruppo dei barbuti intonò l’Internazionale. Uno sgabello si abbattè su una testa. Si fece il vuoto ai piedi della pedana, simile ad un’arena in miniatura. Il silenzio, per un attimo, paralizzò il respiro. Alexandre allora la intravide, rannicchiata in prima fila, il pugno stretto su un fazzoletto di pizzo davanti alla bocca. Lei voleva scappar via. Ma non poteva. Il muro dei contendenti la respingeva. Lui si gettò verso di lei.
Dei randelli, spuntati come per magia, colpivano a casaccio; le sedie volavano; pugni e pedate s’intrecciavano e si abbattevano ovunque. Nella strada risuonarono acuti colpi di fischietto. Poi fu come se il grande lampadario a goccia gli cadesse addosso. Tese le braccia verso di lei. Credette di sentire un grido terrorizzato.
Fu tutto quel che vide della sua prima riunione politica. Non seppe mai chi l’aveva colpito. La polizia era intervenuta manganellando chiunque si trovasse sui suoi passi, soprattutto i barbuti. Il giovane orfano, aiutato da tre compagni, riuscì a portarlo via nella fuga in direzione dell’ufficio. Uscirono attraverso un giardino. Scalarono un muro e lo riportarono a casa coperto di sangue. Facendo smorfie di dolore, chiese che cosa fosse accaduto alla ragazza dalla veletta. Una bruna piccola, con un bel petto? No, loro non ne sapevano niente. Non avevano osservato. C’era tanta gente...
Se la cavò con un’altra settimana di letto. Le sue labbra, la sua fronte, le sue guance assunsero via via colori violacei e verdi. Gli faceva male respirare. Ma non c’era niente di rotto. Marie traduceva in ondate di carezze, di rimproveri, di caramelle, di tisane e di pezze inumidite la paura che aveva avuto vedendolo così malridotto. Joseph, forse nascostamente inorgoglito, non fece alcun commento.
Alexandre, invece, malgrado l’estrema spossatezza, nuotava nella felicità: era come Cimourdain. I Gauvain l’avevano abbattuto, ma questa battaglia perduta non era la guerra. Avrebbe avuto la sua rivincita. Passando senza posa da periodi di esaltazione alla più nera depressione, si chiedeva soprattutto se aveva fatto una figura da eroe agli occhi della dama con la veletta o se invece ella non l’avesse considerato che un miserabile rospo. Questa domanda, cui nessuno poteva fornire risposta, lo ossessionava.
L’orfano, qualche notte dopo, fece fagotto in fretta e furia e se ne andò, di nascosto: qualcuno (lui non sapeva chi) l’aveva denunciato come pericoloso sobillatore. Fuggì verso Lione, dove aveva un rifugio. Lasciava i suoi libri ad Alexandre. Lo pregava anche di andare a suo nome alla tipografia Juge, in rue de la République, quasi all’angolo del boulevard des Dames, ad avvertire che non sarebbe tornato.
Alexandre ci andò. La prima persona che vide, entrando, fu uno di quelli che l’avevano salvato dal vespaio di Noailles, un certo Arthur Roques. O meglio, fu quest’ultimo, un uomo tutto muscoli, sulla quarantina, brizzolato, a riconoscerlo e a stringergli la mano con calore. Juge, il padrone, un tipo burbero grande e grosso dalla voce stentorea, sempre con i lucciconi agli occhi, credette che il messaggero volesse prendere il posto del fuggitivo. L’idea non aveva neppure sfiorato Alexandre. Ma gli piacque. E poi c’era Roques. E così si ritrovò apprendista-tipografo.
Applicò a quel nuovo mestiere lo stesso entusiasmo per il lavoro ben fatto che aveva messo in quello di marinaio ed anche la stessa intelligenza. Ce l’aveva nel sangue. Discendente, con l’eccezione di suo padre, da innumerevoli generazioni di gente abituata a lavorare sodo, il suo rispetto per la competenza era innato. Il signor Juge fu contento del suo nuovo lavorante e Alexandre del suo nuovo lavoro.
Se forse non poté, per mancanza di tempo, diventare “Gavot, compagno del dovere della libertà”, era completamente per quella massoneria operativa che, anch’essa, si riconosceva (e si riconosce ancora) nei simbolici tre punti.
Era arrivato il 1897. La rivoluzione industriale si diffondeva con lo sviluppo delle miniere, delle acciaierie, delle ferrovie, concentrando il proletariato sradicato nelle grandi officine delle sordide periferie. Erano stati tagliapietre, falegnami, fabbri, carpentieri, conciatetti, stuccatori, “lupi”, “passanti” o “divoranti”, che si proclamavano “figli di Hiram”, l’ispirato architetto del Tempio di Salomone, “Figli di Maestro Giacomo” o del “Père Soubise”, i compagni galli di Hiram secondo la tradizione, ritornati nei paesi con i “Segreti”. Ogni lavoratore, fino allora, pareva insostituibile, avviato pazientemente al corso di quei cinque anni di “Tour de France”, fino al giorno in cui la sua “opera d’arte” provasse la sua abilità, potendo così accedere al grado di “compagno”. E l’“opera d’arte” non era che il segno di perfetta realizzazione interiore, padronanza di sé quanto dell’attrezzo, lenta maturazione verso la saggezza, prova che l’uomo può realizzarsi realizzando la sua opera.
Ogni individuo era stato allevato dalla Corporazione come un fiore unico. L’industria invece inchiodava gli uomini alla macchina. Essa sminuiva. Livellava. Sostituiva l’amore per il mestiere con la nozione di rendimento. Al di là dei borghesi e degli imprenditori, responsabili apparenti di questa uguaglianza nell’abbrutimento, di questa fraternità nel fango, di questa libertà di schiavo nelle catene, era contro di essa che si rivoltavano gli anarchici. L’apprendista Jacob, in modo naturale, senza neppure pensarci, accettava gli ordini del signor Juge, perché prima d’essere il padrone, era un “maestro”. Anche nel Nuovo Mondo libertario, ci sarebbero stati degli apprendisti, dei compagni e dei maestri a condizione, beninteso, che questi ultimi non abusassero della propria competenza.
Invece sarebbero mancati i battaglioni rassegnati di sotto uomini decerebrati dal mostro della grande proprietà capitalista. Alexandre (fu questo il tema delle sue prime discussioni con Roques) non comprendeva neppure come si potesse accettare di prostituirsi in un’officina. Quando non si aveva la possibilità di esercitare uno dei rari mestieri rimasti “nobili”, quali la tipografia, bisognava ribellarsi o crepare sul posto. Il giorno in cui i ribelli fossero sufficientemente numerosi, la Rivoluzione sociale poteva finalmente aver luogo. Forse, in quest’ottica, ci si doveva addirittura augurare che gli operai fossero sfruttati un po’ di più: a forza di provare, la scintilla finirebbe per scaturire... Ecco perché egli rimaneva del tutto indifferente agli sforzi di uomini come Fernand Pelloutier che, per diffondere tra le masse gli ideali libertari, si impegnavano nel sindacalismo.
Due anni prima, nel 1895, Pelloutier era stato eletto segretario della Federazione delle Borse del Lavoro, l’agglomerato di corporazioni più potente del tempo. Quello stesso anno, a Limoges, discretamente, era stata fondata la CGT. Dei militanti vi si erano avventurati. Vi avevano conquistato la maggioranza. Avevano lanciato nelle imprese le parole d’ordine del boicottaggio e del sabotaggio, sperando che il fenomeno s’allargasse a macchia d’olio. Secondo loro doveva per forza scoppiare lo sciopero generale insurrezionale, nel corso del quale il potere sarebbe caduto da sé come un frutto marcio... Ma il gran giorno tardava. Lo si aspettava invano ogni anno, ad ogni Primo Maggio. Un paradosso di Pàraf-Javal al riguardo, nel “Libertaire”, colpì profondamente Alexandre: «Che cos’è un sindacato? Un raggruppamento in cui gli abbrutiti si raccolgono secondo il proprio mestiere per cercare di rendere meno intollerabili i rapporti tra padroni e lavoratori. Delle due l’una: o non ci riescono e allora il sindacalismo è inutile; oppure ci riescono e allora il sindacalismo è nocivo, in quanto un gruppo di uomini avrà reso meno intollerabile la propria situazione ed avrà, di conseguenza, prolungato la “società attuale”».
Sotto la guida di Roques, egli conobbe poco a poco gli ambienti libertari di Marsiglia e della regione. Ebbe accesso alla redazione di “L’Agitateur”, in quai du Port 22, dove si tramava tutto. Partecipò alle riunioni dei “Rinnovatori”, al bar Flory sito in allée des Capucines 69; a quelle dei “Vendicatori”, in place Saint-Martin, al “Rendez-vous dauphinois”; a quelle della “Gioventù rivoluzionaria” e dei “Libertari della Belle du Mai” al caffè Briant in rue Blanc 80 nella sala in fondo, con le imposte chiuse. Frequentò la “Taverne provençale” in rue Rameau, dietro il Grand Théâtre; il “Bar du Grand Orient” prima del litigio con il padrone e la “Brasserie du Midi” al quai du Port 10. Partecipò al servizio d’ordine in occasione delle grandi conferenze per le quali si affittava il teatro Chave. Si trovava lì durante quella tenuta da Sébastien Faure, quando era scoppiato un tafferuglio provocato da uno spione di nome Camau. “L’apostolo” era stato condannato ad un mese di carcere duro per aver restituito lo schiaffo a un certo Toyron, altro noto confidente.
Buttava giù poesie nelle “serate familiari” durante le quali i libertari si riunivano con le loro compagne e i loro figli per ascoltare conversazioni, discutere, intonare canti rivoluzionari e a volte danzare. Una sera ci portò Rolande, la figlia dell’impiegato delle poste loro vicino. Ma costei fece la smorfiosa, giudicò quella gente “eterogenea” e volle rientrare subito, raffreddando così la loro relazione. Del resto, egli non aveva nemmeno più tempo di vederla.
Marie, invece, si divertì moltissimo, quelle due o tre volte che ci andò. Se non comprese granché delle elucubrazioni politiche, ballò invece il Boston con molti compagni che lei trovò “simpaticissimi”. Ridevano tutto il tempo. E soprattutto non bevevano che acqua.
Una domenica, Alexandre accompagnò Roques e Toulon, dove doveva prendere contatto con quelli della “Rivolta dei Lavoratori” che tenevano le loro riunioni talvolta da Caneppe, in rue Alezard 23, talaltra al bar degli Artisti in place Maurique, nel quartiere di Chapeau-Rouge. Allacciò rapporti con i “Libertari di Vaucluse” ad Avignon, nel caffè Laguir di porta Saint-Roch o al caffè di Champ-Fleuri, dietro lo scalo merci; e poi con la “Gioventù Libertaria”, alla “Buvette de l’Aveyron”, in rue des Carmes. Fece delle puntate fino a La Ciotat dagli “Indomabili” al bar Sans Pareil in rue des Petits-Ponts 3 e anche a Béziers, al caffè Fourastié di place du Marché 6 per incontrare i militanti locali.
All’“Agitateur” lavorò sodo. Passò notti in bianco, trascurando le raccomandazioni dei medici, per comporre il giornale. A volte lui stesso lo portava, ancora umido d’inchiostro, nei chioschi di Marius Gauchon e della signora Dumont. Distribuì volantini all’uscita degli uffici. E a quella delle chiese, la domenica mattina, distribuiva l’opuscolo di Sébastien Faure, I crimini di Dio: «Rialzati, uomo! E in piedi, fremente, ribelle, dichiara guerra implacabile al Dio di cui, da tempo, hanno imposto ai tuoi fratelli e a te stesso l’abbrutente venerazione!».
Durante le messe, scagliò fiale puzzolenti nel momento in cui il prete saliva sul pulpito: che spettacolo, vedere i bigotti annusare finalmente l’odore dei peccati!
Fece la conoscenza dei compagni più famosi: Henri Lucas che usciva da due anni di carcere ad Angers, Escartefigue Vérité (giunto da Parigi e di cui nessuno conosceva il vero nome), Jésus, a causa della sua barbetta, Manuel, il tipografo di rue Fortia-Géraud presso cui si stampava il giornale, Adrien Pertuis, Francis Guy, Antoine Antignac, Emile Rinaldoin, Eugène Sartoris, Ferdinand Calazel, Emile e Victor Rampal, Leca. Divenne uno dei più saldi pilastri dell’“Agitateur”. Lì si impregnò di una certa visione del mondo che, da allora, condizionò il suo comportamento.
Dovunque, in Europa, decine di migliaia di gruppi autonomi come il loro, in un rigoglio di idee a volte contraddittorie, prodigavano senza avarizia le loro energie per la libertà. Tutto si coalizzava contro di loro: la sciabola, squallida assassina; l’aspersorio, che aliena le anime promettendo aldilà paradisiaci ai sottomessi di oggi; il giudice, ritirato come un granchio nella sua buca di scartafacci; lo sbirro. Questo, lo si vedeva più spesso. Sfruttavano qualsiasi pretesto. Due anni prima i poliziotti avevano arrestato Trémolière, allora gerente dell’“Agitateur”, con dieci compagni, con l’accusa di “furto di dinamite ed associazione a delinquere” dopo aver depositato loro stessi l’esplosivo sotto i loro uffici. Avevano ripetuto l’impresa con Louis Riguier, il gerente successivo, con l’accusa di falsa dichiarazione di domicilio. Con Edouard Roch, quello subentrato dopo, per infrazione alla legge sul deposito dei periodici. Gli informatori, le spie si aggiravano dappertutto. A volte, facevano cantare persino ex compagni: testimone Auguste Marcellin, l’ultimo ad essere stato scoperto e che trasmetteva in modo mellifluo al gruppo degli anarchici i resoconti delle conferenze tenute a Lione o a Torino. E tanti altri! Con il pretesto di una perquisizione, i poliziotti terrorizzavano le famiglie e devastavano le abitazioni. Con la scusa delle leggi sulla stampa o senza nessuna scusa, sequestravano giornali, opuscoli, manifesti, cartelli, corrispondenza. Fare un processo? Anche se si fosse voluto farlo, sarebbero trascorsi due, cinque anni prima del verdetto: il tempo di dichiarare fallimento. Il tempo necessario perché il potere potesse trovare qualcos’altro. I benestanti avevano i fucili, la legge, la banca, le indulgenze plenarie per il Paradiso. Restava la fede, l’agilità mentale, l’audacia. Per un anarchico che cadeva, dieci si rialzavano, sempre più entusiasti, sempre più convinti.
Ogni giorno dalle dodici alle due del pomeriggio, invece di mangiare, Alexandre divorava, in compagnia di Roques, gli opuscoli di propaganda multicolori da cinque centesimi o mezzo franco di Bakunin, di Proudhon, di Kropotkin, di Malatesta, di James Guillaume, di Louise Michel, di Sébastien Faure, di Stirner, di Elisée Reclus che gli aveva lasciato l’orfano, e di cui essi poi, insieme, riferivano in volantini o nelle riunioni.
A poco a poco, un profilo della Francia, di questo paese che egli non conosceva, si delineava dalle letture e dalle discussioni attraverso il “Père Peinard”, “Le Libertaire”, l’“En-dehors” di Zo d’Axa o la “Revue Blanche” dei fratelli Natanson.
A dare retta al governo di “Méline-pain-cher”, come al solito tutto andava bene. I lavoratori erano felici: giacché in Francia si aprivano sempre più libretti di risparmio e si giocava di più alle corse dei cavalli. Ma nessuno parlava delle novantamila persone che morivano di fame ogni anno. Nessuno precisava neppure il grado di frustrazione che bisognava aver raggiunto per puntare due franchi di miserabili sogni di ricchezza su un ronzino.
La nostra bilancia commerciale era prospera. La scienza non aveva forse portato l’età dell’Oro che gli scienziati di un tempo, i Comte, i Taine e i Renan avevano preannunciato (sogni di poeti e di filosofi), ma almeno i nostri ingegneri, i nostri scienziati lavoravano per la prosperità del Paese; milleduecento automobili erano in circolazione, la grande corsa Parigi-Marsiglia e ritorno, che s’era appena disputata tra Renault, Panhard-Levassor, Bouton, Peugeot e Bollée, aveva battuto un favoloso record coprendo una distanza così enorme ad una media di quasi trenta chilometri all’ora, ossia la metà della velocità di un cavallo al galoppo! È vero che se si erano trovati i fondi necessari per costruire quei bolidi per i ricchi sportivi, mai un soldo era disponibile per aumentare i salari o per costruire delle abitazioni per quelli che con le loro mani creavano la ricchezza della nazione.
La bicicletta cominciava a meritare il suo nome di “piccola regina”: adesso, secondo gli slogan pubblicitari, bastavano due mesi di salario medio per pagarsene una. A Marsiglia era stato inaugurato un tram. A Parigi, alcuni audaci ideavano progetti per il percorso di una ferrovia sotterranea: la metropolitana. Dovunque si costruivano nuove ferrovie; si mettevano in servizio vagoni-ristorante e vagoni-letto. Sul mare detenevamo il nastro azzurro con il Touraine, della Compagnia Transatlantica, il più lussuoso piroscafo mai costruito. È vero che per i marinai era sempre Medioevo, con una disciplina degna dell’epoca feudale, l’assenza di cooperative, di case-albergo, di qualsiasi forma di protezione contro il padrone e il suo rappresentante di diritto divino, il capitano, il regno dei mercanti d’uomini, veri negrieri con i quali Alexandre aveva avuto a che fare dopo la sua diserzione: ma questo, i lettori dell’“Illustation” e del “Figaro” non erano tenuti a saperlo.
Insomma, le scoperte scientifiche si diffondevano in maniera incontenibile, in modo, per così dire, naturale e avrebbero indubbiamente giovato poco a poco ad una massa continuamente crescente. Ma gli investimenti venivano fatti senza tenere conto del benessere degli uomini. I finanzieri avevano in testa il profitto, non l’armonia della società. Le loro scelte si rivelavano a volte vantaggiose per tutti, ma quasi involontariamente e per caso. Ad esempio, se la bicicletta si diffondeva era soprattutto perché qualcuno guadagnava di più vendendone un maggior numero e non perché innanzitutto questa arrecava maggior vantaggio ai lavoratori: se no, perché mai i banchieri non fornivano in primo luogo case decenti ai lavoratori? Alexandre aveva visto Kropotkin, sull’“Agitateur”, lanciare un avvertimento ai privilegiati: «C’è una forza – aveva scritto – che dopo mezzo secolo ha sconvolto la produzione. Messa al servizio della menzogna, essa ha dato la disuguaglianza. Messa al servizio della verità, sarà il benessere. È la scienza. Tanto peggio per qualcuno, se oggi si chiama dinamite!».
Il telefono si diffondeva. Si parlava da quell’anno del radiotelefono di Marconi, in grado di trasmettere un messaggio senza fili dall’altro lato della Manica. Si parlava di misteriosi raggi, scoperti l’anno prima dal tedesco Röntgen e capaci di attraversare i corpi più pesanti: i raggi X. Si parlava di un’altra radiazione, emessa da un misterioso metallo, l’uranio, e che impressionerebbe le lastre fotografiche. Si parlava ancor di più della morte di Pasteur, l’anno prima, e del modo in cui aveva “inventato” i microbi, permettendo, dopo il carbonchio e la rabbia, di approntare ben presto dei vaccini contro la difterite, il tifo, la peste e forse la tubercolosi polmonare. Meravigliose scoperte di un vero altruista che stavano per diventare un affare clamoroso e, in farmacia, potevano stare alla pari con le pillole Pink, con le pastiglie Géraudel o con il vino di Cola Mariani. Con tutto questo, la madre di famiglia dei quartieri poveri, incapace di nutrire il suo quinto figlio, continuava e continuerà per lungo tempo ad armasi di ferro da calza, condannata dalla legge e dalla morale, minacciata dall’infamia e dal carcere per aver rifiutato di procreare un futuro soldato.
Nei quartieri alti, si diceva, ci si annoiava, perfino: sicuramente ne avevano il tempo. I gagà si dichiaravano “sfiniti”, “esausti”, “spossati”, pur giocando a tennis sull’erba con belle cocotte. Gli abitanti della Belle du Mai e del vecchio Porto, invece, sgobbavano dalle dodici alle quattordici ore al giorno, senza ferie, senza cassa-malattia o assistenza per gli infortuni, senza pensione, apparentemente più che felici della folcloristica partita a bocce domenicale. Ma, dicevano i padroni, quella gente, con i suoi piaceri semplici, non è forse la più felice?
Insomma, dinanzi ad ogni motivo per lamentarsi, si trovava sempre qualcuno per rispondere che era una bella fortuna vivere sotto la Repubblica, che i deputati, eletti a suffragio universale, erano i veri rappresentanti di ogni cittadino, che il governo era responsabile delle sue azioni dinanzi ad essi e che, di conseguenza, se non tutto era perfetto, ci si avviava lenti ma sicuri verso una maggiore equità. I deputati ci stavano attenti.
Alexandre ebbe con suo padre, su quest’argomento, uno o due feroci litigi che finirono con porte sbattute. In effetti, Joseph, tra un pernod e l’altro, s’accodava alla maggioranza dei francesi per criticare il regime. Ma se i suoi ghigni si erano trasformati in furore al tempo dell’enorme scandalo che fu quello di Panama quattro anni prima, le sue recriminazioni non avevano però mai superato la soglia dei caffè. Una volta che per due ore constava con i suoi amici che “più i ministeri cambiavano, più tutto rimaneva uguale” e che “il piccolo era sempre bastonato”, ritornava a casa sazio di politica, persuaso di aver adempiuto ai suoi doveri di persona civile, in fondo in fondo sorpreso dalla liberalità di questa Repubblica bonacciona, che lasciava sfogare la bile della gente senza infierire.
Brontolone e rassegnato, con teorie politiche d’interesse limitato, sottilmente orientato da una stampa a grande diffusione e scarsa conoscenza professionale, incapace di vederci chiaro da sé, in preda ai demagoghi di ogni tendenza, immerso in problemi di sopravvivenza, non di vita, sensibile alle belle promesse, sciovinista, persuaso di aver indicato la strada della democrazia al mondo intero, e questo malgrado il massacro dei comunardi, Alexandre vedeva in lui il prototipo perfetto di Monsieur Proudhomme, il francese medio. Era la “Bella Francia” di Darien, molle, vanitosa, militarista, egoista; e schernita.
1897. Alexandre aveva allora diciott’anni. Erano passati ventisei anni dalla “occupazione” tedesca del 1871, quando si erano visti i lavoratori di Parigi tentare di resistere all’invasore, mentre i borghesi, scappati a Versailles, coglievano la palla al balzo per decimare, con la collaborazione dell’occupante, quelli che davano loro fastidio. Dopo le dimissioni del generale Trochu “participio passato del verbo Trop Choir [troppo cadere]” (Victor Hugo), avevano massacrato 35.000 comunardi e in particolare tutte le menti, tutte le speranze del socialismo, il che aveva loro permesso di impadronirsi tranquillamente del potere con Thiers alla testa del Quarto Stato. Avevano fatto pagare al popolo il debito di guerra contratto con i prussiani nel trattato di Francoforte, ma avevano decuplicato in pochi mesi il volume dei loro affari. Senza concedere un soldo di aumento ai lavoratori.
I collaborazionisti avevano persino creato, nell’ambito dell’esercito, un comitato di epurazione, per ripulirlo dai quadri che rischiavano di essere troppo sensibili allo spirito della resistenza popolare. Adesso compensavano la loro recente viltà soffiando sul fuoco del revanscismo. Bisognava riprendere l’Alsazia e la Lorena. La “grandeur” della Nazione. Nemmeno un bottone... Eccetera. Quanto a quelli che vi vedevano un po’ di ipocrisia, essi li accusavano di antipatriottismo, ossia li sbattevano a Numea o in Caienna.
Delusi, affamati, condizionati, castrati, amputati delle loro forze vive, quelli che avevano fatto il 1871 si rassegnarono. Avevano paura: paura di loro stessi, paura della repressione, paura della loro ombra. O almeno Alexandre, che faceva parte delle prime generazioni a non aver conosciuto la guerra, così li giudicava.
I politicanti più cinici (o i più onesti) non nascondevano che la “Epopea coloniale” aveva fornito nel momento adatto un eccellente diversivo per utilizzare le giovani energie un po’ folli. Le conquiste africane ed asiatiche non soltanto aprivano nuovi mercati, creando così nuove fonti di profitti, ma permettevano di mandare alla guerra le teste calde.
Alexandre non esitava a raccontare a questo riguardo quel che l’aveva scandalizzato nel corso dei suoi cinque anni di navigazione oltremare, a Panama, in Tunisia, nel Tonkino, in Sudan dove il colonnello De Trentinian aveva “pacificato” i Tuareg; in Costa d’Avorio, dove i negri subivano la stessa sorte con il comandante Caudrelier e il capitano Marchand; nel Dahomey invaso fino al Niger; nell’Alto Ubanghi, dove Victor Liotard devastava il Congo fino al Nilo; in Guinea, in Senegal, in Madagascar soprattutto, dove seimila figli di contadini e di operai erano morti di dissenteria a maggior gloria di una bandiera un tempo rivoluzionaria tra le cui pieghe si nascondevano gli affaristi. I poveri soldati, piuttosto che essere sgozzati, avevano dovuto ammazzare decine di migliaia di Hovas; avevano ottenuto la resa della regina Ranavalo; ogni giorno potavano nuovi imperi per i borghesi. Ah! Le parti ben distribuite! Per i lavoratori il fango ed i massacri; per gli ufficiali nobilucci, cadetti inutilizzabili, la gloria; per i borghesi il profitto. Ma i proletari avrebbero finito con il comprendere! Bastava solo aprire loro gli occhi!
Alexandre, Roques e tutti i compagni, dagli “Uguali di Blanc-Sceau” di Roubaix ai “Compagni” di Longues Haies, passando per i militanti parigini della “Révolte” o del “Libertaire” vi si impegnavano giorno e notte nei capoluoghi e nelle borgate.
1897. I seguaci di Marx che sono ancora chiamati “socialisti-autoritari” (perché prima dell’avvento della società senza classi ritengono indispensabile il passaggio attraverso una dittatura del proletariato, regime provvisorio ma necessario secondo loro per estirpare gli ultimi germi del capitalismo), si gettano nell’attività politica: da qui il disprezzo che Alexandre e i suoi amici provano per loro. Quelli si fanno eleggere deputati nelle circoscrizioni “rosse” sulla base di programmi spesso onesti ma che si rivelano incapaci di realizzare. Dopo le elezioni del 1893 sono in quarantacinque alla Camera: in progresso rispetto ai dodici della legislatura precedente ma un’infima minoranza in confronto ai 445 “mangiatorte dell’acquario”, come loro li chiamano.
Questi 445 (a parte un pugno di nostalgici del bonapartismo o della monarchia schiacciati in seguito all’impresa di Mac Mahon) impilano sottili sfumature, dal rosa confetto dei “repubblicani del governo” al rosso chiaro dei “radicali socialisti” passando per i radicali moderati detti “sinistra progressista”. All’ “Agitateur” non si dà che un’unica spiegazione al loro comportamento: il suffragio universale non impedisce loro di condurre in porto buoni affari e la Repubblica è per loro molto meno scomoda che una dittatura, regime pieno di inconvenienti al quale farebbero ricorso solo in caso di estrema necessità, per incutere nel popolo “il giusto rispetto delle leggi”.
La maggior parte dei “socialisti di governo”, a forza di sguazzare nell’acquario, ha finito per lasciarsi contaminare. L’avvocato Alexandre Millerand, direttore di “La Petite République” ha tenuto nel maggio dell’anno precedente un discorso che ha fatto scalpore, durante un banchetto a Saint-Mandé. Egli vuole “sostituire progressivamente la proprietà sociale alla proprietà capitalista”, ossia nazionalizzare le imprese, ma gradualmente e rispettando molte posizioni acquisite. Egli ammette “l’Internazionale dei Lavoratori” ma a condizione che si resti prima di tutto patrioti. In seguito a questa mozione né carne né pesce, egli viene considerato negli ambienti politici un “realista”, un “uomo che farà strada”. Si prevede che farà una brillante carriera (e così sarà, infatti). I lavoratori lo scherniscono. All’“Agitateur” lo trattano da rinnegato.
Jules Guesde, invece, è rimasto puro. Ma anche lui vuole prima d’ogni altra cosa impadronirsi del potere. E questo attraverso “l’azione parlamentare, che è il principio socialista per eccellenza”: lo ha dichiarato molto apertamente tre mesi dopo il discorso di Millerand, nell’agosto del 1896.
Alexandre non è affatto d’accordo con questa strategia. Certo, lo scopo comune con i marxiani è l’avvento d’una società senza sfruttatori né sfruttati, senza carnefici né vittime. Certo, in Francia, paese capitalista come il resto dell’Europa, si svolge una lotta di classe, a volte sanguinosa, sempre oppressiva. Ma impadronirsi del potere, questo no. “Lo Stato è il male” ha detto Bakunin. L’ingiustizia comincia fatalmente con il potere dell’uomo sull’uomo. Instaurare una dittatura del proletariato significa cadere in una trappola peggiore di quella in cui ci si trova, giacché questo regime comporterà inevitabilmente a breve scadenza la necessità di una polizia segreta, di una censura sulla stampa, di una dittatura esercitata sugli spiriti altrettanto che sui corpi. Esattamente il contrario della pienezza della libertà.
La politica, secondo gli amici di Alexandre, non si pratica delegando i propri poteri per cinque anni ad un individuo che non si ha il diritto di sostituire se se ne è scontenti e questo significa essere cittadini nella millequattrocentosessantesima parte della propria vita (millequattrocentosessantunesima per gli anni bisestili): il fatidico giorno in cui si depone la scheda nell’urna; la politica si esercita, si dovrebbe esercitare tutti i giorni in una genuina democrazia. Gli opuscoli lasciati ad Alexandre dall’orfano tuonano all’unisono contro il suffragio universale.
Louise Michel li riassume tutti nella frase: “Il voto è il muggito di un bue che fiuta il mattatoio!”.
Dopo sei mesi di attività militante, egli era talmente impregnato di quei testi che li citava a memoria. Citava Bakunin come Jourdain recitava. La pratica quotidiana dell’azione aveva fatto dell’apprendista timoniere un agitatore di professione. L’anarchia l’aveva completamente conquistato. Essa gli offriva un ideale, una filosofia, una regola di comportamento. Se fosse vissuto all’inizio dell’era cristiana, avrebbe forse fatto parte dei seguaci di Gesù, l’unico anarchico che abbia avuto successo, secondo alcuni. Nel 1897 egli non vedeva a quale altra causa votarsi se non all’anarchia, lui che era impregnato di assoluto, che non aveva visto che ingiustizia ed atrocità nel mondo, che non fiutava che compromissioni in una Francia deludente.
Dopo le ore passate dinanzi alla sua cassa per composizione da papà Juge, andava ogni tanto in giro per il porto. Allora lo riprendeva la nostalgia degli alisei e delle notti di guardia sotto i tropici quando teneva il timone e il battello tracciava la sua scia nelle acque fosforescenti. Subito incrociava vecchi compagni; evocavano un po’ di passato ma non avevano più niente da dirsi. Erano poveri disgraziati, che trascinavano le loro sconfitte in un mondo di ombre.
Con il capitano Martinaud, forse... Ma come spiegargli che aveva trovato uno scopo alla sua vita, cento volte più grandioso che comandare una nave? Come spiegargli il mondo senza Stato, senza governo, senza leggi, senza polizia, senza giudici, immerso nell’armonia, per il quale egli lavorava adesso? Ci aveva provato, il giorno in cui l’aveva incontrato per caso vicino al bacino del Lazaret. Gli aveva spiegato con tutta la sua foga come l’ingiustizia sociale produce il criminale e come la maggior parte dei delitti non viene commessa che per interesse. Sopprimete l’ingiustizia, capitano, e sopprimerete la stragrande maggioranza dei crimini! La società considera i delinquenti come degli schiavi ribelli che bisogna punire: noi, come dei fratelli malati che ci sforzeremo di guarire con ogni mezzo che la scienza ci fornirà. La storia dell’Occidente si riduce oggi a quella della conquista del potere da parte di caste sempre nuove. Ma non è necessariamente questa la storia definitiva di tutta l’umanità.
– Voi non impedirete che ci siano lupi e pecore, ingordi e avari – aveva mormorato Martinaud, stupito di tanto slancio.
Martinaud aveva taciuto a lungo, fissando il mare con aria ostinata. Poi, con un tono triste, quasi angosciato, aveva detto:
– State in guardia, Jacob. Sono pericolose le utopie. Volendo avere tutto subito rischiate di distruggere tutto.
La conversazione si era interrotta. Si erano lasciati. Ogni volta che Alexandre ricordava quell’incontro, stringeva i pugni. Martinaud faceva parte della categoria peggiore che ci fosse: i liberali. Quelli che hanno la coscienza a posto a forza di credere d’avere capito tutto.
Gli ideali anarchici erano talmente evidenti! Così evidenti che sarebbe bastato diffonderli ovunque per assistere ad una sollevazione generale. L’unico problema serio rimaneva quello della propaganda. Come informare gli sfruttati che non dovevano far altro che spezzare tutti insieme le loro catene per esser liberi? Da vent’anni ce lo si chiedeva.
Nell’estate del 1897, Charles Malato arrivò a Marsiglia nel corso di un viaggio intrapreso per tentare, se possibile, di coordinare le attività dei gruppi della provincia. Alexandre fece la sua conoscenza nei locali dell’“Agitateur”. Ne fu immediatamente conquistato. Trent’anni, il volto quasi illuminato dalle prove subite: l’adolescente vide subito in lui una sorta di esempio. Era il primo eroe del pantheon anarchico che incontrava così da vicino. Quando Malato illustrava un’idea con la sua voce calda e musicale, tutto diventava limpido. Si faceva crocchio attorno a lui.
Raccontava la storia del movimento. Parlava del patrimonio d’audacia e di dedizione prodigato dai militanti di un tempo, ma anche della loro sconfitta quasi completa. Senza lasciarsi scoraggiare dagli eccessi di furore vendicativo di alcuni, calmo, instancabile suggeriva loro insegnamenti da trarre dal passato. Dal loro stesso passato.
Dopo la Comune e l’esplosione dell’Internazionale, era il caos. Scioperi selvaggi, sommosse per la fame erano scoppiati un po’ dappertutto, senza speranza, senza coscienza politica: rivolte di miserabili. Inefficaci congressi operai s’erano tenuti in segreto; qualche processo di grande risonanza, come quello di Lione del 1874, era servito da fugace tribuna. Rifugiati nei dintorni di La Chaux-de-Fonds, nel Giura svizzero, alcuni compagni avevano tentato di tener vivo l’ideale. Ma da tempo nessuno aveva potuto diffonderlo in Francia, dove ogni militante era schedato, braccato, imprigionato senza alcun sostegno presso la popolazione intimidita.
Nel 1880 la maggior parte dei comunardi amnistiati erano rientrati dal bagno penale ed avevano immediatamente ripreso, dove l’avevano interrotto, il loro impegno di agitazione. Nello stesso momento, nei congressi internazionali del Giura, era sorta un’idea: giacché il popolo dormiva, bisognava ridestarlo. Giacché aveva paura, bisognava ridargli fiducia in se stesso dimostrando che si poteva restituire colpo su colpo ai versagliesi. Thiers aveva dichiarato la guerra massacrando i comunardi: si sarebbe raccolta la sfida. Fu allora che l’aristocratico principe Kropotkin, geografo, esploratore della Siberia, più titolato dei Romanov, apppena evaso dopo alcuni anni di detenzione nella prigione Pietro e Paolo di Pietroburgo, lanciò dal “Révolté” di Ginevra la sua esplosiva parola d’ordine: «La nostra azione dev’essere la rivolta permanente, con la parola, lo scritto, il pugnale, il fucile, la dinamite, fors’anche la scheda elettorale se si tratta di votare per Blanqui o Trinquet ineleggibili. Noi siamo coerenti e ci serviremo di ogni arma se si deve colpire, come ribelli. Per noi va bene tutto purché non sia la legalità!».
Sì all’omicidio politico, aveva ribadito Paul Brousse sull’“Avant-Garde” di Ginevra, «se l’omicidio di un uomo impedisce quello di migliaia di altri; decisamente sì se si può, colpendo un soldato stupido, fare trionfare una causa evitando sanguinose ecatombe programmate». No alle violenze ingiustificate, aveva aggiunto. «È evidente che dimostreremo la stessa circospezione e molta maggior prudenza nella scelta dell’atto da compiere per fare della propaganda politica».
Ahimè, questi inviti alla moderazione non sempre erano stati seguiti. Gli apprendisti stregoni di La Chaux-de-Fonds e della valle di Saint-Imier avevano aperto le chiuse ad un torrente. Ognuno si era immediatamente scoperto forti ragioni per scagliare il suo ordigno infernale. Ci si era liberati delle umiliazioni con la nitroglicerina, a caso, per eroismo, per bravata, per vendetta, per disperazione. Non c’era più possibilità di trattenere le masse né di controllare il movimento.
C’era stato un dilagare di violenza in Europa: l’attentato di Nobiling contro il kaiser Guglielmo I nel giugno 1878; in novembre, tentato assassinio da parte di Passanante contro il re d’Italia; nel 1883, bomba al caffè dell’Assommoir a Lione: Cyvoct, accusato a torto di averla deposta, condannato al penitenziario; nel 1884, a Montceau-les-Mines l’operaio Gueslaff, sorpreso mentre deponeva una bomba, feriva tre gendarmi a colpi di revolver; nel gennaio del 1886, i minatori di Decazeville defenestravano l’ingegner Watrin; in marzo, era Gallo che scagliava la sua dinamite in piena seduta di Borsa e svuotava il suo caricatore sugli aggiotatori; il Primo Maggio a Chicago avveniva la sommossa che doveva fare nascere la festa del lavoro e nel corso della quale Spies, Engel, Pearsons, Fischer e Lingg erano stati giustiziati; in seguito, si era ricominciato a ogni Primo Maggio; nel 1890 si decretava lo stato d’assedio a Vienna; nel 1891 a Fourmies, nel Nord, l’esercito uccideva dieci manifestanti tra cui due bambini; a Clichy i gendarmi a cavallo caricavano la folla e bastonavano Decamps...
Fu proprio nel 1885 che Malato ritornò dal bagno penale in Nuova Caledonia dove sua madre e lui avevano seguito il padre che era stato un comunardo.
Aveva trascorso quattordici anni in tutto a Numea, una parte della sua infanzia e quasi tutta l’adolescenza, fino a quando suo padre era morto tra le mani degli aguzzini.
Cresciuto come un selvaggio tra i selvaggi secondo lui più civili dei bianchi, aveva imparato laggiù i dialetti canachi. Fu lui ad insegnarli a Louise. In cambio, quando la signora Malato era morta, abbattuta dal clima nelle baracche di fango e paglia della penisola di Ducos, Louise era stata una seconda madre per lui. L’aveva iniziato alla poesia, alla botanica, alla geologia, alla letteratura, alla musica sul suo pianoforte cui mancava la metà dei tasti, all’anarchia nella scuola che lei aveva aperto per i figli dei deportati e in seguito per gli indigeni. Mentre certi padri, mescolati con i peggiori delinquenti, trascinavano la loro palla al piede, inchiodati alla doppia catena (altri, come Henri Rochefort, godevano di una maggiore libertà), lei trasmetteva ai figli il suo stupore dinanzi alla bellezza delle cose e la sua fede nella trasformazione dell’umanità.
Non c’era alcun bisogno di recinzioni fortificate per custodire i forzati, a Numea: la giungla ed i Canachi s’incaricavano di divorare quelli che tentavano di evadere. Ma Louise un giorno aveva affermato che quei primitivi dovevano essere buoni, perché vivevano a contatto con la natura. Aveva quindi portato con sé Malato in piena foresta: due incoscienti tra gli antropofagi. Nella colonia, li consideravano perduti. Ma fu lei ad avere ragione.
Erano capitati in una tribù di cui lei in poche ore aveva sedotto il capo farfugliandogli le teorie libertarie nella sua stessa lingua. Il capo, seguito subito dall’intera tribù, si era convertito. “Voi ed io siamo della stessa razza” disse quello. “Voi siete stati battuti come i poveri Canachi, quando hanno voluto resistere ai bianchi. Quelli sempre uccidere e sempre avere ragione”. Dopo che lei ebbe curato meglio che poté i malati e deciso di insegnare a leggere a tutti, i deportati politici che evadevano venivano ricevuti a braccia aperte in quella tribù. Gli altri evasi, i “cattivi”, finivano lo stesso i loro giorni in una pentola, come in passato: lo spirito libertario forse non era andato molto avanti.
Nel 1878, quando si erano rivoltati, stanchi di vedere le loro figlie rapite e violentate e i loro più begli alberi abbattuti, stanchi di farsi ricacciare lontano dalle radure nel più profondo della boscaglia, il capo era andato a trovarla. Quasi unica, anche tra gli anarchici, a stare dalla loro parte, lei gli aveva fatto dono del suo tesoro più prezioso: la bandiera rossa che brandiva negli ultimi giorni della Comune. Gli aveva consigliato di tagliare in gran fretta i fili telegrafici dei bianchi. Ma fionde e zagaglie contro fucili a ripetizione e cannoni da montagna, i ribelli erano stati ben presto battuti. Malato e Louise però avevano almeno avuto la consolazione di venire a sapere che il capo loro amico, crivellato di pallottole era stato fasciato con la storica bandiera.
Alexandre, si può bene immaginare, si entusiasmava a quei racconti che gli riportavano alla mente tanti ricordi. Quando Malato era giunto in Francia, sbigottito per la miseria dei sobborghi, s’era immediatamente gettato nell’azione. Aveva scritto un romanzo sul caso di Montceau-les-Mines: Il Grande Sciopero; aveva fondato un giornale con Jean Pausader, detto Jacques Prolo, e alcuni altri: la “Révolution cosmopolite”; aveva partecipato alla conferenza anarchica del 1889, tenutasi all’inizio di settembre alla sala di Commercio. Fu lì che una prima volta, di fronte al caos generale, aveva tentato, con Jean Grave e Pouget (il “Père Peinard”) di coordinare le informazioni sui vari gruppi europei, allo scopo di meglio organizzare l’azione. Aveva dovuto rinunciarvi: in nome dell’individualismo, ogni militante voleva fare di testa propria. Forse che ancora oggi si continuerebbe a morire per niente?
Aveva vissuto troppo in prima persona il 1892 e 1893, gli “anni insanguinati” dell’anarchia, per non temerlo. Millecentoventitre attentati alla dinamite in tutta Europa nel solo 1892. Con quale risultato? L’insurrezione tanto attesa era forse scoppiata?
In Spagna, c’era stata la rivolta dei contadini di Jerez, con le spaventose torture inflitte ai capi. In Francia, per vendicare Decamps, Ravachol aveva deposto le sue due bombe, una per il presidente delle Assise, l’altra per il procuratore della Repubblica che l’aveva fatto condannare a morte. Già con lui Malato aveva avuto l’impressione deprimente di vedere una bella energia sprecata. Gli aveva scritto: “Era una di quelle personalità sconcertanti che possono lasciare ai posteri la reputazione di un eroe o di un bandito, a seconda dell’epoca in cui vivono ed il mondo in cui si muovono”. Ghigliottinato.
Per vendicare Ravachol, Meunier, il carpentiere che egli aveva conosciuto laborioso e sobrio, “con la sua fisionomia bella e pura di freddo entusiasta, il tipo più notevole dell’illuminismo rivoluzionario”, aveva fatto saltare il ristorante Véry. Alla Caienna.
In Spagna, per vendicare Jerez, Pallas aveva scagliato una bomba contro il maresciallo Martinez-Campos. Era stato torturato, quindi garrottato. Per vendicarlo, due bombe erano state deposte al Teatro Liceo di Barcellona: ventidue morti, cinquanta feriti, decretato lo stato d’assedio, centinaia di innocenti evirati, scorticati vivi, impalati, bruciati.
In Francia, Vaillant, che lui aveva conosciuto segretario degli “Indipendenti di Montmartre”, “figura pensierosa, sguardo dolce, che sogna l’evasione”, partito poco prima per fondare una colonia libertaria nel Gran Chaco argentino, deluso da morirne, aveva lanciato la sua bomba imbottita di chiodi durante una seduta dell’ “acquario” [il parlamento, n.d.r.]. Non aveva ucciso né voleva uccidere alcuno. Aveva solo voluto lanciare “il grido di tutta la classe che rivendica i propri diritti e che presto unirà gli atti alle parole”. Ghigliottinato.
Naturalmente, un simile eroismo non mancava di spettacolarità. Naturalmente, tutti questi episodi avevano serrato i ranghi degli anarchici, eccitando anche gli animi più timorati. Del resto, basta pescare a caso negli archivi dell’“Agitateur” dell’epoca. Quello del 1° marzo 1892, ad esempio: «Ha parlato ancora, “la bella”, questa settimana! I recenti attentati sono stati diretti con intelligenza, il primo contro il palazzo della principessa di Sagan, aristocratica e milionaria, il secondo contro lo stabile abitato dal consigliere Benoit, il terzo contro la caserma Lobau, alloggio di soldati-poliziotto. Così, adesso milioni di defraudati e di vittime si sentono rincuorati, presi da speranze folli... Se alcuni gesti bastano a far perdere la testa ai dirigenti, che avverrà quando, per contagio, tali gesti si diffonderanno? E quel momento è vicino! Ecco approssimarsi ore tragiche! È la guerra all’ultimo sangue che ci ha dichiarato la borghesia a Fourmies: noi risponderemo con la guerra all’ultimo sangue, senza tregua né pietà, con tutti i suoi orrori, con tutte le sue conseguenze. Che la responsabilità di tutto questo ricada su coloro che l’hanno dichiarata!...».
In questa guerra di uno contro centomila, il vantaggio era rimasto al nemico. Il borghese terrorizzato aveva fatto votare in fretta e furia le “leggi scellerate”: ottocentomila franchi di crediti supplementari per la polizia; sequestri di giornali, perquisizioni, arresti per un articolo di giornale sospetto, per il minimo tentativo di propaganda; passaggio dei processi al Correzionale piuttosto che dinanzi ad una corte di Assise “per maggiore rapidità”, proibizione di dare pubblicità ai dibattiti, confino immediato dei condannati in Guyana.
Parecchi militanti s’erano intestarditi. Emile Henry, purtroppo ancora persuaso dell’efficacia dei gesti di rivolta brutale che “ridestano la massa, la scuotono con un violento colpo di sferza e le mostrano la faccia vulnerabile della borghesia, tutta tremante ancora nel momento in cui il Ribelle sale sul patibolo”, aveva scagliato una bomba al Terminus-Saint-Lazare il 12 febbraio 1894. Un errore sanguinoso. Malato aveva deplorato anche quel gesto: “Il gesto di Emile Henry, che è nondimeno un anarchico di acuta intelligenza e di gran coraggio, ha colpito soprattutto l’anarchia. Io approvo qualsiasi violenza che sia diretta contro l’ostacolo, che colpisca il nemico, non quella che colpisce alla cieca”. La pugnalata di Caserio, il 24 giugno seguente, all’indirizzo del presidente Sadi Carnot, condannato a morte dagli anarchici per non avere graziato Henry, non l’aveva molto soddisfatto. Adesso, non si sentiva disposto a cambiare parere.
Le “leggi scellerate” l’avevano però costretto ad esiliarsi in Inghilterra in compagnia della buona Louise, di Kropotkin, di Malatesta. Lassù avevano incontrato dei militanti italiani, russi, tedeschi e avevano fondato con loro un giornale, l’“Avant-Garde”, grazie al quale avevano potuto approfondire l’analisi e tracciare un bilancio della “propaganda con i fatti”. Ed era negativo. Certo, gli sfruttatori avevano tremato. Ma avevano ripreso il controllo di sé, stringendo ancor più la vite. Quanto alla classe operaia, forse si sarebbe scoperto dopo un po’ che le esplosioni l’avevano ridestata. Nel frattempo, essa s’era proprio staccata dagli anarchici. Le bombe avevano fatto il gioco dei “socialisti di governo”.
Di conseguenza, come ci si poteva ancora gingillare oggi con le scatole di sardine riempite di polvere verde contro inoffensivi monumenti ai morti? Sinistre stupidaggini quando occorreva, in realtà, ritrovare con ogni mezzo l’attenzione perduta presso il popolo. Un compito umile, ingrato, sotterraneo, l’unico in quel momento che s’imponesse:
“Fare di tutto per distaccare le masse lavoratrici dai sedicenti socialisti che oggi si servono del popolo per conquistarsi una posizione e che, domani padroni, lo sottometterebbero ad un giogo più pesante di quello della borghesia (...).
“Prendere parte attiva negli scioperi come in tutte le agitazioni operaie, rifiutarsi categoricamente di accettare qualsiasi posizione protagonistica.
“Se nonostante tutto i compagni vorranno fare gesti individuali, è indispensabile che questi gesti siano tali che le masse possano facilmente riconoscervi l’opera di gente che lotta e si sacrifica per il bene di tutti”.
A dire il vero, senza il prestigio personale di cui godeva, molti militanti dell’“Agitateur” non avrebbero accettato delle idee così difficili da ammettere. Se ne sarebbero andati sbattendo la porta o meglio l’avrebbero gettato fuori prendendolo per un provocatore. Come! Nel momento in cui venivano maggiormente braccati, spiati, perseguitati, bisognava incrociare le braccia? Rinunciare a battersi? Porgere l’altra guancia? Alla vigilia forse della vittoria?
Allora Malato riprendeva la sua spiegazione mescolandovi gli aneddoti personali adatti a penetrare nell’animo di ognuno. Alexandre, affascinato, lo ascoltava a volte fino all’alba, rimanendo solo con lui per saperne di più, incalzandolo con infinite domande e non lasciandolo che per correre da Juge a riprendere il lavoro.
Quegli attacchi contro l’uso smodato delle bombe non impedivano a Malato di insegnarne spesso la fabbricazione, la sera, al suo giovane discepolo e qualche altro compagno, nella angusta mansarda che aveva affittato e trasformato in laboratorio di chimica. La contraddizione era solo apparente. Perché rifiutare di assumere oggi rischi inutili non impediva (anzi!) di tenersi preparati per il “Grande Giorno”, quello in cui sarebbe scoppiata l’insurrezione generale, che ognuno sperava vicina. I cannoni e i fucili li avevano i borghesi. Non i rivoluzionari. Bisognava compensare con l’immaginazione, esercitarsi sin da ora nella fabbricazione del nitro-benzene, del bitro-benzene e di micce e cominciare eventualmente a fare delle scorte.
— Vi insegno a fare delle bombe – diceva loro sorridendo – ma a condizione che non ve ne serviate. Non subito.
Naturalmente, l’adolescenza esaltata di Alexandre era inebriata dagli acidi, le polveri, le storte e le pentole. Una sera, Malato gli prestò, somma fiducia, quel che chiamava il suo “libro di cucina”, un libretto dalla copertina rossa che conteneva ricette da fare esplodere l’intero universo. Alexandre se lo portò a casa. Lesse con esultanza la prefazione, di un romanticismo inebriante, e la conclusione, apocalittica: “Un compito importante sarà quello di radere al suolo tutti gli edifici che sono un simbolo di oppressione. Nessuna vestigia del passato sarà rispettata... Che tutti gli stabili che potrebbero servire da luoghi di riunione ad una autorità qualsiasi vengano abbattuti senza pietà né rimorsi... Bruciate tutte le scartoffie amministrative ovunque siano. A fuoco i titoli di proprietà! A fuoco il gran libro del debito pubblico! A fuoco le carte dello stato civile, del reclutamento, dell’intendenza militare, dei tributi diretti ed indiretti! A fuoco quelle carte malsane, certificati di schiavitù dell’umanità, difesi da migliaia di soldati, di poliziotti di tutti i generi... Notre-Dame e le antiche cattedrali gotiche in cui i nostri avi hanno messo la loro anima non potrà scuotersi di dosso i pregiudizi di cui essi sono la rappresentazione vivificata... Non potendo chiuderle in campane di vetro nei musei, la cosa migliore è ancora distruggerle malgrado il baccano contro il vandalismo rivoluzionario e le maledizioni dei futuri archeologi”.
Che importava la ingenuità di quel lirismo: le ricette erano buone.
Qualche tempo dopo questa lettura, Alexandre ebbe con Roques, al bar Flory, una discussione riguardo ai punti strategici che secondo loro conveniva far saltare quando fosse giunto il fatidico “Gran Giorno”. Un compagno di nome Leca, apparentemente interessato, si unì a loro. I due ignoravano che quest’ultimo, nei guai con la polizia, era diventato a sua volta una spia. Alexandre, trasportato dal suo slancio, lasciò intendere che si sarebbe incaricato lui solo di demolire tutti i monumenti di Marsiglia. Per colmare la misura, Leca, con il pretesto che si credeva seguito, gli passò sotto il tavolo un pacchetto con del carbone pestato, zolfo e nitrato di potassio sufficienti per confezionare una libbra di pessima polvere. Gliel’avrebbe ripreso tra qualche giorno, quando la sorveglianza si fosse allentata.
L’indomani all’alba, una squadra di poliziotti armati fino ai denti, brandendo un mandato di perquisizione, forzava la porta della piccola casa del Vecchio Porto dove abitava Alexandre. Spingendo Marie e Joseph, inebetiti di sonno, nel corridoio, irruppero nella sua stanza. Rovistarono dappertutto; calpestarono, rovesciarono, fecero un gran chiasso: per scoprire finalmente, tra Jules Verne, Victor Hugo e Kropotkin, il famoso libretto rosso e il pacchetto nemmeno disfatto. Quindi infilarono le manette ad Alexandre e lo portarono al commissariato.
L’interrogatorio non chiarì nulla, se non che il signor Jacob proclamava a gran voce la sua identità di anarchico. Allora gli proposero un affare: o “denunciava la sua banda” oppure lo schiaffavano dentro per fabbricazione e detenzione di esplosivi. Egli schiumava dalla rabbia. Le sue imprecazioni gli fecero rischiare un aggravamento di pena. Il silenzio ostinato che seguì lo condusse difilato alla prigione di Chave.
Inquieto perché non lo vedeva arrivare, Roques corse in mattinata a cercare sue notizie. Ritornò con “le lacrime agli occhi”, secondo il suo stesso racconto. Il signor Juge si precipitò poi di persona al commissariato. Fece e disse quello che poteva fare e dire per il suo dipendente. La sua difesa non servì a nulla. “Occorrevano esempi e Alexandre ne fu la vittima”.
Marie mise in subbuglio tutta la città. Attraverso una cliente, riuscì perfino ad entrare in contatto con Vulliez, il procuratore della Repubblica. Costui, pieno di buona volontà, andò a trovare il detenuto nella sua cella. Ascoltò con un sorriso indulgente i discorsi del giovane. Quindi decise:
– Se aveste commesso un furto, alla vostra età, non sarebbe tanto grave. Ma voi siete anarchico, mio giovane amico!...
Alle Assise, Pianello, l’avvocato di Alexandre, si sforzò invano di sottolineare l’incoscienza e il pentimento: non ottenne la condizionale. Quanto a Leca, non si fece mai più rivedere a Marsiglia.
* * *
– Siete stato condannato a sei anni in contumacia dalla corte d’Assise della Var il 9 giugno 1890.
– Come volete che lo sappia, se non c’ero?
– Avete presentato ricorso avverso questa sentenza e, nel frattempo, siete stato internato in osservazione nel manicomio di Aix. L’incoerenza del vostro linguaggio, le vostre azioni, avevano fatto pensare che foste uno squilibrato. Invece, non eravate che un simulatore che faceva la commedia per tentare più facilmente l’evasione.
– Ognuno si difende come può.
– Insomma, ammettete i fatti?
– Certamente. Io so quel che faccio. Non cerco di discolparmi.
I giurati si lamentano di non riuscire a udire che brandelli di frasi e l’imputato viene interrotto per farlo avvicinare. Incatenato al suo gendarme, Jacob ha difficoltà ad uscire dal suo posto.
– E una vergogna essere trattati così in una Repubblica, in un’epoca che si dice progressista – brontola.
Arrivato con gran fatica al pretorio, prosegue:
– Io rivendico apertamente la responsabilità dei miei atti. Non sono uomo che si pente. Del resto, non ci si può pentire che delle proprie cattive azioni. Sono sinceramente convinto e credo in tutta coscienza di avere agito bene. Quel che ho fatto, l’ho fatto con piena giustizia. Il proletariato non è più schiavizzabile ma è tassabile. Alla massa non basta più mangiare: ora vuole pensare. E perché essa pensi, bisogna distruggere le caste. Io ho scelto il furto come mezzo. Dall’età della ragione, ho scoperto i miei veri nemici: i benestanti, i proprietari, gli industriali, i militari ed i preti. Ossia tutti voi che pretendete di giudicarmi.
* * *
Quando uscì dalla prigione di Chave, nell’aprile del 1898, era maturato. Nel mondo segregato delle celle, nel corso delle lunghe conversazioni con i libertari che le stipavano, aveva imparato molto e molto aveva tenuto a mente. Al punto che se non si fosse ribellato prima del suo soggiorno dietro le sbarre, lo avrebbe fatto allora.
Dopo aver abbracciato sua madre, che l’accolse con la foga entusiasta che si riserva alle vittime di errori giudiziari e ai martiri, ritornò da Juge. Con le lacrime agli occhi più che mai, il padrone lo accolse con aria mogia. Degli ispettori erano venuti a fargli domande sui suoi dipendenti. L’avevano interrogato come fosse un malfattore. L’avevano minacciato di procurargli delle noie: insomma, aveva dovuto, malgrado tutto l’affetto che provava per lui, separarsi da Roques. Neppure parlarne di riprendere Alexandre. Ah! Gli rincresceva molto, perbacco! Quel che facevano i suoi operai al di fuori dell’orario lavorativo non lo riguardava. Ma bisognava anche mettersi nei suoi panni! La paura lo rendeva patetico. Alexandre accettò senza una parola l’attestato di lavoro elogiativo consegnatogli a mo’ di scusa. Poi si mise alla ricerca dei compagni.
Al bar Flory ritrovò Roques seduto al tavolo tra un gruppo di sconosciuti che gli fecero festa al solo udire il suo nome: egli era “caduto” per la Causa. Era ormai “vaccinato”!
I nuovi venuti erano dei “parigini”: la redazione del “Libertaire” quasi al completo. Affascinati dalle lettere entusiaste di Malato che, lamentandosi peraltro di aver passato dei guai in seguito all’“incidente” di Alexandre, aveva preferito nel frattempo partire per un viaggio, essi erano venuti a stabilirsi a Marsiglia. Il gruppo dell’“Agitateur”, morto d’inedia poco prima, s’era fuso con loro. Si era in attesa di Sébastien Faure, in quel momento impegnato in un giro di conferenze. Di primo acchito, si strinsero solide amicizie. Una boccata d’aria pura dopo il soggiorno al fresco. Erano presenti Ernest Girault, Henry Dhorr, Prost, “Imanus”.
E soprattutto Louis Matha, l’uomo che sostituiva Sébastien Faure alla testa del “Libertaire” in caso di assenza, un tipo basso e panciuto, con la barba squadrata, ex parrucchiere, vestito con ricercata affettazione. Un guascone, di Casteljaloux.
Il primo contatto non andò oltre lo stadio della cortesia: Matha all’approccio era un po’ freddo, sostenuto, volentieri silenzioso. Bisognava perforare tutta una corazza di modestia e timidezza per scoprirlo. Solo allora si era ricompensati.
Alexandre conosceva già il suo ruolo come gerente dell’“En-Dehors”, di Zo d’Axa. La sua condanna a due anni di carcere nel 1893, per un articolo che non aveva avuto la sorte di piacere al governo. La sua fuga a Londra. Il suo precipitoso ritorno ai primi di febbraio del 1894, quando era stato informato che Emile Henry avrebbe lanciato la sua bomba. Il modo in cui egli l’aveva seguito passo passo, supplicandolo in nome della Causa di rinunciare a quel gesto. Ma Henry, con i nervi a pezzi, disperato, l’aveva cacciato senza riguardi.
Venne ben presto a sapere dalla bocca stessa del gerente del “Libertaire” il seguito di quell’oscuro caso. Appena Matha ebbe sentito la sinistra notizia e l’orrore dei venti feriti, dimenticando il suo disaccordo, aveva voluto rendere un ultimo favore all’amico. Seguito da Millet e da Ortiz (lo scassinatore-dandy “fin de siécle” dalla scriminatura irreprensibile e dai capelli ondulati), egli era corso in casa dello sfortunato eroe, in rue Envierges, per fare scomparire ogni traccia di esplosivo prima dell’arrivo della polizia. Poiché Henry aveva rivendicato con orgoglio il suo gesto, compiuto volontariamente, per colpire, diceva, “quella massa pretenziosa e stupida di impiegati a trecento o cinquecento franchi al mese, più reazionari dei borghesi loro padroni”, la spedizione non era servita a nulla. In compenso, la “Sûreté” ne aveva avuto sentore, non si sa attraverso quali confidenti.
Avevano subito cercato di implicarlo nell’attentato al ristorante Foyot dove Laurent Tailhade avevano perduto un occhio. L’avevano arrestato varie volte. Infine, in assenza di prove, avevano dovuto accontentarsi di farlo comparire al “processo dei Trenta”. L’ambiguo Bulot, lo spietato procuratore di Decamp e di Ravachol, s’era accanito contro di lui. E poi aveva dovuto rilasciarlo insieme agli altri.
Matha era tutto l’opposto di Malato: un meccanismo di precisione perfettamente lubrificato, che funzionava notte e giorno, imperturbabile, senza sforzo apparente, anche se si aveva sempre l’impressione di vederlo sfaccendato. In realtà, Alexandre fu da lui trascinato in un vero vortice.
Si avvicinavano le elezioni. Bisognava approfittare con tutti i mezzi dell’agitazione che queste creavano nella gente per mettere in ridicolo la “mascherata”. Un’unica parola d’ordine: sabotaggio.
Appena sistemato da Roques in un tipografia in cui quest’ultimo aveva potuto trovare lavoro, Alexandre vi si impegnò al massimo. Dalla Belle du Mai a Menpenti e dalla Madrague alla Croix-Rouge, percorse la città e i suoi sobborghi intervenendo nel bel mezzo delle riunioni elettorali. Fossero queste radicali, socialiste o cattoliche, arringando, contestando, infuriandosi febbrile, sarcastico. A volte occorreva fare a pugni con gli apaches le cui prestazioni come servizio d’ordine quei signori s’erano assicurate. Altrove bastava semplicemente discutere con gli operai ed i contadini. Dovunque egli era il primo.
Il suo più grande successo fu a La Ciotat il giorno stesso delle elezioni che contrapponevano Antide Boyer a quel socialista di nome Eugène Rostand, contro il quale Alexandre nutriva un certo rancore dopo che i suoi sostenitori l’avevano caricato di botte al tempo dei suoi primi passi nell’anarchia. Seguito da tre compagni, irruppe come una folata di vento nella sala del seggio qualche minuto prima della chiusura degli scrutini, introdusse nell’urna un ordigno incendiario e batté in ritirata prima che i gendarmi di guardia avessero il tempo di reagire. Grande fu la gioia al bar Flory quando si seppe che le votazioni avevano dovuto essere annullate. (Ecco, per chi ne fosse interessato, la ricetta fornita dal n. 2 del “Balai social”: «Si prenda un pezzetto, grande come la testa di una grossa spilla, di fosforo, il cosiddetto fosforo in bastoncini che si trova presso quasi tutti i negozianti di prodotti chimici o di vernici, e lo si ripieghi entro una scheda elettorale, lasciandoci però un po’ d’aria, perché il fosforo in bastoncini non attacca che all’aria libera e a 20 gradi: dunque, arrotolato in un pezzetto di carta qualsiasi, dopo un momento, esso deve facilmente prendere fuoco e incendiare tutte le carte entro l’urna nella quale si sarà deposta questa scheda elettorale di nuovo genere»).
In seguito ad alcune imprese di questo genere, egli acquistò grande ascendente sui compagni. Aveva acquistato sicurezza. Benché fosse il più giovane, lo ascoltavano, gli obbedivano, gli chiedevano consiglio. Non si cominciava mai una riunione prima del suo arrivo. Era diventato un leader.
Ma passava la maggior parte delle sue giornate al lavoro e sempre altrettanto seriamente. Non pensava, non aveva mai pensato di fare altrimenti. Fu la polizia a decidere per lui.
Appena un mese dopo l’ordine di scarcerazione, quattro ispettori fecero la loro comparsa dai Jacob, muniti di un mandato di perquisizione. Alla prima parola di protesta, essi erano pronti a portarselo via di nuovo e lui lo sapeva. Assistette quindi senza aprire bocca al saccheggio dei cassetti di sua madre. Quando se ne furono andati, si sarebbe detto che un’orda di Unni fosse passata di lì. Joseph, come dopo una sbronza, rimase a lungo seduto su una sedia in cucina, a meditare in mezzo al cataclisma. Marie si aggirava come una furia tra le stanze devastate.
– Bisogna fare qualcosa! – gemeva fra i singhiozzi soffocati. – Non è possibile! Non ne hanno il diritto! Siamo in una Repubblica!
Solo Alexandre pareva avesse mantenuto il sangue freddo. Quindici giorni dopo, il saccheggio si rinnovò. E quindici giorni dopo ancora. E così ogni quindici giorni, regolarmente.
I vicini, dapprima impietositi per le disgrazie della signora Jacob, si misero allora ad evitare la drogheria secondo il principio che non c’è fumo senza fuoco. Alcuni, come Rolande e suo padre, l’impiegato alle poste, particolarmente preoccupati della loro onorabilità, evitavano ormai di salutarli.
Altri parlavano per allusioni perfide o con domande ipocritamente astiose. Marie si scatenò contro quella muta di cani. S’infuriò, a volte anche a sproposito.
I nervi a fior di pelle, non sopportava che si facessero commenti su suo figlio. Gettò un cartoccio di ceci in faccia alla sua più cara amica. Il capo eretto, passava per strada, infischiandosene delle calunnie, seguendo provocante con il sorriso più radioso quelli che cambiavano marciapiede scorgendola, costringendoli a stringerle la mano.
Mai un solo momento si chiese se la sorveglianza di cui era oggetto Alexandre fosse giustificata o meno. Lui le aveva spiegato il significato della sua attività. Le aveva dato la sua versione dei fatti. Questo bastava. Non mentiva, lui. Gli voleva bene. Ci teneva a fare la sua parte, nelle prove che lui subiva. All’inizio, non aveva capito i suoi accessi di collera né la violenza di alcuni dei suoi propositi. Adesso, davanti alla vigliaccheria generalizzata che vedeva attorno, lei provava i suoi stessi sentimenti. La sua rivolta non era nata da convinzioni profonde, ma dalla rivelazione insopportabile che proprio coloro per cui Alexandre e i suoi amici si impegnavano, erano i primi a perseguitarli. Il risultato era lo stesso, e cioè la rivolta.
Joseph, vedendo sua moglie trasformarsi in rivoluzionaria, non osava dir nulla: senza dubbio era la cosa migliore da fare.
Alla quinta visita dei poliziotti, Alexandre infine alzò la voce.
– È così che contate di farmi rinunciare alle mie idee? – domandò nel modo più calmo possibile.
Gli fu consigliato di rivolgersi al commissariato. Cosa che fece. Il senso di quel colloquio fu chiarissimo. Il commissario agiva in tal maniera esclusivamente per proteggere Jacob contro se stesso. Per spingerlo a ritornare sulla retta via. Per il suo bene, insomma. Gli anarchici che si dichiaravano nemici della società non dovevano meravigliarsi che questa si difendesse contro di loro come meglio poteva.
Alexandre fece osservare che i suoi genitori non c’entravano per niente in una faccenda che tuttavia li vedeva tra le vittime principali. Il commissario parve allora riflettere.
– Un mezzo ci sarebbe – disse. – Fate onorevole ammenda. Scrivete al prefetto. Vedremo poi quel che potremo fare, in funzione delle prove di buona volontà che avrete dimostrato.
– Cioè?
– Mettetela come volete – replicò l’uomo freddamente. – Via! Un po’ di buon senso! Un ragazzo intelligente come voi, non vorrete alla vostra età rovinare la vostra vita con quella gente! Lavorate per noi! Nessuno ne saprà niente...
Alexandre s’infuriò. L’altro lo fermò subito:
– Potrei schiaffarvi dentro su due piedi per oltraggio, se preferite.
Il colloquio era terminato.
La settimana dopo, avviandosi come al solito alle otto al lavoro, vide il suo padrone che l’aspettava sulla soglia.
– Il commissario Fabre è venuto a trovarmi poco fa — cominciò il tipografo.
Alexandre lo lasciò impegolarsi nel suo discorso con un briciolo di sadismo per vedere fin dove sarebbe arrivato il coraggio di quello. Arrivò fino ad una banconota da 50 franchi contornata di belle parole.
Così si ritrovò a diciannove anni senza lavoro e senza possibilità di trovarne, spiato probabilmente da confidenti vittime dei ricatti di Fabre, braccato dalla polizia, i suoi genitori sistematicamente rovinati e indicati a dito nel quartiere, infastidito, recidivo, tra non molto sicuramente ridotto alla fame (dove trovare del denaro per sopravvivere?) tutto questo per aver creduto di potere esprimere impunemente la sua riprovazione contro l’ingiustizia della società. Lui non aveva né ucciso né rubato né lanciato bombe. Aveva incendiato delle urne elettorali, ma nessuno lo sapeva. L’unico crimine che gli si potesse imputare era di voler liberare gli uomini proprio dal genere di tirannia che stava subendo lui.
Le guance arrossate, girovagò a lungo per le strade di Marsiglia, martellando il selciato con il suo furore, assetato di vendetta, disperato. A Marie, carica di debiti, non rimaneva che l’ultima risorsa: andare a trovare quello che lei chiamava “la scimmia”, un commissionario del Monte di Pietà che le aveva ricomprato per una somma ridicola i titoli di proprietà di tutto quel che lei aveva già impegnato al Credito municipale, ossia tutto quello che possedeva. Se entro un anno lei non avesse potuto pagare gli interessi da quello reclamati (all’incirca il 60 per cento del totale) lei e Joseph si sarebbero ritrovati sul marciapiede senza niente. Come vagabondi. (Protetto dall’articolo 411 del Codice Penale, che puniva con il carcere e con una multa coloro che, senza autorizzazione, istituivano o gestivano monti di pegno, il commissionario faceva a quei tempi ottimi affari. Il poveraccio a cui i prestiti del Credito municipale non bastavano per sbarcare il lunario lo andava a trovare. Allora quello gli dava qualche somma supplementare, stipulando un accordo per cui il cliente gli cedeva la completa proprietà dei suoi beni se non fosse riuscito a rimborsare i prestiti in tempo: cosa che avveniva nove volte su dieci. A quel punto non restava che rivendere gli oggetti con un notevole guadagno. Tale mestiere venne proibito poco prima della guerra del 1914).
Per strada gli venivano le idee più strane. Soprattutto una: la più semplice, la più seducente, procurarsi un paio di revolver, cosa semplice in quanto questi erano in libera vendita e, l’ultimo giorno, quando tutte le soluzioni fossero state tentate invano, quando fossero venuti a portar via la casa, i mobili e la bottega, ritornare al commissariato, chiedere di Fabre, crivellarlo di proiettili, contemplare il suo ghigno sorpreso, non senza avergli prima spiegato pacatamente come lui stesso avesse armato il braccio che l’uccideva, poi vendere cara la pelle.
– È triste – diceva ad alta voce fendendo la ressa – è triste avere 19 anni, quando la vita potrebbe essere così bella.
In due parole, raccontò i fatti a Marie. Lei si mise a piangere.
– Vorresti che andassi da Fabre e accettassi la sua proposta? – chiese.
Lei rifletté un momento, non certo sul senso della sua risposta, quanto sulle parole da usare. Poi si sfogò.
Se lei andava fiera per la strada, era perché era orgogliosa di lui. La dignità era il solo bene che rimanesse loro. Non bisognava sciuparlo. Aveva più stima per lui per quel che aveva fatto che per l’altro figlio Brun che era entrato al Politecnico ed era diventato generale. Non sapeva come ne sarebbero usciti. Ma sarebbe stato a testa alta. Se bisognava mendicare, l’avrebbe fatto e anche suo padre, lui non la conosceva. Gli avvenimenti le avevano aperto gli occhi. Lei non aveva voluto credere che il mondo fosse tanto malvagio. E aveva avuto torto. Adesso, lei non aveva fatto granché ma lui, bisognava che riuscisse. Non parlava di riuscita sociale, lui lo sapeva bene. Domani, se facevano la rivoluzione con i suoi compagni, lei sarebbe andata sulle barricate al suo fianco e gli avrebbe passato i fucili. E se lui non ci fosse andato ebbene ci sarebbe andata da sola.
Gli cadde tra le braccia singhiozzando, in preda ad una vera crisi di nervi. Alexandre dovette calmarla. Lei voleva prendere un bidone di petrolio e incendiare il quartiere. Voleva andare a trovare i compagni di suo figlio per organizzare una insurrezione, impadronirsi del municipio, della prefettura, delle esattorie, del Monte di Pietà, della gendarmeria, radere tutto al suolo. Lui fece fatica a spiegarle che le cose non erano così semplici.
Egli però non rinunciò alla sua idea. Roques gli procurò i revolver. Se li tastava attraverso gli abiti ogni volta che incrociava le guardie municipali. Allora le squadrava con arroganza, sperando di essere interpellato per avere l’occasione di tirarli fuori. Era ossessionato da visioni catastrofiche. Era pronto a tutto.
Matha cercò di calmarlo:
– Stai attento a quel che fai – gli disse. – Ci sei più utile da vivo che da morto. Non conosco le tue intenzioni e non desidero conoscerle. Ma rifletti sulle conseguenze. Ricordati di Emile Henry.
L’osservazione era sensata. Avrebbe voluto essere nella condizione di ascoltarlo. Ma non era il suo caso. Era preso dalla rabbia. Non la si cura con le buone parole.
Fu in quell’epoca che la ragazza dalla veletta fece una nuova apparizione, una sera, nella sala posteriore della “Brasserie du Midi”, alla fine di una riunione, nel momento in cui se ne stavano andando. Pallida, il volto tirato, come esausta, quando venne diritta verso di loro, sgorgarono le esclamazioni.
Si chiamava Rose. La conoscevano tutti. E lui che l’aveva cercata per tutta Marsiglia! Era stata anche la donna di Clarenson, quel compagno che ora stava scontando tre anni per furto nella prigione Chave, dove l’aveva incontrato Alexandre.
Lei lo riconobbe immediatamente.
– Tu sei quello che s’è preso sulla testa uno sgabello destinato a me, alla “Brasserie de Noailles”! – esclamò.
Egli arrossì e farfugliò qualche banalità. Lei andò a sedersi vicino. Da quanto tempo era militante? Perché non si erano incontrati prima? Gli altri se ne andavano alla spicciolata senza che loro vi badassero: si ritrovarono soli.
Alexandre diede sfogo alla sua collera. Parlò dei suoi desideri di morte, del senso di impotenza che lo sommergeva, della sua avversione verso il complotto generalizzato della mediocrità soddisfatta, satolla, rigonfia, egoista, chiacchierona, scaltra, subdola, ipocrita: non finiva più di parlare.
– Non fa niente – mormorò lei. – Tu non hai il diritto di gettarti nelle fauci del lupo.
Poi parlarono di Clarenson, che era soprannominato “il barone” per una certa ricercatezza nell’abbigliamento e nel parlare, dovuta ad una eccessiva frequentazione del casinò. Alexandre aveva passato due settimane in cella con lui. Conservava il ricordo di uno strano personaggio, coraggioso ma consumato dal vizio, ribelle ma per desiderio di accedere ad una categoria sociale superiore, a volte incoerente ma machiavellico nelle sue astuzie: certamente anarchico, ma non rivoluzionario. Era dunque lei quella Rose di cui Clarenson si accusava di avere rovinato la vita.
La riaccompagnò fino a casa, una sordida camera ammobiliata in un vecchio stabile vicino al porto e ottenne di poterla rivedere l’indomani. Lo affascinava. Era proprio la prima donna che... Ma questo per niente al mondo l’avrebbe confessato. Le teorie libertarie, aggravate dal temperamento latino, lo rendevano inetto al ruolo del seduttore.
Condusse il suo assedio come un eccellente generale. Un bombardamento a tappeto di appuntamenti e di incontri apparentemente casuali. Imboscate nei caffè, tutta una rete di trincee e di contro-trincee, un turbinio di colloqui, di furore, di speranze e di complicità. L’assalto finale fu sferrato. Ottenne di salire in camera sua (una tana, più che un appartamento) e la prese tra le braccia.
La sua foga la inquietò, ma anche lui ebbe paura di lei. Lei aveva vissuto troppo per non temere di soffrire ancora. Decisa, si liberò dall’abbraccio, facendo violenza più a se stessa che a lui. Lui voleva troppo e subito, il corpo, il cuore e lo spirito. Non sapeva neppure chi era lei. Se poi l’avesse disprezzata quando avesse saputo?...
Quando avesse saputo cosa?
Allora, con la sua voce un po’ rauca, semidistesa vicino a lui sul letto, l’unico posto su cui sedere in quella camera, gli raccontò la sua storia, banale come un romanzo d’appendice da cinquanta centesimi.
Sua madre le aveva abbandonate, sua sorella Jeanne e lei. Le suore le avevano tirate su a randellate, all’Istituto delle Ragazze pentite. Erano state mandate a lavorare come cameriere a quindici anni. Lei, carina com’era, veniva perseguitata dai padroni con le loro mani sudaticce, nei corridoi. E anche dai figli, molto spesso, dei gran babbei foruncolosi. Questo non le andava. Voleva rimanere pura per l’Amore. La cacciarono via. Le suore la punivano. Era andata avanti così fino a quando fu maggiorenne.
Due anni dopo, se ne ricordava ancora, lavorava presso i Carcassone, in rue Condorcet, era cascata su un tipo che le aveva promesso mari e monti. Un anarchico. Un giocatore, soprattutto. Clarenson. Era stata felice per qualche tempo, con lui. Nei periodi in cui vinceva, si faceva la bella vita. L’indomani non c’era più niente in casa. Era più forte di lui. Avrebbe venduto sua madre per rischiare qualche moneta ad un tavolo. Aveva cominciato a svaligiare, con Bonnefoy che lo seguiva ovunque. Avevamo fatto grossi colpi. Due volte avevano dovuto sparare sui poliziotti. Clarenson aveva finito per essere catturato. Nel 1891, prima di conoscerla, s’era già buscato tre anni a Bordeaux. L’avevano tirato fuori di prigione per internarlo in manicomio. Non era veramente pazzo, ma non era neppure normale, lei se ne accorgeva adesso. Irascibilissimo. Aveva crisi di nervi. Si rotolava per terra. Con mal di testa terrificanti, quando stava male, soprattutto alla tempia sinistra. A volte, bastava toccarlo, sfiorarlo appena perché si mettesse a urlare. Poi si calmava. Era isterico, dicevano i medici. Suo padre era epilettico.
Nel 1894 s’era di nuovo preso tre anni, alle Assise di Aix, stavolta. Non s’era più potuto tenerlo in carcere. I medici l’avevano internato al manicomio Saint-Pierre, a Marsiglia. Lei, in quel periodo, s’era trovata senza un soldo. Sua sorella l’aveva aiutata un po’, all’inizio. Poi aveva cercato un lavoro. Senza titoli di studio, aveva dovuto accettare quel che veniva. Due posti, tre e poi più niente. La strada. Il marciapiede. Aveva vissuto così per sei mesi. Non le aveva nemmeno fruttato molto. Aveva vergogna. Aveva paura. Fuggiva quando gli uomini l’abbordavano. Le professioniste la trattavano da smorfiosa. La detestavano. Quando Clarenson era uscito, l’anno dopo, s’erano rimessi insieme. Ma lui era diventato un tiranno. Con frasi perfide la spingeva a ritornare al marciapiede. Lei lo disprezzava perché non riusciva a smettere di giocare. Così, quando lui era stato ripreso, quattro mesi dopo, lei l’aveva lasciato. Si era fatta riassumere come cameriera. Ma il padrone, scoperto il mestiere che aveva fatto, l’aveva messa alla porta, senza neppure pagarle quanto le spettava. Questo accadeva due settimane prima. L’altro giorno, quando era passata alla Brasserie du Midi, aveva l’intenzione di chiedere denaro in prestito a qualcuno, a Bonnefoy ad esempio. Ma Bonnefoy non c’era. E poi si erano messi a chiacchierare, loro due. Adesso, quale soluzione le rimaneva per sopravvivere, se non quella di riprendere quella vita?
Alexandre l’aveva desiderata sin dal primo giorno, alla Brasserie de Noailles. In quel momento, era per lui la cosa più cara al mondo. L’aveva immaginata una regina in esilio: era una puttana. Più nobile di tutte le duchesse, di tutte le vergini e di tutte le bellezze rispettabili. Pura, anche nella sua degradazione sociale. Perseguitata come lui e come lui ribelle. Senza dubbio, ragazza onesta, gli sarebbe ugualmente piaciuta. Ma non con la stessa intensità. Aveva dovuto superare una prova che a lui sarebbe sempre stata risparmiata.
Quell’ingiustizia ridestò il bisogno di proteggerla. Le giurò che non avrebbe mai più dovuto vendere il suo corpo. Si sarebbe occupato lui di tutto. Avrebbe trovato del denaro. L’avrebbe resa felice.
Lei sorrise con indulgenza alle ingenuità di quel ragazzo di vent’anni che credeva con un giuramento di poter cambiare il mondo. Lui si adirò per davvero: lei aveva scrupoli e reticenze da borghese. Era corrotta dai pregiudizi di casta, lui lo vedeva bene. Lei aveva vergogna di quel che aveva fatto. Lui le avrebbe insegnato ad andarne fiera.
L’operaio prostituisce le proprie braccia al padrone. La sarta prostituisce i suoi occhi all’ago, per un salario miserevole. Tutte le prostituzioni si equivalgono. Solo la morale borghese, che considera peccaminoso l’atto sessuale, vi vede una differenza. Il Cristo stesso ha amato e rispettato Maria Maddalena. I preti in genere preferiscono dimenticare questo capitolo della vita del loro eroe preferito. Dà fastidio ai vescovi, impedisce la digestione nei loro drappi di seta, tra gli ori e i gioielli, che il loro buon Dio abbia potuto amare una donna perduta! Ma era certamente l’unico episodio edificante della loro religione di parassiti.
Ah, la bella morale! Non amarsi che nei sacri vincoli del matrimonio! Un sacramento da mercanti del Tempio! Una verginità più una dote in cambio di una posizione sociale: un volgare contratto di vendita! Questa era la vera prostituzione, laida, ipocrita, felpata, viziosa! Le ragazze per bene barattavano per contratto il loro corpo contro un nome, una carrozza, dei vestiti, un castello: lo chiamavano amore, quelli dell’alta società! Bell’amore, dove ci si nasconde per ingannare il proprio marito, l’ignobile parola, per commettere l’adulterio, parola ancor più abietta! Era per distruggere tutto questo, per restituire la loro bellezza alle cose che Alexandre si batteva. Se Rose non ci credeva, se dubitava di lui, se non gli dava la sua fiducia in tutto, su tutto, allora voleva dire che lui s’era sbagliato sul suo conto. Lei non era che una sconfitta. Lui era disposto a riprendere il suo cappello e andarsene.
Lei lo trattenne. Si abbandonò. Divenne la sua amante e lui divenne, da quel momento, il suo uomo. Se la sua fede non aveva ancora sconvolto nulla, lei gli permetteva quantomeno di aprire una piccola finestrella di speranza sulla vita di quella ragazza rassegnata al proprio destino.
Alexandre era assolutamente sincero nelle sue dichiarazioni: il resto della sua vita basterà a provarlo. Rose non era stata che una sgualdrina occasionale. La miseria era il suo vero mestiere. Prima d’essere colpevole, lei era vittima. Era questo che le dava diritto alla considerazione di Alexandre. Lui la trovava bella; gli piaceva; lui credeva alle virtù del libero amore: che cosa di più naturale che farne la propria compagna?
Dobbiamo aggiungere che nessun’altra donna indubbiamente sarebbe stata tanto devota né tanto qualificata per assecondarlo nella pericolosa lotta in cui lui s’era gettato. Senza dubbio lui l’amava. Ma soprattutto amava attraverso lei una certa idea del mondo. Per lei, avveniva l’opposto: lei amerà innanzi tutto l’uomo e poi l’anarchia attraverso di lui. I giudici, che non sono poeti, non entreranno d’altronde mai in simili dettagli: essi arricceranno semplicemente il naso a sentire degli amori colpevoli di un ladro e di una donnaccia di quindici anni più vecchia.
Qualche giorno dopo, Alexandre avvertì sua madre che non avrebbe più dormito a casa. Il pretesto avanzato fu che così il commissario Fabre avrebbe forse rinunciato alle sue perquisizioni. Ma il profumo di Rose gli aleggiava ancora addosso. Marie glielo fece notare. E allora lui confessò.
Un vecchio rimasuglio di cattolicesimo in lei si scandalizzò un poco per quello sposalizio biblico. Ma lui le fece osservare che non poteva accettare le idee libertarie a metà. Se lei era d’accordo con lui sul resto, doveva accettare anche questo. Insomma, lei chiese di vedere l’oggetto di una passione tanto improvvisata. Rose si mostrò sotto i1 suo aspetto migliore, dolce e premurosa. Fu presentata a Joseph come la “fidanzata” di Alexandre. Lui non si lasciò abbindolare. Ma le rotondità avvenenti della sua nuora in anarchismo eccitavano tanto il vecchio ubriacone da fargli dimenticare i suoi scrupoli.
Qualche giorno dopo, un compagno trovò un nuovo lavoro per Alexandre: garzone di farmacia. Mettendosi a lavorare di buona lena, in tre anni di pratica, poteva ottenere il diploma e diventare farmacista di seconda classe. Già si vedeva a rimborsare i debiti di sua madre, competente, alla ricerca di nuovi rimedi alle sofferenze degli uomini. Si gettò a corpo morto nella farmacia.
Fu un periodo di intensa felicità. Aveva abbandonato i suoi progetti di vendetta. Vedeva poco gli amici: non ne aveva neppure il tempo. Matha era ripartito per Parigi con il suo gruppo. Malato, venuto a passare otto giorni, non s’era attardato oltre: con Sébastien Faure, Pouget, Octave Mirbeau e tutti gli altri, s’era lanciato a fondo nell’affare Dreyfus. La pubblicazione del “Libertaire” e quella del “Père Peinard” era stata interrotta dall’inizio dell’anno perché ognuno potesse dedicare tutto il suo tempo a un nuovo quotidiano, il “Journal du Peuple”, ferocemente pro-Dreyfus. Malato era indaffaratissimo. La borghesia manifestava un antisemitismo talmente ignobile che difendere il povero capitano gli sembrava l’occasione agognata di cavalcare finalmente un buon cavallo di battaglia. Preparava la lotta insieme (per una volta) ad alcuni repubblicani... Alexandre ascoltava tutto ciò con orecchie distratte.
Soltanto Roques lo inquietava un po’. Vittima a sua volta del commissario Fabre che l’aveva fatto cacciar via dal nuovo tipografo, s’era lanciato nella espropriazione individuale. Giacché gli impedivano di vivere nella legalità, aveva deciso di mettersi al di fuori della legge. Incitava Alexandre a fare altrettanto. Questi lo approvava completamente: riprendere ai ricchi quel che hanno rubato ai poveri era quasi un dovere. In ogni caso, una linea di condotta perfettamente giustificata e dignitosa. Ma in quel momento, non senza rimorsi a volte, egli preferiva andar per erbe alla domenica con Rose, in campagna, cogliere degli esemplari di vegetali e studiarli nel suo libro di botanica, dopo aver fatto all’amore sotto il sole.
La sera, rientrava direttamente nella sua stanza ammobiliata. Lei lo aspettava. Aveva preparato da mangiare. I compagni venivano a cena. Si attardavano in futuri progetti. Ricostruivano il mondo. Preparavano le future lotte che finalmente avrebbero reso felice l’umanità.
Questo intermezzo idilliaco fu di breve durata. Un mattino del marzo 1899, un uomo entrò nella farmacia. Chiese di parlare al padrone e si trattenne qualche minuto con lui nel retrobottega. Alexandre aveva capito. Si tolse il camice bianco e lo posò sul bancone.
– Voi capite, se la mia clientela venisse a sapere... – gli disse il farmacista.
– Voi maneggiate qui sostanze pericolose...
Due ore dopo, Marie giungeva in lacrime da Rose. Fabre era ritornato con i suoi uomini. Aveva devastato tutto, secondo la sua abitudine. Inoltre, stavolta, un ispettore le aveva confiscato il suo unico gioiello, un anello di fidanzamento, con il pretesto che era troppo bello per lei e che doveva averlo rubato.
Alexandre ascoltò senza batter ciglio. Poi abbozzò uno strano sorriso.
– Benissimo – disse. – Ci divertiremo.
* * *
– Quale è il vostro mestiere?
– Ramo demolizioni.
– Dove abitate?
– Un po’ in tutto il mondo.
– Avete dovuto servirvi di molti informatori?
– Parlate come un magistrato. Se foste uno svaligiatore, sapreste che non abbiamo bisogno di nessuno. Quando arrivo in una città, se vedo ciminiere, mi dico: qui c’è gente che lavora, niente da fare. Ma quando vedo dimore borghesi che sono chiuse, non ho bisogno di altre informazioni
– Voi ve la prendete soprattutto con le chiese.
– Certamente. Se dovessi descrivere tutti i delitti commessi dai preti in nome di Dio: l’inquisizione, le guerre di religione, gli assassini degli amici della verità, non basterebbero parecchie udienze. La religione è morta. La scienza l’ha uccisa. Non calpesterò un cadavere.
Con la scusa di procurare le delizie del mondo ultraterreno, con delle pagliacciate, loro guadagnano ricchezze. Ne posso parlare con conoscenza di causa. Ho rapinato parecchi preti. Da tutti ho trovato una cassaforte e a volte più di una. Non contenevano aringhe affumicate, vi prego di credermi. Se contenevano qualche etto di pane per le ostie, c’erano anche le grosse somme che degli imbecilli spedivano a Dio e che i portasottana custodivano.
Ecco i ciarlatani che osano chiamarmi ladro. Ecco i truffatori che invocano su di me i fulmini della legge! Bisogna ammettere che hanno una bella faccia tosta!
Comunque, poiché sono magnanimo, voglio accordare loro la mia assoluzione.
E così sia.
* * *
I1 31 marzo 1899 un commissario di polizia fasciato di una sciarpa tricolore, seguito da due ispettori e munito di un mandato di perquisizione, si presentava alle due del pomeriggio dal signor Gille, commissionario del Monte di Pietà di rue Petit-Saint-Jean. Costui era sospettato di avere in suo possesso un orologio rubato in seguito ad un quadruplice omicidio. Non era ancora accusato di complicità e di ricettazione, ma poteva esserlo.
Il signor Gille, sconvolto, una mano sul cuore, non ebbe alcuna difficoltà a mostrare i suoi libri contabili. I poliziotti chiusero con il catenaccio la porta d’entrata, tirarono le tende e appesero il cartello “Chiuso”.
Poi gli fecero aprire le casseforti. Uno alla volta, ne tolsero i gioielli, orologi, orecchini, candelabri, titoli, polizze, vasellame, posate. Uno di loro spuntava sui registri. L’altro ricopiava accuratamente la descrizione degli oggetti e il loro valore presunto su un foglio di carta con l’intestazione della Prefettura. Il terzo li riponeva dentro ad alcuni sacchi predisposti a questo scopo. L’inventario, interrotto da commenti sarcastici, durò tre ore piene sotto lo sguardo dolente e impotente della signora Gille e di un impiegato. In tutto, c’era merce per più di quattrocentomila franchi oro.
– Allora, brav’uomo – sogghignò uno degli ispettori, di nome Pons, quando tutto fu svuotato – oseresti negare ancora di essere un lestofante?
Il signor Gille giurò che la sua buona fede era stata sorpresa, che lui era un commerciante onesto e che se qualche irregolarità s’era introdotta nei suoi conti, il suo impiegato ne era l’unico responsabile.
– Ispettore, fate chiamare delle carrozze – tagliò corto il commissario. – Spiegherete tutto al procuratore della Repubblica e vedremo un po’ se vi crederà.
Generale fu la prostrazione nella botteguccia. Gille e il suo impiegato, ridotti a pasta frolla, si lasciarono infilare le manette senza opporre resistenza. Due vetture di piazza si fermarono dinanzi alla porta e i prigionieri, saldamente tenuti dall’ispettore Pons, salirono sulla prima sotto lo sguardo beffardo dei vicini. Sulla seconda presero posto il commissario, l’altro ispettore e i sacchi contenenti gli oggetti della controversia.
Giunti in rue Breteuil, il poliziotto che stava a guardia dei sospetti pagò la corsa e li trascinò con sé sotto la volta del palazzo di Giustizia. Il secondo veicolo non si vedeva, ma non doveva essere lontano. Il terzetto si diresse con passo rapido verso l’ufficio del procuratore. Nell’anticamera, Pons fece sedere il commissionario e il suo assistente su una panca.
– Aspettatemi qui – ordinò.
Poi entrò nell’ufficio del magistrato, da cui uscì qualche istante più tardi, per dire loro, riprendendosi le sue manette:
– Il procuratore è occupato. Vi interrogherà. Io mi assento un momento. Inutile tentare di scappare, vero? Non andreste lontano.
I due uomini rimasero a lungo senza muoversi, seduti sulla panca come sui carboni ardenti. Passò un’ora, poi due. Scese la sera. L’ispettore non tornava. L’andirivieni stava sempre più scemando nella sala. Passò il momento della chiusura degli uffici.
– Il portiere, nel suo giro quotidiano di ispezione, finì per mostrarsi con il suo mazzo di chiavi in mano:
– Che diavolo fate lì, voialtri? – esclamò.
Balbettando, gesticolando infuriato e disperato, il commissionario cercò di spiegare che era innocente, che ce l’avevano con lui, nelle alte sfere, lui sapeva bene chi, ma che lui aveva amicizie ancora più su. Il portiere, preoccupato per quella furia che gli sembrò sospetta e per un discorso tanto incoerente, si mise alla ricerca di un magistrato qualunque. Finì per scovare un giudice istruttore subissato di pratiche che, desideroso di tornarsene a casa, firmò un ordine per sbattere in prigione “quei furbi”. Avrebbe chiarito la cosa l’indomani ad ore ragionevoli.
Il commissionario messo dietro alle sbarre senza molte spiegazioni tempestò, supplicò tanto e così bene che all’alba del l° aprile un brigadiere della gendarmeria esasperato s’interessò alla sua sorte. Gli fece qualche domanda e, piuttosto perplesso, fece rapporto al tenente su quel caso che superava le sue competenze. Costui s’informò sul nome del commissario che aveva proceduto alla perquisizione: Laurent. Lui non lo conosceva. Di quale brigata? Mistero. I suoi ispettori? Uno si chiamava Jules Pons. Controllò. S’informò. Poi perse davvero la testa. Non c’era alcuna traccia né di Laurent né di Jules Pons da nessuna parte. Dovette arrendersi all’evidenza: tutto ciò non era che una spaventosa burla. Un solo elemento purtroppo non aveva nulla del pesce d’aprile: il furto di 400.000 franchi.
Marsiglia e ben presto tutta la Francia furono scosse da irrefrenabili risate. Tutti (ed erano numerosi) quelli che avevano avuto a che fare con un commissionario si sentirono vendicati.
Alexandre Marius Jacob aveva, con un colpo stupefacente che prefigurava il suo “stile”, aperto le ostilità contro una società che ce l’aveva con lui. Iniziava una battaglia, un incredibile spettacolo di burattini nel corso del quale il gendarme sarebbe stato regolarmente, voluttuosamente bastonato. Un’opera da quattro soldi il cui eroe rubava ai ricchi i loro milioni solo per restituirli ai poveri, tenendosi per sé solo un lusso: il riso. Quello, insolente, del Robin Hood della Belle Epoque al quale alcuni l’avevano paragonato, che svaligia il commissionario per vendetta, perché costui ha derubato senza scrupoli i disgraziati in generale e Marie in particolare e quindi spinge la farsa fino a trascinarlo addirittura al palazzo di Giustizia per una raffinatezza, per puro piacere estetico.
Questo è lo stile che adotterà Arsène Lupin, ma da gran borghese vagamente aristocratico, a suo completo agio in quel gran mondo che frequentava Maurice Leblanc suo creatore e che Jacob disprezzava sommamente.
Leblanc non voleva ammettere di essersi ispirato a lui. Non senza ragione. Abbiamo qui a che fare con un ammirevole esempio di rimasticatura aiutata da una salsa letteraria di un personaggio imbarazzante: spogliato di tutto quel che faceva paura in lui, armato di un monocolo, vestito in frac, la bombetta sostituita dal cilindro, Jacob ottenne il trionfo sotto il nome di Lupin. Il subcosciente facilmente tremebondo dei lettori dell’inizio del secolo, di cui la maggioranza non era sicuramente di estrazione operaia e che aveva tremato dinanzi agli attentati anarchici, fu rassicurato dal soavissimo uomo in monocolo. Nulla del resto prova che, settant’anni più tardi, non accada lo stesso.
Ad ogni modo, l’unico infimo rammarico di Alexandre a proposito dell’episodio di rue du Petit-Saint-Jean fu di non aver potuto recitare lui il ruolo del commissario: a vent’anni un grado così alto non sarebbe stato convincente. Roques, con i suoi capelli brizzolati, si confaceva meglio al personaggio. Quanto al terzo ladro, Morel, un compagno dell’“Agitateur”, era stato lui a sentire in prigione, dalla bocca stessa di un criminale, la storia dei quattro omicidi e dell’orologio rubato depositato da Gille. Lui l’aveva raccontata a Jacob, che aveva organizzato il piano e l’aveva fatto ripetere agli altri. Ultimo particolare: la sciarpa tricolore di Roques era stata dipinta da Marie in persona e abbellita con il capo del bracciale della prima comunione di Alexandre cucito per bellezza a guisa di coccarda.
Le investigazioni della polizia non diedero assolutamente alcun esito. Il terzetto, ventiquattr’ore dopo, si trovava già in Spagna. Morel ritornò poco dopo. Alexandre, seguito da Roques, proseguì il suo cammino. Cambiarono senza difficoltà la loro parte di bottino. Versamenti all’ordine di Marie Jacob e di Rose Roux si misero a piovere a diversi fermo-posta, sufficientemente generosi perché la prima potesse rimborsare i suoi debiti e la seconda non dovesse più battere il marciapiede. Buona parte del rimanente trovò impiego immediato.
La lotta aveva assunto in Spagna proporzioni spaventose. Persino liberali (che i due francesi ebbero occasione di incontrare), liberi pensatori, borghesi, certo, ma umani, se ne mostrarono scossi. Il denaro non poteva cauterizzare le ferite dei compagni iberici. Poteva però alleviare la loro indigenza materiale e morale ed aiutarli a preparare le future battaglie. Alexandre donò senza risparmio: all’incirca 50.000 franchi in tutto, sicuramente la somma più grossa che entrasse a quel tempo nelle casse militanti. Roques si mostrò più parsimonioso: in nome di un individualismo che in quell’occasione il suo amico bollò come volgare egoismo, recalcitrò nel vuotare le tasche a vantaggio di sconosciuti.
I loro occhi si spalancavano al racconto insopportabile delle torture inflitte dalla polizia. A Montjuich alcuni prigionieri avevano dovuto bere la loro urina, altri il petrolio fetido delle lampade. Alcuni avevano subito il supplizio dell’affogamento: legati a palla, braccia e gambe annodate dietro la schiena, erano stati gettati a mare per non farveli uscire che al limite dell’asfissia; altri, imbrigliati come cavalli, imbavagliati, avevano dovuto galoppare sotto i colpi di frusta; altri erano stati privati del sonno per parecchi giorni a forza di bastonate. Nulla era cambiato dalla grande Inquisizione, se non il pretesto: le persecuzioni attuali non venivano più inflitte in nome della religione, ma in quello della ragione di Stato. Ogni disgraziato sospettato di avere messo in discussione l’articolo unico che costituisce il dogma degli Stati moderni: “rispettare, quale esso sia, l’ordine costituito” era sottoposto alla questione preliminare. Ancora i grandi inquisitori assistevano alle sofferenze dei loro pazienti. Ancora certuni perdevano conoscenza per “simpatia” con quelle anime ch’essi intendevano salvare a prezzo dell’agonia della carne. Qui, governatori, duchi e generali continuavano a condurre una vita raffinata in meravigliosi palazzi, mentre i loro sbirri, essi stessi figli di operai e di contadini, si accanivano ai loro ordini. Che cosa, se non il cattolicesimo aggravato dal capitalismo, aveva potuto svilire l’uomo peggio che un cane? Quali istinti immondi si scatenavano, qui? Bruciare le carni con un attizzatoio incandescente; strappare le unghie dopo avervi conficcato sotto dei cunei d’acciaio; schiacciare gli organi sessuali; veniva utilizzato persino il buon vecchio elmo di ferro medievale, che si incastrava attorno alla testa e che, grazie ad una vite, comprime il cranio e spezza il naso e la bocca. Alcuni, come Luis Mas, avevano perduto la ragione sotto quelle torture. Moltissimi innocenti si erano accusati di delitti mai commessi. La maggior parte, malgrado avessero il corpo devastato, erano morti da eroi. Tutti, naturalmente, erano definiti dalla propaganda governativa, ripresa dalla stampa benpensante, come banditi con l’unico scopo di saccheggiare, bruciare, uccidere. Sostenuti da un complotto finanziato dall’estero, loro unico obiettivo era evidentemente quello di rovinare la Spagna per instaurarvi il caos anarchico.
I superstiti (tra i quali cominciava a farsi conoscere Francisco Ferrer) tentarono di ricostituire la Federación de Trabajadors de la región española a Madrid, a Barcellona, nelle Asturie. Oltre ai fondi, mancavano loro in modo disperato i contatti con il movimento francese. Alexandre, durante gli incontri che ebbe con loro, promise di fare quel che poteva.
Decise di fare qualcosa sin dal suo ritorno in Francia, nazione che gli parve un faro di civiltà dopo quel viaggio nel fondo dell’orrore, come scrisse in una lunga lettera a Matha.
D’altronde, s’era dato appuntamento con Rose ad Aix.
Ebbero appena il tempo di rubare poche brevi notti d’amore agli eventi: egli venne subito a sapere da una cameriera con cui lei aveva lavorato tempo prima, dei traffici che un certo notaio del luogo organizzava con il denaro dei suoi clienti, così come della maniera in cui trattava i suoi domestici.
Non ascoltando che il suo senso del dovere, alla prima occasione si infilò nella casa di quell’uomo. La sua destrezza non andava purtroppo di pari passo con la buona volontà e la cassaforte gli resistette come un cosciotto d’agnello ad uno sdentato. Dovette accontentarsi di trentamila franchi (e non era male) in titoli trovati in un cassetto e di un orologio, che gli valse molte seccature.
L’indomani del furto, due ispettori l’arrestarono in un caffè dove stava aspettando la sua compagna: gli ritornò allora in mente d’aver raccontato della provenienza del cipollone ad un militante del luogo. Il buon compagno aveva fatto la spia. La cosa era più incresciosa in quanto aveva l’oggetto con sé, insieme ai titoli.
Trovò il modo di liberarsi di quegli oggetti compromettenti facendoli scivolare in una finestrella a livello del marciapiede, mentre faceva finta di allacciarsi le scarpe.
Poi, nei pochi minuti precedenti l’interrogatorio, ebbe la sorte di trovarsi in camera di sicurezza insieme ad un vagabondo che stava per essere rilasciato, un buon diavolo vinto dalla calamità.
– Ti sei mai trovato trentamila franchi in tasca? – gli chiese in fretta.
– Mai – rispose l’altro, stordito da una somma tanto allucinante.
– Li vuoi?
Il vecchio avrebbe solamente dovuto andare a dire a Rose che lei gli aveva regalato, per il suo compleanno, un orologio d’argento molto diverso da quello del notaio. Quindi Alexandre gli indicò il nascondiglio del denaro. L’uomo promise.
Qualche istante più tardi, Alexandre, interrogato dai poliziotti, negò ostinatamente. Dinanzi al giudice istruttore, negò di nuovo. Lo misero a confronto con il notaio: gli orologi non corrispondevano. Fu messo a confronto con Rose, quelli corrispondevano: il vecchio vagabondo aveva mantenuto la promessa. L’avvocato Cabassol ebbe buon gioco, al Correzionale, nel dimostrare che l’affare era stato montato completamente dalla spia, per incassare il premio promesso per ogni denuncia. Le delazioni abusive erano molto frequenti, naturalmente. Nel momento in cui Alexandre fu rilasciato, il confidente era già sparito dalla circolazione. Non gli si può dare torto.
Il processo aveva comunque fatto rumore, ad Aix. I compagni locali espressero la loro soddisfazione di vedere un traditore smascherato così a buon mercato; i poliziotti erano furenti. Alexandre, invece, avrebbe volentieri fatto a meno di quella pubblicità. Decise di prendere il largo. Del resto erano appena giunti da Parigi dei pacchetti di volantini e di opuscoli per gli spagnoli.
Rose ebbe l’incarico di far arrivare a Marie delle istruzioni relative ai mezzi per comunicare, utilizzabili anche per lei, naturalmente. Lei ricevette il denaro proveniente dalla refurtiva, ottenuto nel frattempo dai contatti con i ricettatori, da dividere con mamma Jacob secondo le necessità di ognuno. Poi egli partì a cuor leggero, con qualche soldo in tasca, seguito da Roques, che si era rifatto vivo.
“I santi sacramenti al crogiolo! I buoni dèi di gesso al mortaio! I confessionali in segheria per farne fascine! Se questo vuol dire essere iconoclasti, ebbene gli anarchici lo sono. Quanto alla carcassa delle chiese, potrà servire come scuola o come granaio pubblico”: egli seguiva alla lettera questo consiglio di Malato. La scalata notturna alla chiesa di Allauch, ad una ventina di chilometri da Marsiglia lo divertì in modo particolare: il portale si era dimostrato disperatamente robusto e lui dovette passare dal tetto, lasciarsi scivolare lungo il sostegno di un lampadario e fissarvi una corda per scendere fino al suolo. Ringraziò allora il nostromo di un tempo che l’aveva fatto soffrire spedendolo a raschiare la cima dell’albero di mezzana. Tante acrobazie non fruttarono però che 28 soldi: non ne valeva la pena.
Si vendicò nella Var sulla chiesa di Puget-Ville, poi sulla cappella Sainte-Christine, vicino a Cuers. Il risultato fu più soddisfacente.
Il cammino per la Spagna stavolta fu lungo. Nella notte del 2 o 3 maggio 1899, Roques ed Alexandre fecero visita al signor Couderc, a Poillies, vicino a Lodève, nell’Hérault. Magra consolazione: un po’ di soldi, vesti eleganti, stivaletti ed elastico ultimo grido, lenzuola, asciugamani, coperte: di che farsi una dote. Rose fu comunque sbalordita per i pacchi che ricevette.
Arrivati a Béziers, i due amici non avevano che pochi centesimi in tasca. Spesero due soldi per il pane, sette per il formaggio, otto per un grimaldello, dodici per una lima. Più una stanza presso madame Barthes. Resto: zero. Ma i compagni incontrati al caffè Fourastié diedero loro la chiave della fortuna: la notizia dell’assenza dei conti di Cassagne dal loro castello.
Il cancello del parco venne aperto senza difficoltà; la porta della cucina cedette al succhiello; i mobili rivelarono i loro beni per ottomilaottocentocinquantacinque franchi di titoli, gioielli e argenteria. Soltanto il forziere fece resistenza. Alexandre era furioso. Non era possibile continuare ad esercitare quel mestiere senza conoscerne almeno i rudimenti. A mo’ di scuse, lasciò un biglietto su un cassettone: «Sudicio aristocratico, sei fortunato che non abbiamo abbastanza tempo, altrimenti il tuo forziere sarebbe ora molto più leggero. Alla prossima. Speriamo che vada meglio». Certamente ricordando l’irruzione della polizia da Marie, si firmò “Attila”.
Poiché Roques provò improvvisamente nostalgia di Marsiglia, Alexandre continuò da solo. Tre giorni dopo, il 19 maggio, a Narbonne, si prese come socio un compagno italiano di nome Fossati, che gli aveva detto di avere una solida esperienza in materia di pinze “monseigneur” [grimaldelli, n.d.r.].
Ed era vero. Lo apprese, a sue spese, il signor Tournier, raffinatore di zucchero. Costui perse nell’impresa settemilaottocentonovanta franchi, in cambio dei quali trovò un bollettino di vittoria: «Se dalla contessa avessimo avuto il tempo necessario, le avremmo fatto la stessa cosa. Saluti a tutti. Attila.
«Post-scriptum. Perforatrice: sistema brevettato».
Quindi valicò clandestinamente senza troppe difficoltà una frontiera molto più smagliata di oggi. Ebbe altri contatti con militanti spagnoli. Non portò loro nutrimento terrestre, stavolta, ma una manna spirituale considerevole. Non che credesse al potere delle parole. Diffidava delle ideologie. Conosceva troppo la sterilità delle discussioni con cui non si risolve nulla. Solo l’azione gli pareva creatrice. Ma in quel caso ebbe la sensazione di dare a degli esuli notizie sulla famiglia.
Nel corso delle sue peregrinazioni, si ritrovò in casa dell’alcalde di San Giacomo di Compostela, un simpatizzante cui aveva già fatto visita all’epoca del suo primo viaggio. Avevano allora parlato in generale di un progetto mirabolante che era loro parso irrealizzabile: rubare a beneficio della Causa il San Giacomo d’oro massiccio pesante quattrocento chili che sormontava l’altare maggiore della chiesa, un autentico insulto alla miseria. Stavolta, Alexandre aveva un piano bell’e pronto. Non gli occorreva che la neutralità dell’alcalde per portarlo a compimento.
A Cassis, avrebbe rubato un cutter. Con due complici, l’avrebbe portato nella rada di Bilbao. Da là, il terzetto avrebbe raggiunto San Giacomo, preso il santo, l’avrebbe frantumato in piccoli pezzi e trasportato fino alla barca su un carretto, con i tre uomini travestiti da contadini. L’alcalde si entusiasmò per quella che considerava una mirabolante beffa anticlericale. Infatti, egli detestava il curato.
Purtroppo, pensò bene di comunicare la sua eccitazione alle due figlie, che riteneva emancipate quanto lui da ogni credenza religiosa. Quelle emisero strilli di spavento sentendo che volevano mutilare l’idolo. Rubare il santo, andava bene. Erano d’accordo sul principio. Ma che non gli rompessero le membra: dopo quel peccato mortale, sarebbero finiti arrosto tra le fiamme dell’inferno. Un’intera notte di discussione non fece loro cambiare opinione. Minacciarono di denunciare il loro stesso padre.
Alexandre lasciò l’alcalde ebbro d’ira. La Spagna era un paese di selvaggi. Giurò a se stesso di non rimettervi più piede.
Una lettera di sua madre l’aspettava a Tolone, indirizzata a Juste Meunier, bar des Glaces, place Puget. Gli annunciava brutte notizie: parecchi compagni erano stati arrestati dalla polizia e tra essi Morel, suo complice nell’impresa del Monte di Pietà. Costui aveva rivelato tutto. Alexandre era stato condannato in contumacia, l’8 giugno, a cinque anni di prigione e a tremila franchi di multa dalla corte d’Assise di Marsiglia.
Egli rispose a giro di posta a Marie di non preoccuparsi. Stava per tentare un colpo di cui avrebbero parlato i giornali. Appena gli fosse riuscito, avrebbe inviato del denaro a lei ed ai compagni sfortunati. Preferiva, per maggiore prudenza, che Rose non andasse a raggiungerlo.
Il colpo fu tentato con un anarchico di nome Manille. Si trattava della magnifica gioielleria Lecomte, sulla piazza d’Armi, il cui padrone si assentava regolarmente ogni fine settimana. Bisognava passare per il caffè adiacente, provvisoriamente chiuso, scendere in cantina e fare un buco nel muro divisorio. Uno straordinario lavoro da talpa, che li impegnò per più di ventiquattro ore... per sbucare nella cantina del procuratore della Repubblica: i sotteranei non corrispondevano alla pianta degli immobili!
Marie era desolata, inquieta per le voci che correvano in quel momento a Marsiglia riguardo ad un possibile tradimento di Roques. Gli scrisse secondo il codice convenuto: ogni lettera della parola “portugaise”, che ha il vantaggio di contenere le cinque vocali dell’alfabeto e dieci lettere in tutto, era numerata da 1 a zero. P era 1; O, 2; R, 3; T, 4 e così via. Questo codice viene ancora oggi utilizzato da certi commercianti che non desiderano che i loro clienti sappiano i veri prezzi di vendita. Lo si può giudicare deplorevolmente semplice, ma l’arte del cifrato non era allora che ai primi passi e Jacob ne era un pioniere. «Mio caro nipote, scriveva Marie, tuo zio (un compagno marsigliese, evidentemente) vorrebbe proprio vederti, soprattutto perché ha qualcosa di molto urgente da comunicarti riguardo a 734453 (Arthur, ossia Roques). Non avendo visto niente sui giornali, ho pensato che non hai avuto il posto che ci avevi detto (la gioielleria). Ti assicuro che 3290 (Rose) avrebbe voluto venire. Se per caso incontri 734453, non fare niente con lui prima di sapere quel che dobbiamo dirti. Devi capire che è nel tuo interesse. Soprattutto non preoccuparti se devi inviare qualcosa ai giovani che sono caduti, che si sono fatti male (sono “caduti” in prigione), forse capisci di chi intendo parlare». (Questa lettera fu rinvenuta dalla polizia nella stanza di Jacob nel 1899).
Alexandre seguì i consigli materni e ritornò a Béziers, dove i de Cassagne si erano dimostrati tanto ospitali. I Galabrun, ricchissimi viticoltori, lo furono ancor di più. Non solo la porta della cantina fu semplice da aprire, ma l’apertura del forziere del pianterreno si rivelò un gioco da bambini per il nuovo esperto che s’era aggiunto. Conteneva non meno di ventiduemila franchi in contanti e duecentomila in titoli facilmente convertibili. Inoltre, suprema gentilezza, una borsetta zeppa di gioielli di gran valore. Era un colpo grosso.
Ma infinitamente meno di quel che avrebbe dovuto essere: dai giornali dell’indomani venne a sapere dell’esistenza nella cantina di altri due forzieri contenenti due milioni. Due milioni: dei vagoni pieni di armi, di giornali quotidiani! Nonostante le sue teorie sulla disuguaglianza delle fortune, non aveva mai immaginato che un individuo potesse possedere una simile somma. A quel livello, il denaro diventava quasi un’astrazione. Quante migliaia di miserabili affamati rappresentavano?
Fu quel che raccontò a Rose, a Montecarlo, dove si ritrovarono. Due milioni! Non si perdonava di averli persi così stupidamente.
– Farai meglio la prossima volta — gli disse lei incoraggiante. – Per essere un debuttante, non te la cavi per niente male. Tua madre è molto orgogliosa di te.
A dire il vero, lei non aveva mai creduto possibile che un giorno egli potesse soddisfare i loro bisogni. L’aveva preso per un bambino. Adesso, dinanzi alla sua audacia, alla sua tenacia e soprattutto alla sua bontà, passava di stupore in stupore. Gli aveva ceduto, un po’ per gentilezza, un po’ per debolezza, molto per stanchezza. Per ringraziarlo in qualche modo d’essersi interessato a lei. Anche per la solitudine. Era infinitamente attaccata, adesso, a quel giovane appena uscito dall’adolescenza e già così maturo. Gli obbediva senza neppure riflettere. Come le aveva promesso, si occupava lui di tutto. Lui decideva su tutto. Lui pensava a tutto. Anche ad offrirle dei fiori, delle rose naturalmente, rosse beninteso, cosa che nessuno aveva mai fatto per lei. Le ripeteva tanto e con tanta foga che avrebbe cambiato il mondo che lei finiva per trovare naturale tutto ciò. Egli faceva grandi sogni. Ma agiva altrettanto in grande. La sua inverosimile vitalità non conosceva pause. Come erano lontani i soggiorni in quella stessa Monaco con Clarenson e i litigi dopo una cattiva serata al gioco!
Alexandre la portò al casinò. Si sedette ai tavoli della roulette. Ma rischiava poco denaro. Travestito da gentiluomo osservava il bel mondo che tanto odiava. Rifletteva. Come spigolare un po’ di quelle insolenti fortune?
L’arrivo di Fossati lo tolse dall’imbarazzo. Una sera, all’ora in cui le puntate cominciavano ad esser forti, mentre il croupier gridava: “Les jeux sont faits”, Alexandre cadde riverso, in preda ad un attacco d’epilessia tanto improvviso quanto spettacolare. Forse l’idea gli era venuta pensando a Clarenson e alla malattia di cui soffriva suo padre. Fatto sta che l’inganno riuscì perfettamente: mentre tutti s’affollavano attorno a lui che rimaneva disteso per terra, l’italiano arraffava tutto quel che trovava.
Appena uscito dall’infermeria dove l’avevano portato, Alexandre corse all’appuntamento fissato con il suo complice: nessuno. Aspettò un’ora, invano.
Dovette allora arrendersi all’evidenza: era stato beffato. Questo lo rese folle. Era la stessa gelida collera che provava quando suo padre picchiava sua madre, o quando il nostromo lo umiliava davanti a tutti. Lo stesso desiderio di uccidere. L’ingiustizia gli era fisicamente insopportabile.
– Doveva capitare – gli disse filosoficamente Rose in albergo. – Marie te lo ripete sempre: tu ti tiri dietro gente non sufficientemente sicura.
Senza aprire bocca, tirò fuori le sue browning da una valigia, verificò che fossero cariche e le mise nella giacca. Poi le ordinò di andarlo ad aspettare a Toulon.
Saltò su un treno per l’Italia. Fossati, disonesto ma ingenuo, gli aveva parlato a lungo dei suoi progetti futuri nella sua città natale, se il colpo fosse riuscito. Quindi Alexandre andò difilato a Napoli.
Qui esistono due versioni dei fatti. Secondo la prima, Fossati era già stato assassinato da un’altra delle sue vittime al momento dell’arrivo di Jacob. Se questa ipotesi è quella vera, Alexandre rimpianse sicuramente quell’incresciosa coincidenza. La seconda ipotesi, secondo la quale Alexandre avrebbe ucciso Fossati, anche se non è dimostrata, corrisponde meglio al suo temperamento. Generalmente tenero e dolce, non era però uomo da lasciare impunito un affronto.
Sta di fatto che sulla via del ritorno aveva abbastanza denaro per prestare cento franchi a un compagno tolonese particolarmente in difficoltà. Quella generosità gli costò cara. Costui non era che un’altra spia, come ne giravano tante negli ambienti libertari. Alexandre aveva fatto appena tre metri in Toulon, che un’orda di poliziotti gli saltò addosso.
Fosse capitato alla luce del sole, a protagonisti di primo piano, come Sébastien Faure, Louise Michel o Matha, sapersi attesi da un ispettore ad ogni stazione ferroviaria e indovinare le sale di conferenza zeppe di spie non sarebbe stato che un inconveniente da poco e, del resto, inevitabile. Ma diventava angosciante trovarsi alla mercé d’una denuncia proprio quando ci si gettava nell’attività clandestina. Leca l’aveva venduto per pochi franchi nell’affare degli esplosivi; Morel l’aveva denunciato per il Monte di Pietà; l’anarchico di Aix l’aveva venduto per il notaio; Fossati l’aveva tradito. Adesso si trovava dietro le sbarre per aver reso un favore a un figuro che si faceva passare per un amico. Marie aveva ragione: si circondava di gente poco affidabile. Ma come fare altrimenti?
Non si poteva richiedere ai compagni un documento con tanto di timbro che l’indicasse come membri del gruppo e contemporaneamente combattere ogni forma di centralismo e di burocrazia. Non si poteva considerare i derelitti, le vittime più disgraziate della società come l’unica forza rivoluzionaria valida e contemporaneamente rifiutare di accettarli. Né far domande ad un uomo nel bisogno, quando l’ospitalità è un dovere assoluto. D’altra parte, l’apertura sistematica di tutti gli ambienti anarchici faceva indubbiamente il gioco della polizia. Quando si scopriva un provocatore, era in genere troppo tardi. Si poteva sempre toglierlo di mezzo, ma aveva ormai fatto il suo sporco lavoro.
Ecco su cosa rifletté innanzitutto Jacob nella sua cella. Ma altre preoccupazioni, più urgenti, si affollarono immediatamente. La deposizione di Morel era schiacciante per l’istruzione del processo. Il signor Gille l’avrebbe certamente riconosciuto. Stavolta, non aveva alcuna possibilità di sfuggire ad una condanna.
E tuttavia, aveva tanto lavoro da fare per la rivoluzione... Tanti amici l’aspettavano, in ogni città della Francia... No, lui, Alexandre Marius Jacob non poteva rassegnarsi ad ammuffire sulla paglia umida come un volgare pregiudicato. Bisognava trovare una soluzione.
Il ricordo del fantasioso Clarenson l’aiutò una seconda volta. Era appena rinchiuso da qualche ora che si tolse il cappello e se lo mangiò.
Il guardiano si stupì. Ed anche i magistrati, quando lo videro indietreggiare sulla sedia, spaventato alla loro vista, quindi gettarsi ai loro piedi torcendosi le mani, con gli occhi fuori dalle orbite, supplicandoli di non farlo bruciare.
La prigione di Aix dove venne subito trasferito divenne in pochi giorni una vera babilonia. Il detenuto Jacob passava le notti urlando: orrendi gesuiti in veste nera lo braccavano dappertutto per metterlo ad arrostire su uno spiedo. Nessuno riusciva più a dormire. I suoi vicini di cella battevano contro i muri con tutti gli oggetti che avevano sottomano. Un piccolo gruppo di anarchici, tra cui un certo Joseph Ferrand, che era stato appena arrestato per furto, faceva parte del complotto. Facevano un chiasso d’inferno. Strillavano come fossero mille.
La maggior parte, ignorando di cosa si trattasse, si agitava per emulazione. I secondini, stravolti, correvano in ogni direzione.
Jacob fu messo nei sotterranei. Lo passarono sotto la doccia gelata. Gli infilarono la camicia di forza. Fu dura.
Ricevette il suo avvocato in ginocchio in mezzo alla cella, immerso nei Pater Noster da cui non uscì che per guaire di spavento alla sua vista. L’uomo non riuscì a tirargli fuori altro.
Abbracciò e baciò sulle guance il direttore del carcere che chiamava suo salvatore: in breve, i tre psichiatri che studiarono il suo caso lo dichiararono inguaribilmente affetto da delirio mistico. Marie, preavvertita da Ferrand che era meno sorvegliato, accorse a confermare che il suo povero figliolo (lei non l’aveva mai detto a nessuno finora) era completamente idiota.
I militari, che intendevano approfittare della circostanza per impadronirsi di lui, dato che non s’era presentato alla visita di leva, si rassegnarono a riformarlo. Del resto, i certificati medici presentati da Marie, che li aveva conservati dopo le “febbri” di Dakar e che furono verificati da nuovi esami, tolsero loro ogni rammarico: il soggetto era in cattiva salute. Sicuramente tubercolotico. Probabilmente non ne avrebbe avuto per molto. Quanto meno, quella diagnosi avrebbe evitato in seguito ad Alexandre, risolutamente deciso a non compiere mai il servizio militare, di essere considerato renitente.
Il 29 giugno 1899, infine, la giuria della corte d’Assise di Aix-en-Provence, infastidita da quello strano energumeno, decise, prima di confermare la precedente condanna a cinque anni in contumacia, di farlo mettere in osservazione in un manicomio: quello di Mont-Perril a Marsiglia.
La doccia e la camicia di forza erano, lì, la panacea universale. Il regime era severo. Alexandre però si dibatteva con tutte le sue forze contro i gesuiti seviziatori: non era più tempo di indietreggiare.
Un infermiere chiamato Royère si mostrò estremamente comprensivo verso quel nuovo malato tanto strambo. Gli confidò che neppure lui, benché in limiti più ragionevoli, amava i preti. Jacob lo sondò discretamente, in seguito. L’altro confessò le sue simpatie per l’anarchismo. Diede sufficienti e precise referenze, di nomi, di località e di date, tanto da convincere Alexandre, che si assunse allora il rischio di rivelargli la verità.
Royère fu eccezionale. Consigliò al simulatore di esagerare le sue crisi. Di diventare violento, se necessario. Gli dispensò dei consigli sul comportamento da tenere nei riguardi dei medici, dei guardiani e degli altri pazzi. Lo scopo da raggiungere ad ogni costo consisteva nel farsi rinchiudere nel settore degli agitati in una cella imbottita. Il soggiorno vi sarebbe stato penoso, ma almeno Jacob sarebbe stato da solo e più vicino al muro di cinta. Royère si sarebbe incaricato di assicurare i collegamenti con Marie, per qualsiasi scopo.
E venne il gran giorno. Alexandre mordeva chiunque gli si avvicinasse. I gesuiti si moltiplicarono, sempre più feroci. Nel parlatorio recitò così bene la commedia con sua madre che Royère fece una fatica immane per rassicurarla, il giorno successivo.
Fu una esperienza lunga, penosa, dolorosa. Ma riuscì ad ottenere quel che voleva. Marie cominciò a ricevere innanzitutto dei bollettini sanitari tra l’allarmato e lo scettico. Tremendamente inquieta, non sapeva più quel che doveva temere maggiormente: che suo figlio diventasse veramente pazzo o che l’inganno venisse scoperto. È conservata una delle lettere del direttore del Mont-Perril, datata 14 gennaio 1900: «Il signor Jacob è nelle stesse condizioni. Si ritiene perseguitato dai gesuiti, accusa delle allucinazioni visive e non vuol sentir parlare della sua famiglia. Il signor Jacob è sotto osservazione e non siamo del tutto certi di avere individuato la natura del suo delirio».
I medici non furono sicuri nemmeno tre mesi dopo, quando “il signor” Jacob non era ancora stato dimesso dal manicomio. Il tempo per lui non passava mai. E neppure per Rose e Marie.
Quest’ultima aveva iniziato un’intensa campagna di preparazione psicologica sul suo sposo.
– Rinchiudono tuo figlio in manicomio, vogliono farlo passare per matto e tu non dici niente! – gli diceva. – Tu preferisci giocare a “manille” con i tuoi amici!
Joseph si sentiva a disagio. Non provava più gusto per nulla. Dalla casa alla drogheria, poi al caffè, trascinava una vita miserabile e sfaccendata. Malgrado il pernod di cui era zuppo, era scosso sapendo il suo piccolo tra i malati di mente. Un sentimento sconosciuto s’insinuava lentamente tra i vapori etilici: il senso di colpa.
Tra i numerosi compagni marsigliesi di suo figlio, Marie non fece alcuna fatica a reclutare i due che riteneva più sicuri. Il ristretto stato maggiore si riuniva regolarmente la sera dinanzi agli schizzi preparati da Alexandre e trasmessi da Royère. Il materiale necessario venne ben presto raccolto. Joseph se ne stava rincatucciato in un angolo durante i loro incontri, con la sensazione sempre più acuta di essere inutile, vile e spregevole. Una sera, nel momento più inaspettato, s’alzò d’improvviso:
– Io vengo con voi – disse, avvampando di improvvisa timidezza.
Passato il primo momento di stupore, fu festeggiato. Marie l’abbracciò, cosa che non le capitava da parecchio tempo. Piangendo: cosa che faceva tutti i giorni.
Fu così che, nella notte tra il 18 e il 19 aprile 1900, un calesse con tre persone si diresse verso il Mont-Perril. Si fermò a qualche distanza dal manicomio. Uno degli uomini rimase vicino alla vettura per fare la guardia. Gli altri due scalarono il muro di cinta nel punto previsto, grazie alla scala di cui erano muniti secondo le istruzioni. La calarono nel cortile e con essa salirono su un tetto, lungo il quale seguirono l’itinerario indicato.
All’ora stabilita, ruppero il vetro situato sul soffitto della cella di Alexandre e che, eccettuata la porta, ne costituiva l’unica apertura. Immediatamente, lanciarono una corda con dei nodi.
Piombando al suolo, il vetro fece un chiasso tremendo. Un guardiano si precipitò. Aprì lo spioncino, vide la scena e cominciò a togliere il catenaccio alla porta. Tutto era perduto. Jacob spedito in isolamento per almeno cinque anni. Il divieto di soggiorno. Forse relegato alla Caienna. Allora, con quel sangue freddo che contraddistingue i grandi capi, Jacob gridò:
– Gettatemi il revolver...
Poi, facendo finta di averne ricevuto uno:
– Grazie! l’ho preso...
Il guardiano si bloccò. Alexandre prese la corda. Vi si arrampicò più presto che poté, si tagliò con dei pezzi di vetro mentre saliva, galoppò per i tetti, balzò a terra, saltò un muro di cinta con i suoi due complici, mentre acuti colpi di fischietto squarciavano l’aria e, tutto sanguinante, cadde nel calesse abbracciando suo padre.
L’indomani, vestito da falegname, trasformato da una barba, con un po’ di denaro in tasca, con documenti perfettamente in regola intestati a Jean Concorde, egli si trovava a Sète in casa di Sorel, l’amico di Caserio. Il commissario Fabre, facendo un’altra irruzione in casa degli Jacob, vi scopri una coppia di piccoli commercianti pacifici, sbalorditi di sapere che il loro figlio era evaso. Quando alla giustizia, non poté che prendere atto ufficialmente della fuga, condannandolo in contumacia ad un anno di carcere, il 22 novembre 1900, per “vagabondaggio aggravato”.
III. I centocinquanta “crimini” dell’altro Arsène Lupin
Concorde, seduto su una panca all’ombra della piccola casa, ascoltava attentamente Sorel che gli parlava di Caserio. Il giovane fornaio italiano, una specie di Pierrot magro e pallido dal lungo viso piatto, aveva vent’anni anche lui quando s’era rifugiato a Sète, proveniente da Ginevra e poi da Lione. Anche lui era un ribelle, anche lui adorava sua madre e i suoi amici. Anche lui sognava di realizzare una grande impresa. Quando aveva preso il treno per Lione senza avvertire nessuno, dopo aver acquistato un pugnale passando da Montpellier, nessuno aveva sospettato il suo progetto, neppure Sorel.
«Tu hai avuto la testa di Vaillant, noi avremo la tua, presidente Carnot!» aveva proclamato un manifesto anarchico. Caserio aveva mantenuto la promessa fatta da altri. Ma i lavoratori si erano forse rivoltati? I compagni di Marsiglia avevano sognato bagni di sangue: «Stai pur certo che siamo già pronti a vendicarti», gli aveva scritto uno di loro. «La vendetta si scatenerà tra poco e sarà terribile. L’inizio della mia lettera è scritta con il mio sangue perché tu possa vedere, tra quei barbari carnefici, ancora una volta del sangue umano, un sangue che grida vendetta ai suoi compagni...». Non era successo niente. L’amarezza. Il silenzio, la delusione. Un pizzico di rancore. Sorel insisteva su questo punto. Vedendo Concorde accarezzare, con una commozione che egli giudicava forse inquieta, il cane lasciatogli da Caserio, si domandava a volte se il giovane non intendesse prendere la stessa strada.
In effetti, Alexandre seguiva il filo delle riflessioni cominciate in manicomio. Fino ad allora, si era comportato da dilettante preparato, più che da rivoluzionario. Qualche impresa notevole c’era stata, molto bene organizzata nei particolari, ma senza altro obiettivo determinato che rendere colpo su colpo. Una rivolta impulsiva, generosa e in fin dei conti inefficace. Non aveva reso un servizio all’anarchia; non aveva nemmeno cambiato il mondo. Il “Grande Giorno” non sarebbe mai giunto se ognuno disperdeva così le proprie energie senza beneficio per gli altri.
Quel che, a poco a poco, dalla evoluzione recente della situazione egli apprese da diversi compagni incontrati per caso nei suoi spostamenti, non l’incitò molto all’ottimismo.
Nel febbraio del 1899, al “Journal du Peuple”, questo quotidiano pro-Dreyfus che tanto preoccupava Malato nel suo ultimo soggiorno a Marsiglia, tutti i militanti, dai collettivisti agli individualisti, da Pelloutier e Delessale a Janvion, Degaldès, Grandidier o Guerineau, si erano trovati uniti dietro a Sébastien Faure. Octave Mirbeau e Laurent Tailhade avevano scagliato i loro consueti strali. Gli anarchici avevano fatto un buon lavoro. Anche i loro avversari avevano dovuto riconoscere che erano gli unici tanto combattivi ed organizzati da proteggere riunioni e comizi dai colpi di mano degli anti-Dreyfus. Li avevano in particolare visti all’opera nelle manifestazioni di massa di Auteuil e di Longchamp, in giugno. La grazia concessa a Dreyfus, ottenuta in settembre in seguito al processo di Rennes, era in gran parte merito loro.
Dopo di allora, purtroppo, discordie interne avevano loro impedito di cogliere il frutto di un così bel successo. L’anarchia era scivolata nell’anarchia.
Per Jean Grave e il suo “Temps Nouveaux”, Dreyfus, nonostante lo scandalo, rimaneva un borghese e, quel che era peggio, un militare. L’Affaire non lo riguardava quindi in alcun modo. Che i ricchi si divorassero tra di loro, che offrissero al popolo lo spettacolo dei loro intrighi e della loro viltà: il posto dei militanti era sulle gradinate, a sghignazzare di quelle burattinate.
Janvion replicava che in tal modo si poteva rischiare di incrociare le braccia in attesa di un’epoca d’oro che non sarebbe mai venuta: prospettiva nella quale Grave cominciava a sprofondarsi comodamente. Dreyfus non era più un borghese ma un ergastolano nell’isola del Diavolo. Il dovere dei militanti consisteva nel difenderlo e nell’utilizzare tutti gli avvenimenti suscettibili di mobilitare la gente, per accrescere la loro influenza e reclutare nuovi adepti.
Ma Janvion non era nemmeno d’accordo con Sébastien Faure. Costui aveva avuto ragione, secondo lui, a tuffarsi nella mischia e torto a non sapervi imporre la visione anarchica. Per difendere Dreyfus egli aveva adottato un “tono di balia sentimentale”. Si era lasciato contaminare e il suo “Journal du Peuple” aveva avuto “accenti di puro lirismo repubblicano”.
– Questi rimproveri non sono forse del tutto fuori luogo – disse Matha a Jacob quando si incontrarono a Lione. – Almeno, Faure è stato l’unico ad agire in profondità e, in tal modo, è il solo ad aver preso coscienza di certi problemi.
Problemi che si riassumevano in una parola: denaro. Tre mesi dopo la grazia a Dreyfus, il “Journal du Peuple”, con centomila franchi di debiti, scompariva. Anche se era stato diverse volte riportato a galla dalle sottoscrizioni che gli ambienti anarchici avevano tanto faticato a procurarsi. A dire il vero, esso non avrebbe mai visto la luce senza gli Ebrei e la massoneria. Compromessi? Forse le colonne del giornale si erano concesse a repubblicani alleati provvisori e sovvenzionatori di fondi.
– Ma – sospirava Matha – senza di essi non si sarebbe fatto niente del tutto. Inoltre, siamo stati ben felici di vedere che ci sostenevano, se si trattava di compagni deportati alla Caienna. Henry Leyret ha condotto una campagna su “L’Aurore” per un’amnistia generale dei nostri amici. La Lega dei Diritti dell’Uomo, che è una emanazione del Grande Oriente, lo so bene, ci ha aiutato a fare liberare cinque dei nostri. Cyvoct deve loro la vita. Monod è morto cieco, ma in Francia, grazie a loro, e Liard-Courtois può ringraziarli di essere scampato ad altri cinque anni. In quelle condizioni, non posso dare torto a Sébast. Se fossimo tanto ricchi da poter fare a meno di loro, evidentemente questo cambierebbe tutto...
S’era accusato Faure di corteggiare la massoneria. La cosa appariva probabile. Era un tradimento? Parecchi compagni in effetti avevano scoperto, nel momento della lotta comune per Dreyfus, che la massoneria non assomigliava affatto alla caricatura che se ne faceva. Nel Grande Oriente si trovava gente aperta alle nuove idee. Si era demolito il “Grande Architetto dell’Universo”; non si giurava più sulla Bibbia. Ci si batteva contro il razzismo, contro i preti, contro i possidenti dalla bocca a culo di gallina, contro i culi sacri. Si lavorava a proprio modo per il benessere dell’uomo. Si credeva al possibile miglioramento della sorte dei miserabili. Nulla di tutto questo era disonorevole.
– Capisco che Laurent Tailhade non abbia resistito – diceva Matha. – Come neppure Charpentier o Gustave Hervé, tra quelli di cui, eccetto Faure, si è pressappoco sicuri. E poi, Proudhon stesso non era stato massone?
Inoltre, il fenomeno non era a senso unico. Parecchie logge di rue Cadet avevano a loro volta scoperto, con quelle nuove reclute, le idee libertarie. Quegli iniziati che prendevano sul serio la prima norma: “esser liberi e di buoni costumi”, potevano constatare il rigore dell’ideale anarchico. I seguaci della bandiera nera non erano l’orda di selvaggi assetata di sangue che era loro stata descritta. A conti fatti, l’operazione si sarebbe forse rivelata vantaggiosa. L’intransigenza di Alexandre accettava malvolentieri quelle considerazioni tattiche. Non essendosi mescolato nella lotta, non s’era sporcato le mani.
– I massoni sono repubblicani – obiettò a Matha. – Ogni anno presentano gli omaggi al presidente della Repubblica. Non nascondono di essere i fautori delle leggi che noi odiamo. Sono dei riformisti che approfittano del sistema, pur volendolo migliorare: come se gli sfruttatori potessero rinunciare ai loro privilegi senza avere il coltello alla gola!
Matha gli replicò che forse aveva ragione, ma che da dicembre, dopo che Faure, esulcerato dagli attacchi di Grave e compagni, gli aveva lasciato il “Libertaire” per andarsene a fondare da solo la “Plébéienne” (dopo che “l’apostolo” non colmava più i debiti con il frutto dei suoi giri di conferenze), l’uscita di ogni nuovo numero costituiva un vero e proprio problema. Duemila copie, quando la rivista avrebbe dovuto tirare duecentomila o due milioni di copie; Alexandre poteva capire che cosa significa una cosa del genere? Il fervore militante, la bellezza di un ideale non supplivano alla penuria di mezzi.
Alexandre capiva perfettamente. La sua esperienza di tipografia e il suo passaggio dall’“Agitateur” gli avevano insegnato molte cose.
Quando Malato gli descrisse una situazione quasi simile, la decisione fu presa definitivamente: al centro di tutte le preoccupazioni, c’era il denaro.
Fu allora che “l’idea” germogliò nel suo cervello. Egli la espose immediatamente al suo amico. Questi, passato il primo momento di sorpresa, ne considerò tutti gli aspetti. Fece delle obiezioni: invano.
Il problema era semplicemente di sistematizzare le riappropriazioni individuali su scala tale che i rapporti di forza venissero davvero a mutare all’interno della società. Derubare i borghesi secondo un ritmo industriale e non più artigianale. Innanzitutto per impoverirli. Poi per sostenere i mezzi di propaganda, cosa che avrebbe evitato l’umiliazione di ricorrere ai repubblicani e altri massoni, senza contare l’umorismo di una situazione in cui si fa una rivoluzione con il denaro dell’avversario. Per sovvenire, in particolare, ai propri bisogni come a quelli dei compagni più sfortunati. Soprattutto per dimostrare con l’esempio al popolo che il rispetto della sacra proprietà era un’illusione. Così l’idea si sarebbe diffusa a macchia d’olio. Sarebbero bastati due-trecento compagni sufficientemente addestrati e organizzati per saccheggiare l’intera Francia. La Repubblica non avrebbe resistito. Gli anarchici, ricchi, potenti, armati, avrebbero irresistibilmente trascinato il popolo sulla breccia. In mille, si sarebbero liquidati tutti gli Stati d’Europa, per sostituirli finalmente con la democrazia diretta dei consigli operai e contadini.
Questo progetto potrebbe sembrare insensato. In realtà, la partita non era decisa in anticipo. Jacob aveva spinto più lontano di quanto si potrebbe supporre, a leggere il “Mallet Isaac”, dove egli non figura, la realizzazione della sua impresa. Un certo Stalin svaligiando a colpi di bombe e di rivoltella la banca di Tiflis, accompagnato dal terrorista georgiano Kamo, soprannominato il “brigante del Caucaso”, fornirà, nel 1906, trecentoquarantunomila rubli oro alla causa bolscevica e cambierà, lui sì, la faccia del mondo.
In quell’anno 1900, il furto considerato come una giusta rivendicazione aveva già acquisito i suoi titoli di nobiltà da quattordici anni con Clémente Duval, il violento militante della “Panthère des Batignolles”. Catturato una prima volta con le mani nel sacco di un capostazione, Duval aveva insistito, per puro ideale, nel palazzo di una certa signora Herberlin.
– In nome della legge ti arresto – gli aveva immediatamente intimato un poliziotto mettendogli la mano sulla spalla.
– In nome della libertà io ti sopprimo! – aveva ribattuto Duval immergendogli il pugnale nel petto.
Arrestato, aveva allora fatto una dichiarazione. “Secondo il mio punto di vista, io non sono un ladro. La Natura, creando l’uomo, gli dà il diritto ad esistere e tale diritto l’uomo ha il dovere di esercitarlo nella sua pienezza. Se dunque la società non gli fornisce di che vivere, l’essere umano può legittimamente prendere quanto gli abbisogna laddove vi sia il superfluo”.
Alle Assise s’era spinto ancora più in là: “Ah, se recuperassi la libertà, vi farei saltare tutti in aria! Per farvi saltare era destinato quel denaro!” aveva esclamato. Il presidente l’aveva fatto espellere. La giuria l’aveva condannato a morte. In quello stesso istante era stato promosso eroe. Louise aveva commosso l’opinione pubblica e convocato tutta Parigi alla sua esecuzione, prevista in place de la Roquette. Alcuni avevano persino suggerito in compenso di sgozzare il boia: poi Jules Grévy aveva ritenuto preferibile commutare la condanna nel bagno penale a vita. (Duval evase dalla Caienna nel 1901. Riuscì a raggiungere gli Stati Uniti. Pubblicò le sue Memorie e morì nel 1935 senza fare mai più parlare di sé, eccetto nel 1913 con una clamorosa presa di posizione a favore della “Banda Bonnot”).
Alexandre si trovò d’accordo con Malato nell’ammirare la forza di quell’oltranzismo, non senza deplorarne naturalmente l’ingenuità: poiché seppure Duval voleva “far saltare tutto”, i suoi sforzi solitari sarebbero stati così irrisori come i cinquantamila franchi inghiottiti tempo prima nel pantano spagnolo.
La rottura definitiva dei marxisti con gli anarchici d’altronde risaliva proprio all’affare Duval. «Che un uomo prenda quando ha fame, quando i suoi avranno fame (e non è il caso di Duval): non gli getteremo certo la croce addosso. Ma non confonderemo quel gesto di conservazione individuale o familiare con un colpo di fuoco d’avanguardia»: così aveva sentenziato Jules Guesde nel “Cri du Peuple”. Alexandre vi scorgeva, naturalmente, una tipica reazione dell’“autoritario” che pretende la disciplina anche nell’“avanguardia” e, pur volendo abbattere lo Stato borghese, ammira almeno in esso una certa nozione dell’ordine. Se quella gente là avesse prevalso un giorno, avrebbe imposto al popolo un sistema chiuso, in cui il reclutamento avrebbe sostituito il libero arbitrio e la statistica l’individualità.
Quanto all’obiezione avanzata da Séverine, donna ammirevole, tutta dedita alla difesa dei poveri e degli oppressi che si considerava l’erede spirituale di Jules Vallès e secondo la quale il furto era “tale da allontanare da noi i titubanti, da intimidire i semplici, da sgomentare i paurosi”, Alexandre la liquidava con un’alzata di spalle: se il suo piano diveniva realizzabile, i titubanti invece si sarebbero avvicinati, i semplici avrebbero riacquistato fiducia e i paurosi sarebbero diventati immediatamente delle tigri!
Rubare era legittimo. Tutti gli anarchici erano d’accordo su questo punto: l’austero Jean Grave; Sébastien Faure, nonostante i suoi soci massonici; persino il mite Elisée Reclus, l’ammirato geografo che confessava: “Non è male che la voce di Duval abbia ricordato a tutti noi, moralisti e moralizzatori, che anche noi viviamo di furto e di rapina...”. Con maggiore o minore vigore e passione, ognuno faceva a gara a ripetere, adattandola al proprio carattere, la dichiarazione apparsa un tempo sul “Ça ira”: «Prendete e depredate, è roba vostra!... Non ci sono dieci strade da percorrere, non ce n’è che una: dare l’esempio, mettersi immediatamente a riprendere ai ricchi le loro fortune!».
Come Duval, come Pini e Parmeggiani, come Ortiz, come la moltitudine immensa di anonimi che si erano dedicati alla riappropriazione individuale. Alexandre voleva fare meglio. Con lui il furto non sarebbe più stato una rivolta selvaggia, ma una tattica rivoluzionaria.
Durante il tragitto di ritorno verso il Mezzogiorno, lesse e rilesse un libretto avuto in prestito da Malato e scritto da un compagno di nome Georges Adrien, detto Darien, Il ladro, pubblicato tre anni prima senza molto successo. Malgrado alcuni passaggi troppo romanzati e troppo romantici voli individualistici, a volte dimentichi del socialismo, c’erano idee da prendere, lì dentro... (Alexandre Auriant, il notevole biografo di Darien – vedi in particolare Darien et l’inhumaine comédie nell’edizione Jérôme Martineau – afferma che costui personalmente non ha mai rubato. Non si può tuttavia tralasciare di pensare, leggendo di certe scorrerie, che ci sono particolari che non si inventano, nemmeno se ispirati da molta fantasia).
Quando Alexandre mise piede nella stazione di Montpellier, il suo piano di battaglia era completo. Cominciò immediatamente ad applicarlo con il rigore e l’audacia di una specie di Napoleone del furto.
Primo provvedimento: utilizzò le sue economie per rilevare a Montpellier la gestione di un negozio di chincaglierie. Lo intestò a Rose, che non era sospettata. Non interessandosi ovviamente a vendere ogni tanto pochi grammi di chiodi ad un cliente, quell’acquisto gli permise di farsi poi mandare in deposito tutte le casseforti di tutte le marche possibili ed immaginabili. Così ebbe ogni agio di studiarne i meccanismi. Vi mise la stessa meticolosa passione che per i fondali marini, la tipografia e le erbe medicinali. Con lo stesso mezzo, si procurò gli utensili più appropriati per aprire i forzieri, utensili che sperimentò e migliorò con pazienza. Le pinze, le menarole e le seghe di fabbricazione americana, l’entusiasmarono in modo particolare: il Nuovo Mondo era tecnicamente all’avanguardia.
Roques venne a prendere lezioni. Royère, datosela a gambe dal Mont-Perril nel momento in cui si cominciava a sospettarlo d’avere aiutato la vittima dei gesuiti ad evadere, si aggiunse a loro. Appena liberato dalla prigione di Aix, giunse anche Joseph Ferrand, che aveva ottenuto il nuovo indirizzo di Jacob da Marie. Ce ne furono molti altri: una dozzina in tutto, di cui preferiamo ignorare il nome giacché hanno avuto la fortuna di passare indenni attraverso le maglie della giustizia e dalla polizia.
Rose preparava da mangiare per tutti. La sera, dopo aver ripassato le ultime lezioni, si passava alla pratica.
Per evitare che i membri del piccolo gruppo si facessero notare nel corso degli spostamenti lungo la Costa Azzurra, Jacob aveva riscattato anche una bottega di rigattiere. Dallo smoking alla blusa da pittore, passando per la tonaca ecclesiastica e l’uniforme da capitano degli ussari, ognuno poté così vestirsi da capo a piedi a seconda della necessità o della fantasia. Nessun particolare fu lasciato al caso. I nastrini della Legion d’onore accompagnavano le decorazioni.
Dopo qualche brancolamento, Alexandre imparò anche a falsificare a volontà carte d’identità e passaporti più verosimili degli originali. Così bene che ogni membro del gruppo si trovò in possesso di varie generalità complete. Il glabro abate Royère entrava nella bottega il lunedì per ritornarvi martedì come il tenente Royère carico di medaglie e il mercoledì come stuccatore baffuto. Anche Jacob si portava dietro i suoi travestimenti in una valigia per indossarli alla periferia di Montpellier, nei gabinetti di una stazione o nell’oscurità della campagna.
Da Nizza e Perpignan, quell’estate compirono scorrerie su tutta la costa mediterranea. Svaligiarono sicuramente un gran numero di ville. Ma si circondarono di un tal numero di precauzioni che la giustizia non poté in seguito attribuire ad Alexandre che un unico svaligiamento, quello commesso tra il 17 e il 23 luglio a Sète in quai de Bône 27 in casa Torquebiau, avvocato a Montpellier. Una bella dimostrazione di abilità tecnica, dopo tutto: arrivati sul tetto attraverso il lucernaio di una casa attigua, tolsero silenziosamente dai cardini una persiana, ruppero il vetro di una finestra e scesero fino a terra con una piccola scala a mano.
Il forziere fu coricato su un materasso per essere sventrato, senza rumore. Bottino: numerosi gioielli, obbligazioni della Città di Parigi e del Credito fondiario, buoni dell’Esposizione del 1900 e del canale di Panama. In tutto più di quarantamila franchi. Senza contare un diploma di dottore in legge che Alexandre conservò “perché non si sa mai”.
* * *
– Perché avete rubato quel diploma?
– Stavo già preparando la mia difesa!
* * *
I titoli verranno immediatamente negoziati a Parigi presso Lestiboudois, agente di cambio.
Conosciamo almeno un altro colpo di quel periodo: in casa del marchese di Forbin. La cosa andò male. Dei domestici non previsti nel programma si svegliarono e si armarono con fucili da caccia. Alexandre riuscì a galoppare fino ad un boschetto di pini, ma la campana a martello della cappella privata si mise a suonare. Il vicino villaggio fu messo in allarme. Venne organizzata una battuta. Dappertutto spuntarono uomini preceduti dai cani. Era perduto.
Allora, come il maresciallo di Luxembourg quando incendiò l’Olanda, accese un fiammifero e diede fuoco alla sterpaglia che lo circondava. Con le fiamme che gli lambivano i pantaloni, si mise a correre a perdifiato. In pochi istanti il bosco si trasformò in una fornace. Successe quel che aveva previsto: i suoi inseguitori, sconvolti alla vista dell’incendio, rinunciarono a stanarlo. Egli poté allontanarsi indisturbato.
– Ma – diceva raccontando la sua avventura, – ho sentito caldo...
Appena il suo metodo fu perfettamente a punto, decise di “salire” a Parigi. Infatti la sua popolarità era diventata troppo ingombrante nell’ambiente chiuso dei compagni mediterranei. L’anonimato della capitale, a condizione di essere accuratamente conservato, sarebbe stato più propizio alle sue attività.
Perché poi limitarsi ai territori della lingua d’Oc quando il suo tentativo di sovversione aveva di mira l’intera Francia? I principali protagonisti, i maggiori giornali, il punto di partenza delle linee ferroviarie, tutto era a Parigi.
Verso la fine del 1900, dopo parecchi tentativi, prese quindi alloggio con Rose in un modesto alberghetto di rue de la Clef 18, nel 5° arrondissement, tra il Jardin des Plantes e place de la Contrescarpe. A Thériez, il padrone, non piaceva la polizia, con cui aveva già avuto a che fare due o tre volte. Senza essere veramente rivoluzionario, simpatizzava con le idee anarchiche e andava spesso alle riunioni del quartiere. I suoi affari andavano male. Non aveva che un cliente, o meglio una cliente, Gabrielle Damiens, una di quelle poverette che vegetavano sui marciapiedi di Parigi, senza speranza, senza amor proprio e senza denaro. Tutto ciò garantiva la discrezione di Thériez, unica caratteristica che lo rendesse utile. Capitando all’improvviso uno dopo l’altro, i marsigliesi giunsero a rendere alla spelonca una prospettiva che non conosceva da molto tempo.
Parigi viveva allora le ultime settimane dell’Esposizione Universale, i cui innumerevoli padiglioni si addossavano dal Trocadéro al ponte Alexandre III. Un gargantuesco delirio architettonico aveva invaso le rive della Senna, dominato dalla torre metallica del signor Eiffel ridipinta di giallo e fiancheggiata da un gigantesco globo celeste. Una porta monumentale era sormontata da una orrenda statua che doveva rappresentare “la Parigina”. In fondo al Champ-de-Mars, la Grande Ruota; sulla collina del Trocadéro, un ammasso di villaggi coloniali: algerino, senegalese, cocincinese; un treno elettrico e due marciapiedi semoventi che costeggiavano un’accozzaglia di volte serbe, di arzigogoli persiani, di turcherie, di cupole greche, di edifici modernisti, fettucciformi e traforati in cui s’incrostavano repentini i 260 metri di edifici medievaleggianti della Vecchia Parigi ricostruiti da Robida: tutto concorreva ad abbagliare un provinciale. Era stato inaugurato il ponte Alexandre III e l’avenue Alexandre III, che s’apriva un varco attraverso i giardini degli Champs-Elysées e, fiancheggiato dal Petit e dal Grand Palais, tracciava una magnifica prospettiva fino agli Invalides.
Le linee tranviarie s’allungavano ogni giorno in un concerto d’imprecazioni degli abitanti disturbati dai lavori, malgrado gli imbottigliamenti dovuti alla circolazione di cinquantamila vetture a cavalli e di poche automobili. La linea numero uno della metropolitana, dalla porta di Vincennes alla porta Maillot funzionava perfettamente fin da luglio. La prima ferrovia elettrica francese univa gli Invalides a Versailles. Erano appena stati ultimati la stazione e il palazzo d’Orsay.
Ogni giorno, più di centocinquantamila persone provenienti da tutto il mondo si accalcavano all’Esposizione. C’era stato il sultano di Costantinopoli, lo Scià (il cui assassinio il compagno Salsou aveva stupidamente fallito), i re d’Olanda, del Belgio, di Romania, d’Inghilterra, di Svezia, della Cambogia, di Grecia: una sfilata sontuosa.
Ogni sera o quasi c’erano fuochi artificiali, luminarie, feste notturne e “veneziane” sulla Senna, in un’orgia di torce, di becchi a gas e di proiettori grazie alla fata Elettricità. I balli mascherati all’Opera, sempre più strabilianti, attiravano la crema delle Corti europee verso la Ville Lumière. Tutta l’attenzione era per le nuove toilettes della vistosa Caroline Otero, per l’ultimo amante rovinato da Liane de Pougy, per il salotto di Cléo de Mérode; per il crack della stravagante Boni de Castellane, per i duelli tra il barone Rothschild e il conte di Lubersac; per il milione regalato dalla Castellane nata Gould alle opere di carità; per la carta di Francia ornata di pietre preziose donata al presidente Loubet dall’ambasciatore di Russia; per il banchetto offerto dallo stesso Loubet ai ventiduemila sindaci di Francia e che occupava per un chilometro i giardini dell’Orangerie; per i garden-parties dell’Eliseo; per le geniali opere di Catulle Mendès, François Coppée, Willy, Gyp, François de Curel, Marcel Prévost, Jean Lorrain, Paul Hervieu, Sardou, Sully-Prudhomme, Heredia, Bornier; per le sfilate di moda a Vincennes; per le partite di polo, golf e tennis su prato; per lo steeple-chase, per le corse: era la Belle Epoque.
Alexandre non ne tirava che un’unica considerazione: il governo non aveva tra quei fasti “repubblicani” trovato il tempo di votare che una sola legge sociale: la proibizione per i padroni di fare lavorare le donne e i minori di diciotto anni più di undici ore al giorno. Sessantasei ore di lavoro la settimana: davvero una Belle Epoque!
Dopo un mese di soggiorno nella capitale, la sua diffidenza si trasformò in repulsione e questa in nausea; centocinquantamila persone morivano ogni anno di una tubercolosi dovuta alla miseria, senza contare la spaventosa mortalità infantile della periferia, ma erano stati trovati nelle casseforti pubbliche e nei forzieri privati i centoventi milioni necessari al finanziamento dell’Esposizione. Vi erano rappresentati tutti i capolavori dello spirito; vi si accumulavano tutte le invenzioni del genio umano. Ma gli sfruttatori se n’erano impadroniti con tranquilla insolenza, come se fossero loro opere personali, per farne una mascherata ad uso dei merli sbalorditi in un’orgia di stucchi, fru-fru, piegoline, merletti, raso, frac, quattrini, principi gallonati, granduchi da centomila anime e maliarde distese.
Tutto ciò era stato creato dal popolo. Tutto gli apparteneva. Glielo avevano rubato. Gli confiscavano anche le creazione dei suoi lavori. Ed era contento, il popolo! Applaudiva alla sfilata delle canaglie e alle parate militari! Non si rivoltava sapendo ad esempio che una volta alla settimana, il venerdì, gli si impediva l’entrata alla sua Expo per riservarla ai ricchi, richiedendo cinque biglietti anziché uno! Se non si rivoltava, Jacob voleva credere, era perché nel baccano dei problemi, nelle musichette festaiole, nel carnevale delle uniformi, nella sinfonia melata dei grandi giornali, tutti gli ficcavano lo stesso chiodo nel cranio: “Ammira, plebaglia, il fasto che tu paghi; inèbriati, per procura, con lo champagne che si riservano i tuoi deputati”; il buon senso non aveva dalla sua che uno zufolo da tre soldi per farsi udire! E se non fosse stata quella la giusta spiegazione, se era nella natura profonda degli umiliati di venerare dei capi falsi, allora non rimaneva che il suicidio o l’esilio! Ma no, questa ipotesi era impossibile.
Si gettò con rinnovato furore nell’organizzazione del suo piccolo gruppo di sabotatori. Divise la Francia in quattro zone, in funzione delle linee ferroviarie: il Nord, l’Ovest, l’Est e il Midi. Per ora non era il caso di mettere in pratica la propria abilità a Parigi. La polizia e i confidenti vi erano troppo abbondanti, la popolazione troppo concentrata. Nelle province, invece, i rappresentanti della legge non avevano a loro disposizione una rete di collegamento solida come oggi.
Le tesi di Bertillon, che andava ostinatamente perfezionando il suo sistema antropometrico nelle soffitte del quai des Orfèvres, non erano ancora state accolte ufficialmente. Un bandito ricercato a Nantes per omicidio e catturato a Verdun in flagrante delitto di furto aveva ogni probabilità, a condizione che la sua identità posticcia fosse solida, di non essere punito che per quell’ultimo reato.
Le informazioni venivano trasmesse con estrema lentezza e parsimonia. Nessuno aveva ancora immaginato che un malandrino potesse avere l’audacia di organizzare una banda di dimensioni nazionali e i segugi di Picard scopriranno l’esistenza dei “Lavoratori della notte” solo quando Jacob verrà catturato, quasi per caso. Di più: essi non riusciranno mai ad individuare le immense ramificazioni del suo complotto contro la sicurezza dello Stato.
* * *
– Perché andavate a rubare in provincia?
– Facevo del decentramento.
* * *
Due libri divennero ben presto i favoriti di Alexandre: l’orario ferroviario, che permetteva le più sottili acrobazie geografiche se solo si sapeva leggere tra le coincidenze; e l’elenco telefonico edito dal Bottin, orgoglio dello snob che vi si vedeva inserito e provvidenza del “recuperatore” a caccia d’indirizzi. Certe descrizioni di castelli facevano sognare. Non rimaneva che andare a verificare sul posto.
Jacob aveva dichiarato guerra alle ricchezze, non agli uomini. Assalire una banca, che avrebbe evidentemente reso di più (anche se l’uso dei conti in banca non era ancora generalizzato) significava trovarsi quasi costretti a sfoderare il revolver e forse a sparare su degli innocenti impiegati. Entrare in una casa abitata aveva lo stesso rischio. Non c’era neppure da discutere: Stalin non manifesterà gli stessi scrupoli.
Ognuno in cambio manteneva il diritto di difendersi come meglio credeva contro chi era armato. Alexandre, da parte sua, si dichiarava pronto, se fosse stato il caso, a comportarsi come Etiévant, ex collaboratore del “Libertaire”, che, ricercato dalla polizia per complicità con Ravachol, si recò al commissariato di rue Berzélius, crivellò il piantone con ventidue colpi di coltello, ne trafisse un’altro tredici volte, scaricò il suo revolver su un terzo e al processo dichiarò: “Non ci tengo a vivere; la vita per me non è fatta che di miserie. Capisco che ci teniate voi, signori giurati e anche voi, signor sostituto procuratore generale ma per me è indifferente e io vi chiedo di non accordarmi le circostanze attenuanti.”
In funzione di questi diversi imperativi, egli prese l’abitudine di delegare nella città prescelta un solo uomo “con le mani in tasca”, meno vistoso e meno costoso di un gruppo organizzato. Costui aveva il compito di far scivolare delle zeppe, dei sigilli o dei normali pezzetti di carta, nell’interstizio delle porte dei palazzi più allettanti. Se ventiquattro o quarantotto ore dopo non erano caduti, significava che il locale era, almeno provvisoriamente, disabitato. L’uomo allora spediva a Parigi un telegramma il cui contenuto poco importava, ma che, se firmato “Georges” significava “Venite in due”, se firmato “Louis” “Venite in tre”. Inoltre, la prima parola usata indicava, secondo un codice convenuto, il materiale da portare. Non rimaneva quindi, dopo avere verificato ancora una volta i sigilli, che visitare il posto prima di riprendere il primo treno dell’alba o della notte per Parigi.
Un altro dettaglio: una sentinella, a mezzanotte in una strada deserta, poteva farsi notare. Alexandre ebbe dunque l’idea machiavellica e campestre di munirsi di un rospo, quando il tempo lo consigliava. L’animale veniva abbandonato nel canaletto dello scolo dinanzi alla casa prescelta. Finché quello gracidava, si stava tranquilli: nessun intruso s’avvicinava nei paraggi. In caso contrario, ci si preoccupava di far fagotto.
La scelta della vittima rispondeva ad un ultimo criterio. Nessuna pietà per i forzieri dei tre “parassiti” di Cimourdain: il prete, il giudice, il soldato, né per i responsabili più in vista dell’ingiustizia sociale: i grandi latifondisti, i possidenti e altri profittatori. (I magistrati, spesso provenienti dalla grande borghesia, possedevano in genere, a quei tempi, solide fortune personali).
Rispetto, invece, per quelli che si erano guadagnati il loro denaro lavorando, purché quel lavoro fosse stato costruttivo: medici, architetti, scienziati e scrittori. Fu così che un giorno, a Rochefort, dopo essersi introdotto nella sontuosa dimora di un capitano di fregata, scoprì che in realtà il proprietario era Pierre Loti, pseudonimo di Louis Marie Julien Viaud. Vuotò immediatamente i sacchi che aveva già riempito, rimise accuratamente ogni oggetto al suo posto e lasciò in vista un biglietto così concepito: «Entrato da voi per sbaglio, non saprei prender nulla a chi vive della sua penna. Ogni lavoro merita il salario. Attila. – P. S. Aggiungo dieci franchi per il vetro rotto e la persiana danneggiata».
Alexandre stabilì anche che la divisione del bottino sarebbe stata fatta secondo una regola tassativa: ogni “recuperatore” era tenuto a versare alla Causa un minimo del dieci per cento dei propri guadagni e il resto veniva utilizzato per vivere o per preparare le spedizioni successive. Il numero dei partecipanti era generalmente fissato a tre e quindi era press’a poco un terzo della refurtiva che andava alla propaganda. Lui stesso non teneva per sé che il minimo necessario.
Gli inquirenti saranno stupiti di scoprire che quell’uomo che maneggiava milioni, che avrebbe potuto scorrazzare in carrozza o in De Dion per i viali del Bois, mangiava al risparmio nelle osterie da un franco del boulevard Voltaire e non frequentava gli alberghi internazionali.
Alcuni giungono ora fino a dargli torto di non avere frequentato i luoghi di grande concentrazione monetaria che gli avrebbero permesso sicuramente di decuplicare i suoi recuperi. Essi citano al riguardo l’esempio di George Manolesco, che si fece passare prima per il principe Lahovary e poi per il duca d’Otranto e non rubò meno di quaranta milioni di sterline in dieci anni di frequentazione dei grandi alberghi. Ma i loro casi non possono esser messi a confronto. 1) Manolesco rubava per se stesso. 2) Le sue tecniche consistevano nel barare al gioco o nel sedurre le duchesse per sottrarre i loro diamanti: è improbabile vedere Jacob nei panni di Casanova. 3) Manolesco, come Lupin, amava il “gran mondo” nel quale s’era inserito. Jacob, invece, l’odiava al punto che gli si rizzavano i capelli in testa all’idea di frequentarlo. (Cfr., Maurice Leblanc, L’arrestation d’Arsène Lupin, Paris 1904, p. 3: «Arsène Lupin, il fantasioso gentiluomo che agisce solo nei castelli e nei saloni, una notte era entrato nella dimora del barone Schormann e ne era uscito a mani vuote dopo aver lasciato un biglietto da visita... decorato con la formula: “Arséne Lupin, ladro gentiluomo, ritornerà quando i mobili saranno autentici”». L’eleganza, in questo campo, va a vantaggio di Jacob. Oltre al caso di quella visita a Pierre Loti, un giorno che si trovava da un marchese che egli credeva ricchissimo e che scoprì coperto di debiti, fece di meglio: invece di derubarlo, gli lasciò diecimila franchi (trentamila franchi pesanti). Il marchese non fu da meno, come cortesia: non andò a testimoniare al suo processo. “Le Petit Parisien” del 30 aprile 1903 riferì, d’altronde, imparzialmente, a proposito di Jacob e dei suoi amici: «Quasi tutti i grandi furti commessi nelle chiese, nei castelli e nelle ricche ville che sono stati individuati nelle principali città di Francia in quasi due anni, possono essere attribuiti a questa temibile banda di malfattori». Vedi a questo proposito: J.-J. Lynx, Le Prince des voleurs, Paris 1965).
Insomma, il suo obiettivo era chiaro: non si patteggia, nemmeno temporaneamente, con il nemico. Non lo si spia: lo si combatte e lo si deruba. Possiamo anche ammettere che gli mancasse l’informazione: quel che sapeva del mondo non gli faceva nemmeno immaginare quella che poteva essere la fortuna di un Rothschild. Per lui, un Torquebiau o un Galabrun rappresentavano il massimo del capitalismo.
Questo errore di valutazione poteva essere fatale nel momento in cui si trattava di ribaltare i rapporti di forza in seno alla società.
Comunque, quelli che rifiutarono, in nome dell’individualismo, di adeguarsi alla regola del dieci per cento, furono estromessi dalla banda. Fu questo, in particolare, il caso di Roques. Ciò non gli portò fortuna: dopo qualche colpo fortunato, egli venne catturato a Saintes nel 1902 e condannato ai lavori forzati a vita dalla corte d’Assise della Charente-Inférieure, per fabbricazione e spaccio di moneta falsa.
Il problema più difficile da risolvere rimase a lungo quello dello smercio degli oggetti rubati. L’esperienza aveva insegnato ad Alexandre a diffidare dei ricettatori. La loro astuzia non aveva limiti. Non erano guidati da altro ideale che l’attrattiva del lucro: ed erano anche disposti a denunciare i loro clienti al primo allarme. I malviventi con i quali fu portato ad avere rapporti “professionali” andarono a raggiungere ben presto gli sfruttatori nella sua stima: era gente cinica, pigra, crudele, violenta e inoltre reazionaria.
I titoli al portatore non presentavano alcun rischio: bastava rivenderli ad un agente di cambio. Anche certi oggetti, come le pendole o gli orologi, potevano e senza difficoltà essere depositati nei Monti di Pietà, anche se con pesanti perdite.
Per le pietre preziose e i diamanti, si mise in contatto ad Amsterdam con vari diamantai di cui non ebbe mai a lamentarsi. I suoi rapporti con gli olandesi raggiunsero un grado di confidenza tale che un dirigente dei Lloyds, perfettamente al corrente della sua attività, lo nominò esperto in svaligiamenti, in seguito ad una discussione che s’era prolungata parecchio nelle taverne della Rembrandtsplein e nel corso della quale l’assicuratore, soggiogato, finì per condividere pienamente le sue teorie sulla proprietà. Ciò che denotava certamente in quell’uomo un senso degli affari particolarmente spiccato in quanto nessuno era in migliore posizione di Jacob per smontare il meccanismo del furto con scasso. (Sembra anche che, per amicizia o per senso dell’umorismo, Jacob abbia davvero reso dei servigi due o tre volte, al suo corrispondente nei Paesi Bassi, ma unicamente in sordidi casi di omicidio che egli disapprovava più che ogni altro. Purtroppo, non sono riuscito ad avere dettagli su questi episodi).
Per i titoli nominali, egli pensò di trovare più facilmente acquirenti tra i commercianti dell’Africa del Nord o dell’Egitto, in quanto i valori francesi godevano a quel tempo di una solida reputazione.
E così, verso la fine del 1900, s’imbarcò con Rose, che cominciava ad annoiarsi sotto la pioggia parigina, su un piroscafo che faceva il giro del Mediterraneo. Il viaggio ebbe unicamente un interesse turistico. Le valutazioni che offrivano per la sua merce non superavano quelle praticate nei più rapaci laboratori di Montmartre. Inoltre, al Cairo, una gioielleria indicatagli da un viaggiatore di commercio gli resistette: i servitori dormivano di notte dinanzi alla porta. Si consolò visitando le sfingi e le piramidi ammirate da lontano da giovane, sempre accompagnato da Rose che soffrì il mal di mare a dorso di cammello. Non gli andò meglio ad Algeri, né con gli usurai locali né con le proprietà dell’ambasciatore di Russia. Solo i vicoli della casbah furono per lui accoglienti.
Allora si indirizzò a Londra. Darien aveva già indicato la trafila: qualunque ricettatore di Soho si incaricava di rivendere prestiti russi o buoni del Tesoro ai potentati del Medio Oriente, fedeli sudditi di sua Maestà, incolti, avidi e per i quali ogni quadratino di carta stampata proveniente dall’Europa assumeva il valore di un talismano. Questa parte della rete fu messa in piedi fin dagli inizi del 1901. Ognuno, ladro, intermediario e monarcuccio vi trovò evidentemente il suo tornaconto perché l’interscambio commerciale tra i “Lavoratori della notte” e i topi di Londra diventò subito molto regolare.
Rimanevano i metalli preziosi. Che fare delle montature in oro o della posateria in argento massiccio, particolarmente apprezzata a quel tempo in cui il metallo bianco non era ancora svalutato? Le delusioni da quel lato erano state numerose. Nessuno voleva prendere quella roba, nonostante il suo valore a volte molto elevato, se non per somme ridicole nel timore di denunce. Fu lì che si manifestò con tutto il suo splendore il genio organizzativo di Jacob.
Innanzitutto provò ad improvvisarsi lui stesso fonditore d’oro e d’argento. Ma non aveva la capacità né la licenza, né suoi canali di vendita. I suoi lingotti approssimativi gli rimasero sulla gobba.
La necessità di fare riparare i propri attrezzi e di acquistarne di nuovi lo portò allora ad incontrare un fabbro ferraio che stava in rue de Charenton. Un tipo abbastanza abile, un po’ alcolizzato e molto anarchico, di nome Siméon Charles. A quarant’anni, aveva un padre ammalato, una madre paralitica, una moglie e due bambini. Era affetto da varici alla gamba destra. Aveva collaborato all’effimero “Cri de la Révolte” con lo pseudonimo di Dick ed era rimasto in qualche modo coinvolto nella cattura dei compagni Choup e Bernard a Nancy, l’anno prima. Contro un compenso che poteva variare tra centocinquanta e trecento franchi “secondo dimensione”, accettò di fabbricare pinze e leve secondo i meticolosi disegni forniti da Alexandre.
Malgrado l’amore esagerato per il vino rosso che gli faceva tremare la mano e costringeva a volte a portare da Tardiff, in vicolo Pressoir, le ordinazioni per oggetti di grande precisione, era un brav’uomo. Presentò Alexandre ad Emile Limonnier, un commerciante di una cinquantina d’anni che abitava vicino alla stazione Montparnasse, in rue Lalande 16. Costui, uomo di risorse e anarchico, naturalmente, conosceva il suo mestiere.
– Mi chiamo Escande – gli disse Alexandre. – Faccio l’antiquario. Durante i miei giri in provincia, mi è capitato di scovare delle vecchie montature di gioielli senza altro valore che il loro peso in oro. Non conoscete l’indirizzo di una piccola fonderia di metalli preziosi che mi possa sbarazzare di queste cosuccie?
Limonnier lo portò subito nella sala interna di un caffeuccio del quartiere del Temple, in rue Michel-le-Comte, da Olary.
– La vostra proposta mi interessa – disse Olary. – Vorrei farvi da intermediario.
– Io non voglio intermediari – rispose Alexandre.
– E allora niente fonditore.
– Voglio vedere il fonditore – insistette lui, tirando fuori dalla tasca un rotolo di banconote.
Dieci minuti dopo il padrone portava dinanzi all’antiquario Escande un giovanotto di nome Apport.
– Mi dispiace – cominciò quest’ultimo – ma arrivate troppo tardi. Io non sono che un dipendente. Il mio padrone, che è sull’orlo del fallimento, non vuole più prendere ordinazioni. Sta vendendo il negozio.
– Andiamo a fare un giro – ribatté Alexandre.
Fecero qualche passo per la strada.
– Io ti conosco – proseguì subito. – Ti ho visto in una riunione pubblica del XVII. Tu maledivi l’esercito. Tu sei un anarchico.
Nel giro d’un’ora, Alexandre sapeva quel che desiderava. La fonderia apparteneva a François Brunus, un compaesano di Apport, nativo di Amost, nella Saône-et-Loire. Brunus aveva trentasei anni. In seguito ad oscuri dissensi, i suoi soci l’avevano lasciato due anni prima, carico di debiti e senza clienti. Quindi tirava avanti alla bell’e meglio con la moglie e il suo bambino. Gli affari non s’erano mai ripresi. Brunus era portato alla rassegnazione, all’acredine e all’assenzio. Apport, che abitava presso di lui, mangiava alla sua tavola e si sforzava di procurargli ordinazioni, giurava che era un brav’uomo, inoffensivo, discreto, anarchico in fondo al cuore anche se rifiutava di ammetterlo. Alexandre riuscì ad essergli presentato immediatamente.
Gli offrì da bere, gli diede fiducia, gli dipinse il mondo di rosa, gli dispensò amichevoli pacche e poi, durante la cena familiare che seguì, una solida stretta di mano suggellò la loro amicizia. Alexandre versò a Brunus una somma in denaro contante sufficiente a saldare i suoi debiti più urgenti. S’impegnò inoltre a fornire alla fonderia un centinaio di chili d’oro e d’argento ogni mese da trasformare in lingotti. In cambio, Brunus si associava a lui. Si sarebbero divise le entrate secondo un tariffario che venne accuratamente stabilito.
La fonderia andò così risollevandosi con la certezza di un lavoro regolare. Quanto ad Alexandre, oltre al piacere di aggirare finalmente il “parassitismo del ricettatore”, provava un’intensa esultanza al pensiero che i suoi lingotti, fabbricati da oggetti recuperati da lui, sarebbero finiti tra gli acquisti dei banchieri: rubati due volte.
Parallelamente alla costituzione di quella infrastruttura dalle ramificazioni internazionali, egli proseguiva instancabilmente i suoi furti al ritmo di due alla settimana, procedendo con dei giri nel corso dei quali dieci, a volte quindici case, castelli o chiese venivano visitati in pochi giorni. Quindi si fermava il tempo di spacciare la refurtiva e di versare il denaro ai vari giornali o ai militanti bisognosi.
La banda raggiunse rapidamente il numero di quaranta elementi che operavano sempre a tre a tre, separati, ma che si riunivano con Jacob per preparare le future campagne, esaminare le nuove tecniche e consegnare il bottino. Nei periodi più caldi, nei tre anni che durò la loro piena attività, si può attribuir loro fino a dieci e persino venti svaligiamenti alla settimana. Si conosce all’incirca la metà dei componenti di questo gruppo. Invece, soprattutto per ragioni giuridiche, non si può svelare granché sui beneficiari di questo vero racket dagli scopi rivoluzionari: i loro discendenti sono ancor oggi viventi e, meno libertari dei loro padri, si potrebbero forse considerare quasi diffamati vedendo il loro nome associato a quello di Jacob. Per lo stesso motivo, non sarebbe opportuno evocare altri misfatti commessi dai “Lavoratori della notte” oltre a quelli che sono stati formalmente presi in considerazione dalla polizia o dalla giustizia, ossia appena la decima parte del numero totale, che non deve essere troppo lontano dal migliaio.
D’altra parte, ogni spedizione non fruttava per forza una fortuna. Ci furono delusioni, brutti momenti, fiaschi. Gli inizi furono catastrofici.
Il 13 febbraio 1901, mentre Ferrand, sotto il nome di Dunin metteva in pratica le sue capacità nella regione di Soissons in compagnia di Georges Lombardi, alias Vambelle, militante, acrobata e borsaiolo, Jacob, sotto lo pseudonimo di Feran, s’arrampicava, seguito da Royère, lungo una grondaia della chiesa di Saint-Sever a Rouen, rompeva un finestrino sul tetto della sagrestia, srotolava una fune fino a terra, sfondava la porta di comunicazione che dava accesso al santuario, portava via i quattrini deposti nelle cassette delle elemosine ed il contenuto dei vari armadi, tra cui un calice d’oro massiccio, quindi lasciava sull’altare maggiore il biglietto da visita di Attila, con queste parole: «Dio onnipotente, cerca i ladri che ne hanno derubati altri!».
Il tempo per smerciare a Parigi calice, cibori, candelieri, reliquari, broccati e merletti e i due soci arrivavano a Orléans il 24. Il 27 svaligiavano, in rue de Loigny, il signor Levacher e una tal vedova Benoît, quindi ritornavano tranquillamente nella loro camera d’albergo prima di andare a verificare altri sigilli.
Purtroppo, il signor Levacher, rientrato a casa appena poche ore dopo la loro visita, aveva avvertito la polizia. Tutti gli alberghi e le pensioni della città furono sistematicamente controllati. Alle sette di sera, nel momento in cui si preparavano ad uscire nuovamente, due gendarmi bussarono alla porta. Royère impugnò il suo revolver. Alexandre gli fece un cenno negativo: forse c’erano altri poliziotti di sotto.
– Fa’ come me – gli bisbigliò.
Apri la porta con aria insonnolita, mostrò con educazione i suoi documenti falsi e accettò sorridendo di seguirli al commissariato.
– Fate proprio bene a controllare l’identità dei viaggiatori – disse loro. – Non si sa mai con chi si ha a che fare. Non sarà certo un antiquario che vi impedirà di difendere la proprietà privata!
Ai piedi dello scalone, mentre i rappresentanti della legge giravano a destra, lui si diresse freddamente a sinistra. Royère lo seguì.
I gendarmi li richiamarono. Alexandre accelerò il passo.
– Fila! – disse a Royère. – Io li trattengo un po’.
Contemporaneamente, si diresse sotto un atrio buio. Gli agenti lo seguirono. Risuonarono due colpi. Il gendarme Couillant crollò a terra.
* * *
– Evviva l’agente Couillant! Ha fatto il suo dovere!
– Oh, certo! Ha ben meritato dal capitalismo e dalla proprietà! Questo non è eroismo, è asineria!
– Dovreste vergognarvi di parlare così!
– I fornai fanno il pane. I muratori costruiscono case. I calzolai fabbricano scarpe. Il pubblico ministero taglia teste. Bel mestiere! Non ho rimorsi. Se ho agito così, è perché ho ritenuto di doverlo fare. Se potessi ricominciare, ricomincerei. Prima di scomparire, tengo però a dirvi che vi odio e vi disprezzo. Voi siete i padroni, ma non vi riconosco il diritto di giudicarmi!
* * *
Alexandre batté allora in ritirata verso lo scalone. S’arrampicò fino al secondo piano, aprì una finestra del pianerottolo che dava su un giardino d’inverno di un piano più basso e che apparteneva ad un altro edificio. Quindi si lanciò senza esitare tra un fracasso di vetri rotti, si rialzò incolume e riprese la sua corsa.
La prima porta che vide dava in una sala da pranzo: quella del dottor Buisson, deputato del Loiret, che stava tranquillamente mangiando insieme ai suoi bambini, servito da un paio di domestici. Egli vi si lanciò con il revolver in mano. Tutti ebbero un moto di sorpresa. Era l’irruzione del crimine nella banalità della minestra di cavoli.
– Non vi disturbate per me – disse lui con tono cortese. – Sono un povero contrabbandiere braccato dalla gendarmeria. Faccio questo mestiere per mantenere la mia famiglia.
Così parlando, si tolse in fretta il soprabito e la bombetta, li appese ad un attaccapanni, s’impadronì del berretto di velluto che il deputato teneva in testa, si mise una penna sull’orecchio, prese una mela dal cesto ed uscì di nuovo senza imbarazzo scusandosi d’essere entrato senza bussare.
– Tutto questo accadde così in fretta – disse un’ora più tardi il dottor Buisson al commissario, – che se non fossimo stati in cinque nella sala e se quello non avesse abbandonato il suo mantello, potrei credere d’aver sognato.
Alexandre rimise in tasca il revolver e scese per strada sgranocchiando la mela, come un borghese sorpreso dal baccano mentre pranzava. La folla brulicava attorno all’edificio attiguo. Gendarmi spuntavano ovunque. Tre vetture dei pompieri erano già pronte ad entrare in azione. Per fare come tutti gli altri, alzò la testa con aria incuriosita verso il tetto da dove “quello” pareva fosse fuggito.
– Ne hanno già preso uno! – diceva la gente eccitata. – L’hanno preso mentre fuggiva verso il quai Neuf!
Indietreggiò pian piano, poi girando i tacchi, si allontanò a grandi passi sforzandosi di non correre. Uscì da Orléans. Seguì i binari. La fortuna l’assisteva: ben presto udì il fischio di un treno. Stava avanzando a bassa velocità. Alexandre si nascose tra i cespugli finché la locomotiva non fu passata e balzò sui respingenti di un carro merci.
Cominciò a cadere una pioggia gelida che si mescolava al sudore che gl’incollava la camicia alla pelle. Dopo qualche minuto, stava tremando. Raggomitolato, battendo i denti alle raffiche di vento, rimase aggrappato fino alle prime luci di Artenay. Là, si lasciò scivolare sulla massicciata, si scrollò e tentò di orientarsi. Era inzuppato, inzaccherato di fango e senza cappello, cosa che, più che tutto il resto, gli attirava l’attenzione dei curiosi. Brividi di freddo e di febbre lo scuotevano. Accessi di tosse lo lasciavano senza respiro. Royère, secondo i testimoni, era dunque stato catturato. Con un interrogatorio un po’ troppo pesante, non si sarebbe lasciato sfuggire qualcosa? In tal caso, i connotati di Alexandre sarebbero stati diffusi telegraficamente in tutta la Francia; le stazioni, le strade, i dazi sarebbero stati sorvegliati...
Nella notte opaca e piovigginosa, intravide un cimitero. Saltò oltre il muro. La sete gli bruciava la gola. Bevve con una smorfia un po’ d’acqua melmosa da una pozzanghera, poi assaggiò quella di una vasca che non era migliore. Gli venne la nausea.
Da qualche parte scoccarono le due del mattino. Le tombe non offrivano alcun riparo. Scavalcò di nuovo, con gran fatica, il muro e avanzò vacillante verso i campi, al limite del delirio. Era una crisi come non ne aveva avute dal suo ritorno da Dakar. Quando spuntò un covone di fieno, crollò e vi si sprofondò come in un letto di piume e cadde in un sonno comatoso.
L’alba lo ridestò. La febbre sembrava un po’ calata ma era in uno stato pietoso. Almeno, aveva quasi recuperato la lucidità. Doveva trovare un nascondiglio. Dopo essersi scosso alla bell’e meglio la paglia attaccata ai vestiti ancora umidi, si mise in cammino verso la città, scosso da tali raffiche di brividi da doversi sostenere agli alberi.
Prima di giungere alle prime case, raccolse dei sassolini piatti che si mise in bocca per deformare le guance, si tagliò un bastone e si mise un fazzoletto sulla schiena a mo’ di gobba. Quindi, curvo come un vecchio, si diresse verso la stazione con andatura incerta: in mancanza d’altre risorse, non poteva far di meglio, quanto a travestimenti. Chiese con voce tremante all’impiegato un biglietto di terza classe per Parigi. Il treno non sarebbe passato che un’ora più tardi. Furono lunghi momenti d’angoscia, in un sala d’aspetto mal riscaldata da un braciere. Appoggiato al suo bastone, spiava attraverso gli occhi semichiusi ogni gesto degli impiegati e l’andirivieni dei viaggiatori, dissimulando l’intensità del suo sguardo che gli avrebbe sicuramente attirato sospetti, paralizzato dal freddo, la bocca secca, tormentato da un cattivo sonno, disposto a vender cara la pelle se fossero arrivati i gendarmi.
Quando finalmente venne annunciato il treno, recitò così bene la parte del vecchio vagabondo che uno sconosciuto, mosso a pietà, lo aiutò a fare gli scalini del vagone.
Scese a Palaiseau, comprò un giornale e s’arrampicò su un omnibus. “Il delitto della rue de Loigny” campeggiava sulla prima pagina del “Matin”. L’articolo non riguardava altro che Royère. Nessuna notizia in riferimento al “misterioso complice”, l’inafferrabile futuro Arsène Lupin. Chissà però se una trappola era stata tesa in rue de la Clef, da Thériez?
Andò da Matha. Costui, dopo averlo rivestito decentemente, lo trascinò immediatamente da un medico, che aveva fatto parte della giuria al processo dei Trenta e da allora s’era convertito all’anarchia.
Il dottore lo nascose e lo curò paternamente per quattro giorni. Quell’uomo conosceva attraverso Matha le attività di Jacob. Sapeva a qual punto queste potevano essere preziose per la Causa. Riuscì ad avvertire Rose, divorata dall’ansia per la situazione del suo amante, e le comunicò la proibizione assoluta da parte di Alexandre di tentare per il momento di vederlo: avrebbe potuto essere pedinata.
Il 5 marzo, con i capelli tinti di bianco, la salute quasi recuperata, egli si presentava all’entrata degli artisti del teatro della Porte-Saint-Martin. Una delle sue idee: nel momento in cui tutte le polizie di Francia dovevano essergli alle calcagna, aveva pensato che il modo più efficace di nascondersi era di comparire tutte le sere in pubblico. Il dottore gli aveva parlato per caso delle repliche del Quo vadis di Sienkiewicz, allora in cartellone il cui regista era un simpatizzante. Così, la sera di sabato 16 marzo, il tout Paris delle grandi prime poté applaudire, al fianco di Cora Laparcerie e di Jean Coquelin, il “compagno del piede di porco” che lo faceva trepidare per i suoi ori, nel modesto e muto ruolo del secondo centurione. Dopo lo spettacolo, per maggiore prudenza, Alexandre s’improvvisava un giaciglio in un angolo tra le quinte.
Ben presto ne ebbe abbastanza. Il pilum gli cadeva di mano. Il pubblico mondano dei Boulevard, intravisto durante gli intervalli, l’orripilava. Le repliche dello spettacolo, questo inno all’eroismo dei primi cristiani, erano per lui repellenti. Si arrischiò a fare portare da un ragazzo un biglietto a Ferrand da Thériez, lo vide e l’invitò ad accompagnarlo in una spedizione in Germania: al “Libertaire” si volevano stringere contatti più assidui con i compagni d’oltre Reno per sviluppare soprattutto una campagna pacifista e bloccare i nazionalisti delle due parti. Avrebbe inoltre potuto essere un’eccellente occasione per infondere laggiù le idee che ispiravano i “Lavoratori della notte” e stabilire il movimento di riappropriazione su basi veramente internazionali. E poi l’istruttoria contro Royère proseguiva ad Orléans ed Alexandre continuava a non avere alcun modo di sapere se il suo amico avesse parlato o no.
Si ignora chi Jacob incontrò a Francoforte, ad Amburgo e a Berlino. Si ignora se il suo passaggio ebbe qualche influenza sull’evoluzione dell’anarchismo tedesco. Di quel viaggio non si conosce, dal resoconto che egli ne fece ad Alain Sergent, che l’episodio che poteva costare la vita a due gendarmi di Epinal.
La fatica e la mancanza di cure avevano infettato il suo sangue. Soffriva soprattutto di un antrace dolorosissimo e in una brutta localizzazione, che scoppiò una notte, in albergo, macchiando le lenzuola.
L’albergatore pensò a qualche oscuro fatto delittuoso ed avvertì la polizia. Due sbirri bussarono alla porta della camera occupata da Alexandre e Ferrand nel momento in cui costoro stavano facendo colazione: pensarono subito che si trattasse di qualcosa in relazione all’affare di Orléans. Pur mostrando i suoi documenti intestati a Joseph Escande, Alexandre si tenne pronto ad afferrare il revolver.
Quando i gendarmi ebbero spiegato allo stimato antiquario con un tono un po’ imbarazzato il motivo della loro visita, costui scoppiò a ridere e, approfittando di una occasione che sicuramente non si sarebbe mai più ripresentata, per provare la realtà dell’antrace, si slacciò la cintura e mostrò loro le natiche.
Non ritornò in Francia che alla fine di marzo, quando una lettera gli comunicò finalmente che la corte d’Assise di Orléans aveva pronunciato il suo verdetto: Royère era condannato ai lavori forzati e lui stesso a morte, ma sotto il nome di Feran. Royère quindi non aveva parlato.
* * *
– Il vostro complice Royère è morto durante la prigionia.
– Una vittima in più o in meno, vero?, vi importa poco! Ma lui era innocente!
– Se lo era, perché avete lasciato che venisse condannato?
– Mi prendete per fesso? Volevate due colpevoli invece che uno solo? Royère non era un chiacchierone né una spia né un delatore! Ecco perché non mi ha denunciato! Voi, voi l’avete assassinato!
* * *
La scomparsa del fedele compagno gli causò un dispiacere tanto più profondo perché se ne riteneva responsabile. Senza il suo arrivo a Mont-Perril, Royère vi sarebbe rimasto come infermiere, l’unico essere comprensivo verso i malati, forse più utile in quel ruolo che in quello di svaligiatore al quale, malgrado la sua buona volontà, non s’era mai abituato. La guerra sociale aveva quindi fatto un’altra vittima. Alexandre non poteva abituarsi all’idea di aver provocato la tragedia di un uomo, fosse anche uno solo, mentre lui lottava per migliorare la sorte di tutti. Per sé, accettava i rischi. Ma soffriva a condividerli con gli altri.
Verso il 5 aprile, un colpo di mano in casa del signor Merlin, a Reims, in rue Nicolas Henriot 5, si rivelò difficile da portare a termine. Bisognò introdursi attraverso una grata, forare a colpi di sbarra di ferro il tramezzo di mattoni che separava il vestibolo dalla scala della cantina e sventrare la cassaforte del primo piano.
Ci vollero due ore. Il tutto, è vero, per una bella sommetta: all’incirca diecimila franchi.
Nella notte tra il 10 e l’11 aprile, in casa del signor de la Rivière, mancò poco che li catturassero: la signora Bourg, la vicina, una cuoca, udì rumori e mise in allarme tutto il caseggiato. Per fortuna, il lavoro era ormai al termine ed il bottino, quindicimila franchi, radunato; ma dovettero fuggire alla svelta.
* * *
– Signor Presidente, si potrebbe precisare meglio dove si trovavano i querelanti quando mi sono introdotto in casa loro?
– Erano in campagna.
– Ah! Hanno due case? Non sono certo dei poveretti! E di cosa si lamentano!
* * *
Sempre ad Amiens, il 26 maggio, in casa del signor Chivot, in boulevard de Belfort 38, il lavoro non fu più agevole. Le numerose serrature e la foratura di un forziere particolarmente ostinato impegnarono parte della notte, mettendo a dura prova i nervi dei complici di Alexandre. Solo lui mantenne la calma. Dovette persino confessare che prendeva gusto a quel nuovo mestiere. Il pericolo l’eccitava come una droga.
* * *
– Jacob, che cosa avete fatto del flauto d’argento, del valore di seicento franchi, rubato al signor Chivot? L’avete sicuramente fuso.
– Sarebbe stato un peccato. Conosco più di lui il valore degli oggetti. L’ho regalato ad un amico.
* * *
Finché si era rimasti alla teoria, i militanti erano stati insieme a lui con entusiasmo. Nella pratica, la vicinanza quotidiana con il pericolo, le conoscenze tecniche indispensabili ma troppo lunghe o troppo difficili da acquisire, cominciavano a scoraggiare anche i più volenterosi. Non tutti avevano allo stesso grado lo scrupolo e l’audacia del loro ispiratore. Più questo s’entusiasmava, più le defezioni diventavano numerose.
Alexandre scoprì allora che gli uomini di buona volontà non sono per forza i più utili nella guerriglia. La constatazione non poteva non essere lacerante per un idealista. Ma non c’era modo di sfuggire. Così, per riempire i vuoti nelle sue truppe, egli fu costretto a utilizzare le capacità di personaggi dal passato avventuroso.
La giustizia concorderà nel vedere in essi dei “malfattori incalliti di cui sarebbe ben difficile immaginare il pentimento”. I giudici istruttori li tratteranno da “spostati”, condanna senza appello, massima scomunica. Ma chi aveva forgiato quel termine di spostato se non loro, che avevano perfino negato la realtà quotidiana della lotta di classe? Come Rose, quegli “spostati”, prodotti e rifiuti della società, erano per Alexandre degni a priori di compassione. Trasformati in fuorilegge, coerenti con se stessi, potevano diventare rudi combattenti.
Egli non ebbe alcuno scrupolo ad utilizzare la loro abilità. Poco importava che quel pregiudicato non avesse mai letto Stirner o Bakunin, se era ribelle nel profondo e se durante un furto con scasso poteva rendere maggiori servigi alla Causa che quel tale teorico incapace e pauroso: occorre superare un esame di filosofia per diventare rivoluzionari? Egli non imponeva che un’unica condizione al loro ingresso: che non fossero mai caduti nel circolo vizioso dei malviventi, quella gente che obbedisce alle leggi del milieu, che adora un dio, il denaro, che si prostra dinanzi ad un padrone, la forza bruta. La società bollava come marci quelli che essa voleva abbattere, come si accusa un cane di avere la rabbia. Jacob, con gli anarchici, prendeva sempre le difese del cane.
A forza di sentirsi ripetere che avevano un “fondo malvagio”, a forza di vivere in condizioni ignominiose, qualcosa in quegli angeli scacciati dal paradiso sociale non s’era forse deteriorato? Può darsi. Alexandre tuttavia rovesciava l’obiezione: a forza di approfittare di privilegi ingiusti, il migliore dei borghesi si trovava forzatamente corrotto. A forza di subire la schiavitù dell’officina, il più intelligente degli operai (a meno di passare ad un livello superiore della gerarchia, cosa che non faceva che abbassarlo nel rango di servo dello sfruttatore) diveniva automaticamente idiota. Insomma, non era semplice (sicuramente non lo fu mai) essere allo stesso tempo individualista e socialista.
Ad ogni modo, Pélissard, alias Edme, alias Plessis, alias Royan, venne ammesso senza difficoltà tra le file dei “Lavoratori della notte”. (Nato il 15 giugno 1867 a Lione. Celibe. In teoria esercitava il mestiere di venditore ambulante. Sua madre era commerciante, come suo fratello, abitava negli Stati Uniti, a Los Angeles, in Aliso Street 312).
La sua fedina penale era piuttosto pesante: un mese di prigione e 16 franchi d’ammenda nel 1886 per oltraggio e ribellione, un titolo di merito di certo notevole agli occhi di Alexandre, quanto la citazione da lui ottenuta durante il servizio militare all’epoca della campagna del Tonchino “per aver salvato a rischio della propria vita un ferito che stava per cadere nelle mani dei cinesi”: sei mesi, in quello stesso anno, per percosse e ferite (ma bisogna pur difendersi); cinquanta franchi di ammenda nel 1888 per infrazione al divieto di pesca (bisogna pur mangiare). Altri sei mesi per percosse e ferite nel 1888, con contorno di cinque anni di divieto di soggiorno: da qui verranno tutti i guai. Pélissard aveva un’opinione ben precisa sul divieto di soggiorno. L’ha scritto: «Questa legge ha fatto più forzati da sola che l’insieme di tutti i cattivi istinti. Aveva come scopo la degradazione del proletariato, con il fine di ridurne il numero di elettori. Con il divieto di soggiorno nacquero le grandi retate in cui, con l’accusa di sette od otto tipi diversi di vagabondaggio, si spediva la gente in prigione. Otto arrestati su dieci erano innocenti ed inoffensivi. Fu quello il primo contatto con l’ambiente non di “correzione” ma di “corruzione”. Una parte di quella gente non poté decidersi ad abbandonare la propria città: e poi, un buon numero era alla trentesima o quarantesima condanna variante da uno a tredici mesi di prigione, per l’orribile delitto di respirare l’aria del paese natale e questo in un’epoca in cui le parole Patria e Libertà erano tanto esaltate. Io ne rimasi vittima proprio quando mia madre voleva prendermi con sé nel suo negozio di Lione ma non potei. Quella legge mi precludeva non soltanto Lione, ma un centinaio di città della Francia, e chi ne è vittima deve utilizzare l’astuzia più sottile per sfuggire alla repressione. Quella legge ripulisce una città per infettarne altre, costituendo ambienti cosmopoliti (?)... Se non m’avessero impedito di diventare onesto, adesso farei il commerciante a Lione».
Questa arringa vale quel che vale, ma Alexandre non poteva non esservi sensibile. Vi ritrovava un po’ di quel che aveva subito. I magistrati invece non avevano evidentemente ascoltato Pélissard: gli avevano inflitto ancora cinque anni di reclusione, più altri cinque di divieto di soggiorno, alla corte d’Assise del Rhône, il 20 maggio 1895, per furto aggravato; quattro mesi nel 1899 per infrazione al divieto di soggiorno; sei mesi, subito dopo, per lo stesso motivo: egli era là quando Alexandre lo iniziò in loco alle sue tecniche, in casa del signor Hulot, giudice di pace di Le Mans, nella notte tra il 9 e il 10 giugno 1901. Pélissard, ebbro di felicità per il suo tentativo di svaligiare uno di quei “tartufi” che lo spedivano dalla cella all’isolamento, vi imparò l’uso del piede di porco per spaccare una porta d’ingresso; quello del grimaldello per aprire la porta di un salone; quello del trapano per il forziere. Il bottino fu grosso: più di 156 catene, medaglie, bomboniere e gioielli rarissimi, fin troppo belli, alcuni risalenti al XV secolo e tutti erano piccole meraviglie, senza contare l’argenteria, i vestiti e i merletti. Alexandre, da parte sua, fu tanto soddisfatto dell’operazione che lasciò la sua firma sul caminetto: «A te, giudice di pace, noi dichiariamo guerra». Pélissard, più rozzo nell’esprimere la sua gioia, si accontentò di urinare in una bottiglia di vino bianco svuotata in precedenza e di depositare un superbo stronzo su una poltrona del salone. Quando, verso le quattro del mattino, incrociarono per strada il signor Camille Bolée, industriale di Le Mans, Alexandre gli fece educatamente tanto di cappello.
* * *
– Poco dopo quel furto, mia moglie è morta di dispiacere per commozione cerebrale. Così, mi hanno rubato la mia ricchezza e ucciso la mia povera moglie!
– Mi rincresce per la coincidenza, mio povero signore. Ma io non sono Dio padre.
* * *
Nella notte tra l’8 e il 9 luglio 1902, il signor Verdier, fabbricante di maglieria abitante ai Saints-Pères, ricevette la loro visita nella sua fabbrica di Nanteuil-les-Meaux. La cosa più difficile non fu tanto introdursi nella fucina, quanto trasportare il forziere su un materasso dall’ufficio fino alla fabbrica, dove il rumore si sarebbe sentito meno, quindi aprirlo, poiché quella Notan-Schmidt esigeva mani esperte. Dalle sue viscere furono estratti quattromilacinquecentocinquantacinque franchi, oltre a cinque azioni del “The London and Paris Chemistry”. Verso le tre e mezzo del mattino, il macellaio Gaston Cruel, che andava a pescare, li scorse mentre si dirigevano tranquillamente alla stazione.
Il primo agosto fu la volta della signora Clemot, allora in vacanza alle Sables-d’Olonne, di riceverli in casa sua a Niort in avenue de Limoges 24.
Poi Pélissard si fece prendere stupidamente in una retata a Parigi e fu di nuovo condannato a sei mesi, sempre per infrazione alla legge sul divieto di soggiorno.
* * *
– Pélissard, avete qualcosa da dichiarare a vostra discolpa?
– Non ho niente da discolparmi. Sono un figlio della Natura, nemico di quella degli uomini. (...)
Le leggi naturali farebbero della terra un paradiso. Le leggi umane ne fanno un inferno.
Son sorpreso di esser trascinato dinanzi a voi per dei giochi da ragazzi, dopo quel che mi venne insegnato da militare. Nel Tonchino ho visto i soldati francesi avventarsi su indigeni inoffensivi, sgozzarli furiosamente dopo aver incendiato i villaggi dove quelli si erano rifugiati; e questo perché si rifiutavano di portare i nostri bagagli a centinaia di leghe lontano dalle loro case. (...)
La borghesia è un’associazione a delinquere legale che impedisce agli altri di prendere il potere. (...)
La stampa è una muta di cani, che abbaia al servizio della polizia, che tollera le sue rapine e i suoi ricatti.
La polizia? Il mezzo più potente per rendere un popolo vile e pusillanime.
La giustizia: una bilancia che pesa di più o di meno per lo stesso fatto a seconda che si sia ricchi o poveri. (...)
L’anarchia è l’ideale sublime di quelli che gemono e la poesia degli spiriti fecondi.
È tutto quel che avevo da dire.
* * *
Lo sostituì uno dell’Ardèche: Marius-Antonin Antoine Baudy, nato a Grospierres il 18 ottobre 1875. Era appena stato liberato dalla prigione centrale di Nîmes in occasione del 14 luglio 1901. La celebrità di Jacob in quei luoghi malfamati era tanto grande che andò subito alla tana di rue de la Clef. Vi capitò contemporaneamente a Clarenson, “il barone”, che era appena stato rilasciato dalla stessa prigione. Con Thériez, il padrone, e Bonnefoy, l’alter ego di Clarenson appena arrivato da Marsiglia, furono da allora interminabili partite a carte e a bocce. Il rifugio del Quartiere Latino divenne una bisca. Alexandre aggrottava le sopracciglia. L’ambiente cominciava a degenerare. Si infuriava. Inutilmente. Lo trattavano da maestro di scuola e da lacchè.
Baudy fece ben presto la conquista di Jeanne, la sorella di Rose, che chiamavano “la marsigliese” a causa del suo accento. Tutti insieme, pranzavano in un ristorantino in boulevard Voltaire 5. Poi, mentre Alexandre, diventato il guastafeste, preparava un nuovo colpo con Ferrand o rimaneva a colloquio con Matha, Sébastien Faure, Pouget, Jean Grave, Pierre Martin o Malato nella sala interna del caffè Muniez, all’inizio di rue Lepic, gli altri riprendevano in mano il bossolo dei dadi. Appena voltava la schiena, la placida spelonca ridiventava una succursale di Macao: i legionari sono meno facili da trattare che i chierichetti.
Personaggio affascinante, Baudy, questo ragazzo perduto della Belle Epoque! In prigione ha scritto qualche pagina di Confessioni, “Canzone del ragazzo finito male”, gesta della desolazione, memorie di un “vinto dalla vita”, come dice lui, attraverso cui è difficile riconoscere il “temibile malfattore che non indietreggia dinanzi ad alcun crimine” di cui l’accusa traccerà il profilo. Senza dubbio, egli leviga, già che c’è, gli spigoli troppo vivi. Ma lasciamogli la parola.
«Io sono un figlio postumo: mia madre, vedova dopo pochi mesi di matrimonio, per sovvenire ai suoi e ai miei bisogni, mi affidò alla nonna, donna dal cuore tenero e affettuoso, che mi allevò fino a otto anni.
«Mia madre mi riprese per lasciarmi presso uno dei suoi fratelli, sposato, padre di famiglia. Prendendomi, aveva lodevoli intenzioni, ma io non piacevo a mia zia. Con quell’istinto proprio dei bambini e degli animali, compresi di non essere amato. Sarebbe troppo lungo riferire tutte le umiliazioni e tutte le offese che ho subito durante quattro anni. Ebbero un’influenza notevole sul mio carattere. La mia indole tetra e timida con predisposizione alla malinconia ne fu aggravata. Diventai sempre più chiuso. Ero triste in permanenza. Avevo un’aria infelice. Amavo la solitudine. Per sfuggire a mia zia, vagavo per i boschi e i campi per giornate intere. Per amico avevo un cane che, capendo la mia solitudine, era l’unico essere che mi fosse un po’ affezionato. Spesso mi svegliavo di soprassalto di notte, singhiozzando e invocando la nonna. Povero orfanello, ero già trattato come un paria.
«A dodici anni, dopo una punizione immeritata, me ne scappai da mia madre, allora cuoca in una casa borghese alla periferia di Marsiglia. Dapprima lei si sorprese. Quando le feci vedere i segni dei colpi, scoppiò a piangere. Ma non poteva tenermi presso di sé. Allora mi mandò da un altro suo fratello. Quello fu buonissimo con me. Fu lui a darmi un’istruzione.
«A quindici anni, mi mise come apprendista presso uno scultore. Ma questo zio, che faceva il vetturino, non poteva occuparsi di me né lenire la mia malinconia. Tanto che mi misi a leggere racconti, soprattutto romanzi, che turbarono il mio cervello di bambino. La lettura di scene strazianti della miseria e dell’infelicità del popolo, mi sprofondò in abissi onirici.
«Le lotte civili, il problema del pauperismo, tutte quelle piaghe che devastavano l’umanità erano altrettanti punti interrogativi che stimolavano il mio spirito ad approfondirne le cause. L’impossibilità in cui mi trovavo di scoprire la soluzione a tanto male mi dava angoscia. Tuttavia, nel caos dei miei pensieri, mi pareva che, poiché non tutto andava per il meglio nel mondo, un prossimo cataclisma fosse inevitabile e che uno spirito innovatore, un Cristo, un Messia sarebbe sorto a rigenerare l’umanità secondo un ordine nuovo più giusto. Da ciò venne la mia predisposizione alle idee di progresso. Era fatale che il vento rivoluzionario che soffia sulle contrade del vecchio sistema sociale, trovasse in me un terreno propizio e vita, sperando di trovarvi la soluzione al problema sociale che tanto mi angosciava. Mi misi a frequentare con assiduità conferenze e gruppi che trattavano dei problemi della società.
«All’epoca del risveglio anarchico, nel momento dei gesti di violenza di qualche disperato e delle leggi repressive, non sfuggii all’occhio della polizia e fui oggetto di una intensa sorveglianza. Nella mia ingenuità, credevo che la libertà di coscienza fosse un diritto acquisito, inviolabile. Come mi sbagliavo! La polizia non era di questo avviso. (...)
«Cominciarono subito le perquisizioni domiciliari, con la interferenza nei miei affari familiari, nei miei segreti più intimi così come in quelli di mio zio che, tuttavia, era ben distante dalle mie opinioni, investigando presso i vicini sui miei propositi, sulle mie azioni, appropriandosi della mia persona nel momento della visita di qualche personalità ufficiale o di qualche tiranno, violando con delle azioni il sacro diritto alla libertà personale. Tale comportamento della polizia provocò la rottura tra me e mio zio e fece sì che parecchi padroni non volessero più farmi lavorare. Quel comportamento serviva poco a intimidirmi, anzi. Avevo dalla mia la coscienza a posto, scevra da qualsiasi atto e anche da qualsiasi intenzione malevola. Sentivo germinare in me un sentimento di collera verso una società che tollerava un così abominevole abuso di potere. Non si poteva continuare così.
«Riuscii a far perdere le mie tracce alla polizia. Trovai lavoro dal signor Pernod, ebanista e scultore a Marsiglia, in rue Haute-Rotonde 4. Ci stavo da appena tre o quattro mesi che i segugi mi scovarono. E allora altre seccature. Tramarono losche manovre presso il mio padrone. Ma si illudevano: quell’uomo onesto disse, in mia presenza:
« – Non mi interessa niente quel che i miei operai pensano fuori di qui. Io sono soddisfatto di lui. E lo tengo con me. Ma i poliziotti non si diedero per vinti.
«Avevo una stanzetta attigua alla casa del mio padrone. Qualche giorno dopo la loro prima visita ritornarono, mettendo sottosopra e frugando tutta la casa, senza trovare nulla. Ma il loro arrivo aveva messo scompiglio nel quartiere. Il padrone, temendo lo scandalo e soprattutto la perdita di clientela, dovette rassegnarsi a licenziarmi. Non avevo forse il diritto di indignarmi contro quell’inqualificabile provocazione e di esclamare con Mirabeau: “Chiunque si vede rifiutare il lavoro che deve procurargli il mantenimento, diventa il nemico naturale degli uomini e ha diritto di dichiarare una guerra personale contro la società?”.
«Per qualche giorno cercai invano lavoro. D’altronde, la certezza che la polizia m’avrebbe trovato mi tolse ogni coraggio. Mi sprofondai in amare riflessioni. Dinanzi a me avevo la prospettiva di un orrenda miseria, senza pane né alloggio. Non osavo più chiedere aiuto a mia madre che m’aveva già tolto dai guai diverse volte e che d’altra parte aveva già difficoltà a sopravvivere. Dopo aver finito gli ultimi soldi, mi ritrovai per la strada. Pazzo di tristezza, di dolore, la testa che mi scoppiava, le viscere attanagliate dalla fame, vagai senza meta come un’anima in pena. Per due giorni, senza cibo, dormii all’aperto, sognando pranzi pantagruelici, divorato dalla febbre, esausto dalla fatica, in stato pietoso, non potendone più. Poi trovai un amico che mi diede da mangiare e mi prestò un letto.
«Questo non fece che rimandare il problema. Il dilemma in cui mi trovavo era in realtà causato dalla polizia: “Vivere o morire? Ma morire come? Crepando di fame su una strada vicino ad un paracarro, come un cane, oppure sfuggire a quella agonia con una morte violenta ma ardente, il suicidio? Vivere? Ma allora, infrangendo le leggi che il codice reprime?”.
«Dei due mali ho scelto il minore; dopo una violenta lotta contro tutti i miei scrupoli, spinto dall’istinto di conservazione, ricorsi al furto come mezzo di salvezza. Lungi da me l’idea di elevare a principio il furto, che io esecro come tutto ciò che è contrario alla lealtà e alla franchezza. Penso che ogni essere valido debba, secondo la sua forza e la sua capacità, contribuire per la sua parte alle ricchezze sociali e che chiunque, beneficiando di quelle stesse ricchezze si sottrae ai suoi obblighi, è un tiranno. Il diritto impone dei doveri. Ma logicamente si può forse accusare di essere un ladro chi, non avendo altre risorse, prende per bisogno quel che gli viene rifiutato attraverso il lavoro? Non credo che i presidenti delle Assise siano d’accordo».
Alexandre, invece, non poteva condividere queste considerazioni. Ma Baudy sottolinea perfettamente ciò che costituirà la differenza tra l’organizzatore dei “Lavoratori della notte” e il suo sèguito. Jacob aveva scelto il furto come mezzo per giungere alla rivoluzione, mezzo sicuramente sgradevole, nella misura in cui sarebbe stato preferibile inventare delle cose più fruttuose per l’umanità, ma provvisoriamente necessario. I suoi compagni, di indole meno elevata, spesso non vi vedevano che un mezzo comodo per non morire di fame.
Ma il paradosso sta nel fatto che Jacob, il cui disinteresse è fuore di dubbio, mentre accusava Guesde ed i marxiani di rendere impossibile il raggiungimento dell’obiettivo perseguito in comune, una società felice, perché esaltavano sistemi autoritari, ricadeva senza saperlo in una trappola simile: il metodo del furto contrassegnava l’anarchismo con marchio indelebile, come l’aveva già contrassegnato la propaganda con il fatto. Baudy, meno ragionatore, era più ragionevole. Egli insomma poneva senza saperlo un dilemma storico attualissimo: ogni rivoluzione non è che il prodotto dei mezzi impiegati per conseguirla. Le rivoluzioni che hanno bisogno di impiegare la violenza generano dunque altre violenze. Nessun progresso pacifico fino allora era riuscito vittorioso in una riconciliazione universale (e anche la necessità per gli oppressi di abbattere l’oppressione di privilegi insopportabili si faceva sentire sempre più) e il problema resta tale e quale. Preoccuparsi della sorte dei propri simili è un boomerang, che spinge all’ossessione della propria liberazione.
La sorte di Baudy non era tuttavia delle più invidiabili: «Alla chiamata alle armi della mia classe, partii arruolandomi nel 19° Artiglieria da montagna, a quel tempo di guarnigione a Nizza. Quel periodo non ebbe alcuna influenza sul mio destino. Tuttavia, il 18 marzo, per essermi recato con l’uniforme ad una riunione non ancora cominciata, dietro rapporto fatto in malafede da poliziotti di Nizza, il generale governatore della piazza mi gratificò di 60 giorni di prigione. I1 capitano, dopo aver svolto la sua inchiesta, concluse che il rapporto di quei signori andava ben al di là della verità. Oltre a quel fatto, non ho di che lamentarmi dei miei superiori.
«La prima condanna mi venne inflitta dalla corte d’Assise di Aix che mi giudicava in ultima istanza il 10 febbraio 1898. Tre anni di prigione. Una disgrazia non arriva mai sola.
«Durante la detenzione preventiva, il mio compagno di cella ebbe un litigio con un altro detenuto a proposito di un paio di scarpe sottratto ad un altro povero diavolo. Il mio compagno lo colpì, provocandogli ferite gravissime. Io avevo preso le sue difese. La giustizia fece il suo corso. Ne venne una incriminazione. Io, per evitare un aumento di pena al mio compagno (che aveva già una condanna a cinque anni) mi assunsi tutta la responsabilità della cosa. E così la stessa corte di Aix, il 30 marzo 1898 mi condannò ad un altro anno, senza aggravio di pena.
«Fui inviato alla prigione centrale di Nîmes, dove meditai sulle vicissitudini della vita. Grazie alla buona condotta, venni liberato il 14 luglio 1901 con una liquidazione di trecentocinquanta franchi, frutto del mio lavoro. Mi recai immediatamente a Marsiglia a trovare mia madre e chiederle perdono per tutte le amarezze che le avevo procurato. Non feci fatica ad ottenerlo. Lei poi mi diede altri seicento franchi, che una prozia m’aveva lasciato morendo.
«Andai allora a Tolosa, dove stava il padrone che mi doveva fornire un attestato per il lavoro svolto. Arrivando, seppi che quello aveva dichiarato fallimento. Appena la polizia fosse venuta a sapere la cosa, mi sarei trovato in prigione. Feci allora in modo di nascondermi. Cambiai nome e mi diressi a Parigi».
Fu là, in rue de la Clef, che Baudy conobbe Jacob, Jeanne (con cui del resto ruppe dopo due mesi “per incompatibilità di umore e di carattere”), Ferrand, Clarenson, Bonnefoy e tutta la compagnia. Pare proprio che, almeno all’inizio, si occupasse più del gioco a carte che di espropri individuali.
«Avevo sentito parlare di sistemi e metodi di gioco in grado di aumentare le vincite. I calcoli mi sembravano giusti, razionali, indiscutibili. Non c’era altro che metterli in pratica. Non avevo dubbi che sarei riuscito. In realtà, nei miei calcoli non avevo tenuto conto del carattere dell’uomo, di quella febbre del gioco che pervade il giocatore, paralizza tutte le sue facoltà mentali e annulla in lui ogni volontà e ogni prudenza.
«Mi misi a frequentare le sale da gioco di Montecarlo, del Belgio, così le stazioni balneari ed estive di Francia. All’inizio giocai con prudenza e moderazione: guadagnai molto. Poi diventai più emotivo, persi il gusto delle cose; il mio pensiero era sempre rivolto al tavolo verde. Non concepivo niente altro al di fuori di quella sfera. Anche il mio carattere ne risentì. Divenni più irritabile, più taciturno. Non era più quella dolce malinconia della mia giovinezza, che mi sprofondava in sogni incantevoli, ma era una cattiveria feroce, biliosa, che mi sconvolgeva la mente. L’abuso di tabacco, di bevande alcoliche, quell’aria ammorbata che ubriaca, le alternative d’emozione che si provano, eccitavano il mio sistema nervoso e mi surriscaldavano il cervello. Allora raggiungevo il parossismo della febbre, perdevo, volevo fuggire. Impossibile. La roulette mi stregava. Ero in uno stato di prostrazione mentale che mi pietrificava e mi inchiodava dov’ero. Anche il fisico si alterava. I miei lineamenti si stereotipavano con le stimmate della passione. Il mio volto si rivestiva di un colore cadaverico. Un imbarazzo gastrico mi dilaniava lo stomaco. Davvero non ero felice. La vita del giocatore è ben miserabile e di tutte le passioni il gioco è di gran lunga la più funesta. Esso spezza ogni energia dell’anima e del cuore; soffoca i sentimenti migliori dell’uomo. Nauseato, disgustato di una esistenza così distante dalle mie aspirazioni, ero esausto della vita. Accarezzavo nella mia mente sinistri pensieri di suicidio. Non avevo più forza per reagire contro quell’abbattimento morale. Sia la mia anima che il mio spirito erano annullati. (...) Tuttavia, non ero malvagio, lo so, e l’inizio della mia vita non mi riservava un’esistenza così miserabile. Senza gli odiosi persecutori di cui ero stato vittima, non avrei adesso da gemere sulla mia sorte crudele. Sono stato un giocattolo tra le mani del fato».
Tutto ciò era senza dubbio drammatico. Ma Alexandre non poteva tenersi tra i piedi un giocatore. Appena s’accorse della “funesta inclinazione” di Baudy, lo emarginò. Non poteva certo impedirgli di alloggiare nell’hotel de la Clef né proibire a Clarenson di traviarlo, ma il lavoro doveva continuare ad ogni costo, con o senza di lui.
Il suo aiutante più serio rimaneva ancora Ferrand, il cui idillio con Gabrielle Damiens, l’unica inquilina di Thériez al loro arrivo, non ostacolava l’attività. Anzi: nei giorni pesanti le faceva portare da Limmonier o da Apport la roba raccolta. A volte, se la portava dietro addirittura come aiutante nelle sue spedizioni...
Quella volta i due soci si gettarono in un giro grosso. Il 1° settembre svaligiarono il signor Meslay a Laval: 300 franchi in gioielli. Nella notte tra il 2 e il 3, fu la volta del colonnello Louis, a Rennes, in boulevard de la Duchesse 50.
* * *
– Jacob, ammettete di aver rubato il revolver al testimone?
– Sì, ma vorrei che il colonnello mi dicesse a cosa gli serviva quel revolver: a guarire o ad uccidere la gente?
– Il furtarello assomma ad un migliaio di franchi.
– Una sciocchezza certamente, per questo signore. Ma un operaio ci mette un anno a guadagnare quella somma!
* * *
Quella stessa notte, andarono dal capitano Buissot, vicino del colonnello: duemilacinquecento franchi in contanti. Il 7 si trovavano a Roubaix, in rue de Clermont 10, dal signor Trubert di cui lasciarono disgustati le saliere placcate in oro ma di cui capovolsero e sventrarono il forziere, un magnifico Raoul da trecento chili: diecimila franchi di gioielli, due orologi d’oro, un altro revolver, delle bellissime spille da cravatta e delle chiavi che permisero loro di uscire tranquillamente dalla porta.
Il 18 erano a Liegi, in casa del signor Delgeur, nientemeno che il vice presidente del tribunale di prima istanza. Un certo Mathieu Souvenay, già autore di numerosi svaligiamenti fu del resto, con grande stizza di Jacob, condannato a tre anni dal Correzionale di Liegi per quel furto che non aveva commesso: ma per un vice presidente derubato bisognava ben trovare un colpevole.
I1 21 si introdussero nella casa del signor Vergne a Nevers, in boulevard Gambetta 9. A colpi di coltello distrussero tre quadri e un arazzo (“Le opere d’arte sono la civetteria, il capriccio dei capitalisti”) e gli portarono via i risparmi, più una grossa rivoltella. Il 22, sempre nella stessa città, il signor Gorbon, ispettore d’accademia, che aveva affidato casa sua in custodia a Ranvier, usciere in Prefettura, ricevette la loro visita: ebbero il buon gusto di non toccare la raccolta di minerali cui teneva tanto.
Nella notte tra il 26 e il 27 settembre, verso l’una del mattino, la signora Perrotte, moglie del notaio di Saint-Martin-au-Mont, udì un rumore insolito. Guardò dalla finestra e scorse in cortile un individuo con un largo cappello. Destò il marito, che svegliò il domestico. Corsero verso la cassaforte: malgrado i suoi cento chili, era scomparsa. Fu organizzata una battuta. La ritrovarono in un campo, a duecento metri. Intatta: i banditi non avevano avuto il tempo di sondarne i segreti.
E poi, ci fu quello che i giornalisti definirono “il colpo di genio di rue Quincampoix, una grande prima mondiale in materia di svaligiamenti scientifici e da cui Jules Dassin, più i cinquant’anni dopo, trasse ispirazione per il suo Du rififi ches les hommes [1955, n.d.r.] tanto audace era la tecnica. Stavolta vi prestarono il loro aiuto Clarenson e Bonnefoy.
Clarenson, l’ex “protettore” di Rose, che si faceva chiamare “Audierne” e andava a letto in quel periodo con una bella mora, Antoinette Bernard, vedova Amiglio, già dama di compagnia della signora Bonnefoy; Clarenson, inveterato giocatore riconosciuto pazzo da diciassette medici, bel ragazzo bruno dagli eleganti baffi, sempre vestito alla moda con una specie di ampio dolman di panno nero a collo diritto, con un cappello floscio a larghe tese che gli davano una vaga aria da moschettiere, non fu di molta utilità: era più a suo agio davanti ad un tappeto verde che con il piede di porco in mano. Bonnefoy invece si rivelò prezioso.
Honoré, Alphonse, Joseph Bonnefoy, alias Fondet, nato il 10 gennaio 1861 a Parigi, era invece un vero eroe da romanzo di cappa e spada.
Ne aveva il portamento: fronte larga e prominente, occhio vivacissimo ma profondamente celato sotto sopracciglia cespugliose, naso forte, baffi a ferro di cavallo. Insomma, un’aria molto mefistofelica.
Dopo eccellenti studi in seminario, s’era arruolato. Il Tonchino, come Pélissard. Fu nominato sergente, quindi sergente maggiore sul campo. Disertò nel luglio 1881, raggiunse l’Australia, poi l’Inghilterra e Ginevra. Nel 1889, approfittando di una amnistia, ritornò in Francia. Vi conobbe una magnifica donna, ma civetta e spendacciona, Marcelle Deschamps, che sposò. Due figli, una balia, una dama di compagnia: cominciarono le preoccupazioni economiche. E i guai: due condanne in correzionale, una per minacce di morte, l’altra per aver truffato un minorenne.
Fin dal 1894 è segnalato come pericoloso anarchico. Seguono episodi curiosi: nel 1894 l’accusano di aver assassinato, durante un viaggio sulla linea ferroviaria Parigi-Lione-Mediterraneo, il signor Bernard, presso cui lavorava in qualità di impiegato. La tesi del suicidio prevalse: assolto.
Qualche mese dopo, due persone che ritornavano da Montecarlo nello stesso suo vagone vengono assassinate. Coincidenza? La cosa si risolve con un’altra assoluzione.
Parte alla conquista del Nuovo Mondo, seguito da Marcelle e dai marmocchi. A Chicago si getta nel commercio dei cavalli: senza fortuna. Il suo socio viene trovato, un bel giorno, assassinato. Assolto.
Di ritorno in Francia, si dà al gioco.
– In poche settimane, perse tutto il denaro, che ammontava a trentamila franchi – dirà costernata sua madre.
Marcelle deve mettersi a lavorare. S’improvvisa cantante da caffè-concerto ed ha grandissimo successo, con il suo nome da ragazza. Fa volentieri ore supplementari, che le rendono molto di più che le canzoni e suo marito non vi vede alcun inconveniente. Anzi. Egli incontra Clarenson. Frequenta l’“Agitateur”, vi conosce il giovane ed entusiasta Jacob, abita a Marsiglia dall’ottobre del 1899 al marzo 1900 in rue du Progrès 30. Parte a cercar fortuna in Tunisia, ritorna ad abitare in rue Saint-Thomas dal 10 luglio al 17 settembre 1900, fa una puntata a Parigi, se ne ritorna vicino al Vecchio Porto, in rue Pisançon 11, dall’ottobre 1900 al 6 aprile 1901, frequenta le sale da gioco di Montecarlo, le roulettes clandestine di Marsiglia, fa saltare il banco a Spa, gioca forte e guadagna forte. E perde forte.
Arriva infine, il 19 luglio 1901, in rue de la Clef con sua moglie, si fa adottare da Alexandre, giura che dividerà i guadagni e si mette alla ricerca del colpo grosso.
Qui interviene un altro personaggio, dolce sognatore, intellettuale, teorico dell’anarchismo, che ha già pubblicato tre libri ingenuamente scandalosi: Etats d’àme, Quand égorgerons-nous enfin? e Le Pacte surtout, in cui esalta lo svaligiamento e il diritto ad assassinare quando è in gioco la libertà personale. Il suo nome: Jacques Sautarel, detto Rossignol. È nato in Spagna il 5 gennaio 1870, a Llado, in Catalogna.
Anche lui ha raccontato la sua vita, molto più tardi, su “Le Bonnet Catalan”, giornale socialista che dirigerà e redigerà interamente tra il 1924 e il 1926. Ancora una vita privilegiata: «Sono nato da una ragazza-madre e da padre ignoto, magistrato in un capoluogo di cantone della Linguadoca. Ma questo, l’ho saputo solo in seguito, durante una malattia di mia madre, prima che ne morisse. Sono figlio del miracolo. Un pomeriggio, mia madre, di ritorno dalla campagna, schiacciata dal dolore, crollò e finì per trascinarsi in una valletta di montagna, dove io nacqui in un mare di sangue, sotto il temporale.
«I compagni di classe, a scuola, mi segnavano a dito come bastardo. Mi allontanavano dai loro giochi. Mi prendevano in giro in continuazione. Dovevo battermi con loro ogni giorno.
«Più tardi, diventato garzone di fattoria, dormivo nella paglia con gli animali e i padroni si preoccupavano più delle malattie di quelli che delle mie.
«Giunto bene o male alla maggiore età mi misi a frequentare il bordello, questa orribile caricatura dell’amore.
«I gendarmi vennero ad acciuffarmi per il servizio militare, a duecento leghe dal mio paese. La patria è proprio una brutta troia».
Tutto ciò sarà riassunto in poche parole dalla giustizia: “Perfetto prototipo di avventuriero. Già disertore. Frequentatore di bische e di giochi d’azzardo. Non esita, all’occasione, a passare personalmente all’azione”. Povero Sautarel, lui che era destinato a diventare un onesto agente elettorale del partito socialista e membro, a Perpignan, della loggia “San Giovanni delle Arti e della Regolarità”, emanazione del Grande Oriente!...
Per il momento, è ritornato dal servizio militare. È sposato. Ha due figli. Lo dicono “coinvolto nel peggiore mondo di ladri e di assassini”: si sarebbe potuto dire lo stesso di Darien. Professione: gioielliere.
È stato impiegato per qualche tempo dal signor Bourdin, gioielliere in casa propria in rue Quincampoix 76. Da lì gli verranno tanti guai. È forse lui che ha segnalato l’affare alla banda? O invece è stato vittima di un increscioso concorso di circostanze, ossia il suo tirocinio da Bourdin, la virulenza dei suoi scritti e le sue convinzioni anarchiche? Meglio non cercare di saperlo. Egli giura che non conosceva Jacob, a quel tempo. È possibile. Ma aveva già incontrato Bonnefoy e Clarenson. Questo gli costerà di ritrovarsi al loro fianco sul banco delle Assise di Amiens.
Ad ogni modo, il 1° ottobre 1901, un martedì, Bonnefoy si presentò sotto il nome di Guillot alla portineria di rue Quincampoix per prendere in affitto l’appartamento al quinto piano, situato al di sopra dell’alloggio del signor Bourdin. Secondo l’uso, versò al cerbero dieci franchi di mancia. L’indomani, tornò a pagare l’anticipo di duecentosettantasette franchi d’affitto.
– Aspetto mia moglie e i bambini – disse. – Vado ad affittare dei mobili.
Effettivamente, il giovedì, arrivò un carretto di Klein, tappezziere abitante in rue Richer 41, carico di sedie, armadi e letti. I1 sabato, dopo la colazione, Jacob, con un soprabito grigio ferro e con la sua bombetta, andò a trovare “Guillout”. Uscirono insieme alle sei del pomeriggio, poco dopo il signor Bourdin. Lo seguirono fino a quando, alla stazione Saint-Lazare, quello salì su un treno suburbano con la sua famiglia. Il campo era libero. Sicuramente fino a domenica sera. Parte della notte fu dedicata ad uno studio minuzioso del posto. Ma non c’era niente da tentare a quell’ora, a causa del rumore. L’indomani, Alexandre tornò di buon’ora, con un grembiule bianco e una borsa simile a quella dei fabbri. Il portiere non ci vide nulla di anormale: il nuovo inquilino aveva certo dei lavori da fare in casa. Perché non chiedere aiuto ad amici? Clarenson, vestito da pittore, li raggiunse dopo un’ora.
Allora cominciò il lavoro. Alexandre tolse il più silenziosamente possibile le listelle dal pavimento in legno della camera da letto. Poi, con un succhiello, cominciò a forare l’impiantito. I tre uomini lavoravano a turno. Alle dieci, il buco era ultimato. Carponi, sotto si poteva scorgere il letto di Bourdin. L’apertura venne allargata in modo da poterci far scivolare un ombrello. Con un sistema di bastoncini e cordicelle, Alexandre riuscì ad aprirlo e a tenerlo sospeso sotto il pavimento: così, tutti i calcinacci sarebbero ricaduti al suo interno senza provocare alcun rumore.
Alle undici e mezzo, venne srotolata una scaletta di corda. Seguito da Clarenson, Jacob discese nell’appartamento di Bourdin. A mezzogiorno, con una facilità irrisoria, grazie a un filo di ferro e a un foglio di carta di sigarette, il forziere era aperto. A mezzogiorno e cinque, Clarenson abbracciava Alexandre, si sporgeva esultante sul lavoro da orologiaio eseguito dall’amico e, con la sua goffaggine, confondeva la combinazione. Bisognava ricominciare daccapo. Nemmeno parlarne di rimettersi a giocare con la serratura: bisognava sfondare tutto. Jacob fu preso da istinti omicidi.
Dovette farsi passare tutto il materiale con una corda e, rabbiosamente, rimettersi al lavoro. Il forziere venne rovesciato a fatica sul letto. Il trapano entrò in funzione in un inferno di cigolii e di stridii che era convinto si potessero udire a cento metri di distanza. Per fortuna, scoppiò un violento temporale. Cominciò a cadere la pioggia.
Le ore passavano. Bourdin poteva rientrare da un momento all’altro: sarebbe rimasto a pranzo in campagna o no? Non aveva avuto la cortesia di avvertirli. Bonnefoy si mise di vedetta sul balcone, nonostante la pioggia, per sorvegliare la strada.
Alle due e cinquanta, Alexandre emise una specie di ruggito: aveva riportato la vittoria sulla materia. Il forziere aveva esalato l’ultimo respiro. Con mano svelta, ne estrasse sette chili d’oro, duecentottanta carati di pietre, trecento perle, ottomila franchi in contanti: ossia all’incirca centotrentamila franchi. Oltre duecentomila franchi in titoli. In tutto, un milione e mezzo di franchi pesanti, non tenendo conto, naturalmente delle enormi differenze di potere d’acquisto tra quell’epoca e la nostra.
Alle tre e dieci, Clarenson e Jacob erano risaliti al quinto piano. La scala di corda era stata ripiegata. Il materiale riposto. Con i vestiti ripuliti, ripassarono tranquillamente davanti al portiere con le valigie in mano, per non ritornare mai più.
Il signor Bourdin, rientrato in serata, si precipitò al commissariato di rue des Lombards. La polizia si mise in moto: invano. Nessun indizio. Nessuna pista. Nessuna denuncia. Nessuno aveva mai sentito parlare di uno svaligiamento effettuato con metodi simili. Jacob aveva inventato il furto scientifico.
Maurice Leblanc scriverà a giusto titolo, nella prefazione alle prime avventure di Arsène Lupin: «Il talento, il genio dei malfattori moderni pare assumere, nel nostro tempo in cui tutto progredisce, anche il male, delle proporzioni grandiose. Chi può vantarsi di sfuggire dopo le imprese criminali di cui il racconto che pubblichiamo descrive la straordinaria avventura? (...)».
“Malfattore”, Jacob lo era molto più di Lupin: poche settimane dopo, Matha entrava in possesso, in rue d’Orsel, vicinissimo a rue des Martyrs, del terreno che stava tenendo d’occhio da tempo e dove poteva installare la redazione e la tipografia del “Libertaire”, dotata finalmente di rotative decenti, grazie alle quali si potevano diffondere le cattive idee su vasta scala.
È vero che quando Maurice Leblanc parla, poco più in là di «formidabili mezzi d’azione che gli davano (a Lupin) una ventina di manciate di pietre preziose prelevate dal suo patrimonio», confessa implicitamente che il suo eroe non scialacquava di certo una fortuna così mal guadagnata quanto quella di Alexandre, subito redistribuendola interamente.
Tuttavia, dopo un simile colpo a sorpresa, effettuato in pieno giorno in piena Parigi, bisognava essere prudenti. I “Lavoratori”, simili ad uno stormo di passeri, si sparpagliarono per tutta la Francia. Bonnefoy, provvisto di solido patrimonio e di un assegno di 5.000 franchi firmato da Alexandre, andò a Bordeaux.
Alexandre fece fondere il grosso dei lingotti da Brunus; egli stesso portò la maggior parte dei titoli ai suoi corrispondenti londinesi e la maggioranza dei diamanti ad Amsterdam. Poiché erano d’accordo che si lavorasse in cooperazione, ognuno ebbe la sua parte. Persino Charles, il fabbro riparatore degli attrezzi, trovò un mattino sul suo banco da lavoro, a La Varenne-Saint-Ilaire, un po’ di perle entro una busta con queste righe: “So che non siete ricco. Potrete sempre ricavarne da centocinquanta a duecento franchi per voi”.
Una parte dei gioielli verrà ritrovata parecchio tempo dopo, in casa del signor Henry Duthil, gioielliere di rue d’Odessa 5. La trafila è rivelatrice dei metodi di Jacob: Duthil li aveva acquistati il 13 maggio 1903 da un certo signor Feldmann, abitante a Saint-Mandé, in avenue Sainte-Marie 49 che si occupava di compravendita di gioielli provenienti dal Monte di Pietà. Feldmann li aveva disimpegnati dopo che un certo signor Lévy, anch’egli di Saint-Mandé, abitante in avenue Gambetta 5, gli aveva venduto due grossi lotti di polizze, tra le quali si trovavano quelle. Ma non è tutto: Lévy aveva il pacchetto di lotti di Joseph Donnadio, ex gioielliere di avenue de Saint-Ouen 70 (fallito nel frattempo e ricercato per appropriazione indebita) che lo aveva ricevuto da un altro Lévy. Dopo mesi di indagini, la polizia dovrà fermarsi a quel punto, senza essere mai riuscita a ritrovare l’uomo che, pare, si trovasse all’origine di quell’intrigo, un tal Picart, o più probabilmente uno pseudonimo di Jacob, o piuttosto del signor Escande, antiquario.
Messe in moto queste molteplici operazioni, Alexandre corse a raggiungere Bonnefoy a Bordeaux, dove Rose lo ritrovò nel gennaio del 1902. Lei aprì un secondo conto, al Crédit Lyonnais. E un terzo per l’ammontare di diecimila franchi, di passaggio a Parigi, poche settimane dopo. Bonnefoy si mise in testa di ritirarsi dagli affari per aprire un negozio di vernici. Alexandre, invece, non aveva alcuna intenzione di mettersi a riposo. La sua missione non era conclusa, giacché la rivoluzione non s’annunciava ancora. Litigi. Disaccordi. Partì per Tolosa dove prese alloggio in rue Breteille 8 sotto il nome di Bonnet, con Rose, naturalmente: fece un salto a Parigi il tempo di cambiare altri ventiduemila franchi di titoli e forse di fare un filo di corte ad Antoinette Bernard, vedova Amiglio, l’amica di Clarenson, che l’aspettava all’arrivo del treno. Poi, più seriamente, fece vendere da Marie la drogheria di Marsiglia dove non veniva più alcun cliente dopo le perquisizioni del commissario Fabre, seguite ben presto dalle prime crisi di delirium di Joseph. A costo di mantenere sua madre, preferiva averla presso di sé, la sua “carissima”, la sua “buonissima”, la sua “dolcissima”.
Sentiva il bisogno di prendere respiro. Era deluso. Le spedizioni rendevano senza troppe difficoltà, come s’era aspettato. Ma l’evoluzione della banda non gli piaceva. Naturalmente, non collaborava con degli agnellini. Ma quell’ambiente da bisca, quei loschi figuri che gravitavano attorno a rue de la Clef, l’egoismo di ognuno che lo costringeva a battere il pugno sul tavolo per effettuare le sue collette, i loro sorrisetti sempre più insolenti riguardo alla sua dedizione, che definivano sprovvedutezza, le loro scurrilità, le loro bevute, la loro rapacità: era troppo perché lui potesse sopportarli. Aveva confessato quel progressivo decadimento a Malato, che aveva scosso la testa con aria perplessa: l’idea a suo avviso rimaneva buona. Era fiducioso che Alexandre potesse rimediare alle difficoltà. Intanto, non era più un complotto: era una razzia.
L’occasione era troppo bella, dopo rue Quincampoix, di rompere almeno provvisoriamente con loro. Che se la cavassero da soli: chissà cosa sarebbe successo. Chissà se potevano fare senza di lui. Aprì quindi a Marie un’altra drogheria sotto il nome di Berthou, in quella città di Tolosa in cui la tribù Jacob poteva passare inosservata, in rue aux Changes 3. Joseph non esagerava. Era affetto da decadimento senile precoce. Tremante, pieno di acne, era ai suoi ultimi giorni. A volte gli uscivano ancora dalla bocca dei borborigmi di protesta ma era talmente imbevuto d’alcool che un bicchiere di vino bastava ad ubriacarlo.
Clarenson il matto era andato difilato a Monaco. In pochi giorni, aveva scialacquato il suo denaro. Un appello al buon cuore di Bonnefoy si tradusse in una lettera contenente un titolo da trecento franchi e indirizzata fermo-posta di Montecarlo. Povero Clarenson! Quando volle cambiare la sua rendita al 3 per cento, nel gennaio 1902, lo sbatterono in prigione. Ebbe un bel protestare che lui si chiamava Puits, che un lontano amico di nome Cabrier gli aveva spedito la somma per provare un nuovo sistema di puntata al gioco e che ignorava assolutamente la provenienza del titolo: lo trasferirono a Parigi e ci vollero non meno di sei mesi di istruttoria prima che beneficiasse di un’assoluzione, il 27 luglio successivo. Marie, sempre sensibile alla malasorte degli amici di suo figlio, gli inviò regolarmente del denaro alla Santé per tutta la durata della detenzione.
Anche Baudy, il giocatore scalognato e romantico, aveva preso il largo, abbandonando nella fuga Jeanne in lacrime e senza un soldo. Aveva raggiunto Marsiglia. Quindi Nîmes, dove s’era messo insieme ad Henry, anarchico originario di Montmartre che per quarantamila franchi aveva appena cloroformizzato un po’ troppo una vecchia ereditiera. Proprio il tipo di azioni che Alexandre aborriva. Quando questi lo venne a sapere, più tardi, esigerà un’immediata rottura con Henry. Non vorrà lavorare mai più con lui. Uccidere una vecchia per derubarla del suo gruzzolo, voleva dire abbassarsi al livello del putridume contro cui si combatteva. Questo disonorava la Causa: che degli individui senza scrupoli si definissero anarchici, lui non poteva impedirlo, ma almeno non voleva avere niente a che fare con loro.
Solamente Ferrand, che non aveva lasciato Parigi, proseguiva con accanimento l’opera di recupero. Nei dieci mesi che durò l’arrabbiatura di Alexandre, egli s’improvvisò ispiratore del gruppo. Ma se aveva imparato molto bene dal maestro le tecniche e le trafile di smercio, non aveva lo stesso fiuto nella scelta delle vittime. Non era un osservatore.
Nella notte fra il 15 e il 16 ottobre 1901, a Soissons saccheggiò la casa del comandante Baland, allora di guarnigione a Digione: solo qualche cucchiaino d’argento da far fondere a Brunus. Il 30 fu la volta della vedova Roché, a Corbeil: il grosso del bottino consisteva in un fucile da caccia Bernard, rivenduto da Deschamps, un tappezziere anarchico di Champigny amico del fabbro Charles, e in un binocolo. Poi a Gassicourt, sulla strada di Rosny, ci fu lo svaligiamento ai danni del signor Shroder, rappresentante di commercio a Parigi. Gabrielle Damiens, eccitatissima, fu della partita. Bilancio pressoché nullo.
Alexandre fu costretto, in occasione di un rapido viaggio effettuato a Parigi verso la fine di novembre per dare un’occhiata ai conti della “sua” fonderia, a fargli rilevare che “tutto questo era meschino”. Prendersela con i rappresentanti di commercio e con le vedove era indegno di loro. Pare persino che, nella sua esasperazione vedendo frainteso il senso della sua attività, egli si fosse incollerito tanto da ingiuriare Ferrand.
– Ah, bene! Giacché sei tanto bravo, allora facci vedere tu come si fa – ribatté quello con aria di sfida.
Così, il 23 novembre, Alexandre e Ferrand, seguiti da Touzet, un novellino che Ferrand aveva preso sotto la sua protezione, si introdussero ad Amiens in casa del signor Guénard, in rue Laurendeau 12. Allorché, uscendo dalla cantina da cui avevano dovuto passare, accesero le loro lampade Edison, il più imprevisto degli spettacoli li pietrificò. Touzet si mise a battere i denti. Ferrand si grattò la testa con nervosismo. Avevano violato il regno proibito del sogno. Si trovavano nel castello della Bella Addormentata nel Bosco. Una casa incantata. Delicate ragnatele legavano tra loro mobili di una altra epoca. Muffe color malva bordavano gli zoccoli delle pareti, cosparse di segature e di escrementi di topo. Il mobilio era ricoperto da spessi strati di polvere. Nessuno era entrato lì dentro da anni. Vagamente, l’idea che stessero disturbando il fantasma di quel luogo e che la loro inaspettata intrusione potesse scatenare qualche cataclisma soprannaturale, li paralizzava.
– Tagliamo la corda? – mormorò Ferrand.
Quelle tre parole vibrarono nel silenzio soffocate senza che nessuno spettro rispondesse. Alexandre tirò fuori di tasca il fazzoletto e cominciò a aprirsi un varco tra le luci, le ombre ed i riflessi. Spolverò un cassettone. I suoi gesti quotidiani ebbero il potere d’imporre l’ordine umano tra i fantasmi. Tutti ripresero coraggio.
E così scoprirono il Perù. Rotoli di piastre d’oro con l’immagine di Luigi XIV stavano in disordine sui ripiani. Più in là, c’erano pile di napoleoni. Una parure d’oro tempestata di diamanti era distesa su un comodino. Fasci di banconote da cento franchi emessi sotto Luigi XVIII sonnecchiavano in un grande vaso di porcellana cinese. Orologi d’oro. A quanto ammontavano quei tesori antichi? Cinquantamila franchi, sicuramente, forse molto di più.
Nel salone, dietro un tavolo, c’era un forziere. Ferrand voleva svignarsela. Senza aprir bocca, Alexandre tirò fuori i suoi utensili dal “contrabbasso” e si mise al lavoro. Dovettero aiutarlo. Un’ora dopo ne estraevano manciate di titoli. Per almeno centomila franchi, dedotto quel che sarebbe stato difficile smerciare. Un’altra fortuna cadeva loro dal cielo, o piuttosto dal purgatorio.
Sul treno del mattino per Parigi, pensarono a quel bizzarro signor Guénard che si preoccupava così poco dei suoi beni. Forse era fin troppo ricco. Forse aveva avuto qualche delusione d’amore, come pare ci si possa permettere il lusso di avere quando se ne hanno i mezzi. Ad Alexandre, comunque, sarebbe piaciuto fare la sua conoscenza. Ma sarebbe stato sicuramente indelicato.
Egli fu moderato nel suo trionfo, ma resistette a rimproverare Ferrand: aveva voluto una prova delle sue capacità? L’aveva fornita. Adesso, avrebbero capito, tutti quanti, che lo svaligiamento non era né uno sport né una scappatoia per poltrire, ma una tecnica per preparare l’insurrezione.
Quanto al denaro, egli ne trovò un impiego immediato: Matha aveva cambiali da pagare e numerosi compagni ritornati dalla Caienna vivevano nella più nera miseria e Ferrand dovette accontentarsi di cinquemila franchi. Alexandre stesso riprese a tasche vuote il treno di Tolosa.
Sul momento, Ferrand fu convinto della giustezza delle sue opinioni. Ma Gabrielle non condivise il suo entusiasmo: rimproverava ad Alexandre le sue “arie”. Con quale diritto egli dava delle lezioni di morale? Trattò il suo amante come un imbecille: lui non aveva ricavato nemmeno un centesimo da quella miniera d’oro. Nel loro panico superstizioso, sicuramente non avevano esplorato tutto, ad Amiens. Senza dubbio rimanevano altri tesori da prendere da Guénard. Non fosse altro che i quadri di famiglia e le dorature dei mobili che Jacob s’era rifiutato di rovinare. Lei voleva ritornarci.
Ferrand, il duro dal cuore tenero, cominciò a cedere. Per fortuna, passando da place de la Bastille, acquistò “Le Progrés de la Somme”. Il loro svaligiamento era in prima pagina. Allora s’infuriò. Alexandre aveva ragione. Facevano tutti una vita immonda. L’ideale stava degenerando. Bisognava ritrovare la purezza perduta, per non diventare abbrutiti come i borghesi e questo senza godere della loro bella vita.
Corse quindi a comprare una roulotte e un cavallo, ben deciso a trascorrere tranquillo e libero il resto dei suoi giorni vendendo tessuti nei mercati. Gabrielle, bisbetica, dovette seguirlo mugugnando. Quel capriccio durò meno di due mesi. Gabrielle aveva freddo. Le mancavano le sue comodità. Commerciare in tessuti la umiliava. In gennaio abbandonò il suo amante nel gelo, dalle parti di Château-Chinon per ritornare al suo antro di rue de la Clef “dove si trovava a suo agio”. In febbraio, contrariato, barbuto, sfinito, lui la raggiunse, dopo aver svenduto a pochissimo il carrozzone impantanato sulle rive della Loria.
Di Jacob, nessuna notizia, se non qualche parola asciutta di tanto in tanto per segnalare un furto da portare a termine. Solo Rose era stata a Parigi tre settimane dal 7 dicembre. Era andata in aiuto di sua sorella, che l’abbandono di Baudy aveva sprofondato nella stessa disperazione in cui s’era trovata tempo prima anche lei, prima dell’incontro provvidenziale con Alexandre. Per una settimana aveva alloggiato in una stanza ammobiliata di boulevard Magenta 48, dai Mellion, con la figlia naturale che Jeanne aveva avuto da un altro amante cinque anni prima.
Il fatto è che Jeanne sentiva il bisogno delle sue serate. Di lei s’era appena infatuato un operaio della Renault, Bailly, che stava a Boulogne in rue de Solférino 39 e che per lei voleva lasciare tutto, moglie e due figli. Rose dovette ascoltare le confidenze di ciascuno. Sopravvivevano così tra l’indigenza e il rosa-confetto. Zola incrociato con François Coppée. Uno Stendhal proletario: lei li immaginava rifarsi insieme una vita a duecento franchi al mese, con un figlio in braccio, una moglie nello sconforto e due bambini per la strada. Tentò di dissuaderli. Invano. Certo, per lei era facile ragionare con freddezza, lei che “se la passava bene con il suo damerino anarchico”. Ma l’amore aveva il diritto di fiorire anche tra le ortiche delle sterpaglie, no? Rose s’occupò un po’ degli affari di cui Alexandre l’aveva incaricata al Crédit Lyonnais e da Brunus, e soprattutto fece lunghe passeggiate con Jeanne e una delle sue amiche, Henriette Joffray. Un bel giorno, il 15 dicembre, per scherzo, per dimostrare a loro stesse di non essere più stupide dei loro uomini, le tre ragazze si misero in testa di rubacchiare al “Bon Marché”. Furono sorprese in flagrante, per due sottovesti e una veletta di pizzo. L’ispettore, intenerito dalle loro lacrime e trovandole graziose, accettò di rilasciarle in libertà provvisoria. Rose si trasferì quella sera stessa all’hotel Riviére in rue Fontaine, dove rimase fino al 12 gennaio. Se Alexandre fosse venuto a saperlo!...
Lui lo scoprì perché lei non riuscì a nasconderglielo, al ritorno. S’aspettava una delle sue sfuriate violente; ma egli si mostrò semplicemente rattristato.
– E con simili idiozie che si può rovinare tutto – si contentò di aggiungere con tono amareggiato. – Ma tu sei libera di fare quel che desideri.
Quella disavventura lo preoccupò visibilmente. Lei ritenne sproporzionata la sua inquietudine.
– Se si ritornasse a Parigi, invece di vegetare in questo buco – mormorò lei – non capiterebbero queste cose.
Lui non volle sentire ragioni. Era amaro. Si era rifatto una vita nel Midi. Stava spogliando sistematicamente, da solo, la borghesia locale. Aveva ritrovato Marie. Gli era mancata moltissimo. La sera, mentre Joseph smaltiva le sbornie, egli accompagnava spesso le “sue due donne” al “Capitole” a sentire concerti e ad assistere a spettacoli teatrali. Stava bene in provincia. La sua organizzazione era del resto così perfetta che la sua assenza dalla capitale non gli impediva affatto di trattare i suoi affari. Utilizzava un po’ di più il sistema di corrispondenza in codice, ecco tutto.
Dovette aspettare il 24 luglio successivo per decidersi a sloggiare. Quel giorno ci fu una perquisizione dai “Bonnet”, nell’ambito di accertamenti di identità estesi a tutta la regione e causati dall’allucinante ondata di svaligiamenti che dilagava nel Sud-ovest da qualche mese. “Bonnet” aveva un forziere: come tutti. I gioielli che conteneva? Ricordi di famiglia. I trapani e le punte? “Bonnet” aveva conservato, dalla professione di falegname esercitata tempo prima, il gusto dei lavori manuali. Quei cinquemilaseicento franchi in contanti? Depositati da un cliente, che era anche una parente, la signora Berthou, una negoziante, potete verificare.
– Benissimo. Le crediamo senz’altro – dissero gli ispettori, presi alla sprovvista. Non abbiamo alcuna ragione per arrestarvi. Ma vi presenterete domattina al commissariato per completare la vostra deposizione.
Non rividero mai più lo stimato signor Bonnet nell’Alta Garonna. Quanto a Marie, non ebbe difficoltà a disfarsi dei poliziotti: lei aveva dei beni al sole.
Al suo arrivo da Parigi, Alexandre non commise l’errore di ritornare ad abitare nella bettola di rue de la Clef. Prese un appartamento borghese in boulevard Ornano 14, il 15 agosto 1902, da quello stimato antiquario che era. Rose divenne per l’occasione sua cugina, la signorina Roux: non aveva avuto il tempo di fabbricarle un’altra serie di falsi documenti.
Quel nuovo modo di vivere lo portò a condurre una doppia vita. Allacciò rapporti nel mondo dello spettacolo. È così che Bourdin, il gioielliere di rue Quincampoix lo riconobbe una sera all’angolo tra boulevard Sébastopol e boulevard Saint-Denis, in compagnie di Maule, celebre cantante al “Parisiana” sotto il nome di “Honoré”. E in quello degli affari, soprattutto. Ad esempio, rimase per lungo tempo in trattative con un certo Bléchier che voleva aprire un’agenzia di pubblicità e la sua disonestà lo divertiva. Smontare il meccanismo capitalista grazie al quale si può costruire una fortuna “onesta” turlupinando legalmente la gente lo affascinava. Egli spingeva Bléchier, dinanzi al quale aveva fatto balenare la speranza di un grosso apporto di denaro liquido, a lasciarsi sfuggire delle enormità.
– Ma non è certo molto corretto, quel che mi proponete! – prorompeva allora.
Bléchier diventava paonazzo.
– Buon Dio! Voi siete un uomo intelligente, signor Escande! – insisteva il disgraziato. – Voi vedrete bene che decuplicheremo i nostri investimenti nel giro di due anni!...
– Certo, ma non lo trovo morale. Bisogna che inventiate un’altra cosa, mio caro Bléchier, che non prenda la gente per degli asini.
Grande poteva essere la tentazione di trasformare le sue banconote acquisite fraudolentemente in qualche affare onesto e astuto. Era già successo. E invece, no. Irrimediabilmente ladro-gentiluomo, egli s’era messo al servizio di un’idea cui non rinunciava.
Ferrand, quando un giorno lo incrociò al caffè Vayssade in rue Château-d’Eau, gli cadde tra le braccia, come se avesse all’improvviso ritrovato un fratello scomparso in Papuasia.
– Se n’è fatto di lavoro, mentre tu non c’eri! – esclamò lui felice prendendolo in disparte. – Quel colpo, tu sarai fiero di noi. Non avrai nulla da rimproverarci!
Effettivamente, avevano qualche bel successo al loro attivo.
Tra Natale e Capodanno, in casa del signor Rouard, a Chartres, avevano scalato un muro di due metri e venti. Nella notte fra il 3 e il 4 gennaio, dal signor Thonnet, in boulevard Lamartine, a Le Mans, all’angolo con rue Moyenne, in una casa a strapiombo sulla Sarthe, avevano sventrato un forziere contenente duemila franchi di gioielli e dell’argenteria. La porta era munita di una suoneria automatica. Se ne erano accorti in tempo e l’avevano neutralizzata.
Nella notte tra il 9 e il 10 gennaio, avevano visitato, con Baudy ed Henry, successivamente il palazzo del signor De Coutade e la casa di Hippolyte Godard in rue du Bel-Air 20, ad Angers. Il 12, il signor Loudreau, a Nantes. Il 13, la signora Richoux, a La Roche-sur-Yon. Del resto, le cose non erano finite bene: erano scesi all’hotel Coq-Hardi. Se ne erano allontanati alle 7 di sera con la scusa di lasciare le loro borse alla stazione prima di prendere il treno delle 23. Alle 10 e mezzo, verificavano i sigilli: intatti.
Scalano il muro di cinta, attraversano il giardino, forzano una persiana, una porta, due porte. E poi, all’improvviso, degli urli: un guardiano, Eugène Merceron, che era giunto da un’altra entrata, dormiva lì. Scappano. Fuori, un assembramento. Estraggono le rivoltelle.
– Ma non ce ne siamo serviti, sai? – gridò Ferrand con una tale aria di trionfo, quando raccontò l’avventura, che Alexandre non poté trattenere un sorriso.
Insomma, avevano dovuto abbandonare alla stazione le loro preziose borse con il loro contenuto. La polizia se ne doveva essere impadronita. Charles aveva dovuto fabbricare un nuovo lotto di utensili.
Poi Baudy, che aveva guadagnato due soldi nelle sue varie operazioni, era ridiventato inutilizzabile. Si era trasferito con Touzet in boulevard de la Gare 175 e, di là, era ripartito per un nuovo giro dei casinò.
Era stato subito rimpiazzato da François Vaillant, un commerciante di fiori di rue Geoffroy-l’Asnier, un bravo ragazzo, di Orléans, che aveva seguito la stessa strada di tutti: militanza, impossibilità di trovare lavoro. Truffe. Furti. (Vaillant nacque il 24 luglio 1871 ad Orléans. La sua prima condanna, a tre mesi con la condizionale, risale al 1897). E poi Noël Blondel, Noël il bello, un teppistello verso il quale Ferrand provava tenerezza. Un tipografo, anche operatore cinematografico, all’occasione. Un lionese. Già condannato due volte. Un povero ragazzo. Dei genitori alcoolizzati. (Blondel nacque il 25 aprile 1882 a Lione. Era stato condannato il 31 gennaio 1898 a Lione e riconsegnato ai suoi genitori, poi ancora il 7 aprile di quell’anno per “vagabondaggio aggravato”, quel che i rapporti di polizia chiamano anche “condotta infame”).
Alexandre aveva avuto in quel momento la cortesia di inviare a Ferrand un indirizzo con la mappa del posto e tutte le indicazioni necessarie e loro non avevano dovuto fare altro che andare a Coulommiers, il 21 gennaio, dal signor Ogier de Baulny, in rue Valentin 3. Una delusione: qualche vecchia moneta, gettoni d’argento, medaglioni.
In seguito, avevano improvvisato e, del resto, senza fortuna. L’11 febbraio, Ferrand era andato ad Abbeville con un certo Châlus, meridionale, tenutario di una “casa” sulla Costa Azzurra, sposato ad una ex prostituta, Anna Calendini, diventata vice-maîtresse (il suo sogno di sempre). Châlus voleva semplicemente, secondo la sua espressione, “sgranchirsi le gambe”: niente. L’8 marzo ad Amiens, dalla signora Beaugrand in rue Saint-Fuscien 67, con Vambelle, detto Lombardi (o il contrario, nessuno è mai riuscito a scoprire la sua vera identità), in breve un borsaiolo italo-belga: niente. Gabrielle li aveva accompagnati fino a Longueau; da lì, lei aveva raggiunto Arras.
I1 12 marzo a Dreux, nuovo incidente in casa Binet, in rue de la Gare 21, sempre con Vambelle-Lombardi. La vicina, la signora Dollet aveva scorto della luce verso le 11 di sera. Si era messa a gridare. Un altro vicino, Grandjean, che era un maresciallo della gendarmeria in pensione, aveva tirato fuori uno schioppo e aveva cominciato a sparare loro addosso: avevano dovuto filare via.
Poi altri due indirizzi forniti da Alexandre, ambedue a Rouen: un possidente, il signor Durel, di rue Saint-Maur 62 dal quale Ferrand s’era introdotto il 4 aprile, approfittando del fatto che costui era in villeggiatura a Honfleur: un magnifico malloppo di gioielli. Forse cinquemila franchi. Questo insieme a Vambelle e Baudy, di nuovo rovinato al gioco e che giurava di non ricascarci mai più. E il signor Deuve, consigliere del Tribunale. Era stato un tale piacere svaligiare quel magistrato che Baudy e Vambelle erano ritornati l’indomani da Parigi per fargli una seconda visita. In totale all’incirca altri cinquemila franchi. Baudy era naturalmente sparito subito dopo, in direzione di una qualsiasi Montecarlo.
Infine, delle sciocchezzuole: il signor Ferry ad Abbeville, verso la fine di aprile: trecentosessantacinque franchi. Ferrand e Vambelle avevano, tra parentesi, vissuto da costui momenti d’angoscia: due fidanzati che amoreggiavano in modo molto spinto dinanzi alla porta di casa sembravano non volersi più staccare l’uno dall’altra e ostacolavano la loro uscita. La signora Aubin, vedova Théron, a Beauvais in rue d’Amiens 52, il 17 maggio: qualche centinaio di franchi, malgrado un forziere sventrato con gran fatica. Il signor Meurdesoif ad Abbeville, nel quartiere del Bois l’11 giugno: impossibile aprire il forziere. Inoltre, quell’imbecille di Châlus, il tenutario, ladro dilettante, s’era fatto notare in giornata al bordello locale. Aveva recitato la parte dell’inglese ubriaco e tentato di portarsi via una ragazza, Marie Blond, per metterla nella sua scuderia.
– Insomma – concluse Alexandre quando Ferrand ebbe terminato il suo circostanziato racconto degli ultimi avvenimenti – a parte i tre indirizzi che ti avevo inviato io, niente di molto brillante.
– No – riconobbe Ferrand.
– Sono andato a verificare i conti da Brunus. Ho fatto un rapido calcolo. Tu sei in debito di più di ventimila franchi su quello che dovevi versare all’organizzazione.
Ferrand cercò di difendersi.
– Non ti chiedo spiegazioni – riprese dolcemente Alexandre. – Voglio credere che gli affari sono andati male per tutti voi dacché me ne sono andato. È vero che i miei guadagni a Tolosa hanno compensato le vostre perdite. Ma adesso, se volete ancora stare con me, bisognerà stringere di più il gruppo. Quelli che preferiscono la roulette alla rivoluzione non devono fare altro che andarsene. La rivoluzione non ha bisogno di loro.
* * *
– Durante questo periodo, sembra che ve la prendeste in particolar modo con la nobiltà.
– Non solo durante questo periodo. Le mie opinioni non sono mai cambiate. Nel novero delle fortune borghesi, alcune possono a rigore esser considerate come il prodotto legittimo di un’impresa commerciale o industriale. Ad esempio, il negoziante di alcool s’arricchisce avvelenando intere generazioni; il fabbricante di armi riempie d’oro le sue casseforti costruendo macchine di distruzione. Il tenutario di casino, questo esimio cittadino con licenza, elettore ed eleggibile, accumula grandi ricchezze dedicandosi alla salvezza della morale borghese: le loro fortune sono in qualche modo il frutto di un... tipo di lavoro. Ma per i “nobili”, lavoro è sinonimo di degradazione. Così sono sempre rimasti “nobili”. Basta studiare la storia per constatare che non devono la loro fortuna che ai delitti, al brigantaggio ed alla prostituzione. Per dieci secoli la nobiltà non si è distinta che per l’arte di spogliare e di massacrare i popoli. Più tardi, la monarchia assoluta ha concentrato il potere nelle proprie mani e i nobili si sono trasformati in cortigiani ossequiosi e vili. Era una gara a chi più si sprofondava in riverenze dinanzi al padrone per assicurarsi dei privilegi. I luoghi malfamati divennero dei lupanari, il banditismo lasciò il posto alla prostituzione.
Oggi, malgrado tre rivoluzioni, questa casta non ha derogato alle sue care tradizioni. Gli uni non vivono che grazie ai redditi di beni mai guadagnati; gli altri, certamente spinti da un’influenza atavica, non potendo più saccheggiare ed uccidere per conto proprio, comandano all’esercito di questa stessa repubblica che i loro nonni di Coblenza vollero soffocare. Alcuni, infine, più avidi di guadagno che di gloria, restaurano le loro fortune sposando la loro progenie ai commercianti di porci d’America! (Allusione forse al matrimonio, nel 1895, di Boni de Castellane, discendente dei Talleyrand-Périgord, dei Courlande, dei Radziwill, dei Sagan, con Anna Gould, la prima ricca ereditiera in the world, che del resto non doveva la sua fortuna ai “porci”, ma alle ferrovie).
Insomma, la nobiltà assomiglia a quei fiori incantevoli che stillano una sostanza velenosa letale: essa costituisce un ostacolo, un pericolo sociale, come nemico di ogni innovazione umanitaria. Parassiti decorati d’orpelli, i nobili non vivono che a detrimento delle classi lavoratrici. Così io mi sono fatto strumento di rivolta spogliandoli del frutto delle loro rapine, con l’amaro rimpianto di non aver potuto far meglio. (È soprattutto qui che si può percepire la trasposizione da Jacob, plebeo, a Lupin, cavaliere d’Andrésy da parte di madre, alcuni pseudonimi del quale erano nientemeno che: duca di Charmerace, principe Sernine o don Luis Perenna).
* * *
Da quel momento Alexandre riprese in mano il suo piccolo gruppo. Non voleva né Baudy né Clarenson né Bonnefoy. Ognuno era libero di condurre la propria vita come voleva. Ma bisognava che i suoi collaboratori fossero un po’ più devoti alla causa se si voleva raggiungere un risultato.
Baudy, sempre così malinconicamente perdente, proseguì dunque il ciclo dei suoi desolanti giochi. Poi, la sua nuova amica, Julia Ruffa, riuscì, pare, a fargli risalire per un po’ il pendio scosceso su cui stava scivolando:
«Senza l’aiuto di questa coraggiosa compagna – scrive nelle sue confessioni – adesso non sarei più niente a questo mondo. Con il suo affetto e la sua tenerezza, ella riuscì a risollevare il mio morale abbattuto. Con uno sforzo di volontà, riuscii a liberarmi da quella pericolosa apatia. Era tempo.
«Mi misi immediatamente in contatto con diverse aziende commerciali. Un’azienda di profumeria di Tolosa e un’altra di oli e saponi mi assunsero come piazzista. Sebbene nuovo nel ramo, il presente mi faceva ben sperare per il futuro».
Fatica mal ricompensata: Baudy si farà arrestare stupidamente il 22 settembre seguente, a Tolosa. Il tribunale dell’Alta Garonne lo gratificherà in quell’occasione di cinque anni di reclusione.
Clarenson, rilasciato alla fine di luglio malgrado la sua sfortunata rendita al 3 per cento, andò, dal canto suo, a trascinare la sua esistenza maniaco-depressiva di giocatore di carte a Villeneuve-Saint-Georges presso il signor Gauthier in avenue de Paris 28 bis, in compagnia della sua Antoinette vedova Amiglio. Questo fino al gennaio 1903, allorché un rimorso della giustizia lo getterà di nuovo in prigione. Per rilasciarlo due mesi dopo. E rimetterlo dentro. E rilasciarlo di nuovo. Quanto a Bonnefoy, aveva cominciato a seguire la legittima consorte nei suoi giri pseudo-canori.
Il posto dunque era libero. Alexandre ne approfittò per circondarsi meglio, malgrado qualche litigio con Ferrand sempre pronto ad ingaggiare il primo venuto.
Dapprima fu Léon Ferré, detto François, detto Mercier, detto Lemercier. Alexandre lo incontrò in una riunione del XIV arrondissement. Un ragazzo quasi analfabeta, ma militante convinto. Proveniente da Narbonne, dov’era nato il 27 giugno 1865. Operaio mosaicista, onesto, serio, generoso, lavoratore. Dopo il servizio militare, nel 1887, aveva lavorato per un anno e mezzo a Béziers dalla signora Lignan. Poi dall’aprile 1888 al settembre 1889 dal signor Sautel in rue des Abattoirs 44, nella stessa città. Quindi a Barcellona per un anno da Orsola-Sola. Era ritornato a Béziers dal signor Planchais in rue des Abattois 31 fino al 17 maggio 1891 quando era partito in cerca di fortuna ad Algeri. Vi aveva trovato una donna, Angèle Bononi, di origine italiana, bella, dolce, buona, anche lei gran lavoratrice. Lì s’era anche preso un eczema alle mani. Cosa che l’aveva costretto a ritornare in Francia. Planchais, Sautel, di nuovo Planchais, a Béziers. Poi il grande salto: Parigi. Dal 1° aprile 1896 all’aprile del 1897, Ivry, più precisamente, presso la vedova Labrouille, in rue Nationale 51. In seguito dal signor Picot, in vicolo Milord, nell’avenue de Saint-Ouen per due mesi. E infine il signor Verdy in rue d’Alleray 66.
Ma il mosaico non rendeva. L’eccellente Ferré si sentiva turlupinato, truffato, “coglionato”, per usare le sue parole, dai suoi padroni successivi. Con i loro due bambini, che essi volevano allevare dignitosamente, “non ce la facevano”. La sua Angéle aveva dovuto mettersi a fare la portinaia in rue Labrouste 41 per potere arrivare a fine mese. Fu allora che Alexandre lo scovò.
Era verso la fine di agosto. Alexandre, con Ferrand, aveva appena ripulito la vedova Donay, a Meaux, in boulevard Victor Hugo 13, di una pila di denaro giudicato superfluo. Diede a Ferré qualche luigi e, con franchezza, gli propose di seguirlo. Ne discussero nel gabbiotto con Angèle. Non solo lei diede il suo consenso, ma si entusiasmò. Era pane benedetto. Il signor Jacob aveva mille volte ragione (“Chiamami Marius, diamoci del tu, se vuoi”): ne avevano abbastanza. Bisognava vendicarsi. Lei aprì la portineria alla banda. Per evitare sospetti, si convenne di affittare ad Alexandre, sotto falso nome, l’appartamento al secondo piano, che era libero. Vi si potevano tenere le riunioni. Sarebbe anche servito da rifugio per i compagni in difficoltà. Inutile mostrarsi troppo insieme, del resto. Quando ci si voleva incontrare, sarebbe bastato bussare tre volte al vetro, di passaggio, e ritrovarsi in un bistrot di rue de Vouillé 49, da Devaine. Era un compagno. Non faceva mai domande. Orecchie cucite. Bocca cucita.
Così fu fatto. Da allora, fu una vera frenesia di furti. La macchina messa a punto da Alexandre girò a pieno regime. I gruppi, simili ad api in un alveare, avevano appena il tempo di depositare la loro refurtiva in rue Labrouste, in boulevard Ornano o da Apport o Limonnier, e ripartivano immediatamente. Ce ne furono fino a tredici, ad agire contemporaneamente. Alexandre lavorava di preferenza con Ferrand e Ferré, ma non sistematicamente.
Quando era il turno di Ferré di partire in esplorazione, poiché questi non sapeva scrivere, Angéle gli scriveva in anticipo diversi testi di telegrammi: lui non doveva far altro che scegliere quello giusto. Il suo primo tentativo (riuscito) ebbe luogo dalla signora de Breda a Compiègne, il 29 agosto. Alexandre, di ottimo umore, volendo mettere a suo agio il nuovo venuto, trascorse il tempo a scherzare. La signora de Breda, donna di qualità, aveva due forzieri. I due li aprirono. Come fece loro osservare Jacob quando le operazioni furono concluse, essi erano “benemeriti della patria”. Settantadue chili d’argento da affidare a Brunus, oltre a numerosi gioielli.
L’indomani, sempre a Compiègne, andarono in rue Vermenton dal capitano Edon, che si trovava allora per manovre nel campo di Lissonne. Bottino: un servizio da tè in argento, un paio di spalline, medaglie, tappi da caraffa in cristallo, timbri, cento azioni della “Sedoline” in venti certificati e cinquanta della “Standard Oil of California”, che il povero derubato, al processo di Amiens non saprà neppure pronunciare. Confesserà in compenso di averli acquistati per milleduecento franchi, attirandosi allora la replica di Alexandre:
– Ah! Vi siete fatto fregare, signore! Non valevano assolutamente niente, le vostre azioni, e le ho bruciate! Ma quei ladri là non sono certamente stati arrestati! Agivano ben protetti! Forse portavano le decorazioni della Legion d’Onore...
Per l’operazione dai signori de la Rivière, ad Abbeville, in rue aux Pareurs, il 17 settembre, Ferrand fece da sentinella. Fu un colpo magnifico: 15.000 franchi di gioielli e di argenteria. Invece, tre giorni dopo, a Caen, dal signor Pougheot in rue Singer 20, Alexandre, colto da un accesso di febbre e tosse, dovette rinunciare dinanzi al forziere, incapace di tenere in mano i suoi attrezzi. Fu sul punto di svenire. Era dimagrito come ai tempi delle febbri di Dakar. Tutta la sua vitalità sembrava ridotta allo sguardo. I suoi due complici dovettero portarlo fuori, sostenendolo ognuno per una ascella. Lavorava troppo. Malgrado la sua salute malferma, passava a volte tre notti di seguito senza dormire, ingerendo caffeina. Non mangiava quasi più.
Nella notte tra il 26 e il 27, aveva tuttavia già recuperato abbastanza da aprire a Cherbourg il forziere dell’ammiraglio de Pontaumont in rue de l’Alma 30. Ne estrasse chili di gioielli e di argenteria. Per almeno cinquantamila franchi: la marina pagava bene.
Il mattino successivo, ripassando dinanzi al palazzo dell’ammiraglio per andare a controllare altri “sigilli”, vide un giovanotto che stava esaminando il cancello e che fuggì immediatamente guardandosi attorno furtivamente. Alexandre, incuriosito, andò a mettersi in osservazione sulla terrazza di un vicino caffè. Una mezz’ora più tardi, il giovane ritornò con due agenti. Poi il palazzo venne circondato da una compagnia di fucilieri della marina. Infine giunsero i pompieri: il giovane, che era poi il figlio dell’ammiraglio, viste le tracce di effrazione sul cancello d’entrata chiuso, aveva creduto che i ladri si trovassero ancora all’interno.
Alexandre assistette con soddisfazione infinita alle intimazioni, quindi all’avanzata dei fucilieri nel parco, di albero in albero e all’assalto finale: quel sistema di cordicelle da lui inventato e che permetteva di richiudere le porte dietro di sé dall’esterno era decisamente un’idea eccellente. Gli rimaneva il rammarico di non poterlo brevettare.
Mescolato alla folla di curiosi, ne approfittò per tentare di divulgare le sue opinioni: i ladri avevano fatto benissimo a svaligiare un ricco! Che degli ammiragli se la spassassero in simili possedimenti mentre la maggior parte dei francesi vegetava in topaie, era una vergogna! Non ottenne il successo sperato. Quella brava gente non capì ciò che voleva dire. Naturalmente che era meglio svaligiare un riccone come l’ammiraglio! Ma sarebbe potuto benissimo capitare a chiunque tra loro. Non c’erano soltanto i grandi svaligiatori: c’erano anche le piccole canaglie, i malfattori disgraziati, i morti di fame di ogni risma, gli zingari, tutti i nomadi pronti a sventrare un operaio per i dieci luigi del suo salario. O la drogheria per la sua cassa. Allora, come stabilire la differenza tra i ladri “buoni” e quelli “cattivi”? Non si poteva andare troppo per il sottile.
I bighelloni insomma respingevano l’idea che Pontaumont potesse essere arricchito della loro miseria e quindi che impoverirlo significava forse arricchire loro.
Quelle reticenze non facevano però vacillare le convinzioni di Alexandre: egli ne concluse invece che doveva rubare ancora di più, per finanziare una propaganda più estesa e permettere così alle idee anarchiche di meglio diffondersi. Diede maggiore impulso alle sue riappropriazioni.
In ottobre, il trio spogliò di argenteria, gioielli, tappeti, il signor Mauduit de Sopicourt, a Reims, in rue de Talleyrand 66. In novembre, ad Amiens, all’angolo tra boulevard d’AlsaceLorraine e rue des Ecoles-Chrétiennes, dal signor de Witasse, per provocazione, per puro odio verso la ricchezza, tagliarono le teste degli eroi antichi che adornavano le tappezzerie delle poltrone, Il 9 dello stesso mese, a Meaux, in place Geoffroy, rubavano alla mignora Leroy, una pendola in bronzo verde di cinquanta chili che verrà impegnata al Monte di Pietà, due candelabri di bronzo verde che Angèle invierà in regalo ai suoi parenti a Béziers; ottantatré asciugamani con sigla in cotone rosso, trentasei camicie da donna, fazzoletti di pizzo ricamato, borse e nastri di perle, del pizzo di Valenciennes, diciotto tovaglie di biancheria fine, pacchetti di tende in mussolina e altre cosette. Del resto, scoppiarono i litigi tra Rose ed Angèle a proposito della divisione dei vestiti e della biancheria di casa: ognuna delle due voleva approfittare delle spoglie della prudente borghesia per farsi il corredo. Quindi Ferrand e Ferré conclusero che le donne, anche se compagne e militanti e ladre, rimanevano animali inferiori presso cui il senso della proprietà restava troppo forte.
Terminarono quella serie la notte successiva, con uno svaligiamento mancato: quello della chiesa di Saint-Jacques a Compiègne. Riuscirono a superare un muro di tre metri per saltare nel cortile della sacrestia, quindi a scardinare quattro porte, ma dinanzi al forziere dovettero dichiararsi battuti. Ad Alexandre mancava un attrezzo. Ferré aveva male interpretato un telegramma indirizzatogli a nome di Mercier: “Ricevuto pacco conforme, firmato Radinot”. Firmato “Radinot” e non “Georges”. Ferré s’era sbagliato nelle leve da portare.
Ferré era pieno di buona volontà, ma non sempre all’altezza delle circostanze. Mancava totalmente di discernimento. Così Alexandre non aveva nulla da rimproverare a priori al suo amico Alcide Ader, uomo di Mont-de-Marsan, che aveva lavorato al movimento merci della stazione Nord e fondato in seguito una colonia libertaria in America del Sud. Ma perché introdurre nel gruppo un tizio che, al primo stormir di fronde scappava via come se uno squadrone di ussari lo stesse inseguendo a sciabola sguainata? Certo, era un vecchio militante. Un caro amico della coppia, che Angèle andava a trovare spesso con suo marito in avenue Michelet 114 e che in quel momento si trovava in difficoltà. (Alcide Ader era nato nel Gers, il 13 aprile 1859. Quindi aveva 42 anni nel 1902. Era un tipo bruno, brizzolato, affetto da reumatismi. Non era mai stato condannato). Ma i cani sperduti non avevano posto in quest’avanguardia dell’avanguardia che essi costituivano.
D’altro lato, Ferrand si mise a sua volta a ricalcitrare. A proposito della questione del 10 per cento, naturalmente. Tanti rischi, tanta fatica per non avere neppure un giorno di riposo!
– A volte, preferirei lavorare in officina piuttosto che seguirti! – sbottò.
Gabrielle lo spingeva in questo senso. I vestiti, la pettinatura e il tè in boulevard des Italiens dove lei poteva fare la duchessa; ecco tutto quel che lei apprezzava nell’impresa di recuperi. L’ideale? Bah... In fondo non aveva mai perdonato ad Alexandre di non essersi lasciato sedurre da lei al momento del suo arrivo in rue de la Clef.
– Sei un bel ragazzo. Perché ti tiri dietro una vecchia? – aveva delicatamente suggerito a proposito di Rose.
Alexandre aveva sorriso, impallidendo un po’, ma comunque aveva sorriso:
– Restiamo amici, vuoi? – aveva detto. – La qualità non si misura dalle rughe. Del resto, Rose non ne ha, che io sappia. Ferrand è un amico. Non capisco quel che vuoi dire.
Poi, non s’erano mai più ritrovati a quattr’occhi.
E così, da un lato la vana gentilezza di Ader, dall’altro la cocciutaggine di Ferrand: si ripresentavano esattamente gli stessi problemi. Alexandre a volte s’immaginava come una formica che vuole uscire da una buca di sabbia e sotto le cui zampe i grani sprofondano ogni volta che avanza di un centimetro. Marie, per fortuna, gli risollevava il morale con le sue lettere: da quando era riuscito a convertirla, lei era più fanatica di lui. Il suo buonsenso di contadina non concepiva quelle oscure difficoltà. E poi c’era Rose. Rose e il suo sorriso simile a un gran sole.
– Mio buon Ferrand, se non sei d’accordo, sbrigatela da solo. Non posso fare di più per te – concluse quando litigarono per i soldi.
Ferrand, per orgoglio, per non dare agli occhi di Gabrielle l’impressione di cedere sempre, si credette in obbligo di insistere. Ma non era che una semi-rottura. La loro complicità l’avrebbe avuta vinta ben presto sulle offese all’amor proprio.
L’incontro con Bour, alle “Conversazioni popolari del XVIII arrondissement”, che in ottobre lo storpio Libertad aveva fondato in uno stambugio di rue de Chevalier-de-la Barre, fu invece come una folata d’aria fresca.
Bour, detto Herselin, detto Tellier, tipografo parigino, aveva ventun anni. Era il figlio naturale di una donna di servizio, Félicie Moulard, che l’aveva affidato, quando aveva due anni, a sua nonna perché lo tirasse su, a Brumets nell’Aisne. Bour, dolcissimo, docilissimo, gentilissimo, era stato chierichetto. Andava a comprare la “Croix” per la “signora” del posto, la viscontessa de Melun, che gli faceva una tremenda soggezione. Molto spesso le faceva la spesa. Per tutto ringraziamento, lei gli dava dei buffetti sulla guancia. La nonna vedeva già per lui uno splendido futuro di maggiordomo a castello, forse di guardiacaccia.
– Voi capite, era colta, quella donna – si scusò lui candidamente quando si confessò con Alexandre, una sera da Muniez, dopo una conferenza su “La scienza e sua utilizzazione da parte dei borghesi”, che si era conclusa con un gran tafferuglio. – E poi, i suoi vestiti, il suo modo di parlare... Non era come a casa...
– Innanzitutto, diamoci del tu – rispose Alexandre. – E poi confessa che te ne eri innamorato. E terzo raccontami che cosa aveva più delle altre, la tua viscontessa.
Bour non poté fare altro che cercare di descrivere il salotto in cui lo riceveva, il rispetto con il quale il curato parlava di lei, i vocaboli che lei usava, la mano che tendeva da baciare: tutto quel che faceva lei per farlo sentire rozzo, plebeo e volgare in sua presenza.
– E tu ti sei lasciato incantare da tutte quelle smorfie.
– Avevo otto anni...
Poi aveva preso la licenza elementare. Sua nonna era morta. Era ritornato ad abitare da sua madre. Era diventato apprendista tipografo, come Alexandre, dai coniugi Didelot. Sua madre si era sposata con un muratore, Bour, che gli aveva dato il suo cognome. Ma non c’era buon sangue tra patrigno e figliastro. Quest’ultimo s’era innamorato di una cameriera di caffè, Léontine Tissandier, una ragazza di Marcillac, nell’Aveyron, una attraente ventenne. Lei aveva subito perduto il posto e lui non aveva avuto abbastanza soldi per pagarsi l’albergo.
– S’è messa a battere?
– Be... Non so... aveva dei soldi... Si viveva così...
– E adesso?
– Vorrei che ci sposassimo. Ma non ho mica vinto al lotto. E poi, devo partire militare, allora quando ritornerò...
– Ma davvero? Vuoi andare a fare il coglione nell’esercito?
– Lei è in ospedale, capisci. Io non posso fare più niente.
– Incinta, scommetto.
L’indomani, Rose, carica di pacchetti, fece visita a Léontine che preferiva farsi chiamare Alice Vincent, in rue de l’Estrapade. Anch’essa aveva conosciuto quella vita. Non perché andava in giro in carrozza aveva dimenticato. Fece scivolare nelle mani della povera ragazza una grossa banconota. Dai suoi risparmi personali. Aveva fatto piangere anche lei, quella storia tenera e idiota di due ragazzini che si amano come in un romanzo di Montépin e che si riducono cosi.
Quando Léontine-Alice raccontò a Bour delle mele, i dolci, il denaro, i fiori portati da Rose, lui ne fu soffocato. Letteralmente. Gli mancò il respiro. Era un mondo diverso quello, in cui le idee si facevano atti in totale naturalezza, senza promettere, senza vantarsi, senza contropartite. Egli era andato alle riunioni per rivolta. Ma la rivolta era dunque anche generosità? Per otto giorni cercò Alexandre per tutta Parigi. Finì per ritrovarlo. Gli annunciò la sua decisione di disertare. E il suo desiderio di entrare nelle file di quei “Lavoratori della notte” di cui aveva sentito parlare sotto il vincolo del segreto.
– Mi piacerebbe – rispose Alexandre. – Ma tu hai innanzitutto una vendetta da prenderti, compagno. Forse che non ti piacerebbe andare a vedere a cosa rassomiglia la tua viscontessa nell’intimità? Solamente dopo, potrai decidere con conoscenza di causa.
L’idea entusiasmò Bour. Nella notte tra il 22 e il 23 novembre, lui, Alexandre e Ferré, seguiti da Ader che si ecclissò com’era sua abitudine nel momento in cui facevano saltare la bocchetta della porta penetrarono nella chiesa di Brumetz. L’ex chierichetto poté esorcizzarvi i suoi timori di ragazzo.
* * *
– E poi, signor sacrestano, che cosa vi hanno rubato?
– Le pianete, i cibori... Hanno aperto la cassetta... Hanno preso quelle poche offerte, l’obolo dei nostri fedeli...
– E via, sacrestano! Un po’ di memoria! Non state dicendo tutto! Ci state accusando in nome del vostro Dio e della vostra morale. Ma dell’armadio che conteneva delle stampe... delle stampe nello stile, per così dire, Fragonard, che cosa dite?
* * *
Da lì, andarono dalla viscontessa. Portarono via tutto. Sistematicamente. Compresi i quadri, le camicie da notte, i merletti. Bour era il più accanito. Regolava i suoi conti. Alexandre sorrideva vedendolo svuotare i cassetti, esclamare, andare in collera, bestemmiare, saccheggiare, distruggere, rubare.
* * *
– ... Un fazzoletto di pizzo, ereditato dalla mia bisnonna, almeno duecentocinquanta franchi solo per quello...
– Non vi permetto! Non è forse da solo un insulto alle classi lavoratrici?
* * *
– Adesso sono dei vostri, vero? – disse Bour con aria implorante al termine di quel duplice successo. Era ormai uno dei loro. La sua attività non si fermò più.
Nella notte tra il 26 e il 27 novembre, il portale in legno di quercia della chiesa di Saint-Etienne a Beauvais, resistette. Bisognò far saltare le pietre per un diametro di un metro attorno alla bocchetta. Fu poi un piacere aprire le cassette delle elemosine e la doppia porta del tabernacolo dell’altare della Vergine dove era nascosto un ciborio in argento dorato. Ader, dopo aver tremato nell’ombra dei platani, visto che tutto andava bene, non fu il meno entusiasta quando Attila lasciò la sua firma su un cartoncino foderato di seta bianca: “Dio onnipotente, che ne hai fatto del tuo calice?...”.
* * *
– Io sono il cappellano della chiesa di Saint-Côme, a Chalon- sur-Saône. Questi banditi, questi disgraziati hanno svaligiato il luogo sacro nella notte tra il 5 e il 6 dicembre... Non avevano neppure richiuso una botola nel presbiterio. Ci sono caduto dentro all’alba. Ho creduto di sprofondare nell’inferno!
* * *
Quella stessa notte, Ferrand, cui s’era aggiunto Pélissard, rilasciato dopo la sua quarta condanna per infrazione al divieto di soggiorno, metteva in mostra la sua capacità presso i coniugi Noché in rue Campoberg 7, a Rouen.
Il 18 dicembre, Alexandre, Bour e Ferré si trovavano a Cherbourg, dal contrammiraglio Aubry de la Noë le cui tele non potevano non nobilitare la collezione di un antiquario rinomato come il signor Escande. Il 19 era la volta di Adam, ispettore generale della marina, già individuato in occasione dell’incursione dell’ammiraglio de Pontaumont tre mesi prima. Il 20, la chiesa di Saint-Godard a Rouen. Il 23 quella dedicata al culto di San Giacomo ad Abbeville. Il 24, notte di Natale, ad Evreux, dal comandante Vignone, allora di stanza a Versailles.
Fu durante quel giro che giunse ad Alexandre la notizia della morte di suo padre dopo una lenta agonia. Non fu una sorpresa. Senza nemmeno perdere tempo a cambiarsi di camicia, saltò sul primo treno per Tolosa: Rose volle accompagnarlo. Marie, in lacrime, esausta per le lunghe notti di veglia e allo stesso tempo sollevata per quella soluzione che aspettava, cadde tra le loro braccia piangendo. Gli ultimi istanti erano stati particolarmente penosi. Egli soffriva. Urlava che un granchio gli divorava il fegato.
Rose seppe trovare le parole opportune. Amava Marie come una sorella appena più vecchia di lei. Tutt’e due idolatravano Alexandre. Decisero di non lasciarsi più. Alexandre non poteva annullare degli “appuntamenti” urgenti, ma Rose rimase là ad aiutare mamma Jacob ad impacchettare la sua roba. Nel frattempo, a Parigi, lui disdiceva l’affitto di boulevard Ornano, raccontando al proprietario che si sarebbe stabilito ad Asnières ed affittava un altro appartamento un po’ più grande, in boulevard Magenta 14. Da cui comunque si trasferì dopo qualche settimana per andare in rue Leibniz 82, giacché la portinaia di boulevard Magenta era affetta da spionite. Le “donne Jacob”, come le chiamerà il presidente Wehekind, lo seguiranno e poi anche Bour con la sua Léontine detta Alice, con la scusa che non sapevano dove andare, ma in realtà perché Alexandre era diventato per l’apprendista svaligiatore, il padre che non aveva mai avuto e perché Marie e Rose sapevano dare alla casa quella calda atmosfera familiare che mai lui aveva conosciuto. Per Alice, affermare che fu soddisfatta di quella sistemazione, sarebbe dire troppo. Qualche battibecco ci fu in cucina a proposito delle pentole che lei lasciava sporche. Seguirono altri litigi, in bagno, per delle sottovesti “lasciate in disordine”. Le Jacob erano donne di casa. Lei no. Un giorno, il tono si alzò. Alice intimò a Bour di scegliere tra lei e loro. Non c’era alternativa possibile. Nessuno aiutò la povera ragazza a far fagotto.
Se ne andò a testa bassa. Alexandre, venuto a sapere la cosa al ritorno da una conferenza, riuscì a rintracciarla. Le procurò anche un lavoro in un bistrot di amici suoi. Ma la rottura era definitiva. Lei non voleva più coabitare con “quelle megere”. Bour, dal canto suo, s’era attaccato ad Alexandre come un cane al suo padrone: exit Alice. Una separazione gravida di conseguenze.
* * *
– Alice Vincent, parlate senza timori. La vostra sincerità in istruttoria ha servito la causa della giustizia e della verità. Avete assistito personalmente alla spartizione della refurtiva, vero?
– Sì... insomma, c’erano dei bauli stracolmi che arrivavano in rue Leibniz. E poi dei conciliaboli tra Bour, Jacob, Marie Jacob, Rose Roux e Ferrand. E anche Ferré, mi sembra. Parlavano dei loro furti, di sicuro. E Bour mi ha raccontato come, a Brumetz...
– Quando penso che ho raccolto questa ragazza dalla strada, quando non aveva né alloggio né di che sostentarsi! Ecco cosa vuol dire fare del bene!
– Rose Roux, tacete! E d’altronde anche voi partecipavate a quelle riunioni! Voi eravate complice del vostro amante!
– Io condividevo la sua vita. Faceva quel che voleva. Io gli ubbidivo.
– Voi gli ubbidivate? Ma andiamo! Questa sottomissione sembra tanto più strana in quanto voi avete almeno quindici anni in più di lui!
– Signor Presidente! Io ho il diritto, credo, di scegliere per compagno chi mi pare. Non m’immischio di sapere con chi andate a letto voi! Conosciamo bene i costumi dei magistrati! Voi non prendete donne più vecchie di voi! Preferite le fanciulle, le adolescenti in casa vostra, vero?
* * *
Ma il lavoro non s’era interrotto. Adam in rue Saint-Rémy 4 a Soissons, nella notte tra il 1° e il 2 gennaio: qualche vestito, un fucile da caccia. Bahim, in rue Gambetta, poche ore dopo, nella stessa città: cinquecento franchi di argenteria, venticinque obbligazioni del “Panama”, due azioni della “Bourse Agricole di Soissons”, una della “Société de Paille et de Fourrage dell’Aisne”, il tutto prelevato da una cassaforte a cassettiera marca Petitjean, oltre ad un barattolo di marmellata che consumarono sul posto.
Ferrand, da parte sua, faceva coppia con Vaillant, il fiorista di rue Geoffroy-l’Asnier, con cui abitava allora in compagnia di Gabrielle. Al loro attivo: il signor de Boismarin in rue Moyenne 44 a Bourges nella notte tra il 5 e il 6 gennaio: un bell’assortimento di gioielli, tra cui un anello d’oro con diamanti e delle lenzuola; il signor de Beaurepaire, cognato e vicino di Boismarin, quella stessa notte: altri gioielli. Oltre all’argenteria, portata, sembra, da Gabrielle a quel soave intellettuale di Sautarel, che in cambio le avrebbe consegnato duecentoventicinque franchi. Sautarel infatti era riuscito molto provvisoriamente ad aprire una gioielleria in boulevard Beaumarchais 92. (Chiuderà bottega il 15 gennaio e da allora si stabilirà con moglie e figli a Vincennes, dove la polizia finirà per ritrovarlo). La polizia si chiederà sempre da dove provenivano i venticinquemila franchi-oro che egli diede a vari fonditori in quel periodo, da trasformare in lingotti. Sautarel non saprà mai spiegarlo. In verità era innanzitutto un poeta.
Il 6 gennaio, Ferrand e il suo accolito (“Cos’è questa parola? – Il vostro compagno, se preferite. – Ah! Bene! Mi piace di più”) andavano a Saint-Quentin, dal signor Noë: un solido forziere della ditta Bauché di Reims venne svuotato del suo contenuto. Il 16 svaligiarono a Chauny la signora Grand, in boulevard Gambetta. Blondel, l’efebo che Ferrand proteggeva, li raggiunse in quella città. Pranzarono, cenarono e giocarono a carte quasi tutta la giornata al ristorante Vandenberg.
Con quell’impresa doveva concludersi la serie dei loro colpi. Il 23 gennaio, individuati in occasione di un doppio svaligiamento compiuto a Nevers, Ferrand e Vaillant si fecero arrestare nel loro appartamento di rue Geoffroy-l’Asnier. Blondel, che sul momento alla polizia parve troppo effeminato per aver altro ruolo che quello del paggio, fu lasciato libero. Lo richiuderanno a sua volta solo nel maggio 1904.
Perché furono catturati? Qualche geniale segugio era riuscito a seguirli fino al loro domicilio? Sautarel disse immediatamente la sua opinione al proposito:
– E stata una donna a vendere Ferrand – comunicò a Gabrielle, incontrata in rue Réaumur qualche giorno dopo quella cattura.
Ingenuo Sautarel! E proprio a Gabrielle aveva sentito il bisogno di confidare i suoi dubbi! Gabrielle, l’unica donna nella vita di Ferrand, Gabrielle, gelosa dell’affetto (per non dire altro) che il suo amante mostrava per Blondel, Gabrielle la confidente della polizia! Quando Sautarel comprenderà la propria ingenuità, troppi fatti saranno accaduti. Sarà troppo tardi per avvertire gli altri.
Royère era appena morto. Clarenson si dibatteva in tagliole procedurali a proposito del suo tre per cento. Baudy, preso in trappola, non riusciva ad offrire prove molto convincenti della sua innocenza ai giurati dell’Alta Garonne: “Il gioco non mi aveva arricchito. Benché non fossi in ristrettezze finanziarie quando mi misi nel commercio, non avevo abbastanza per aspettare la riscossione mensile delle mie commissioni, d’altra parte minime, all’inizio. Allora incontrai uno dei miei vecchi compagni di reclusione. Era accompagnato da altre tre persone. Avevano con sé un’attrezzatura da svaligiatori. Temendo la curiosità dei camerieri e dei padroni d’albergo, non vollero lasciarla in camera loro e me la diedero in custodia. Feci la sciocchezza di prenderla e, essendo un po’ al verde, fui così stupido da accettare anche del denaro e degli oggettini provenienti dai furti, rendendomi così complice volontario. Fui denunciato ed arrestato. Trovarono in casa mia tutto quell’armamentario (...). Tutto ciò può sembrare incredibile...”. E lo era davvero.
Ma nessuno di loro aveva rilevato l’esistenza dell’organizzazione. Ferrand e Vaillant adottarono lo stesso atteggiamento. Tutto poté quindi proseguire come prima.
Il 23 gennaio, a Poitiers, Jacob, Ferré e Bour s’impadronivano di gioielli, parure, pellicce, vestiti e medaglie appartenenti al signor Boyer. Il 24 a Cambrai rubavano l’argenteria e i gioielli del signor Boudoux. Il 26 a Niort era la volta delle pellicce e degli abiti della signorina des Roches; il 27, nella stessa città, argenteria e gioielli del signor de Neuchaise. Nella notte tra il 10 e 1’11 febbraio, a Compiègne, in rue du Moulin, i due forzieri della signora de Frézal, offrivano loro settantadue chili d’oro e d’argento, senza contare i meravigliosi gioielli (“Se la testimone avesse avuto delle posate di latta, non le avrei preso niente”). Tre giorni dopo, Bour, ritornato a Compiègne per tentare di completare l’opera e resosi conto che il furto era stato scoperto, s’affrettò a spedire ad Alexandre un messaggio firmato Henri: il segnale d’allarme.
Si vendicarono ad Alençon, dai Duchazé, in boulevard Lenoir 21. In casa di Horace Sebastiani, a Beauvais s’accontentarono di bere del vino prelibato: il proprietario non era tanto ricco da doverlo alleggerire. Alexandre ammirò invece con il massimo rispetto la sua collezione di sigilli, che lasciò intatta.
Dalla signora du Postel, a Evreux, in place du Parvis-Notre-Dame, il 21 febbraio, dopo aver rubato molti oggetti preziosi e vari ricordi di famiglia, Bour diede fuoco ad una camera. L’incendio si spense da sé. Ma al processo di Amiens, Alexandre terrà a rivendicare quest’altro “delitto”.
– Un incidente di percorso. Io disapprovo l’incendio. Ma se ho incendiato la proprietà della signora du Postel, vuol dire che ne aveva una. E poi... forse i giurati maledicono la memoria di quelli che incendiarono il Palatinato? Ogni giorno vi sono eserciti che incendiano, non una casa, ma intere città. Si plaude a queste imprese. E si biasima me perché sono anarchico, perché non sono servo dei giurati, mentre costoro strisciano dinanzi a chi ha dei galloni! Io sarei senza pietà per voi. Voi potete esserlo per me. La violenza è di ogni tempo. Non scomparirà che quando comincerà il regno della giustizia!
Alexandre non aveva dubbi sull’utilità della sua azione. Lo spaventavano invece le discussioni che s’inasprivano negli ambienti anarchici parigini. Faure teneva il broncio. Jean Grave si riteneva al di sopra della mischia e non partecipava ad alcuna lotta. Libertad e Paraf-Javal eruttavano ognuno per proprio conto l’universo intero. Malgrado gli incessanti apporti di capitali che egli faceva ad ognuno e al “Libertaire” in particolare, le tirature dei giornali non aumentavano. Sarebbe stata necessaria una quantità di denaro mille volte maggiore. Cento volte più recuperatori di professione, a condizione naturalmente che tutti considerassero il furto come un impegno militante. La propaganda rimaneva inefficace. I litigi tra i gruppi, le rivalità di campanile, i bizantinismi teorici assorbivano i due terzi delle energie, senza che nessuno apparentemente si occupasse del risultato. C’era da diventare matti. Tanto valeva non pensarci. Nel frattempo, gli “altri”, i sindacalisti, guadagnavano terreno: il congresso di Montpellier aveva appena sancito l’unificazione tra le Borse del Lavoro e la CGT, alla cui testa Victor Griffuelhes era succeduto a Pelloutier. Naturalmente, erano anarchici anche loro. Ma il genio individuale dov’era, nelle attività di massa che essi auspicavano?
Alexandre ritornava da ogni riunione, da ogni assemblea, da ogni conferenza, sempre più scoraggiato. Non era il solo. Anche Malato si angustiava. E Matha. E Louise. E molti altri. Ma ognuno, nonostante i propri sforzi, non poteva impedire il crescere delle divisioni. Lo si sarebbe detto un microcosmo affetto da pazzia, tagliato fuori dalla realtà, dove tutto andava a rotoli, dove i peggiori abusi, le più insondabili incoerenze si mescolavano alle più folli generosità. Tutto si frammentava al punto che si sarebbe ben presto arrivati a non avere più una tendenza anarchica ma tanti anarchismi incompatibili gli uni con gli altri quanti erano i militanti.
La sua unica soddisfazione la trovava ormai nella gioia del lavoro ben eseguito. Con il grimaldello, la leva, il piede di porco o il trapano in mano, sotto lo sguardo attento di Bour e di Ferré, solo allora si sentiva rivivere. Le giustificazioni svanivano ad una ad una. Non voleva perderci tempo. A testa bassa, continuava a caricare come un toro, pensando forse che a forza di perseverare si sarebbe risolto tutto. Predicando con l’esempio, pagando in prima persona, perché è nelle circostanze più difficili, quando tutto vacilla attorno a sé, che si deve dimostrare quanto si vale.
E poi, forse s’era anche lasciato prendere nell’ingranaggio. Forse lo svaligiare era diventato per lui una seconda natura, un fine a sé, di cui egli non analizzava più a sufficienza i motivi. Forse, se anche gli si fosse dimostrata l’assurdità della sua attività, in quel momento si sarebbe rivelato incapace di fermarsi.
Ma nessuno attorno a lui, in verità, si sognava di contestare la legittimità della sua attività di recupero.
* * *
Lettera personale ai giurati del processo Jacob.
Borghesi,
Voi siete chiamati a giudicare parecchi compagni nostri. Secondo quali diritti e quale logica vi ergete a giudici di azioni di cui ignorate completamente il significato e la grandezza?
Voi non siete in grado di dirlo! Stoltamente vi siete costituiti giudici.
Orbene, sappiate che la legge e quelli che la fanno sono banditi dalla nostra logica.
Nella circostanza, voi siete la migliore di queste leggi. Ecco perché abbiamo verso di voi un po’ di clemenza. Perché se ventisei dei nostri sono nelle vostre mani, noi siamo numerosissimi fuori.
Dall’atteggiamento risoluto dei nostri compagni, avete potuto constatare che in nessun momento la paura si è insinuata tra le loro file. E così è per noi. Con, in più, possibilità d’azione, perché noi siamo liberi.
Avremmo potuto, anche nel corso del dibattito, compiere qualcosa di clamoroso, giacché la morte non ci spaventa. Forse saremmo finiti nel novero delle vittime. Ma tutti voi ci avreste lasciato la vita.
Il nostro Comitato ha preferito aspettare il vostro verdetto; ma sappiate bene, borghesi-giudici che non è né un indietreggiamento né un cedimento dinanzi all’azione da compiere.
Non è che una attesa.
Quindi, borghesi, meditate su questa decisione del nostro Comitato:
Se il vostro verdetto colpirà crudelmente i nostri compagni, è la vostra condanna a morte, perché la vostra decisione avrà provocato la nostra.
Non credere ad una vana minaccia. Scegli tra:
La vita tranquilla o la Morte.
Parigi, 11 marzo 1905
Comitato terrorista internazionale
* * *
A Reims, nella notte tra il 24 e il 25 febbraio, il terzetto sventrò, in casa del signor Roger in rue Werlé, un forziere da cinquecentocinquanta chili, da cui portò via gioielli e argenteria per settemila franchi.
Per entrare dalla vedova Lhuillier, a Vernon, nella notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo, Pélissard, appena rilasciato dai suoi consueti sei mesi per infrazione al divieto di soggiorno, si aggiunse a loro. Quella sera, prima di entrare in azione, cenarono tranquillamente all’Hotel de Paris, serviti dal cameriere Lemieux.
L’indomani, ad Angoulême, in rue Bouillond 3, s’impadronirono della raccolta di oggetti esotici in casa della signora Ripoteau: tappeti di pelle di scimmia, pelli di pantera, una pantera imbalsamata, coltelli da caccia, sciabole, oltre alla solita argenteria e gioielli.
* * *
– Le pelli trafugate alla signora Ripoteau erano state acquistate nelle colonie. Sappiamo bene come gli ufficiali fanno i loro acquisti nelle colonie! La guerra in Cina ne è un esempio!
* * *
Ferré decise allora di prendersi un po’ di riposo. Alexandre, Pélissard e Bour andarono quindi, senza di lui, la notte tra il 27 e il 28 marzo, a Tours, dove avevano deciso di attaccare la cattedrale. Fu una delle imprese più audaci che avessero mai compiuto.
Tutto ebbe inizio con un errore di Bour, spedito in ricognizione, che aveva descritto male il luogo: la porta della sacrestia non era costituita da una tavola di quercia, come aveva riferito, ma da un unico pezzo scolpito di almeno 15 centimetri di spessore su cui le leve più solide si ruppero. Ma Alexandre non si diede per vinto.
Scoprì in un cantiere una scala da muratore, l’appoggiò alla facciata, si arrampicò fino al rosone, tagliò con lo scalpello la griglia che lo proteggeva, quindi dissigillò i piombi della vetrata. In seguito, fissò alla pietra la sua lunga scala di seta e si lasciò scivolare fino al suolo. Qui l’aspettava una seconda delusione: la porta di comunicazione tra la navata e il presbiterio era insormontabile come quella esterna. Per scrupolo di coscienza esaminò le cassette delle elemosine: nemmeno sufficienti per una messa.
Allora scorse i superbi e pesanti arazzi degli Aubusson del XVII secolo che pendevano dalle pareti: la Natività, i Re Magi, Gesù tra i dottori, la Presentazione al Tempio, la Fuga in Egitto. Pezzi inestimabili per un collezionista.
Gli ci volle tutta la sua abilità di marinaio per staccarli e costituire, nel silenzio impressionante della volta, in piena notte, un sistema di pulegge e di cavi in grado di issarli fino al rosone. Ma ci riuscì. Quindi, essendo troppo voluminosi da trasportare a forza di braccia, mandò Pélissard a prendere un carretto intravisto nel provvidenziale cantiere. Vennero così trasportati fino alla stazione, poi, con estrema semplicità, spediti in treno fino a Parigi.
Numerosi giornalisti, in occasione del processo, hanno ripetuto, sulla base delle parole male interpretate del prefetto di polizia Hamard, che gli arazzi sarebbero stati ritrovati tagliati a pezzi in casa di Alexandre, in rue Leibniz, un pezzo come tappezzeria per una porta, un altro come rivestimento di una poltrona. La verità è più buffa. Due degli arazzi furono venduti ad un collezionista inglese (un maniaco) che propose poi ad Alexandre di portare via per lui dal museo di Bayeux un arazzo attribuito a Berthe au Gran Pied e che raffigurava l’arrivo di Guglielmo il Conquistatore in Gran Bretagna. (Operazione che la dimensione e il peso dell’oggetto resero del resto impossibile).
Quanto agli altri tre, furono con molta abilità ritoccati e colorati a cura di Deschamps, tappezziere di Champigny amico di Charles il fabbro, per poter essere ricettati. I soggetti delle scene erano completamente cambiati: la “Adorazione dei Re Magi” in particolare era diventata “Vercingetorige ad Alesia”...
Alexandre fece poi una spedizione dello stesso genere nella cattedrale di Le Mans. Impresa ancora più pericolosa perché non disponeva di una scala. La cattedrale era in riparazione, ma egli non poté aiutarsi con le impalcature che per i primi metri. Poi, dovette aggrapparsi alle pietre, intrufolarsi tra le statue ed appendersi ai doccioni sul vuoto. Che il guadagno non fosse pari alla prodezza, gli importò poco: in simili occasioni solo l’amore dell’arte lo guidava, lo stesso amore che l’aveva già spinto un bel giorno sulle torri di Notre-Dame a Parigi, quelle sì ben custodite con un sistema d’allarme che lo fece scappare a gambe levate.
Quel gusto della sfida, dell’impresa, lo spinse anche a praticare un gioco pericoloso in compagnia di Lombardi-Vambelle, che era stato acrobata. L’esercizio consisteva nel passeggiare insieme, tranquillamente, la sera, nei quartieri alti. Quando scorgevano una finestra aperta al primo o secondo piano, vi lanciavano dentro una monetina. Se non s’affacciava nessuno, Lombardi s’arrampicava lesto sulle spalle di Alexandre. Da là, si tirava su a forza di braccia, entrava nell’appartamento e in pochi minuti arraffava a caso quel che trovava. Il banchiere americano Pierpont Morgan, in particolare, dovette a quella specie di pesca con la lenza la scomparsa di un sontuoso collier di brillanti sul quale era scritto con le pietre preziose il nome della donna che amava.
L’audacia di Alexandre parve duplicata, come se, presentendo la vicina fine, avesse deciso di chiudere in bellezza. Durante i tre anni di lotta contro la società, aveva riportato folgoranti successi personali. Ma la fanteria (i propagandisti) non avevano seguito le truppe d’assalto che lui aveva costituito. S’era dedicato corpo ed anima alla Causa. Il mondo non era però cambiato. Pochi compagni erano andati fino al limite del sacrificio. Non aveva dunque più nulla da perdere. Ma una cosa da conservare: l’onore, la dignità.
Ferré reclutò in quel periodo due nuovi amici: Emile Augain, nato il 22 febbraio 1863 a Houdan, un fabbro estremamente abile nell’aprire porte e casseforti e che viveva a Suresnes con le sue due sorelle, accanite anarchiche quanto lui; e Westermann, un alsaziano, nato il 20 luglio 1866 a Rischwiller, imbianchino, sposato, felice padre di due bimbe rosee e fresche, falsario per dovere, anarchico per convinzione, che stava a Puteaux, in rue Saulnier 11. Ferré li aveva conosciuti in una riunione pubblica. Non ebbe del resto a lamentarsi di loro: nella notte tra il 6 e il 7 aprile Augain gli aprì senza danni il forziere della vedova Garmuchot, in rue d’Albuféra, a Vernon, da cui asportarono qualche chilo di argenteria e titoli.
Dopo tutto, non da lì venne il dramma, ma proprio da Jacob. Egli, malgrado un attacco di febbre e di tosse che l’aveva inchiodato a letto per otto giorni quasi in coma volle, unicamente per coerenza professionale, partecipare ad un’altra spedizione di cui aveva stabilito il piano. Era un’insidia del destino. Malattia o spossatezza morale: accumulerà gli errori.
Il 21 aprile, con il treno serale, in compagnia di Pélissard, raggiunse ad Abbeville Bour che era stato incaricato di apporre i “sigilli”. La loro passeggiata serale li portò direttamente fino dalla signora Tibboloy in place Saint-Pierre 5. Quella tragica notte, “l’arresto di Arséne Lupin”, la clamorosa caduta di Fantômas, così strana che la si direbbe quasi volontaria, fu raccontato dallo stesso Alexandre in un articolo pubblicato da “Germinal” nell’aprile del 1907 con il titolo “Ricordi di un ribelle”.
«Guidato dall’esperienza – scrisse – con un solo colpo d’occhio giudicai la porta invalicabile. Simile a quei vecchi portali di chiesa muniti di poderose guarnizioni di ferro, ornati di grossi chiodi dalla testa tagliata a diamante, la porta non offriva e non poteva offrire alcuna presa. Lo feci osservare ai miei compagni; ma Pélissard non fu di quell’avviso. Provò a spingere. I suoi sforzi furono inutili.
« – Faremmo meglio ad attaccare lo sfiatatoio della cantina – dissi.
«L’idea venne accolta e, dopo qualche sforzo, la grata cedette. La portai immediatamente sotto un androne a qualche metro dalle Nuove Gallerie di Abbeville, di fronte all’alloggio e agli uffici dell’esattore, in modo da celarla agli sguardi dei passanti. In quella mia breve assenza, Bour aveva provato ad introdursi in cantina ma, impedito da una sbarra di ferro posta orizzontalmente nel telaio dello sfiatatoio, non c’era riuscito. Dinanzi a quell’ostacolo, non insistetti. Cercai un’altra via di entrata. Andai in mezzo alla strada per meglio esaminare l’edificio».
Un terzo percorso gli apparve allora possibile: passare per le finestre del primo piano le cui imposte «erano completamente fuori del telaio, di modo che sarebbe bastato fare pressione dal basso in alto per sfilarle dai loro cardini». Per salire fin lassù, avrebbe usato la scala di seta.
Prima inquietante imprudenza: una volta tolte le persiane, invece di utilizzare il suo diamante da vetraio per tagliare un vetro, trattenendo le schegge con una ventosa, come aveva sempre fatto, diede un gran colpo con il pugno. Era l’una del mattino. Il rumore del vetro in pezzi echeggiò nel silenzio quasi assoluto.
Qualche attimo più tardi, Bour fischiettò il motivo del “Père Duchesne”: un uomo stava uscendo di corsa dall’edificio di fronte, per dirigersi verso la rue Saint-Wulfran. Era il signor Leleu, gestore di un caffè in rue Alfred-François 2. Aveva un violento mal di denti. Nel momento del rumore, stava misurando disperatamente la sua stanza battendo i piedi. Aveva sentito. Aveva dato un’occhiata alla piazza. Li aveva visti.
« – Maledizione! È la strada per il commissariato di polizia – dissi loro. – Forse è un cittadino zelante. In ogni caso, gli vado dietro. Rimanete lì, ritorno subito.
«La mia missione si concluse presto. Aprendo le imposte per saltare sul marciapiedi, scorsi una testa di donna, entro il riquadro di una delle finestre della casa di fronte. I miei compagni avevano visto la scena contemporaneamente a me: in un batter d’occhio ci trovammo tutti e tre per la strada.
« – Prendeteli – gridò quella – sono almeno tre!
«Poi, precipitosamente, sprangò la finestra. Il pericolo era davvero grande. Non si trattava di un’allucinazione come ne hanno spesso quelli che fanno il palo».
Seconda imprudenza di Alexandre: invece di lasciare che il gruppo si disperdesse, egli decise di andare tranquillamente ad aspettare un treno da qualche parte alla periferia di Abbeville:
“« – Andiamocene! – dissi a Pélissard. – Quei tizi della polizia non sono così zelanti come credi. Quando avranno constatato l’effrazione, ritorneranno a casa loro, impazienti di rimettersi a dormire. Poi, domattina, continueranno la loro inchiesta... Del resto, non è la prima volta che mi capita una cosa simile... ».
Ma una terza persona s’era svegliata ad Abbeville: una giovane domestica. Li vide uscire dalla città per la porta Saint-Gilles e dirigersi verso Pont-Rémy a due chilometri da lì. Ispettori, agenti e gendarmi, stanchi di perlustrare inutilmente la città e i sobborghi, stavano effettivamente per rinunciare alla caccia quando due di loro, il brigadiere Auquier e l’agente Léonard Pruvost li avvistarono. Si precipitarono immediatamente verso Pont-Rémy.
I tre ladri arrivarono in paese alle due del mattino. Il treno di Boulogne-sur-Mer, da dove volevano proseguire il loro giro, non sarebbe passato che alle cinque e mezza. Pioveva. La stazione era chiusa. Trovarono un guarda-semafori che, prendendoli per impiegati, offrì loro l’ospitalità della sua capanna. Terza imprudenza: invece di fare la parte che quel brav’uomo aveva loro attribuito, Alexandre gli fece delle domande sulla sua vita. Quel tizio non era un ribelle. Alexandre s’innervosì, come faceva ogni volta che si trovava alla presenza di un delatore. Volle spiegargli come gli sfruttati, accettando passivamente la loro sorte, si rendessero complici degli sfruttatori. Come fosse l’inerzia della massa a paralizzare l’azione dei liberatori. Battuti, umiliati, contenti di esserlo o piuttosto troppo vili per ribellarsi, aspettando che la libertà cadesse loro dal cielo, quelli come lui rendevano impossibile qualsiasi rivoluzione. Quel tizio gli ricordava troppo l’atteggiamento dei bighelloni di Cherbourg, dopo il suo svaligiamento dall’ammiraglio de Pontaumont.
« – Scusatemi – mi disse – bisogna che faccia i segnali per il rapido delle tre e quattordici.
«Uscì.
«Qualche minuto dopo, il rapido passò come un lampo. Vedendo tutti quei vagoni stracarichi di ricchi viaggiatori (che forse erano degli azionisti della Compagnia) correre sul nastro d’acciaio ad una velocità vertiginosa e che un granellino di sabbia, per così dire, poteva ridurre in briciole, pensai al guarda-semafori, le cui parole mi risuonavano ancora nelle orecchie: “Andrò in pensione... io sono onesto, io lavoro!”.
«Fu allora che capii tutta la potenza morale di quel pregiudizio. Credersi onesti perché si è schiavi! Fu allora che capii anche la forza di quel freno contro la rivolta! La speranza di una pensione. Andiamo, borghesi! Avete ancora magnifici giorni da regnare sul popolo! Non avrete da temere nulla finché le vostre vittime ignare saranno avvelenate dalla speranza di una pensione e dall’imbecillità di credersi onesti perché crepano di fame».
La rivolta contro l’ingiustizia cedeva il passo, in lui, alla rivolta contro quelli che non si rivoltavano: il cerchio si chiudeva. Solitudine. Impotenza. Angoscia. Derisione degli sforzi.
Verso le cinque e un quarto la stazione venne aperta. Il terzetto vi entrò.
«Nel momento in cui mi avvicinai allo sportello, due uomini entrarono precipitosamente. Improvvisamente, senza alcuna spiegazione, il brigadiere Auquier (era accompagnato dall’agente Pruvost), con voce stentorea, gridò:
« – Eccoli, i ladri di place Saint-Pierre! Eccoli! I ladri del signor de la Rivière! (Oltre al signor de la Rivière il 17 settembre 1902 – Jacob, Ferré, Ferrand – Jacob e Ferré avevano, come s’è visto, svaligiato ad Abbeville anche la chiesa di Saint- Jacques, i1 23 dicembre 1903).
«Quelle tre esclamazioni furono pronunciate difilato, senza interruzione. Credo persino di poter aggiungere senza respirare, poiché il suo volto divenne rosso come il pavimento di un mattatoio. Proprio così! Quel poveretto mancava di tatto e di prudenza! Credeva proprio di inchiodarci sul posto con delle frasi? Figurarsi!
«Le parole diventavano inutili. Bisognava passare all’azione. Feci due passi indietro e, con il revolver in una mano, il pugnale nell’altra, gridai:
« – Lasciateci passare, per Dio, o sparo!
« – Ah! Delle armi! – Gridarono con terrore Pruvost e Auquier.
« – Sì, delle armi!... E adesso?...
«A quelle parole, cominciò la lotta. Durò poco, ma fu accanita. Brutalmente, Pruvost si gettò su Pélissard, agguantandolo da dietro, per la vita. Così stretto, Pélissard si trovava in posizione difficilissima; e sebbene fosse dotato di grandissima forza muscolare, non se la sarebbe mai cavata se Bour non fosse andato in suo soccorso. Quest’ultimo, vedendo il pericolo che correva il suo compagno, non esitò a far fuoco sull’agente che, preso in pieno cuore, lasciò Pélissard e stramazzò a terra, sulle ginocchia, mormorando: “Sono morto!”.
«Appena libero, Pélissard mostrò la superiorità dei suoi garretti prendendo la fuga, senza preoccuparsi più dei suoi compagni.
«Auquier, invece, era avanzato verso di me, cercando di agguantarmi il braccio per disarmarmi; ma io mi sganciai subito colpendolo all’anca sinistra con il mio pugnale. In quel momento, Nacavant (Nacavant il guarda-semaforo, lo stesso che qualche minuto prima ci aveva stretto la mano, volendosi dimostrare quello che in gergo civico si chiama un cittadino zelante) giunse a dare manforte agli agenti. Entrato in scena dalla porta che dà accesso alla strada, mi prese brutalmente da dietro e mi mandò a rotolare in fondo al locale. La sorpresa dell’attacco e la violenza con cui fui spinto, mi fecero andare disteso sul pavimento quanto ero lungo. Naturalmente, cercai di rialzarmi immediatamente; ma Auquier e Nacavant me l’impedirono. Si precipitarono furiosamente su di me... La mia posizione era delle più critiche. A un certo punto, la canna della mia pistola si trovò puntata al mio petto, proprio sul cuore. Ed è veramente un miracolo che non sia partito il colpo sotto la pressione dei movimenti che le contrazioni nervose facevano subire alle mie dita. Per alcuni secondi, rimasi così tra la vita e la morte. Fortunatamente per me, Bour venne a trarmi d’impaccio. Dopo aver liberato Pélissard, avanzò dal fondo della stanza spianando l’arma contro Nacavant.
« – Pietà, pietà! – si mise a gridare il cittadino zelante con terrore. Poi, lasciandomi subito, si rifugiò nel gabinetto del capostazione. Un altro impiegato della stazione, Ruffier, lo imitò nella sua ritirata. Bour, non scorgendo più Pélissard, che aveva appena liberato, prese a sua volta la fuga.
«Io rimasi solo alle prese con Auquier. Nel momento stesso in cui Nacavant mi lasciò, un colpo partì dal mio revolver; non colpì nessuno. Al rumore della detonazione, o per assicurarsi di non essere stato colpito o per altro motivo, anche Auquier mi lasciò. Ma prima che avessi il tempo di rialzarmi completamente, quello mi afferrò di nuovo. Rapidamente, gli feci lo sgambetto che lo fece cadere a terra. Ma mi stringeva tanto che mi trascinò nella caduta. Non rimanemmo a lungo per terra. Tutti e due ci rialzammo subito».
Seconda ripresa: mossa a chiave alle braccia di Jacob da parte di Auquier. Jacob viene respinto verso la sala d’attesa. Pruvost, l’agente morente, resuscita per agganciarsi alle sue gambe. Jacob cade. Auquier cade su di lui. Ignorando lo stato di Pruvost, Jacob lo colpisce con il suo pugnale. Spara su Auquier; viene colpito Pruvost. Auquier lascia la presa, quindi lo riafferra ai polsi da dietro. Jacob indietreggia e lo rovescia con tutte le proprie forze contro la parete di mattoni. Auquier molla la presa.
Terza ripresa: Auquier ritorna alla carica. Jacob prende la mira. Auquier nasconde la testa tra le braccia. Jacob lo raggiunge al petto. La palla viene deviata da una custodia. Fine del primo incontro. Jacob fugge. «Non vidi né Bour né Pélissard. Non essendo quello il momento di sognare né di riflettere, mi affrettai a lasciare il teatro della lotta».
Ma dei testimoni si occupano già a trasportare i feriti all’ospedale. Altri avvertono Stemler, il procuratore della Repubblica, che arriva in compagnia di Atté, giudice istruttore, e di parecchi gendarmi. Saltano su un’automobile. Viene loro segnalata la presenza dei banditi in un boschetto. Viene organizzata una battuta. Un fuggitivo viene subito catturato nella palude di Airaisnes: si tratta di Pélissard.
Alexandre, invece, riesce a fare qualche chilometro. Dall’alto di una collinetta, osserva i dintorni con il cannocchiale: «Non era uno di quei vecchi catorci che si trovano sulle bancarelle di qualsiasi mercato, ma un cannocchiale dei più potenti: vi prego di credere che non era roba scadente». Infatti, era appartenuto un tempo all’ammiraglio Aubry de la Noë. Jacob vide tutto il paese in movimento. La popolazione preparava la battuta.
«A grandi mali grandi rimedi. Allo stesso modo di quel greco che tagliò la coda del suo cane per stornare l’attenzione dei suoi denigratori, decisi di incendiare il bosco che mi dava asilo... Tagliai tutti i rami che potei dall’albero sul quale m’ero rifugiato. Quindi discesi e feci numerose fascine che incendiai attorno al fusto di alcuni alberi. E poi, poi dovetti restare là, perché se l’idea non era malvagia, posso dire che divenne irrealizzabile. Nella fretta, non avevo pensato che non mi trovavo alle Bouches-du-Rhône dove la cosa m’era riuscita già una volta durante un’incursione nella proprietà del marchese de Forbin. Non ero in Provenza, ma nel paese della pioggia, della nebbia. Finii tutti i fiammiferi. E poi, non soltanto gli alberi erano bagnati, ma eravamo anche in aprile, alla fine di aprile, allorché la linfa percorre tutte le fibre del legno. Una vera scalogna. Senza più fiammiferi, dovetti rinunciare al sistema di Alcibiade.
«Nella fretta, dimenticai il cannocchiale: Un così bel cannocchiale! Ci si rattrista anche per meno, vero? Ma via! mi dissi dopo un momento, troverò pure un ammiraglio che me ne offra un altro».
Un vecchio, presso il quale si fa passare per un contrabbandiere padre di due bambini, gli indica il cammino da seguire. Si accorge allora di aver perso la bombetta nella lotta e incrocia un giovanotto: «Poiché con due figli ho avuto ragione del Padreterno, mi dissi, sarebbe proprio diabolico non riuscissi con questo innocente. E prima di lasciargli il tempo di riflettere, lo pregai di cedermi il cappello».
Provvisto del suo copricapo, vide due gendarmi a cavallo avvicinarsi. Quarta o quinta imprudenza. Non gli sarà ancora fatale. «Ero stanco, stanchissimo e la prospettiva di montare a cavallo non mi dispiaceva. Cercavo già un bersaglio per farli ruzzolare giù dai loro ronzini. Quello di sinistra, in particolare, mi faceva gola con il suo mantello color cioccolato, mi ci sentivo già sopra, divorando i chilometri, sfuggendo ai miei nemici. A venti metri da loro, caricai il revolver, tenendolo in tasca pronto a fare fuoco in quella posizione, poi con l’altra mano li salutai militarmente».
I gendarmi, che vengono da Véry-Aumont e non da Pont-Rémy, gli restituiscono il saluto. Non sono al corrente di nulla.
A Dreuil, Jacob entra in una locanda. Si fa passare per un antiquario in cerca di mobili. I contadini si avvicinano per vendergli la pendola della nonna e il forziere di zio Charles. Ma la voce dello scontro è arrivata fin là. Alexandre riparte quindi in direzione di Airaisnes.
«Airaisnes... Per me questa parola è tutta una catastrofe. È la mia Waterloo. I miei cento giorni non sono durati che cinque ore. Come tutto degenera!».
Effettivamente, poche centinaia di metri dopo quel villaggio, una vettura si ferma bruscamente al suo fianco: quella del procuratore della Repubblica. Perché non l’ha sentita avvicinarsi? Perché non s’è nascosto? La febbre ha indubbiamente svolto un ruolo fondamentale in quell’occasione. Ma non spiega tutto. «Ero in una di quelle fasi di prostrazione in cui si guarda senza vedere, in cui si tocca senza sentire, in cui si è vivi senza vivere», precisa senza fare altri commenti. Lo interrogano, lui farfuglia. Gli chiedono i documenti: lui, sempre così organizzato, non ne ha. Dopo centocinquanta furti confessati, di cui alcuni sono stati capolavori nel loro genere; dopo aver messo in piedi un’organizzazione sbalorditiva, si comporta tutt’a un tratto come un novellino. Atteggiamento inverosimile, inesplicabile, se non si pensa che da qualche ora, da qualche giorno o qualche settimana, egli ha adottato inconsciamente l’atteggiamento del vinto. A meno che, naturalmente, non abbia finito per credersi invulnerabile.
Lo spingono dentro la vettura. Ci sale senza protestare. Poi ha un ultimo soprassalto.
«Guardavo il paesaggio che s’offriva al mio sguardo e che si susseguiva come le inquadrature di un film: gli alberi, i prati, i campi, i covoni di fieno, i cumuli di pietre scaglionati qua e là sulla strada, il contadino e i suoi due cavalli attaccati ad un aratro, a lavorare la terra; bevevo tutto con gli occhi, dicendomi: “È dunque finita? Non vedrai più niente di tutto ciò?” Pensavo a quelli che mi lasciavo dietro, ai miei affetti, ai miei parenti, ai miei amici, alla mia compagna, a mia madre che avevo lasciato malata, inchiodata al letto per le conseguenze di una operazione chirurgica. A quel pensiero, una vampata di rivolta mi salì al cervello ribollendomi di collera.
«E che? Assisterò pacificamente al mio funerale? mi dissi recuperando un po’ di energia sotto l’impulso dei miei ricordi. Perché difenderti? Perché uccidere? Imbecille!... Ma se non ti difendi, se non li uccidi, saranno loro ad uccidere te. E che? La pecora bela, il bue muggisce, il maiale grugnisce, tutti levano il loro grido di rivolta quando vanno al macello, si dibattono, si dimenano, si difendono per sfuggire ai loro boia e tu, uomo, tu te ne vai a testa bassa al patibolo?».
Non l’hanno neppure perquisito. La sua browning è sempre nella tasca. Vi affonda lentamente la mano, nasconde la pistola nella manica, rialza il braccio... Un sobbalzo. L’arma scivola sul predellino. Cade sul selciato senza che i suoi custodi nemmeno se ne avvedano.
A Pont-Rémy ritrova Pélissard. Li mettono su un treno per Abbeville. Là li attendono le forche caudine destinate agli sconfitti. Bisognerà passarci. Il buon popolino li accoglie con grida. Poveri schiavi. «C’erano ventiquattro poliziotti a cavallo che formavano quadrato. Il capitano della gendarmeria, spada sguainata, marciava alla testa. Prendemmo posto in mezzo al quadrato per essere protetti! Ah! ragazzi miei! Che baccano! In tutti i toni e con ogni timbro, dalla voce stridula e acuta dei bambini fino alla nota rauca e profonda degli uomini, passando per il suono flautato delle voci femminili, gli “A morte! Al fiume! Alla ghigliottina!” non smisero un attimo dalla stazione fino alla prigione. Tutta quella folla seguiva il corteo cercando di superare la barriera formata dai cavalli, avvicinandosi, allontanandosi a ondate come un mare oleoso, urtandosi, spingendosi, cadendo a terra, calpestandosi perfino e rialzandosi per gridare più forte».
Nel momento di entrare nella prigione di Abbeville, la moglie del capo guardiano si gettò su di lui e lo morse al polso. Senza quella scorta di cavalleria, sarebbe stato linciato. No, il popolo non era bene informato.
* * *
Signori,
Ora sapete chi sono: un ribelle che vive del frutto dei suoi furti. Inoltre, ho incendiato diversi palazzi e ho difeso la mia libertà contro l’aggressione di agenti del potere. Ho messo a nudo tutta la mia esistenza di lotta; la sottopongo alla vostra intelligenza come un problema. Non riconosco a nessuno il diritto di giudicarmi, non imploro né perdono né indulgenza. Non prego quelli che odio e che disprezzo. Voi siete i più forti; disponete di me come volete. Mandatemi al bagno penale o al patibolo, poco importa. Ma prima di separarci, lasciate che vi dica un’ultima parola (...).
Voi chiamate un uomo ladro e bandito, applicate contro di lui i rigori della legge senza chiedervi se egli poteva essere altro. S’è mai veduto un possidente farsi svaligiatore? Confesso di non conoscerne. Ma io, che non sono possidente né benestante, che non sono altro che un uomo che possiede le sue braccia e il suo cervello per assicurarsi di che vivere, io ho dovuto tenere un’altra condotta. La società non mi accordava che tre vie di esistenza: il lavoro, la mendicità, il furto. Il lavoro, ben lungi dal ripugnarmi, mi piaceva. L’uomo non può nemmeno fare a meno di lavorare; i suoi muscoli, il suo cervello, hanno una somma di energie da dispensare. Quel che mi ha fatto ripugnare è sudare sangue, e linfa per l’elemosina di un salario, è creare delle ricchezze di cui sarei stato depredato. Insomma, m’ha fatto ripugnanza darmi alla prostituzione del lavoro. La mendicità è l’avvilimento, la negazione di ogni dignità. Ogni uomo ha diritto al banchetto della vita.
Il diritto di vivere non si mendica, lo si prende.
Il furto è la restituzione, la ripresa di possesso. Piuttosto che essere rinchiuso in un’officina come in un penitenziario, piuttosto che mendicare ciò a cui avevo diritto, ho preferito rivoltarmi e combattere palmo a palmo i miei nemici facendo guerra ai ricchi, attaccando i loro beni. (Jacob qui passa discretamente sotto silenzio il ruolo della polizia, nella persona del commissario Fabre, nella scelta del proprio destino). Certo, capisco che avreste preferito soggiacessi alle vostre leggi, che come operaio docile e infrollito creassi ricchezza in cambio di un salario irrisorio e che, con il corpo consumato e il cervello inebetito, me ne andassi a crepare all’angolo di una strada. In quel caso non mi chiamereste “bandito cinico”, ma “onesto operaio”. Con blandizie mi avreste perfino premiato con la medaglia del lavoro. I preti promettono un paradiso a quelli che riescono ad abbindolare; voi siete meno astratti, voi promettete loro della carta straccia.
Vi ringrazio molto per tanta bontà, per tanta gratitudine, Signori! Preferisco essere un cinico cosciente dei suoi diritti che un automa, una cariatide!
Da quando sono entrato in possesso della mia coscienza, mi sono dedicato al furto senza alcuno scrupolo. Non ho niente a che fare con la vostra pseudo-morale che esalta il rispetto della proprietà come una virtù, mentre non esistono ladri peggiori dei proprietari.
Ritenetevi fortunati, Signori, che questo pregiudizio abbia messo radici nel popolo, perché è lui il vostro gendarme migliore. Conoscendo l’impotenza della legge o, per meglio dire, della forza, ne avete fatto il più sicuro dei vostri protettori. Ma state attenti, tutto finisce. Tutto ciò che è costruito, edificato con la forza e l’astuzia, forza ed astuzia possono demolire.
Il popolo progredisce ogni giorno. Non vedete che, consci di queste verità, consapevoli dei loro diritti, tutti i morti di fame, tutti i pezzenti, insomma tutte le vostre vittime, s’armano di grimaldello, vibrano l’assalto alle vostre case per riprendere le ricchezze che essi hanno creato e che voi avete loro rubato? Credete che sarebbero più infelici? Io sono convinto del contrario. Se ci riflettessero meglio, preferirebbero correre qualunque rischio piuttosto che ingrassarvi gemendo nella miseria. La prigione... Il penitenziario... Il patibolo, si dirà! Ma cosa sono tali prospettive in confronto ad una vita bestiale, fatta di ogni sofferenza? Il minatore che strappa il suo pane alle viscere della terra, senza mai vedere la luce del sole, può morire da un momento all’altro, vittima di una esplosione di grisou: il conciatetti che vaga per i tetti può cadere e ridursi in briciole; il marinaio conosce il giorno in cui parte, ma ignora se ritornerà in porto. Un gran numero di altri lavoratori contrae malattie fatali nell’esercizio del proprio mestiere, si sfinisce, s’avvelena, si uccide per creare per voi; perfino i gendarmi, i poliziotti vostri servi che, per un osso da rosicchiare che tirate loro, trovano a volte la morte nella lotta che intraprendono contro i vostri nemici.
Cocciuti nel vostro egoismo meschino, rimanete scettici nei confronti di questa prospettiva, vero? Il popolo ha paura, sembrate dire. Noi lo governiamo con il terrore della repressione; se grida, lo getteremo in prigione; se brontola, lo deporteremo al bagno penale; se passa all’azione, lo ghigliottineremo! Calcolo errato, Signori, credetemi. Le pene che infliggete non sono un rimedio contro i gesti di rivolta. La repressione, anziché un rimedio o un palliativo, non è che un aggravamento del male.
Le misure coercitive non possono che seminare odio e vendetta. È un ciclo fatale. Del resto, da quando tagliate le teste, da quando gremite le prigioni e i bagni penali, avete forse impedito all’odio di manifestarsi? Parlate. Rispondete! I fatti dimostrano la vostra impotenza. Da parte mia, sapevo per certo che il mio comportamento non poteva aver altro sbocco che il bagno penale o il patibolo. Vedete bene che non è stato questo ad impedirmi di agire. Se mi sono dedicato al furto, non è una questione di guadagno, di lucro, ma una questione di principio, di diritto. Ho preferito conservare la mia libertà, la mia indipendenza, la mia dignità di uomo piuttosto che essere creatore della fortuna di un padrone. In termini più banali, senza eufemismi, ho preferito essere ladro che derubato.
Certo, anch’io disapprovo che un uomo s’appropri con la forza o con l’astuzia del frutto della fatica altrui. Ma è proprio per questo che ho fatto la guerra ai ricchi, ladri dei beni dei poveri. Anch’io vorrei vivere in una società da cui il furto fosse bandito. Io non approvo il furto e non l’ho utilizzato che come mezzo di rivolta in grado di combattere il più iniquo di tutti i furti: la proprietà privata.
Per distruggere una conseguenza, bisogna prima distruggere la causa. Se esiste il furto, è solo perché c’è abbondanza da una parte e penuria dall’altra, perché tutto appartiene solo ad alcuni. La lotta scomparirà solo quando gli uomini metteranno in comune le loro gioie e le loro pene, il loro lavoro e la loro ricchezza, solo quando tutto apparterrà a tutti.
Anarchico rivoluzionario, io ho fatto la mia rivoluzione, l’Anarchia verrà!
* * *
Il signor Atté, giudice istruttore di Abbeville, interrogò inutilmente Jacob e Pélissard, che una decina di testimoni affermavano di riconoscere. Alexandre negò tutto: il furto dal signor de la Rivière come quello di place Saint-Pierre. Lui era Escande, l’antiquario. Pélissard si chiamava Léon Edme. Originario della Boemia. Viaggiavano per affari.
Purtroppo, trovarono nelle tasche di Escande un anello appartenente al signor de la Rivière (si può essere più stupidi? Portarsi dietro i resti di un furto commesso proprio nella città in cui si va!) e un pezzetto di carta con queste parole semi-cancellate. “Escande” e, più in là, “Ornano”...
Il signor Atté inviò una commissione rogatoria al signor Lascoux, suo collega di Parigi, incaricandolo di scoprire la vera identità dei malfattori, i loro complici e, se possibile, il loro domicilio. Questo ordine finì al signor Hamard, il capo della Sûreté, che condusse con risolutezza l’inchiesta.
Tre giorni dopo, una domenica, Hamard scoprì il vecchio domicilio di “Escande” in boulevard Ornano 14. In poche ore, risalì fino a rue Leibniz. Nell’appartamento di “Escande” trovò parecchie pendole, bronzi, scialli di seta, argenteria... e due donne. Una “sulla cinquantina”, affermò di chiamarsi Elisa Berthou: era Marie. L’altra “di 26 anni” disse di chiamarsi Berthe Béziat: era Rose. Né l’una né l’altra avevano mai sentito parlare di Escande né di furti. Hamard, poco convinto, le spedì al carcere provvisorio di Parigi e tese una trappola.
Il 23, un martedì, un “giovanotto biondo” i cui connotati corrispondevano alla descrizione che ne avevano fatto i testimoni di Abbeville e che era appena sceso dal treno di Boulogne alla stazione Nord, cadde nella trappola: era Bour.
Spossato, esausto, sconvolto per la scomparsa di Alexandre, subissato di domande, confessò lo svaligiamento di place Saint-Pierre e quello di Tours. Poi ritrattò. Ma aveva già parlato troppo: aveva fatto il nome di Alice-Léontine.
Abilmente cucinata, costei, per dispetto, noncuranza o scempiaggine, raccontò quel poco che sapeva. Bour sogghignò. Pélissard alzò le spalle. Alexandre propinò, a chi l’interrogava, un discorso sulla giustificazione teorica del furto. Esaltò tanto e così bene l’anarchia ai suoi guardiani che glieli dovettero sostituire con altri venuti da Parigi. Quanto ai fatti precisi o ai nomi dei suoi complici, non ci fu verso di strappargli una parola.
Il capo della Sûreté proseguì comunque sulla pista fornita dalla giovane donna che lasciava sempre in disordine la cucina.
Innanzitutto si attaccò ai famosi coniugi Ferré, i portinai di rue Labrouste. Invano. Questi se n’erano andati senza lasciare indirizzo. (Avevano precipitosamente preso in affitto una camera ammobiliata in rue de Lagny 26).
Hamard si diede allora da fare con le schede antropometriche del signor Bertillon, metodologia di cui si contestava ancora l’efficacia, ma che era appena stata utilizzata una prima volta con successo il 16 ottobre 1902, a proposito dell’omicidio del domestico di un dentista.
A forza di consultare incartamenti, finì per scoprire l’esistenza di un certo Clarenson, detenuto alla Santé. Quel nome diceva qualcosa ad Alice. Confronto. Clarenson non la riconobbe. Non riconobbe nessuno. Non aveva partecipato al furto di rue Quincampoix. Non capiva che cosa volevano da lui: era innocente.
La sua amichetta Antoinette Bernard, vedova Amiglio, indicata da Alice, rimase introvabile: si era infatti rifugiata da Matha che l’aveva mandata “in campagna”.
Hamard fece poi visita a Baudy il Perdente, nella sua cella della prigione di Thouars: stessa cocciutaggine, stesso mutismo. Anche Julia Ruffa, sua ultima compagna, quella che era succeduta alla sorella di Rose, non sapeva assolutamente niente. Poi fu la volta di Vaillant. Idem. Quindi Ferrand. L’ex braccio destro di Alexandre si limitò a sogghignare. Non riuscirono a tirargli fuori una sillaba. Ma Hamard ritrovò la sua donna, Gabrielle Damiens, grazie ai suoi confidenti. Allora si fece finalmente luce: Gabrielle doveva vendicarsi del disprezzo di Alexandre e dei tradimenti di Ferrand.
Ella non ebbe alcuna difficoltà a raccontare nei minimi particolari quel che sapeva della banda. Aveva visto parecchie cose. E ricordava molto. Era una vera enciclopedia. La misero al fresco a Saint-Lazare. In caso di dubbio su qualche dettaglio, bastava andare a interrogarla. Lei rivelò immediatamente indirizzi, circostanze o luoghi degli appuntamenti che volevano. C’è da credere che nella delazione lei provasse un piacere supremo.
Il 14 ottobre veniva arrestato il gruppo di fonditori d’oro e d’argento: Brunus, Apport e Limonnier. Inutilmente Apport aveva tentato ventiquattr’ore prima di correggere i libri dei conti: le date nelle quali Brunus aveva venduto lingotti coincidevano con quelle dei furti di Jacob.
Il 30 di quel mese, fu la volta di Ferré ad Angers dopo una tumultuosa disputa con il commissario Izoird. Egli si trovava con Augain, una delle sue ultime reclute. Costui venne rilasciato in mancanza di prove il 21 novembre. Poi arrestato di nuovo. Westermann, la recluta numero due, l’imbianchino di Puteaux, aveva avuto il tempo di fuggire. Fu rintracciato qualche settimana dopo.
Alla fine di ottobre, Angèle Bononi, la donna di Ferré, fu catturata in avenue des Grésillons 195, a Gennevilliers, dove era stata assunta come donna tuttofare dai signori Sortais.
Poi toccò a Charles, il fabbro, il riparatore d’attrezzi, il 3 febbraio 1904. Ebbe l’ingenuità di confessare l’episodio delle perle trovate in un cantuccio del suo bancone, dopo rue Quincampoix.
Quindi fu la volta di Alcide Ader, l’amico di Ferré, il falegname che scappava durante i furti cui partecipava. Sautarel, il gioielliere scrittore, fu scovato a Vincennes. Bonnefoy, l’avventuriero, il marito della cantante di caffè-concerto venne preso al volo il 15 aprile 1904 allo scalo del piroscafo Cao-Bang a Gibuti. Aveva acquistato un biglietto per Saigon sotto il nome di Arsac. Voleva rifarsi una vita in Indocina. Ci avrebbero pensato loro a rifargli un’esistenza, in un’altra colonia, meno accogliente.
A parte tre importanti fuggitivi (Vambelle detto Lombardi, o viceversa, l’acrobata; Deschamps, il tappezziere di Champigny che aveva tanto abilmente ritinteggiato “l’Adorazione dei Re magi” della cattedrale di Tours; Henry, l’uomo che Alexandre odiava per aver troppo cloroformizzato una ereditiera, più altri due accoliti occasionali, Gaudin e Federmann), la polizia si convinse di aver messo al fresco tutta la banda. Alexandre fece di tutto per convincerla in questo senso.
Quando gli imputati si trovarono riuniti nella prigione di Abbeville per l’istruttoria, egli ricopiò per tutti l’alfabeto Morse su dei pezzetti di carta. Così essi poterono comunicare senza ostacoli battendo leggermente sulle tubature. Egli diede loro immediatamente delle consegne imperative che furono osservate alla lettera. La sua strategia era semplice: 1) Non dire niente degli amici che non erano stati catturati. 2) Tentare di salvare i meno compromessi negando sistematicamente la loro partecipazione, anche nei casi più evidenti. 3) Si sarebbe accollato lui ogni delitto, anche quelli che non aveva commesso, giacché era ormai troppo tardi per tacere su tutto. 4) Liquidare le due spione, imprigionate a Saint-Lazare.
Si occupò lui personalmente di quest’ultimo punto, come è dimostrato da un messaggio spedito ai compagni parigini che imponeva loro di “impedire con ogni mezzo che Gabrielle Damiens e Léontine Tissandier comparissero alle Assise”. Su questo non fu obbedito che a metà: infatti un bel mattino ritrovarono Gabrielle la spia misteriosamente avvelenata nella sua cella (la Procura preferì, per evitare polemiche, concludere per il suicidio). Ma Léontine-Alice ebbe maggiore fortuna: sopravvisse. D’altra parte, la sua testimonianza era meno importante.
Gli altri punti del piano vennero eseguiti con grande precisione. Alexandre cercò ad esempio disperatamente di fare credere che era lui l’assassino dell’agente Pruvost. Il signor Gastine-Renette, l’armaiolo, tentò di dimostrare il contrario grazie alle differenze di rigatura che aveva osservato tra la canna del revolver di Jacob e il proiettile fatale per Pruvost. Alexandre gli indirizzò i suoi sarcasmi. Bour, suo ultimo allievo, suo protetto, era innocente. Egli gli mancava. Fino al processo, lo difenderà.
«Non ho più nessuno che si occupi di me su questa terra, – gli scriveva il giovane dalla sua cella. – I miei genitori mi hanno maledetto. Ad una lettera che avevo loro spedito, mi hanno risposto con ingiurie e non cercano di mitigare la mia sorte inviandomi del denaro. Non mi resti dunque che tu e apprendo che sei malato. Perché non ti curi?».
«Sono malato, in verità – gli aveva risposto Jacob – ma penso, benché stia sputando sangue, di riuscire ad arrivare fino alle Assise. Se il mio male che è, lo so, inguaribile, mi facesse soffrire troppo, saprei, stai certo, mettervi termine. Siamo su questa terra non per soffrire ma per godere. (...) Una madre, vedi, è tutta l’umanità. Dammi l’indirizzo della tua e del tuo patrigno. Scriverò loro come la penso. (...) Non ti preoccupare troppo per il processo. Parlerai secondo la tua opinione. Il tuo avvocato si spiegherà secondo le sue idee. È una regola, che vuoi farci? Non fare chiasso, non provocare scandalo, parla poco, ma utilmente, energicamente, chiarisci le nostre teorie. Che importa quel che succederà! Ma sappi che non dobbiamo aspettarci nulla di buono dalla giustizia borghese». Si direbbe un colonnello che arringa le sue truppe prima di lanciarle all’assalto di una fortezza inespugnabile.
Il morale di Pélissard, invece, rimase ben alto per tutta la durata dell’istruttoria. Non si sognava nemmeno di lamentarsi per le leggi sul divieto di soggiorno: «Il governo è davvero pieno di attenzioni verso di me – scrisse ad Alexandre. – Mi organizzerà, e nei dettagli, un viaggio che desideravo fare da tempo. Potrò dunque andare in Guyana. Che festa, quando saremo tutti insieme! (...) Tu hai ragione. Il processo sarà molto divertente. Ci saranno giornali parigini, avvocati parigini. Ne approfitteremo per fare in pubblico le nostre dichiarazioni e per terrorizzare i magistrati con le nostre risposte. Faremo vacillare l’edificio sociale sulla sua base. (...). E poi forse la caduta di un ministero potrà darci una mano a scardinare la magistratura?».
Così, dal fondo di una cella in cui “sputava sangue”, mezzo morto fisicamente, Alexandre continuò a dirigere il suo gruppo di ribelli, come aveva fatto nei bei giorni di libertà, inventando cento modi per comunicare con l’esterno senza essere scoperto, rialzando il morale di quelli che vacillavano, braccando le delatrici, combinando le risposte agli interrogatori e ai confronti, sfidando apertamente la giustizia; vinti, certo, ma indomiti. Evadere? Egli ci fece un pensiero, all’inizio dei suoi due lunghi anni di carcere preventivo. Ma in quel momento era troppo debole per correre per i tetti. (Riguardo i modi di comunicare ne conosciamo almeno quattro. Scrivere un testo normale, mentre un secondo messaggio viene vergato con l’acido tra le righe: basterà scaldare leggermente il foglio di carta per farlo comparire. Un testo normale e un secondo scritto con l’acido su un foglio di carta da sigarette ripiegato sotto il francobollo. Tracciare delle lettere nelle frasi, con carattere leggermente più grandi: unite, formano il messaggio reale. Bucherellare la carta su cui si scrive con uno spillo secondo l’alfabeto Morse. Jacob utilizzava simultaneamente due sistemi, uno visibile, l’altro no. Se anche gli scritti venivano intercettati, la polizia non scopriva che proprio quello che lui voleva che vedesse. Questi differenti sistemi erano stati da tempo messi a punto con i suoi corrispondenti per essere utilizzati in circostanze simili).
Quando ebbe recuperata la salute, qualche mese più tardi, fu una ragione completamente diversa a spingerlo ad abbandonare provvisoriamente tale progetto: un capitano non abbandona una nave in pericolo. Lui era il solo a tenere tra le mani la matassa imbrogliata degli intrighi. Solo lui poteva confondere le piste, perché solo lui sapeva ciò che cercava la polizia. Se scompariva lui, gli altri sarebbero rimasti nei guai. Marie e Rose sarebbero state forse condannate a pene severe. I compagni non sarebbero riusciti ad evitare le tagliole tese quotidianamente da Atté. D’altra parte, quale insperata tribuna, quella del processo, con la probabile presenza di tutti i giornali borghesi! Quale occasione offerta alla propaganda! Non si poteva lasciar passare una simile fortuna. Se evasione doveva esserci, avrebbe potuto realizzarsi solo dopo.
Fu allora, verso la fine del 1903, che con messaggi cifrati egli diede al riguardo l’allarme ai compagni parigini. Fu allora che parecchi di quelli vennero a stabilirsi ad Amiens. Fu sempre allora che, su sua raccomandazione e grazie in gran parte a capitali di riserva e a fondi nascosti per un’occasione del genere, venne creato “Germinal”.
Ferrand, invece, non aveva alcun motivo per manifestare gli stessi scrupoli. Dall’inizio della sua carcerazione ad Abbeville nel maggio 1903, condivideva la cella con un piccolo truffatore alcolizzato di nome Collevaert, condannato per un raggiro di generi alimentari e che sarebbe stato presto liberato. Gli venne l’idea di approfittare di quella coincidenza. Alexandre, venutone a conoscenza, l’incoraggiò in tal senso. Alternando promesse e minacce, Ferrand riuscì a convincere quel tizio a rendergli una serie di servigi. Il piano era di rara abilità. Purtroppo, Ferrand non conosceva l’evoluzione degli avvenimenti all’esterno. Né il livello di onestà di Collevaert. Costui doveva:
1) Andare a trovare Gabrielle Damiens, detta Minette all’hotel-caffè del signor Sautais in rue Jean-de-Beauvais 31. Ella riceverà da lui delle lettere indirizzate al fermo-posta del quartiere. Il testo avrà poca importanza. Il messaggio sarà nascosto sotto il francobollo. Faccia bene attenzione a non essere seguita quando andrà alla posta (povero Ferrand, che illuso!). Lei gli risponderà con lo stesso procedimento. E firmerà: “Tuo cugino Baron”.
2) Andare a trovare Sautarel in cours de Vincennes 74. Dovrebbe aver lasciato per timore di perquisizioni il suo negozio di gioielleria di boulevard Beaumarchais. (In realtà, sta per essere messo in prigione, grazie ai buoni uffici del cugino Baron). Che spedisca del denaro; che scriva seguendo lo stesso metodo prima riportato, che si firmi: “Tuo zio Libert”.
3) A proposito di Sautarel: dirgli che non deve temere nessuna denuncia, né da parte sua (di Ferrand) né di quella di “Georges” (Jacob).
4) Andare a trovare Matha, del “Libertaire”, in rue d’Orsel 15. Che parli di loro il più possibile, sul giornale. Che spedisca denaro, se possibile. Che si tenga pronto ad ogni eventualità. In particolare, che predisponga un nascondiglio e documenti falsi. (Anche Alexandre scriveva a Matha, ma senza intermediari).
5) Andare a trovare Châlus, il tenutario, che frequenta il ristorante Veyssade, in rue du Château d’Eau dove è conosciuto come “il Cacciatore” a causa del suo perenne abbigliamento da caccia, che Châlus scriva a Ferrand, sempre con lo stesso sistema. Gabrielle-cugino Baron l’avvertirà del giorno in cui dovrà consegnare gli attrezzi necessari all’evasione. Questi attrezzi saranno passati ad un compagno di Abbeville che prima di farsi arrestare per vagabondaggio, li avrà nascosti nella suola delle sue scarpe.
6) Infine, andare a trovare Charles il fabbro a Champigny, in avenue Parmentier. Una grande chiave rossa a mo’ d’insegna al di sopra della porta indica il posto. Dirgli di fabbricare una sega da metallo, oltre ad un grimaldello destinato ad aprire i catenacci delle catene di sicurezza, nel caso che Ferrand fosse trasferito in un’altra prigione.
Tutto fu organizzato in modo preciso. Tanto che proprio Maurice Leblanc non disdegnerà d’ispirarsi a certe astuzie ferrandiane, mescolate ad atteggiamenti jacobiani, per L’evasione di Arsène Lupin. Non senza abbellirlo, già che c’è, naturalmente, con un colpo di bacchetta magica. (Ecco, tra gli altri, alcuni dettagli. 1) I messaggi che Lupin riceve in prigione dall’esterno sono scritti su fogli di carta da sigarette arrotolati in sigari. Come nella realtà quei messaggi verranno intercettati dalla polizia, ma Lupin, come Jacob, l’aveva fatto apposta, per sviare i sospetti. 2) In istruttoria, Lupin adotta esattamente lo stesso atteggiamento di Jacob: rifiuta di parlare, oppure s’addossa la responsabilità di ogni misfatto. «Ed in realtà non parlava molto, Arsène Lupin. Da mesi, il signor Jules Bouvier, il giudice istruttore, si sforzava invano. [...]. Di tanto in tanto, per educazione, lui si lasciava sfuggire: – Ma sì, signor giudice, siamo d’accordo: il furto al Crédit Lyonnais, il furto di rue de Babylone [...], lo svaligiamento dei castelli di Armesnil, di Gouret, di Imblevain, dei Groseilliers, del Malaquis, tutto è opera del servitor vostro. [...]. Confesso tutto in blocco, tutto e anche dieci volte di più di quel che supponete». 3) Come Jacob ha i “suoi” giornali, il “Libertaire”, “Germinal” dove i suoi compagni in libertà esprimono il suo pensiero, così Lupin ha il suo: “L’Echo de France” nel quale può lanciare messaggi: sta qui il resoconto della sua evasione fallita. 4) Alla fine Lupin evade grazie alla complicità di un vagabondo, Désiré Boudru, che «viveva di elemosina e dormiva in uno di quei tuguri degli straccivendoli che s’ammassano vicino al dazio della Ternes»).
Ahimé, il progetto machiavellico di Ferrand non ebbe tutto il successo che arrise a Lupin. Poiché Collevaert s’era messo spontaneamente a vuotare il sacco, per vigliaccheria, per paura di diventare “il complice di una sporca storia”, il signor Atté non dovette fare altro che raccogliere i vari dispacci di Ferrand. Erano indirizzati come previsto: “C.C. (Charles Collevaert) – 22. Fermo-posta. Rue des Archives 7, Parigi”. Ferrand vi si faceva passare per il fratello di Collevaert, notaio in provincia. Sotto il francobollo, il 7 dicembre, furono trovate scritte queste parole: «Amico, non m’abbandonare. Non dare ascolto a quelli che vogliono scoraggiarti. Non ho più che te. L’istruttoria non è finita. Ti avvertirò immediatamente. Vai tutti i giorni alla posta. Tieniti pronto. Di’ a “Libert” che se non mi manda del denaro, io lo denuncio. Di’ al cugino Baron che se non mi manda qualcosa, lo faccio arrestare subito. Rispondi immediatamente».
Naturalmente Collevaert non rispose. Un secondo messaggio, più pressante, più patetico ancora giunse in rue des Archives il 30 gennaio 1904. Ferrand fiutava qualcosa di losco. Ma non supponeva ancora l’ampiezza del tradimento del cugino Baron né quello dell’amico di prigione. «Vai a trovare Libert. Digli che si salvi in fretta se è ancora in tempo. Che cambi nome. Che parta subito. Qualcuno l’ha denunciato. Il suo nome e il suo indirizzo sono noti. Vai a trovare il cugino Baron. Sarai ricevuto bene, adesso, credimi. (Ferrand ripuliva generosamente Gabrielle di ogni sospetto...). Vai a trovarlo. Digli che mi scriva con l’acido. Se potete inviarmi qualche soldo, mi farete un piacere. Di’ anche al mio amico che cerchi di cambiare nome. Cercano anche lui. Tuo per la vita».
Erano gli ultimi sussulti di una falena che sbatte contro una lampada dove rimane bruciata. Qualche giorno più tardi, Ferrand veniva messo a confronto con Gabrielle. Fu colto da vertigine. Non avrebbe mai potuto immaginare tali abissi d’ignominia in colei che egli aveva raccolto mezza morta di fame in rue de la Clef. Voleva strangolarla sul posto. Quattro gendarmi dovettero domarlo. Ma il danno era fatto. Ferrand, da allora, ricalcò l’atteggiamento di Jacob: rivendicò a sé tutti i crimini possibili e improbabili e negò qualsiasi partecipazione altrui.
Atté ci mise quasi due anni ad uscire dal labirinto in cui vagava a tentoni. Migliaia di perquisizioni, di verifiche, di arresti, di confronti, di inchieste si aprirono per suo ordine in tutta la Francia: non riuscì mai a saperne di più di quel che gli avevano rivelato i suoi tre delatori; non riuscì mai a scoprire un solo altro complice oltre a quelli di cui essi gli avevano rivelato il nome. Ma ipotizzava, senza riuscire ad individuarle, le ramificazioni immense che Jacob aveva tessuto: «Questo procedimento testimonia d’uno zelo perseverante, – scrisse dopo aver terminato le centosessantuno pagine del fascicolo – rappresenta un cumulo di lavoro considerevole e tuttavia è appena una breccia in un’organizzazione temibile di malfattori il cui stato maggiore non è smascherato e il cui quartier generale rimane ancora da scovare».
Queste frasi non vengono citate pubblicamente al processo di Amiens, per non sconvolgere l’opinione pubblica. In un certo qual modo, fu conveniente fare così: scomparso Jacob, l’organizzazione messa in piedi da lui sarebbe rimasta decapitata. Tuttavia, di quale “stato maggiore”, di quale “quartier generale” intendeva parlare Atté?
Forse quel magistrato s’immaginava per tutta Europa un brulichio di “forze incontrollate”? In tal caso aveva ragione. Le strutture sociali erette dalla borghesia, grande beneficiaria della “rivoluzione industriale”, si screpolavano in ogni nazione per una specie di colpo di rimbalzo, rimesse in discussione dai lavoratori decisi a riacciuffare in corsa la Storia di cui essi erano stati le vittime, a ritrovare a loro vantaggio il “senso della Storia” intenzionati a recuperare il loro ritardo con una “rivoluzione sociale”. Le forme stesse degli Stati e i modi di governo venivano contestati. La Francia, l’Inghilterra, la Germania, l’Italia, il Belgio, i Paesi Bassi si cavavano provvisoriamente d’impiccio spedendo la loro gioventù all’altro capo del mondo a far la guerra all’arabo, al nero e al giallo. S’intravedeva già la soluzione di ricambio, la Grande Guerra divoratrice di carne da cannone; e la tensione abilmente mantenuta tra il Kaiser e la III Repubblica cominciava a rendere incandescenti le fibre patriottiche, deviando così l’attenzione dai veri problemi. Ma lo zar Nicola II, così gioiosamente festeggiato dalla folla, così sfarzosamente ricevuto poco tempo prima a Parigi e in onore del quale il risparmiatore si rovinava con i “prestiti russi”, cominciava a sentire l’Impero scrollarsi sotto il suo stivale. La rivoluzione mancata del 1905 scoppierà proprio durante il processo Jacob, facendo nascere un’immensa speranza in tutti i compagni francesi. I primi sussulti della crisi erano di già percepibili nel 1903. Molti emigrati russi vagavano per Parigi, Londra e Bruxelles. In mancanza di informazioni più precise, i guardiani dell’ordine immaginavano volentieri una machiavellica ragnatela intessuta attraverso tutta l’Europa e di cui Jacob sarebbe stato uno dei fili. Significava attribuire un enorme credito alle possibilità di organizzazione dei rivoluzionari di allora...
Lo “stato maggiore” a cui Atté faceva allusione avrebbe però potuto avere una consistenza più precisa.
Ci si ricorda dei contatti avuti tra massoni e anarchici al tempo dell’affare Dreyfus. Sébastien Faure, Laurent Tailhade, Armand Charpentier, Gustave Hervé, per non parlare che di loro, avevano senza alcun dubbio superato le prove di iniziazione. Inversamente, parecchie logge del Grande Oriente s’erano ritrovate “contaminate” dalla sinistra. Un gran numero di massoni era rimasto sedotto dalle idee libertarie. Orbene:
1) Jacob s’era gettato nella mischia poco dopo i momenti più caldi dell’affare.
2) Egli vedeva molto spesso almeno Sébastien Faure.
3) Alle elezioni del 1902, l’ala moderata, repubblicana del Grande Oriente aveva riportato la vittoria. Ad Emile Loubet, presidente della Repubblica dal 1899, si erano aggiunti tra gli altri, Combes, nominato presidente del Consiglio, Chaumié alla Pubblica Istruzione, Peletan alla Marina, Léon Bourgeois, presidente della Camera. Erano tutti “Fratelli”. Parallelamente, si organizzò, poco a poco, un più stretto controllo degli iniziati troppo “di sinistra”. Perché, infatti, favorire un’agitazione rivoluzionaria, quando poi si poteva accedere al potere per vie legali e si poteva sperare di migliorare la società grazie a delle “riforme”? I più agitati furono dunque “messi in sonno”; le logge troppo turbolente scomparvero.
4) Nello stesso tempo (fine 1902-inizi 1903) si accrebbero le discordie tra le file libertarie; Jacob passò dall’indignazione allo scoramento, per lasciarsi infine catturare, stupidamente, come se non credesse più a niente.
5) Jacob, quando qualche anno dopo indirizzerà lettere a ministri o ad alti funzionari, farà seguire la firma dai tre punti a triangolo.
Millanteria o realtà.
In ogni caso, bisogna sottolineare tutte queste diverse coincidenze. Jacob aveva rapporti in certe logge del Grande Oriente, allora estremamente potenti. Forse queste sono state più importanti di quel che non si sia creduto. Fin dove è giunto il complotto? È stato considerato come una semplice eventualità in caso di colpo di Stato reazionario? Si è sviluppato, anche per un breve lasso di tempo, in maniera coordinata? È comunque certo che sia esistito, almeno nelle intenzioni, presso qualche individuo e forse l’arrivo al potere del “piccolo padre Combes” ha salvato la III Repubblica da un’ondata di agitazioni sociali.
Ad ogni modo, nonostante qualsiasi considerazione politica, il giudizio verso Alexandre da parte dei magistrati che si occuparono di lui non fu certo tenero. L’imputato era stato posto nel quadro del diritto comune: e lì lo si sarebbe mantenuto saldamente. Aveva rubato, sparato su degli agenti: era un criminale.
«Jacob è nella piena accezione del termine un ladro di professione – scrisse uno di quelli. – Egli organizza spedizioni che guida di persona con grandissimo metodo e prudenza.
«Ispira fiducia ai suoi complici. Non trascura nulla per realizzare il bottino presto e bene, al meglio di tutti gli interessi di cui egli ha responsabilità (...).
«Jacob ha giudicato opportuno vantarsi dei centocinquanta furti ai quali ha preso parte in ogni angolo della Repubblica e all’estero. Egli dimostra di pretenderli ispirati da un ideale politico e durante i suoi interrogatori ad Abbeville, ha assunto atteggiamenti da apostolo. Costui non è che un vero malvivente, un gran millantatore.
«Ladro incorreggibile, detenuto inemendabile, animato dal più detestabile spirito, egli non appare sotto alcun punto di vista suscettibile di riparazione né degno di clemenza per il futuro».
La vendetta della società aveva inizio.
L’istruttoria fu conclusa nelle ultime settimane del 1904. Gli imputati furono quindi trasferiti nel carcere Bicêtre di Amiens e si aprì il processo.
Jacob, fin dall’inizio, rispose a tutte le domande con un’insolenza senza limiti. “Il suo atteggiamento in udienza è stato assolutamente inqualificabile”, giudicheranno unanimamente i magistrati. “Jacob è un personaggio veramente bizzarro” – scrisse da parte sua l’inviato speciale de “L’Aurore”. – “Il suo volto smagrito riflette contemporaneamente odio e dolcezza. Quando si rivolge al presidente o al procuratore generale, i suoi muscoli si tendono ed i suoi occhi, due grandi occhi neri conficcati profondamente nelle orbite, hanno bagliori feroci. Invece, quando lancia una battuta ai testimoni o quando si rivolge con buonumore al suo generoso difensore, l’avvocato Justal, si riempie di bontà. È un personaggio enigmatico e inquietante, che riflette di volta in volta i sentimenti più contraddittori”.
“I1 suo comportamento in udienza è straordinario – riprendeva “L’Illustration”. – Prende in giro, schernisce le sue vittime le cui ricchezze, dice, sono un insulto permanente alla miseria. Il presidente non riesce a trattenerlo. È un tipo poco ordinario, malefico, pericoloso, ma curioso. Ironizza, scherza, a volte non scioccamente, cinico, mai a corto di battute, perfettamente indifferente, pare, alle conseguenze delle sue azioni». Alla minima occasione, tira fuori le diatribe che s’è preparato. Sulla nobiltà, sulla giustizia, sui possidenti, sul clero. Sull’esercito: «Non si guerreggia più contro gli infedeli. Si civilizzano gli insorti. Non bisogna uccidersi l’un l’altro. Se ho scelto i militari come nemici è perché li considero degli assassini”.
Don Chisciotte all’inseguimento di un sogno di un mondo migliore, egli si batte contro tutti i mulini a vento. Ferrand, Bour, Pélissard, Bonnefoy si alzano a loro volta per leggere le loro dichiarazioni di guerra. Non è più un processo: è una requisitoria socialista.
I testimoni si susseguono. Alexandre li disorienta a forza di battute, di commenti, di sarcasmi. Un fuoco d’artificio di risposte secche. Il pubblico, benché composto nella sua stragrande maggioranza da notabili locali selezionati all’entrata, non può trattenersi dal ridere.
Arriva un sacrestano a testimoniare: Wehekind gli chiede di prestare giuramento:
– Perché, pensate che possa mentire? – fa Jacob. Wehekind parla delle “donne Jacob”:
– Si direbbe che io abbia un harem – si lamenta.
Wehekind rimprovera a Clarenson di essere pazzo solo quando gli fa comodo:
– Oh, signor Presidente! Ci sono degli alienati persino tra i giudici istruttori! – sogghigna.
Wehekind cerca di spiegare il meccanismo d’uno svaligiamento.
– Signor Presidente, state sbagliando – lo interrompe. – Per spedire la gente al bagno penale o al patibolo, voi siete competente, ne convengo. Ma in materia di svaligiamenti, mancate di competenza. Non mi vorrete insegnare il mio mestiere.
Quando, alla terza udienza, legge per più di mezz’ora, con voce profonda e accalorata, la sua professione di fede di ladro il pubblico è attonito. La stampa non riesce a capacitarsi. «Non è la società, rappresentata dai magistrati e dai giurati a giudicare Jacob, capo dei malviventi, – scrive “L’Aurore” – ma è il capo dei malviventi Jacob che fa il processo alla società. In verità, è lui che guida il dibattimento. È sempre in scena. È sempre pronto alla replica. All’occorrenza, pone le domande e fornisce le risposte. È lui che presiede! È lui che giudica!».
Nei giornali a grande tiratura si minimizza ancora la portata dei suoi interventi. Ma ad Amiens, “Germinal” è in vendita dappertutto. Non si sta con le mani in mano nella botteguccia del calzolaio Lemaire. Tutta la notte si tirano volantini che riportano le dichiarazioni pronunciate da Alexandre il giorno prima e vengono distribuiti fin dall’alba.
La popolarità del Ladro aumenta. Le donne ne sono affascinate. Ha venticinque anni. Ha del fuoco. Le turba. Gli uomini lo discutono aspramente. Non si parla più che di lui in tutta la Francia e certo anche all’estero. Non si riescono sempre a seguire i suoi ragionamenti, ma la sua audacia lo rende simpatico. «Si rimane coinvolti dinanzi ad un uomo simile – esclama il “Libertaire”. – Dopo due anni interminabili di segregazione, isolato, tra due muri di notte, una persona che abbia ad un livello sempre uguale una tale energia, una simile lucidità, è di natura poco comune. S’è tentato di presentarlo sotto il duplice aspetto di un fanfarone esaltato e di un delinquente egoista e sanguinario. Le sue dure dichiarazioni, tutta la sua vita, il suo sorriso buono e calmo quando i suoi occhi si posano su qualcosa che non sia una espressione dell’autorità, ne sono la smentita più formale...».
Ogni mattina, all’arrivo dei furgoni cellulari, una folla sempre più densa e più amichevole si accalca, mentre gli imputati entrano nel palazzo cantando l’Internazionale o la Carmagnola. Sì, la gente comincia a percepire il senso della sua attività. Per arrivare a questo, occorreva che il raddrizzatore di torti divenisse vittima. Al tempo in cui sfidava la polizia, faceva paura, incatenato, lo applaudono.
Eppure i rapporti dei confidenti che arrivano da Parigi diventano allarmanti. Qualcosa si sta preparando.
I sobillatori cercano di trascinare la plebe. E poi, non s’è visto forse Jacob, alla fine della quarta udienza, scambiare dei segni d’intesa con parecchi individui dall’aspetto equivoco, che erano riusciti a infiltrarsi nella sala?
Effettivamente, Malato, Souvarine, Pacaud, Ouin sono in agguato. Sono riusciti a far passare un piccolo sacchetto di polvere ad Alexandre. E una lima. Dove, quando, come se ne servirà? È sorvegliato giorno e notte. La lampadina rimane sempre accesa nella sua cella e lo spioncino aperto. E i fucilieri della sua scorta sono troppo numerosi. Dappertutto pullulano gendarmi che lo seguono passo passo. Che importa! Jacob pensa adesso di aver compiuto la sua missione. Ha fatto il massimo possibile per Marie, per Rose, per i suoi coimputati e per i suoi soci sconosciuti. I termini del dilemma sono mutati: non è più loro o lui, ma, adesso, la libertà o la morte.
– Sarà per domani o dopodomani, – annuncia finalmente Malato il 13 marzo nell’ufficio di “Germinal”. – Tenterà il colpo nella stanza adiacente alla sala delle udienze durante una sospensione della seduta. Andrà in gabinetto, si sbarazzerà delle catene, salterà nel cortile del Palazzo attraverso un abbaino, salirà per una scala e si lancerà da una finestra. Noi lo aspetteremo là con una vettura. Ha una possibilità su dieci.
Il silenzio è pesante.
– Stamattina i giurati hanno ricevuto la loro lettera minatoria – fa il vocione di Souvarine. – Serve sempre a farli riflettere un po’.
Quella stessa sera, alla fine dell’udienza, alle diciassette, una folla considerevole, entusiasmata, aspetta Jacob in rue Victor Hugo. Alla comparsa dei cellulari, si fa sempre più forte il clamore: “Viva Jacob! Viva l’anarchia!”. Si forma un corteo in direzione di place Saint-Denis. La truppa avanza. La folla esita, ondeggia, i soldati caricano. Salgono grida da sinistra e da destra: “Morte agli sbirri! Viva l’anarchia! Viva Jacob!”.
I confidenti di Lépine si danno da fare. Uno di loro si getta su Jules Lemaire. Un bravo giovanotto, venuto da Ailly-sur-Somme per vedere Jacob, cerca di frapporsi. Schiaffano dentro anche lui. E anche una certa Gabrielle Mariette, per cui redigono un verbale per “oltraggio ad agente”, e un’altra decina di persone, tra cui un fiaccheraio che si sgola al massimo sulla sua carrozza.
Il presidente Wehekind viene a conoscenza di questo inizio di sollevazione. La misura è colma. Le repliche e le dichiarazioni dell’imputato principale, la lettera di minacce ai giurati, questi cortei: la giustizia viene schernita. Bisogna riprendere in mano la situazione.
L’indomani mattina, martedì 14 marzo, proprio all’inizio dell’udienza, avviene l’incidente. L’occasione viene fornita dalla deposizione di Devaine, il proprietario del caffè di rue de Vouillé, sotto i Ferré, presso il quale la banda si ritrovava così spesso. Devaine riconosce Rose tra gli imputati.
– La chiamavano perfino “la marchesa” per la sua aria fiera – dice.
Rose arrossisce di collera.
– Io non ho mai avuto l’aria di una marchesa! – esclama. – Non so che cosa voglia dire costui.
Il presidente, che non aspettava altro pretesto, dà in escandescenze.
– Ma chi è questa imputata che si permette di rivolgere delle domande direttamente al testimone?
– Sono io – dice Rose.
– Alzatevi.
– Vi chiedo anzi di lasciarmi sedere. Sono ammalata.
– Voi siete sempre malata quando vi fa comodo.
È un po’ troppo. L’avvocato Lagasse, difensore di Sautarel, interviene:
– Ci sono tra gli accusati persone che hanno una malattia. È quella d’essere innocenti. E loro...
– Va bene, avvocato Lagasse, lo direte nell’arringa! – replica il presidente.
– Io sono convinto di poterlo dire tutte le volte che voi vorrete accordarmi la parola per difendere il mio cliente – risponde l’avvocato.
– Se credete di avere l’ultima parola con me, vi sbagliate!
– La difesa ha diritto a dei riguardi.
Il tono sale. L’avvocato Fabiani, difensore di Ferré, del foro di Amiens, al contrario di Lagasse che è del foro di Parigi, interviene a sua volta per protestare. Dall’inizio del processo, gli avvocati della capitale non sono stati accolti con molto calore dal presidente Wehekind, che non ha mai smesso di rivolger loro frecciatine.
– Voi sì che siete un uomo cortese! – dice il presidente a Fabiani. – Vi darò la parola tutte le volte che me la chiederete. I membri del foro parigino, invece non sono educati e non ne sono soddisfatto.
Lagasse esplode:
– Sono diciott’anni che sono avvocato e non mi sono mai sentito fare simili commenti – tuona. – Non li tollero.
– Voi starete a sentire quello che ho da dirvi!
– Non ho mai visto un presidente mancare di riguardo verso la difesa come state facendo voi!
– Io rispetto chi se lo merita.
– Visto che non meritiamo il vostro rispetto, ce ne andiamo.
E gli avvocati André Hesse, Bergougnhioux de Wailly, Silvy, Grad, Lévy-Oulmann, Lafont, Justal lo seguono davvero fuori.
Allora Jacob si alza, con un salto:
– Visto che non abbiamo più avvocati, non possiamo restare qui – ruggisce.
Ad un suo cenno, i ventisei imputati balzano in piedi, urlando a più non posso:
– Viva l’anarchia! Presidente schifoso! Assassino! Branco di banditi! Bella, la vostra giustizia! È una trappola! Banditi! Banditi!
Intonano l’Internazionale. I gendarmi li trattengono a fatica. Nella sala, le elegantone venute a fremere alla vista del ladro e a ridere per le sue battute, vedendo che la commedia si volge al dramma, girano i tacchi. Il tumulto è indescrivibile. Finalmente, si fa sentire la voce squillante del sostituto procuratore generale.
– In applicazione della legge, chiedo l’espulsione degli imputati!
– Bravo! Bravo! Urrà! – rispondono costoro.
Il presidente, seduta stante, emette un’ordinanza di espulsione per Jacob e per Ferré, Pélissard, Bour, Sautarel, Clarenson, Baudy, Vaillant e Apport.
Viene decisa una sospensione dell’udienza. I nove imputati, diventati furiosi, vengono trascinati via e portati nei furgoni cellulari. Gli avvocati Justal e Hesse, che non sono stati coinvolti direttamente nell’incidente, tentano un passo di riappacificazione presso il presidente. Quest’ultimo rifiuta di aprire loro la porta. Essi inviano un telegramma al ministro della Giustizia: invano. Gli espulsi non verranno più ammessi nella sala delle udienze per il resto del dibattimento. Nessuna richiesta verrà presa in considerazione. Solo un ricorso in Cassazione potrebbe modificare la situazione. Ma, anche se non venisse respinto, il processo avrebbe tutto il tempo di terminare.
– L’essenziale per noi è di concludere questo processo – commenta il presidente alla ripresa dell’udienza.
In altre parole: che la giustizia non venga più sfidata apertamente.
Per Alexandre, è la catastrofe. Non l’aveva previsto. Il presidente l’ha preso in trappola. Il tumulto che egli ha provocato si ritorce contro di lui. Il progetto di evasione sfuma definitivamente. Lo rinchiudono nella cella per non tirarlo più fuori.
La vettura che l’aspettava lungo le mura del Palazzo, riparte malinconicamente. Al “Germinal”, sono sconvolti, disperati, straziati, furiosi, indispettiti. Che fare? Niente. Approfittare dell’incidente per montare lo scandalo. Denunciare l’atteggiamento di quei giudici iniqui che, quando un imputato dà loro fastidio perché dice loro la verità, gli impediscono semplicemente di assistere al proprio processo.
Per Souvarine, non si può avere più alcuna esitazione: il popolo, finalmente dalla loro parte, aspetta un gesto. Bisogna passare all’azione immediata. Massacrare almeno uno o due giurati, immediatamente. I magistrati, impossibile: sono protetti dalla polizia. Se ne discute. Qualcuno approva la proposta dell’emigrato russo.
– Ma, – dicono gli altri, – si ritorcerà contro di noi: adesso simpatizzano con noi, ci odieranno di nuovo. E i nostri compagni, che fungeranno da ostaggi e saranno condannati a morte? Noi non lo vogliamo
La saggezza prevale. Si concorda per un accomodamento: un avvertimento chiaro e fermo all’indirizzo dei giurati. Rimanendo bene inteso che non si esiterà più, all’occorrenza. Si giura. Poi ci si mette a redigere una seconda lettera minatoria.
«Insieme a magistrati di carriera, voi siete chiamati a giudicare Jacob e i suoi compagni. Riflettete sulla situazione in cui vi state cacciando. Avete intenzione di lasciarvi influenzare dalle parole vendicatrici dei giudici, dei procuratori che s’aspettano una sicura promozione grazie alla loro requisitoria?
«Non crediate che, se emetterete un verdetto severo, potrete ritornare ai vostri affetti familiari. Non crediate, soprattutto, che la vostra giustizia abbia tra le grinfie tutti i membri di questo manipolo di ribelli che han “giurato di annientare la proprietà. Sappiate che noi siamo qui, a spiare i vostri movimenti, a sondare le vostre intenzioni e che se osate colpire, noi vi distruggeremo.
«La lotta non è uguale. Voi avete la legge e la forza. Noi abbiamo l’astuzia. Chiuderemo i nostri cuori alla pietà. Vi colpiremo personalmente nelle vostre mogli e nei vostri figli. Tutti i mezzi saranno buoni per noi: esplosivi o rivoltelle. E non crediate a vane minacce. Ricordatevi del presidente delle Assise Benoit, del procuratore Bulot che ha fatto condannare Ravachol, del granduca Sergio e degli altri funzionari che non credevano alla vendetta dei revolver.
«Osate colpire senza pietà i nostri amici e, senza pietà, anche noi vi colpiremo. State certi delle nostre rappresaglie; e che questa visione fatale del vostro destino si affacci spesso al vostro spirito nel momento del giudizio.
«Siete avvertiti.
«Attenti a voi.
«Amici di Jacob».
I giurati furono attenti. Furono più sensibili a questa missiva poco allettante che all’arringa pronunciata dell’avvocato Justal a favore di Jacob? “Un cuore violento e tenero, una natura comprensiva e feroce insieme... Il suo atteggiamento a volte sconveniente... Egli m’è tuttavia apparso come l’incarnazione del genio del bene, poiché invece di avere come scopo una vita opulenta, per lui, rubare significa riprendere ai ricchi per dare ai poveri... Egli si considerava soprattutto come un riparatore di torti... In ogni epoca della storia noi vediamo questi tipi allucinati attraversare la società all’inseguimento di un irraggiungibile ideale, parecchio prima che l’anarchia avesse elaborato la sua teoria. C’è nel fondo di questi esseri una fede che non riusciamo ad afferrare... Egli non ha mai voluto uccidere... Voi avete chiesto, signor procuratore, la sua testa. Jacob la offre, questa testa, in una lettera che mi ha appena inviato. Ma chi oserà prenderla?”.
Alexandre salvò la sua testa.
Il 22 marzo, un mercoledì, dopo le ultime arringhe e la lettura delle seicentonovantasei domande cui doveva rispondere, la giuria si ritirò per deliberare. Le ci vollero undici ore. Dovettero portarle da mangiare sul posto. “Il servizio d’ordine era dei più rigorosi – scrisse l’inviato del “Petit Parisien” – e il palazzo di giustizia era deserto. Il pubblico non è stato ammesso che in serata. La sala, appena le porte si aprirono, è stata letteralmente invasa.
“I dieci imputati colpiti dall’espulsione non sono stati ricondotti in udienza. Sono esattamente le nove e mezzo quando la seduta riprende e il capo della giuria prende la parola”.
Il verdetto era il seguente.
Jacob, come il suo allievo Bour, veniva condannato ai lavori forzati a vita.
Venivano assolti: Alcide Ader, l’uomo che scappava durante gli svaligiamenti (commento del procuratore: “Egli non era, secondo i suoi coimputati, un ladro intrepido. Ma rimane, dopo tutto, un uomo assai disonesto, assai poco scrupoloso”); Georges Apport, il fonditore d’oro aggiunto (commento: “Ci rincresce la sua assoluzione”); Emile Augain e Westermann, le due ultime reclute di Ferré (commento del procuratore su Augain: “Il suo rilascio è deplorevole, in quanto è destinato ad accrescere l’audacia di un malfattore tra i più pericolosi”); Châlus, il tenutario (“l’unica testimonianza di una prostituta non era sufficiente a fare condannare nemmeno un tenutario di casa chiusa”); Limonnier, l’intermediario occasionale tra Jacob e i fonditori; oltre naturalmente a Léontine Tissandier detta Alice Vincent, l’ex amante di Bour, la confidente.
Per gli altri, le condanne erano pesanti: Ferrand, il braccio destro di Jacob, vent’anni di lavori forzati, Pélissard, colpito da divieto di soggiorno e Bonnefoy, l’avventuriero ripescato a Gibuti, otto anni di lavori forzati. Cosa che, come faceva rilevare “Germinal”, equivaleva alla condanna a morte, giacché una condanna al bagno penale superiore ai sette anni comportava l’obbligo di risiedere in Guyana per il resto dei propri giorni; Clarenson, il mezzo pazzo, cinque anni di lavori forzati; anche Sautarel, l’intellettuale, cinque anni: era moltissimo; Ferré, il portinaio mosaicista di rue Labrouste, dieci anni di reclusione.
Vaillant, l’aiutante di Ferrand, dieci anni di reclusione (che gli importavano poco, giacché quella condanna andava a sommarsi ai dieci anni di bagno di cui aveva appena “beneficiato” il 3 agosto 1903 dinanzi alle Assise della Nièvre); Baudy il Perdente, dieci anni, più la relegazione a vita in Guyana. Charles, il riparatore d’utensili, cinque anni e la relegazione; Brunus, il fonditore, cinque anni, come Blondel, l’efebo di Ferrand, e Rose.
Marie si vedeva gratificata di cinque anni di prigione. “Nessun incidente è avvenuto durante la lettura del verdetto. La seduta è stata tolta alle dieci e mezzo”.
Una folla immensa era ammassata dinanzi al palazzo. Scoppiarono discussioni molto vivaci. Si venne alle mani due o tre volte. I litiganti dovettero essere separati. La maggioranza era d’accordo sulle condanne di Jacob e di Ferrand: loro avevano giocato secondo le regole e pagavano; era normale. Invece, si considerava esagerata la condanna inflitta a certe comparse come Sautarel, Marie o Rose.
All’improvviso, i poliziotti a cavallo uscirono dalla loro caserma. Tre plotoni di fanteria, di gendarmi e un nugolo di agenti di polizia vi si aggiunsero. Caricarono molto violentemente e riuscirono a fare indietreggiare la folla di dieci metri. Le vetture cellulari si misero in moto. Urli, grida mille volte ripetute di “Viva Jacob! Viva l’anarchia!” partirono da ogni parte. Il commissario Jénot sorvegliava la scena. Le “spie di Lépine” tenevano d’occhio i gruppi. Sorpresero dei militanti che stavano distribuendo dei volantini. Se ne impadronirono. Non era un appello all’insurrezione come temevano, ma una poesia di Pélissard dal titolo “Consigli alla canaglia” che così concludeva:
«Rispetta il proletario, svaligia il ricco
Come un vero cavaliere del grimaldello.
Spoglia il borghese, questo cinico ladro:
Ecco in poche parole la regola indispensabile
Che devi agire da vera canaglia giudiziosa».
Ancora una volta, si organizzò una manifestazione. Un gruppo compatto di un migliaio di persone discese lungo rue des Trois-Cailloux cantando l’Internazionale, “sotto lo sguardo dei sergenti impotenti”. I “Viva Jacob!” salivano lungo le facciate dalle tende chiuse. In rue de la Hotoie, incrociarono due ufficiali che furono subissati di urla.
Dinanzi alla sede sociale di “Germinal” si tenne un comizio spontaneo. All’interno dell’ufficio, si dibattevano le forme d’azione da realizzare da quel momento in poi.
Nella sua cella, Alexandre Marius dormiva pacificamente aspettando di essere trasferito ad Orléans, dove l’attendeva un secondo processo, per tentativo di omicidio contro l’agente Couillant.
* * *
Un crimine giudiziario
Il verdetto ipocrita e vile del processo Jacob dà un colpo al cerchio e uno alla botte. Ma c’è un limite a tutto, anche all’infamia. Lo stesso “Progrès de la Somme” lo ammette a proposito di Sautarel: “Qual è dunque la causa di questa implacabile, rancorosa severità contro questo imputato?”. La verità? È che Sautarel è stato condannato e colpito con ferocia non perché i giurati hanno creduto alla sua colpevolezza, che non era provata da alcunché, ma perché egli s’è proclamato anarchico. Sautarel è stato punito per un delitto d’opinione. Gli hanno fatto un processo alle intenzioni. Lo mandano al bagno penale perché è anarchico. Ecco chi farà rinascere il sentimento dell’ingiustizia.
I chicchi che avete seminato,
O Borghesi, usciranno dalla terra.
L’odio, questo fiore del male,
Germe vivace nelle nostre viscere.
Ne sgorgherà ciò che marcirà!
Forza, ragazzi! È Germinal
Che farà spuntare le sementi!
Che dire della condanna della signora Jacob? Che dire dei vostri testimoni, una puttana morta (Gabrielle) e un pazzo alcolizzato (Collevaert, che infatti era stato internato nel frattempo in un manicomio)?
Persino la Lega dei Diritti dell’Uomo, benché riformista, protesta contro questo verdetto. Persino l’“Avant-Garde’, benché conservatore; persino “Le Cri du Peuple”, il cui redattore capo, Rodrigues, afferma tuttavia che sarebbe criminale e pazzesco utilizzare “i metodi violenti dei nostri compagni russi in un paese con la libertà di pensiero” – tutti sono commossi per simile iniquità.
È la rinascita dell’Inquisizione e l’apoteosi del sacrificio umano. Ecco quel che i benpensanti definiscono un errore giudiziario. E lo è. Sautarel, tra gli altri, è vittima di una vendetta. Si è voluto colpire in lui lo scrittore, il pensatore, l’anarchico, l’idea libertaria. È un’imboscata!
“Germinal” – 9 aprile 1905
(“Germinal” sopravviverà due anni al processo, con lo stesso spirito e la stessa virulenza).
* * *
Il trasferimento di Jacob avvenne il 30 marzo. Di prigione in prigione, ne scrive a sua madre: «Seppure non ho preso un treno turistico, il mio viaggio non è stato senza attrattive. Come puoi immaginare, ero l’oggetto della curiosità della gente. Da Amiens a Liancourt, ad ogni stazione, ad ogni fermata, la folla di viaggiatori si ammassava attorno al vagone, curiosa e, devo aggiungere, amichevole. Qualche operaio mi ha persino offerto il suo modesto pasto. Queste manifestazioni di simpatia hanno un loro significato. Il popolo è buono, per quanto se ne dica. Non era la folla in delirio, stimolata dall’alcool che, ad Abbeville, urlava frasi stupide e feroci, ma uomini istruiti, meglio preparati dai dibattimenti della corte d’Assise».
Il suo sacrificio non era dunque stato inutile: attraverso di lui, era l’anarchia che quegli uomini consideravano con nuova attenzione. Il suo morale ne trasse giovamento: «Il cortile dove sto a passeggiare assomiglia tanto a una delle fosse per gli animali selvatici del giardino zoologico, è divertente. E poi vedo un sacco di belle cose: pietre, terra, legumi e infine qualche albero da frutto che fa pietà tanto è macilento. Provo lo stesso sentimento verso quattro o cinque pianticelle di cui ignoro specie e famiglia, che vegetano miseramente sotto la protezione di una campana di vetro. So che cosa manca loro: qualche anno di lavori forzati farebbe loro bene. Godrebbero di una temperatura più clemente. Ma non va al bagno penale chi vuole... Penso a tutte le specie di cataclismi che minacciano i mortali che vivono in libertà ed io, recluso, mi sento felice. Mangio, bevo, dormo, respiro, penso, che cosa vuoi di più? Ecco che cosa fa meglio comprendere la vocazione del cappuccino... Il mondo è un miscuglio di vittime e di birboni o, per servirmi di un’immagine più consona alla nostra situazione, di cacciatori e di conigli. Adesso, per il momento, noi siamo i conigli e non ci resta che fare in modo perché non ci mettano in salmì... Come per il passato, ti consiglio di rimaner salda e forte. Non chiedere né grazia né libertà condizionata. Poiché non hai fatto niente, non hai niente da sollecitare. E così, una volta liberata, non ti consiglio di fare rivedere il tuo processo: la revisione ti potrà mai rendere gli anni di libertà che la società ti ha sottratto?...».
Tuttavia, con nove imputati del processo di Amiens che ne ebbero l’idea o la possibilità, Marie aveva presentato ricorso in cassazione. Venne accolto il 5 giugno. Un nuovo processo si aprì per loro a Laon, dinanzi alla corte d’Assise dell’Aisne, il 26 settembre.
Marie venne assolta il 1° ottobre 1905. Alexandre ne provò una gioia senza limiti.
Rose ebbe meno fortuna: le vennero confermati i suoi cinque anni di reclusione. Quando uscirà di prigione, nel 1908, a quarantatre anni, sarà una donna prematuramente invecchiata, Alexandre le scriverà ancora, di tanto in tanto, e poi...
Due altre assoluzioni: Brunus, il fonditore, che ritornerà ai suoi forni; e Sautarel, che continuerà fino al primo dopoguerra ad avere una vita attiva e militante, a Perpignan.
Quanto alla sorte degli altri, eccola, nella misura in cui è stato possibile ricostruirla.
Per Baudy, il giocatore sfortunato e romantico che aveva scritto “confessioni” tanto commoventi, i dieci anni di reclusione di Amiens furono ridotti a sette. Ma il confino venne mantenuto: «Delinquente incallito, di cui è ben difficile immaginare la riparazione. A Laon non è stato colpito troppo severamente. Occorre fare eseguire il confino cui è stato condannato nell’interesse sociale». Il confino significava la Guyana. («Il confino consiste nella deportazione, in principio perpetua, sul territorio delle colonie o dei possedimenti francesi, dei condannati di diritto comune considerati incorreggibili in ragione della frequenza dei loro crimini»). Gli verrà assegnato un pezzetto di terra da dissodare, dalle parti della Caienna, dove avrà il diritto di morire di fame sotto il sole, tra le zanzare. La sorte dei confinati, teoricamente liberi di muoversi, non era più invidiabile di quella dei forzati. Dunque gli facevano un regalo avvelenato.
Bonnefoy, l’avventuriero, il marito di Marcelle la cantante, fu, pare, più fortunato: i suoi otto anni di lavori forzati furono ridotti a sette anni di reclusione, oltre a dieci anni di divieto di soggiorno. Il commento della giustizia al suo riguardo rimane tuttavia inquietante. «Si deve tenere conto del suo atteggiamento in carcere per l’esecuzione integrale o meno della sua condanna. Sarebbe desiderabile gli si trovasse un lavoro qualsiasi nelle colonie, dove lui stesso aveva intenzione di trasferirsi al momento del suo arresto». Quali colonie? Ogni sua traccia è andata perduta.
Angèle, la portinaia, la moglie di Ferré: i suoi cinque anni di prigione furono portati a tre, a Laon; non le restavano dunque, contando il periodo di carcere preventivo, che pochi mesi. Liberata nel 1907, andò ad abitare a Narbonne, dove il marito poté raggiungerla due anni dopo, grazie alla sua buona condotta in prigione, al fatto che non aveva precedenti e ai loro due figli.
Vaillant, l’aiutante di Ferrand: gli commutarono i dieci anni di prigione in sei, ma gli venne confermato il confino. Per la Caienna.
Blondel, l’efebo di Ferrand: l’avvocato d’ufficio (Grad), che gli era stato attribuito al processo di Amiens, lo abbandonò freddamente appena pronunciata la sua condanna a cinque anni di reclusione. Tanto che, quando scoprì la possibilità di ricorrere in cassazione, i termini regolamentari erano scaduti. Scontò dunque la sua pena e ritornò a vivere a Lyon, dove riprese il vecchio mestiere di tipografo.
Bour, l’allievo prediletto: ogni ricorso era stato inutile, per lui. Diverrà un forzato tra gli altri e morirà laggiù.
Charles scontò la sua condanna alla prigione centrale di Melun, dove tenne un buon comportamento. Il senatore del Loir-et-Cher, dove vivevano suo padre infermo e sua madre paralizzata, intervenne in suo favore. Poi il presidente del Consiglio generale del Cher, Tassin e il deputato Ragot. Si finì per accordargli il condono. Venne liberato nel 1907 e riprese il suo mestiere di fabbro.
Clarenson, il pazzo vero-falso, invece, avanzò ricorso e si presentò alle Assise dell’Oise il 19 giugno 1906: la condanna gli fu ridotta a cinque anni, oltre al confino. «Come testimoni c’erano esclusivamente agenti di polizia», scriverà. Lo manderanno al carcere centrale di Beaulieu. Da quel momento, la sua vita assomiglia ad una storia di pazzo intelligentissimo. Sua madre inonda il ministero della Giustizia di suppliche e di richieste per il suo povero figliolo “affetto da una malattia mentale ereditaria: mania di persecuzione e mitomania; diciassette medici alienisti l’hanno dichiarato pazzo”. Al Centrale, il suo stato di salute si deteriora: “È esausto. Il suo cervello non funziona bene. È un martire. Non vive che di latte e uova. Ha i reumatismi. Ha un braccio paralizzato. L’inverno sarà rigido. La sua condanna sarà terminata nel maggio 1908. E poi ci sarà il confino... Bisogna risparmiargli quest’ultimo incubo: non sopravviverà”.
Ma la giustizia è implacabile: il 17 luglio 1908, Clarenson viene imbarcato per la Guyana in confino collettivo. Il 3 novembre 1910 viene ammesso al confino individuale a Saint-Jean-du-Maroni: ossia egli ha il diritto di sfruttare una piccola concessione, senza sorveglianza, quasi come un colono normale. Da quella data, non si sa più niente di lui. Scomparso, volatilizzato: la sua relativa libertà gli ha permesso di fare “il colpo”, sogno di tutti i deportati. Ritorna in Europa passando per l’Italia, non ritrova Antoinette Bernard vedova Amiglio, alla quale scriveva dalla prigione: “Mia povera, amata Vinette...”. “Il tuo grand’uomo...”. “Quello che non vive che per te”: è che si preoccupava poco di ritrovarla; ritorna ai suoi cari tappeti verdi, a Montecarlo si fa prendere in flagrante mentre bara, viene condannato a tre anni in contumacia dal tribunale di Monaco il 26 giugno 1912 e scompare definitivamente verso altre avventure.
Quanto a Pélissard, quello sempre colpito da divieto di soggiorno, condannato ad otto anni di lavori forzati, che ha tenuto “un atteggiamento da malfattore privo di qualsiasi senso morale durante l’istruttoria”, “delinquente incallito non suscettibile di riparazione” e, del resto, militante anarchico convinto, rimarrà, nelle isole della Salute, il ribelle che è sempre stato. Matricola 34441 (è ormai il suo nome), dal carattere insubordinato, “incline alle idee anarchiche”, dopo molti giorni di cella, morirà nell’inferno della Guyana.
Quel che capiterà anche a Ferrand.
È indubbio che, nella maggior parte di questi casi, l’ossessione del movimento “libertario” fu per molti provocata dalla pesantezza delle pene inflitte ad alcuni dei “Lavoratori della notte”.
* * *
Jacob a Marie.
Da parte mia, non mi faccio cattivo sangue. Addolorarmi perché vado al bagno penale? Giammai!... È roba per gli onesti, piangere e soffrire in questa valle di lacrime. Quelli sono sicuri di godere di ogni felicità nel mondo futuro. Ma io, povero bandito incorreggibile, rassegnato a servire da antracite nel focolare della caldaia del signor Lucifero, io faccio in modo di godere dei piaceri di questo basso mondo per quanto i miei mezzi me lo permettono. Per il momento, questi piaceri consistono nell’infischiarmene di tutto, nel mostrarmi superiore agli avvenimenti, nel non lasciarmi guidare da essi, ma nel cercare di guidarli a mio vantaggio...
Non vedo l’ora di essere portato ad annusare tutte quelle fragranze tropicali, a mangiare noci di cocco, manghi, banane e... lardo salato. A vedere il bagno penale, finalmente, con le sue grandezze, le sue passioni, le sue bassezze, le sue viltà e le sue rivolte. Vi rivedrò vecchie conoscenze; vi ritroverò vecchi amici. Sono convinto che sono già informati della mia situazione e che mi aspettano. Sono ancora fortunato a trovare amici al bagno penale. Quanti uomini non riescono a trovarne da nessuna parte!...
* * *
Il 24 luglio 1905 la corte d’Assise di Orléans, sotto la presidenza del signor Escoffier, condannava Alexandre a vent’anni di lavori forzati per “furti aggravati e violenze ad agente”. Una semplice formalità, dacché Alexandre partiva comunque per la Caienna senza speranze di ritorno. Il caso venne discusso e giudicato in un’unica udienza.
Alexandre ne approfittò per lanciare le sue abituali battute contro la società. Cercò anche di evadere: ma s’era immaginato diversamente il posto e, dopo esser saltato da un abbaino, si trovò di nuovo tra due gendarmi.
Nove giorni prima, esattamente il 15 luglio, era comparsa, su “Je sais tout”, la rivista mensile lanciata dall’editore Pierre Laffitte nel febbraio precedente, la prima parte della biografia di Arsène Lupin: L’arresto di Arsène Lupin. Ma mentre l’eroe di Maurice Leblanc si apprestava a diventare in misura sempre maggiore un gentleman e sempre meno uno svaligiatore, quindi a virare nel nazionalismo, nel moralismo e nella conservazione man mano che si dipanavano le sue avventure, Jacob indossava una specie di saio marrone di panno rozzo, gli zoccoli con la tomaia di cuoio, la camicia, il vestito di tela e il berretto da forzato. Un altro personaggio si delineava ormai sotto il cranio rasato: quello di Vautrin, capo dei forzati, detto Trompe-la-mort [Duro a morire, n.d.r.].
Non avrebbe vissuto che di un’unica speranza: la fuga.
E di un unico nutrimento: le lettere di sua madre, centinaia di missive arrivate a destinazione a volte con mesi di ritardo, una corrispondenza intima che durerà ventitre anni, tra quella che lui chiamava la sua “buonissima” e la matricola 34477.
“In caso di morte – precisa il regolamento penitenziario – il numero di matricola è l’unica iscrizione che si incide sulla croce di legno del cimitero. Questo numero viene costantemente portato in evidenza sul braccio sinistro”.
IV. Un quarto di secolo all’Isola del Diavolo
Nel novembre 1905, Alexandre, scortato dai guardiani della prigione di Orléans, viene rinchiuso in un vagone piombato poi agganciato al treno di Parigi. Diciotto ergastolani vi si aggiungono. Secondo treno: direzione La Rochelle. Piove. Fa freddo nella stazione. La gendarmeria, la guardia mobile e la polizia locale li stanno aspettando. Attraverso il quai Valin, il quai Duperré e la borghesissima rue du Palais, il corteo funebre s’incammina a piedi verso la prigione, situata in pieno centro cittadino. Sbarramenti di agenti bloccano la circolazione ad ogni incrocio. Un detenuto privo di una gamba, assassino di un’ereditiera, si trascina a fatica. Alexandre gli passa il braccio sotto le spalle e l’aiuta a camminare. Massaie, ragazzine, uomini eleganti osservano, con sguardo attonito beffardo o concupisciente, transitare il bestiame verso l’anticamera della morte.
Un tozzo di pane, un mestolo di minestra chiara, una notte trascorsa a rabbrividire, incatenato su un tavolaccio e l’indomani, all’alba, il corteo, ingrossato con un altro centinaio di condannati, raggiunge l’imbarcadero del battello dell’isola di Ré, il Coligny, una sgangherata caffettiera a pale. Li ammucchiano sul ponte tra un branco di porci e qualche cavallo. Appena doppiate le torri merlate di Saint-Nicolas e della Chaîne, il mare è grosso. L’onda lunga spazza rabbiosa il ponte. In pochi istanti tutti i passeggeri sono inzuppati. Parecchi vomitano. Non c’è più da scherzare. I muscoli sono contratti. Alexandre si mette a tossire.
La traversata fino a Saint-Martin-de-Ré dura un’ora e mezzo. Un cordone di gendarmi e di soldati senegalesi, fucile carico, li accompagnano poi verso la vecchia cittadella di Vauban dove tradizionalmente i forzati vengono raccolti, smistati ed immatricolati, prima delle partenze per la Guyana, che hanno luogo due volte all’anno, in luglio e dicembre. Dal 1873 al 1936, cinquantamila esseri umani sono passati di là.
Nel grande cortile rettangolare, vengono divisi in reparti. All’improvviso, la matricola 34477 sembra far nascere un problema. Il capo guardiano discute con veemenza del suo caso con i due ufficiali. Tutti gli sguardi si volgono verso Alexandre che si solleva quanto può. Fa il coraggioso. In realtà, trema di febbre.
Finalmente, lo portarono all’infermeria. Durante il percorso, lo sbirro l’ingiuria più violentemente che può. Alexandre non reagisce. Lo sbattono in una cella speciale.
Non che l’Amministrazione Penitenziaria abbia deciso di vegliare particolarmente sulla sua salute. Ma il suo fascicolo riporta la menzione “omicidio”. Errore volontario o no, ci vorranno vent’anni per farlo scomparire. Sulla copertina grigia del fascicolo, il procuratore della Repubblica ha aggiunto di sua mano: «Bandito eccezionalmente pericoloso. Da sorvegliare molto strettamente». Per maggior sicurezza, il ministero dell’Interno ha redatto una nota speciale al suo riguardo: «Questo anarchico della peggiore specie deve essere isolato dagli altri forzati. Da non disinternare per alcun motivo». Ecco perché Alexandre ha diritto ad un trattamento di favore. Egli sarà un dannato tra i dannati: prestigio assicurato tra i più demoniaci dei bruti, ma di cui egli si sarebbe volentieri infischiato, anche se, per il momento, quell’isolamento gli evita qualsiasi promiscuità.
«Basta una visita autorizzata al carcere di Saint-Martin-de-Ré – scrive il capitano della gendarmeria Pyguillem sulla “Revue de la gendarmerie” – per essere colpiti dal perfetto contegno dei condannati, dalla sollecitudine con cui si alzano e si scoprono, dal silenzio quasi monacale che regna in questi luoghi». (In un articolo dal titolo: “Concentramento ed imbarco dei condannati per la Guyana” e pubblicato in fascicolo nel 1936).
Per i visitatori, questa osservazione è certamente sensata. Del resto, il capitano stesso ne dà la spiegazione: «Indipendentemente dalla gamma delle punizioni ordinarie, sono state installate nei vari locali delle spranghe di punizione». Questo apparecchio consiste, come indica il suo nome, in una sbarra di ferro verticale, fissata davanti ad un muro. Il suppliziato, di schiena, viene inarcato, tenuto arcuato dagli anelli che inchiodano il muro caviglie e polsi. La sbarra gli entra nella colonna vertebrale. Il criminale più incallito al dolore non resiste più di un’ora al supplizio. In caso di ribellione, lo si può lasciare una notte intera in quella posizione. Viene ancora praticato, si dice, ai giorni nostri, malgrado il regolamento formale lo proibisca, in certe prigioni francesi.
«Grazie a queste indovinate misure preventive, la disciplina è generalmente buona», commenta il capitano.
Ma di notte, nonostante la regola del silenzio assoluto, gli uomini si agitano nelle gabbie. Nascono sordidi idilli. I più autoritari impongono la loro legge. I più depravati si scelgono un “amante”. Inutile che il prescelto tenti di resistere: sarà violentato, riempito di botte, ucciso, se necessario. La vita di un forzato non vale nulla: un assassinio comporta qualche mese di prigione, qualche giorno a volte, solo per il principio.
Alexandre subisce le prime prove. La perquisizione: nudo. Compreso l’interno della bocca e del retto. Poi il “barbiere” e la vestizione. Quindi si organizzano le giornate. Una mezz’ora di passeggio, in fila indiana, mattino e sera. Divieto di parlare, anche lì, come di fumare, cosa che non gl’importa nulla. Quando è chiaro, dall’alba al crepuscolo, ci sono le occupazioni più fastidiose: sfilacciare la canapa, fabbricare pantofole di cimosa, lenze da pesca, mollette per biancheria, zoccoli di legno, stracci, sacchetti di carta.
«Il regime alimentare sembra sufficiente – prosegue Pyguillem. – I pasti constano di centotrenta grammi di gallette, settecento grammi al giorno di legumi vari e poi carne il giovedì, la domenica e i giorni festivi». In realtà, il pane è ammuffito e i fagioli marci.
Il primo serio incidente avviene qualche giorno dopo l’arrivo di Alexandre. Nel momento del pasto, il detenuto incaricato di distribuire la zuppa lo fissa diritto negli occhi. Poi si raschia la gola. Un enorme sputo finisce nella gavetta piena. L’uomo scoppia a ridere. Il guardiano che l’accompagna lo imita. Alexandre stringe i denti.
– Guarda un po’ questo smidollato! – sghignazzano i due soci.
Alexandre, i pugni serrati, rimane di marmo. Uccidere un forzato, soprattutto se si è reputati pericolosi, come è per lui, sarebbe troppa gloria per quelle canaglie. Probabilmente la gerarchia li ricompenserebbe. Il suo sguardo non s’abbassa. Non dimenticherà mai quella faccia. I detenuti-guardiani, schiuma del marciume del penitenziario, sono condannati nella manica dell’amministrazione che li ha nominati guardiani supplenti.
Dei kapò. Arabi, per la maggior parte, si prendono la loro rivincita sugli “infedeli” grazie all’autorità che viene loro delegata. Oppure bianchi, come quello, della razza degli sciacalli. Delatori, vili e sadici.
I due che portano la zuppa, indispettiti dal fiasco, passano alla cella vicina, dove sta un giovane superstite dei battaglioni d’Africa. Il gioco ricomincia. Ma il giovane ingenuo non ha imparato a dominarsi. Lancia la gavetta in faccia al guardaciurma. Alexandre sente dei colpi sordi, degli urli. Poi il silenzio.
«I malati vengono curati con ogni attenzione desiderabile da un medico di servizio dello stabilimento», dice ancora il capitano. Tuttavia, qualche pagina più oltre, annota: «Lo stato sanitario in generale è soddisfacente: non si può che esserne sorpresi, a causa della elevata percentuale di malati polmonari e di malati di ogni genere».
Lo si è meno quando si legga il libro del dottor [Louis] Rousseau, Un médecin au bagne. Questo futuro amico di Jacob ha infatti rinunciato a contare i casi di tubercolotici in punto di morte, di atassici o di gente con una sola gamba ricevuti da lui in Guyana. Il fatto è che i sanitari di Saint-Martin-de-Ré non si prendono neppure la pena, per la maggior parte del tempo, di esaminare i futuri deportati: e perché mai dovrebbero farlo quando hanno a che fare con dei rifiuti della società? Si accontentano dunque di timbrare i libretti carcerari. Alexandre, da parte sua, nonostante la febbre, non s’è mai avvicinato a più di dieci metri dal capitano della Coloniale preposto all’infermeria.
Del resto, il bagno penale non è fatto per guarire, ma per punire. Ogni anno, il battello porta alla Caienna un carico di circa novecento persone. Ogni anno, settecento forzati muoiono. Se si aggiungono a questa cifra gli evasi che hanno trovato la morte cercando di fuggire, si arriva ad un sistema di sterminio assolutamente efficiente e non meno ipocrita, che permette all’amministrazione di conservare laggiù sempre degli effettivi pressappoco equivalenti, all’incirca seimila uomini. Queste cifre provengono dal signor Henri, ispettore delle Colonie. Il dottor Rousseau aggiunge una precisazione: la durata media della vita di un individuo giovane e robusto al bagno penale è, in ragione del clima e dell’alimentazione, di circa cinque anni. I forzati che Alexandre ha incontrato un tempo a bordo della Ville-de-la-Ciotat erano fortunati. Numea era un paradiso in confronto alla Caienna. È questa del resto la ragione per cui è stato soppresso il bagno penale: i contribuenti infatti hanno protestato, all’epoca, contro lo “spreco del loro denaro”. Quindi, piuttosto che migliorare lo stato delle prigioni francesi, s’è peggiorato il bagno penale. La Guyana è attualmente la ghigliottina secca: senza mannaia. Ma un’agonia nell’abiezione, il degrado, la putredine del corpo e dall’anima. La Guyana è un ascesso purulento nel fianco dell’America latina e tutte le istanze internazionali ripetono invano ai nostri ambasciatori che essa è una vergogna per il paese dei Diritti dell’Uomo.
* * *
Saint-Martin-de-Ré, dicembre 1905
Mia cara mamma.
Sono trentadue mesi che vivo nell’attesa ed ho avuto il tempo di abituarmi alla pazienza e così non mi annoio affatto. Lascio che la Terra giri e prendo il tempo così come viene. D’altronde, da qualche giorno sono solo in cella e mi trovo molto meglio. Te l’ho detto un sacco di volte, ho sbagliato mestiere. Con i miei gusti ultra-misantropici, sarei stato un perfetto cappuccino. Inutili rimpianti! Del cappuccino non ho che l’abito (il colore, naturalmente) e ben presto, non potendo portare una croce, prenderò la zappa. Sta dunque scritto che sarò demolitore anche nei paesi esotici! Oh, fatalità delle fatalità! Ecco uno dei tuoi scherzi!...
* * *
Il 22 dicembre 1905, completamente rivestito a cura dell’intendenza coloniale di Rochefort, con tascapane, gavetta, forchetta, cucchiaio, bicchiere da un quarto di litro e coperta regolamentari, con la sua razione di cioccolato nero e formaggio, Alexandre viene portato all’adunata che si tiene nel grande cortile.
Da ieri le visite sono cessate. Alexandre non ha avuto il permesso di scrivere che un’unica lettera a sua madre su foglio regolamentare, in modo da facilitare la lettura agli sbirri. Marie è stata avvertita troppo tardi della data della partenza. Per un giorno, lei non ha avuto il permesso di vederlo. Le griglie chiuse del parlatorio l’hanno bloccata.
In piedi, in colonne di quattro, sono là, ottocento, divisi in gruppi, in ordine rigoroso: quelli che partono per il continente. Caienna, Kourou; Saint-Laurent-du-Maroni e adiacenze, Saint-Maurice, Nouveau-Camp, Godebert; poi quelli delle isole dette della Salute per antifrasi, riservate agli irriducibili. La Reale, Saint-Joseph, l’Isola del Diavolo, famose per i loro pescecani. Posti da cui non si evade. Il cappellano passa per incoraggiarli a pentirsi dei loro peccati. Li benedice.
Il tono patetico del cappellano diverte alquanto Alexandre. Quest’uomo è venuto a trovarlo nella sua cella. Hanno parlato soprattutto di Mirabeau e di Henri de Rochefort, che l’hanno preceduto nei quattro metri quadrati che egli occupa.
«Ed è finita. Eccoli che si mettono in marcia, scrive Pyguillem, trasformato in benevolo cronista, nel suo stile inimitabile, superano una porta, attraversano uno stretto cammino di ronda, superano un’altra porta ed entrano nel cortile principale che precede il ponte levatoio.
«Le anime sembrano essere scomparse! Rimane solo il rumore degli zoccoli del branco e l’altro rumore, secco, metallico, che segue il secco ordine: “Caricare le armi!” lanciato dal capitano dei gendarmi.
«Preceduti dal corteo ufficiale, inquadrati dai fucili, passano il ponte levatoio e si trovano dinanzi un vecchio porticciolo. Seguono allora un lugubre viale di tamerici, poi svoltano per un sentiero erboso che attraversa il bosco della Barbette e che chiamano “il viale dei sospiri”.
«La voce del mare si mescola a quella del vento che, in questo punto, non cessa mai; e l’insieme dà alla scena un’impronta di tristezza ineguagliata.
«Arrivano al porto. Qui lo scenario cambia e anche l’atmosfera. L’agitazione è estrema, ma la si avverte, piuttosto che vederla. Le imposte chiuse lasciano indovinare l’intensa curiosità ch’esse nascondono. Alcune di esse sono persino dotate di piccoli buchi misteriosi attraverso i quali ingegnosi fotografi trovano il sistema di agire».
A nessuno è permesso stazionare lungo il cammino della colonia. Laggiù, a cento metri, una piccola buona donna dai capelli prematuramente bianchi urla a pieni polmoni. Picchia con il pugno sul ruvido cappotto di un fuciliere.
– Lasciatemi! Ma lasciatemi passare, accidenti! Bruti! Bruti! È mio figlio!
La sua voce non si sente. Marie si trova sottovento in rapporto ad Alexandre che non si volta.
Lei non comprende. Perché lo isolano come un appestato? Perché lo trattano come se fosse un selvaggio? Perché non può più accompagnarla a teatro, come in passato? Per venti anni, lei rifiuterà di capire l’irreversibilità del bagno penale.
– Non hanno nemmeno voluto lasciarmelo abbracciare! – si lamenterà nel 1925.
Si imbarcano sulle chiatte. Mezz’oretta più tardi, nella rada di La Pallice, accostano al piroscafo Loire. Uno ad uno, si arrampicano per la scaletta di ferro. Arrivati sul ponte, gettano il loro bagaglio in fondo alla stiva e discendono a loro volta.
«Maleducati (la parola è bella), tarati, degenerati, anormali, certamente; ma comunque sempre uomini e che si rendono conto in quel momento che la punizione non si può evitare (...).
«Nel penitenziario galleggiante: otto gabbie di circa cento posti ciascuna. Non manca nulla, nemmeno il riscaldamento centrale, sotto forma di canalizzazioni di vapore... a doppio uso... Questi “signori” non hanno di che lamentarsi!».
Alexandre, sempre privilegiato, viene ficcato in una gabbia speciale in compagnia di altri tre detenuti ritenuti pericolosi quanto lui. Un tubo pericolosamente grosso, pronto a scaricare vapore bollente, pende al di sopra delle loro teste.
La sera di Natale, all’incirca all’ora in cui Rose e Clarenson, riuniti per caso nello stesso furgone, arrivano al carcere di Beauvais, il Loire fa scalo ad Algeri dove vengono imbarcati i condannati arabi. Poi il bastimento riparte.
La traversata dura in tutto sedici giorni. Una mezz’ora di uscita all’aria ogni mattina, in silenzio, in piedi di fronte al mare. Bisogna approfittarne per riempirsi in fretta i polmoni di ossigeno, prima di ripiombare nel puzzo di vomito, di luridume e di muffa. All’inizio le enormi fauci si agitano. Tuonano contro la malasorte a colpi di risate provocanti. Intonano le canzoni oscene che ognuno conosce. Vociano volgarità. I più tarati danno il la. Gli altri seguono. Il vizio è contagioso. Si diffonde come la scabbia. È l’uguaglianza nell’immondo. Come resisteranno a questo trattamento ragazzi fini e sensibili come Bour e Baudy?
Alexandre si ostina nel suo silenzio. Egli osserva di sottecchi. I suoi compagni di gabbia vogliono fare cagnara con lui. Uno sguardo, un sorriso bastano a scoraggiarli. Con la fama che ha, preferiscono non insistere.
Il calore umidiccio di serra ammorbante aumenta con il passare dei giorni. I duri giacciono nel loro brodo, a bocca aperta, cercando un improbabile alito d’aria. Il 16 gennaio, il ritmo dei motori rallenta. Si tocca terra. Alexandre viene trasbordato su un vaporetto che assicura il collegamento tra il continente e le isole. Lo lasciano dapprima all’Isola Reale, centro amministrativo, ospedale e laboratorio delle isole; poi lo trasferiscono a Saint-Joseph, il centro in cui la disciplina è più feroce e a cui, ovviamente, è destinato. L’Isola del Diavolo, dove soggiornò il capitano Dreyfus, è riservata ai deportati politici. Gli anarchici considerati come condannati comuni non vi hanno accesso.
All’inizio, una visione paradisiaca. Una vegetazione lussureggiante. Alberi di cocco. Un mare azzurro. Un sole di piombo fuso. Non è quel forno della Caienna: quando piove, a ciclone, il vento del mare spazza via i miasmi. A questo riguardo, sono piuttosto favoriti rispetto al contingente destinato a Saint-Laurent. I parassiti formicolano di meno: culici, zanzare, mosche con le zanne, mosche senza ragione, mosche di Caienna, pulci (quei piccoli vermi neri che bucano la pelle per depositare le loro uova sotto la pianta dei piedi), zecche, pulci di aguti, formiche-manioca, ragni-granchio, tarantole, millepiedi grossi un dito, scorpioni, serpenti di ogni misura e di ogni specie, caimani; tutto ciò che brulica, succhia e pizzica sul continente, qui manifesta minore virulenza. Ad ogni modo, i pescecani compensano largamente.
Nel momento in cui la scialuppa tocca terra, una piccola imbarcazione esce dal porto. A bordo, tre uomini, due forzati che remano ed un guardiano che agita una campanella. Giunta a poche braccia da riva, la barca si ferma. Una specie di bara fatta di assi sconnesse viene gettata in mare. Immediatamente, da ogni parte, si precipitano gli squali. Strappano le assi; il cadavere del forzato scivola in acqua. È un vorticare di pinne. In pochi minuti, non rimane nulla di quel che era un uomo. I becchini dell’Oceano hanno fatto il loro dovere. In fondo, questa soluzione igienica evita le epidemie.
Poi si arriva. Alexandre prende conoscenza del suo nuovo luogo di residenza offerto dallo Stato francese che rischia di essere l’ultimo. Un recinto fortificato. Un litorale molto ripido, che porta al campo, costituito da due file di baracche rettangolari. Ognuna è lunga venticinque metri e larga sei. Da sessanta a settanta individui si ammucchiano in ogni baracca ed ognuno dispone al massimo di ottanta centimetri per mettere le sue spalle e le braccia. Il soffitto è costituito da lamiera ondulata, senza naturalmente alcun isolamento termico.
È mezzogiorno quando Alexandre depone il suo sacco sul pancaccio che un secondino gli indica. Per lui niente minestra: la distribuzione, era avvenuta alle dieci. Poi, c’è la siesta. O piuttosto l’ora del forno quotidiano. La temperatura varia fra i trenta e i cinquanta gradi all’ombra. Si appiccica tutto. Gli uomini sudano, sbuffano e si lamentano.
Ad Alexandre viene assegnato un lavoro: tagliare pietre in una strada per riparare il molo danneggiato. Poi, lo manderanno a costruire qualcosa. Poco importa che cosa. Nessuna attività è realmente produttiva. Si affrontano sempre i problemi più urgenti. Si contende alla giungla lo spazio che questa invade. Si ripara il tetto abbattuto da una tempesta. Si pesca con la lenza per apportare un supplemento al menù. Il bagno vive in autosufficienza. I suoi inventori pensavano, inviando mano d’opera gratuita sotto i tropici, di potere favorire la colonizzazione. È invece accaduto il contrario. Gli emigranti volontari in cerca di fortuna sotto i tropici, spaventati (a ragione) per la vicinanza dei forzati, non sono venuti numerosi come in Indocina o in Algeria. Da parte sua, l’Amministrazione Penitenziaria, la temibile Tentiaire, non ha prodotto nulla. Su quattromilacinquecento deportati presenti nel 1910, tenuto conto dei moribondi, degli inabili, dei puniti, dei malati, degli imboscati utilizzati come domestici presso i privati, dei secondini, degli impiegati del servizio amministrativo, solo millesettecento sono adibiti a costruire qualche cosa: una linea telegrafica, la ferrovia del Maroni, la strada coloniale n. 1, soprattutto, un bell’esempio di realizzazione, ventiquattro chilometri sono stati dissodati in sessant’anni, al prezzo di settanta forzati al mese; diciassettemila morti, solo in due punti: al chilometro 24 e al chilometro 36. Caduti perché non mangiano quant’è la loro fame e non hanno più forza di sollevare il piccone. Perché le febbri, senza chinino, li abbattono come mosche. Perché non hanno nemmeno scarpe: “Quando ne avevano, le vendevano”, dice l’Amministrazione. I loro piedi nudi sono piaghe aperte, monconi consumati da cancri di ogni sorta.
Il rendimento è insignificante a quel prezzo. I deportati di Mauthausen, del resto, conobbero questo tipo di metodi ed Hitler per organizzare i suoi campi non ha che ricopiato l’esempio che abbiamo offerto noi per cent’anni.
Nelle settimane che seguono al suo arrivo, Alexandre si rende conto del posto e della gente. Un’ossessione lo punge: la fuga. Fare quel che nessuno (o quasi) è mai riuscito a fare partendo dalle isole. Ma come, visto che non lo lasciano solo neppure un istante e che, egli immagina, delle spie sorvegliano i suoi gesti?
Il primo compito, il più urgente, è di farsi rispettare. Tra gli anarchici deportati a Saint-Joseph per avere troppo messo in pratica il recupero individuale o troppo maneggiato gli esplosivi, egli non conta che amici. È un eroe. Ci pensano loro a difendere la sua fama presso gli altri. Tuttavia, il suo atteggiamento, all’inizio, gli nuoce, come al tempo in cui imparava il mestiere di marinaio: egli non beve, non fuma, non gioca; rifiuta di lasciarsi contaminare dalla pederastia.
Orbene, ogni sera, una volta chiusa con il catenaccio la porta della baracca dal porta-chiavi (è così che chiamano i secondini), mentre uno di loro sta di guardia, i forzati cominciano la loro vera vita. Le coppie si abbracciano. Alcuni sono “sposati” quasi ufficialmente, con la tacita benedizione dei sorveglianti. I secondini arabi prendono parte a questi giochi. A volte, il capo del campo offre agli sposi persino la possibilità di costruirsi un “carbet”, una capanna di lamiere, di fogliame e di pezzi di legno, dove essi possono isolarsi. Il rhum non stagionato, la tafia, eccita le passioni. I drammi della gelosia si susseguono, lotte a morte, con il coltello, tra due compagni di pena, per i begli occhi di un giovane.
Del resto, qualsiasi occasione è valida per sventrarsi: uno ha creduto di vedere una pulce sulla spalla del suo migliore amico. L’altro accusa un terzo di averlo derubato o guardato di traverso.
Questi litigi avvengono nel limitato corridoio tra le tavole che fungono da letti, in un’atmosfera elettrizzata. L’indomani mattina, quando la ciurma scopre il cadavere, nessuno ha visto né sentito niente. Nessuno sa nulla. L’Amministrazione si accontenterà di dare alla baracca una leggera punizione collettiva: dopotutto, vuole dire un forzato di meno.
Se una spia denuncia il colpevole, pagherà con la vita.
Perché se le discussioni personali, provocate dal furto o dalla gelosia o dall’imbroglio si regolano “in via amichevole”, tra gli interessati, l’“alto tradimento” (tradimento riguardo al personale della Tentiaire, s’intende) coinvolge la collettività nel suo complesso. È passibile di Corte marziale. In ogni campo esiste un tribunale occulto, composto da un capo e da una giuria. I suoi verdetti sono inappellabili. Le pene vanno da uno o due colpi di coltello alla morte. La giuria designa un esecutore che non ha il diritto di rifiutarsi, se non vuole vedere applicare su di sé la stessa pena del colpevole.
Unica generosità di questo codice rudimentale: l’eventuale condannato ha la possibilità di scegliersi il suo modo di esecuzione, la lama o il veleno. Le lame, ognuno ne possiede una: coltelli a serramanico fabbricati dagli anziani e venduti a tre o quattro franchi l’uno, o stiletti d’acciaio, realizzati da un forzato in un laboratorio, sotto lo sguardo del guardiano e del secondino che avranno parte del ricavato della vendita. Neppure il veleno è difficile da procurare: basta andare nella giungla e staccare una radice di barbadina, di Datura stramonium o rivolgersi all’infermiere, sempre dietro pagamento, per acquistare un po’ di Hura crepitans polverizzata; è rapida e non lascia traccia, neppure all’autopsia.
Ma il passatempo preferito di quelle notti d’incubo è il gioco: marsigliese o tre carte, accovacciati a terra, con un mazzo sbocconcellato, alla luce di una lanterna cieca. Che cosa si giocano? Gli spiccioli che stanno nel loro “forziere” personale consistente in un tubo di alluminio lungo sei-otto centimetri, composto da due parti che s’incastravano ermeticamente, come un astuccio di termometro e che si nasconde nell’ano.
È il tesoro personale. Si sbudella di buon grado e si fruga tra la viscere per procurarsene uno. Gli infermieri, con grandi pedate nel ventre, recuperano quello del malato che è morto tra le loro braccia. L’uomo affetto da dissenteria trema per la sua ricchezza: non può più conservarla. Deve interrarla da qualche parte, accuratamente avvolta in uno straccio imbevuto d’olio. Lì, molto spesso, avviene il dramma: un topo rosicchia il tessuto; l’oggetto diventa visibile; qualcuno lo ruba; le lame escono di nuovo.
Quanto al denaro, esso ha due origini: i vaglia inviati dalla famiglia, dopo che i guardiani ne hanno prelevato almeno la metà (questo furto legalizzato è entrato nell’abitudine); oppure una moltitudine di piccoli traffici, imbrogli, intrighi di ogni genere, sul tabacco, il cibo, la tafia, i coltelli, i veleni, sempre con la complicità dei guardiani.
Tutto ciò è rivoltante per Alexandre, come lo rivoltavano i proprietari dei castelli. Egli rifiuta di partecipare a questi furti infimi ed infami. Mentre gli altri ansimano sbattendo le loro carte, pronti a sgozzarsi per un mezzo luigi, egli legge con avidità quelle pagine delle opere ordinate a Marie che l’Amministrazione non gli ha confiscato. In pochi anni, la sua cultura diventa immensa. Jean Normand, professore di diritto, che fu suo compagno di gavetta per quattro anni, lo testimonierà in seguito, nel suo libro Les Mystères du Bagne: «Jacob riceve periodicamente il “Mercure de France”... Egli medita sulla letteratura con Jean de Gourmont, Rachilde, ecc. Studia le arti con Georges Kahn, il teatro con Henri Béraud, i giornali con De Bury, l’attualità giudiziaria con Renaud, la storia con Barthélemy, i problemi militari con Jean Morel e le scienze con Bohn». Adesso è alle prese con Malebranche, che non è censurato («Inviami, se puoi, la Recherche sur la Vérite di Malebranche. Filosofo cartesiano, metafisico, spiritualista, l’autore è un benpensante e forse, credo, classificato tra i migliori moralisti. A questo titolo, l’opera mi sarà consegnata»). A scanso di errori, perché gli avevano appena confiscato i suoi Nietzsche.
Ma soprattutto fa i suoi primi passi nella giungla del diritto penale ed amministrativo. Disprezza comunque quella che alcuni chiamano giustizia. Ma non è più in una posizione di forza: deve giocare d’astuzia. Se vuole sopravvivere ai tranelli che gli tende questa “giustizia”, che conta sulla sua ignoranza, bisogna che ne apprenda i trucchi per trarne vantaggio. I furbi sfruttano il codice per fare fortuna. Lui, il puro, se ne servirà perché costretto e obbligato, per rivendicare il suo diritto a non essere d’accordo e a respirare. Prima, si batteva dall’esterno attaccando le fortezze dei ricchi. Questi l’hanno gettato nel dimenticatoio. Uscirne è un desiderio legittimo. Ma anche un dovere: per testimoniare e combattere di nuovo. Per vivere, in modo esemplare, contro.
Come un tempo ha studiato le correnti marine tra il baccano dell’alloggio dell’equipaggio, adesso s’accanisce sui manuali: “Ho studiato diritto penale per conoscere bene le regole e le leggi e violarle meglio”, dirà un giorno.
E all’avvocato Lafont, l’ex difensore di Alcide Ader, scriverà: «C’è forse una punta d’ironia da parte vostra nel trovarmi tanta competenza ed una reale conoscenza del diritto penale francese e straniero. Permettetemi di rispondervi senza alcuna immodestia che, da autodidatta, ho studiato diritto con Garraud, G. Vidal, Cruche [cruche: tondo, stupido, n.d.t.] (scusate, Cuche!), Tarde, Lombroso, Garofalo, Enrico Ferri, Garçon, Hugueney, Maxwell, Beccaria, Bentham, De Rossi, Von Litz, Prius, van Hamel, che cito alla rinfusa e altri autori che dimentico».
A poco a poco, malgrado il suo rigore morale che preoccupa qualche capoccia, la sua personalità si impone nella “baracca rossa”. Ha parecchie buone carte in mano: il suo atteggiamento intransigente con il “nemico”, ossia chiunque, piccolo o grande, rappresenti l’Amministrazione; la sua onestà (“eccessiva”, dice Normand), il suo imperturbabile buonumore, il suo senso della battuta, il suo coltello, i suoi amici anarchici e il suo senso di solidarietà.
Questa fu la causa della sua prima punizione, nel luglio del 1906. Un suo compagno di reclusione gli chiede di stendere per lui un reclamo contro un guardiano particolarmente abietto, lui fa con la sua abituale vena, puntellandosi con la lettera del regolamento: otto giorni di reclusione cellulare. Fa allora conoscenza con il temibile supplizio. Una cella di un metro e quaranta di lunghezza per due metri di altezza. All’inizio non si può stare che accoccolati, mai allungati. Per dodici ore, delle catene fissano i piedi ad una sbarra di ferro, mantenendo così il punito sulla schiena, senza possibilità di girarsi; le altre dodici ore, deve tagliare manici di scopa. O più in generale dedicarsi ad un lavoro sistematicamente inutile, fatto per provocare nel colpevole un “sentimento di sfinimento morale”. Per nutrimento, pane e acqua. La cella non ha soffitto: questo è sostituito da grate sulle quali cammina la guardia.
Terminata la settimana, Alexandre si vede promosso guardiano della baracca: è ora responsabile degli avvenimenti notturni. Se c’è un omicidio, lui pagherà per il colpevole ignoto. Se interviene in una rissa, sarà a suo rischio e pericolo.
Questa disposizione si ritorce contro l’Amministrazione: Alexandre acquista un ascendente maggiore sui suoi compagni di pena. Diviene il giudice di pace, l’arbitro dei conflitti, il consigliere giuridico e soprattutto l’uomo dalle idee: ne ha per qualsiasi occasione. Tanto che una nuova “banda Jacob” si organizza e si dà da fare per farlo nominare cuciniere, nella speranza che la sua onestà, la sua astuzia e la sua audacia permetteranno agli infelici occupanti delle baracche, ultima maglia di una lunga catena in cui ognuno arraffa e prende a volontà, di mangiare un po’ più decentemente.
A stare al regolamento, come a Saint-Martin, il cibo è accettabile: carne fresca o conservata, oppure lardo a mezzogiorno, con un mezzo litro di brodo; riso o legumi secchi con un altro mezzo litro di brodo per la cena, che avviene alle cinque del pomeriggio. Oltre a settecentocinquanta grammi di pane per la giornata. In realtà, quando la roba non è avariata, cosa che capita spesso, resta appena un terzo di tutto ciò nella gavetta del condannato.
In cucina, Alexandre scopre senza troppa sorpresa i diversi meccanismi della frode: per il pane, il forzato incaricato del forno aggiunge quanta più acqua possibile alla farina e rivende quel che ha rubato, dividendo il ricavato con i guardiani. Per il caffè, stesso metodo. Per la carne, il traffico parte da più in alto: i manzi, spediti vivi dal continente, devono avere tutti un peso stabilito. In effetti, non essendoci bilance sull’isola, non c’è possibilità di controllare. Ancora fortunati quando l’animale non ha il carbonchio, come il dottor Rousseau riferisce essere avvenuto parecchie volte.
Per quel che è di sua competenza, Alexandre fa cessare i traffici. Non tutti ne sono soddisfatti. Un secondino minaccia di ucciderlo. Alexandre alza le spalle. L’altro, furioso, approfittando del momento in cui Jacob è girato, nasconde nei suoi effetti personali una uniforme da guardiano che lui stesso ha rubato, quindi lo denuncia al sorvegliante Venturini per furto e tentativo di evasione. Alexandre se ne avvede in tempo e si sbarazza dell’ingombrante regalo. Venturini, uno dei rari guardiaciurma onesti dell’isola, prende le sue difese. Il secondino viene cambiato. Il cibo migliora un po’. Il prestigio di Alexandre cresce.
Qualche giorno dopo, arriva Hespel, seguito dal suo aiutante. Hespel, forzato con funzioni di boia, è talmente detestato che ha il diritto del tutto straordinario di portare un revolver. Egli reclama doppia razione: è la tradizione. Alexandre rifiuta: non è nel regolamento. Gli occhi di Hespel lampeggiano. Nessuno ha mai osato fargli uno scherzo simile. Se non ci fossero testimoni, sicuramente avrebbe fatto fuori Alexandre con la scusa che è stato lui a volerlo aggredire.
– Questa me la pagherai! – ringhia.
L’indomani, il suo assistente arriva da solo per avere le loro due razioni. Tende un recipiente. Macchinalmente, nel momento di versarvi la minestra, Alexandre vi getta un’occhiata. C’è un po’ di liquido ocra sul fondo. In un lampo, capisce: è della barbadina. Hespel vuole fare credere che Alexandre ha cercato di avvelenarlo.
Farabutto! – ruggisce. – So perfettamente che cos’hai versato dentro!
Si avvicina Venturini. Vedendoli, anche lui capisce. Freddamente Alexandre versa il veleno per terra.
– Pezzo d’idiota! – urla Venturini. – Potevi farlo arrestare! Con il fascicolo che hai tu, se il suo piano funzionava, eri pronto per la forca!
Me la sbrigo da solo – replica Alexandre.
Questo episodio fa il giro dell’isola. Alexandre diventa una specie di cacicco. Un anno dopo il suo arrivo, è ormai uno dei più incontestati di Saint-Joseph. I capoccia sono costretti a rispettarlo: potrebbero avere bisogno dei suoi consigli giuridici. I deboli implorano la sua protezione. I secondini lo spiano. Lui ha un occhio per tutto. Lo consultano per ogni problema. Diventa estremamente imbarazzante per l’amministrazione: il comandante Michel, direttore delle Isole della Salute, lo fa da allora in poi rinchiudere ogni notte in una cella isolata, la catena al piede. Alexandre spedisce lettere di protesta al direttore del penitenziario; Marie si dà da fare a Parigi: in base a quale articolo di quale regolamento si può punire un forzato senza motivo? Michel lo deve rilasciare. «Io che, nelle Isole della Salute, conoscevo simultaneamente più di mille forzati con il loro nome e numero di matricola, i loro meriti e le loro tare – scrive il comandante – sono stato messo nel sacco da uno di loro. Per anni mi ha tenuto testa. Lo consideravo alla fine come un pericoloso nemico di me stesso e della società. Bisognava abbatterlo o essere abbattuti da lui. Si tratta di Jacob, il capo dei Lavoratori della notte, quello che ispirò il romanziere Maurice Leblanc per il suo eroe, Arsène Lupin. Jacob, un personaggio degno di entrare nella leggenda.
«Quell’uomo non aveva bisogni, ma aveva troppo orgoglio. È lui che, dal bagno, scrisse a sua madre: “Quando si può affermare che non s’è mai tradito nessuno e s’è sempre rispettata la parola data, questo vale ben più delle vane lodi altrui”».
Tra il comandante e il forzato nasce una guerra feroce e subdola. “Si temeva che un simile capobanda, un organizzatore dotato di tale carattere freddo e astuto potesse riuscire a trascinare tutto un penitenziario in una sanguinosa rivolta”, prosegue il comandante, «Il seguito degli avvenimenti dimostrò che questo timore non era infondato».
Il comandante lo fa nuovamente rinchiudere per precauzione. Non riesce tuttavia ad impedirgli di comunicare con gli altri: «Ed è lui, l’uomo rinchiuso in una gabbia, a divenire uno dei capi più pericolosi tra i condannati relegati sulle isole», confessa.
Forzato di ultima categoria, che non s’è però osato inviare nell’atroce Charvein con gli altri “incorreggibili” per paura che li possa contaminare, Alexandre si ritrova nel 1908 nello stesso tipo di situazione di quando aveva vent’anni: solo contro l’intera società. Per la stessa ragione: un’allergia morbosa per l’ingiustizia.
Robin Hood arrostito alla Caienna. La società industriale non ha il tempo di ascoltare quelli che la rimettono in discussione; essa non li decapita neppure, li usa. I suoi metodi nei riguardi di Jacob sono traducibili in queste cifre: quasi nove anni di segregazione o di cella di punizione; sette processi dinanzi al Tribunale Militare Speciale di Saint-Laurent-du-Maroni, da cui in ultima istanza dipendono i deportati: sei assoluzioni. Una sentenza annullata dalla Corte di cassazione. Diciassette evasioni. Tutte prove nel corso delle quali Jacob manterrà lo stesso brio, la stessa dignità, la stessa spettacolarità di cui questo brano di una lettera datata gennaio 1908 e scelta a caso dà un’idea:
«Mia cara mamma, certo che fai bene a raccontarmi le vicissitudini della tua vita. Se non ti sfoghi con me, con chi lo puoi fare? Non sono io quello che ne è più toccato?
«A volte, ti ho forse scritto un po’ bruscamente quando, ammalato, devastato dalla febbre, abbattuto dalla dissenteria, tendevo ad un pessimismo un po’ esagerato... Tu sei abbastanza infelice, senza che io aumenti ancor più le tue pene...».
Marie, dopo la liberazione, guadagna sei soldi all’ora come sarta su misura, presso la signora Bouillot, una simpatizzante che presto diverrà un’amica. Quale migliore smentita a quelli che potrebbero supporre che suo figlio ha nascosto un tesoro?
Riceve due tipi di corrispondenza da Alexandre: quella ufficiale, che la Tentiaire spulcia e di cui lei deve comprendere a mezze parole i brani compromettenti; e poi, a volte, tramite un condannato meno sorvegliato, delle lettere più precise, cifrate, nel caso in cui cadessero in mani estranee. Attraverso queste ultime lettere, Alexandre nel 1907 la incarica di mettere in piedi un’operazione di cui Malato si offre immediatamente di essere il principale esecutore.
Neppure Charles Malato, dopo Amiens, è rimasto con le mani in mano. È stato in particolare coinvolto nell’attentato commesso all’angolo tra rue de Rivoli e rue de Roham il 31 maggio 1905 contro il giovane re di Spagna, Alfonso XIII. Due bombe che hanno provocato diciassette feriti, una sinistra macchinazione, in cui il ruolo della polizia rimane oscuro, ma che l’ha condotto dinanzi alle Assise. Lucien Descaves, Vaughan, ex direttore de “L’Aurore”, Henri Rochefort e Aristide Briand, tra gli altri, sono venuti a testimoniare in sua difesa e il procuratore Bulot, con rabbia, ha dovuto rassegnarsi all’assoluzione. Alexandre gli scrive quando può e, da parte sua, il militante dà di quando in quando una mano a Marie.
Il progetto del deportato sembra logico: giacché l’evasione di un internato nelle isole è troppo aleatoria, si dovrà procedere per tappe:
1) Passare in “prima classe”. Un decreto del 18 giugno 1880 dispone che vi si acceda automaticamente quando non si sia incorsi in condanne da diciotto mesi. Alexandre dovrà dunque fare in modo di star tranquillo per il tempo necessario.
2) Richiedere in seguito che gli venga attribuita una “concessione”, un pezzettino di terra da dissodare da qualche parte in un’isola. Pini, l’anarchico del gruppo degli Intransigenti, condannato a vita nel 1890 per aver messo in pratica l’esproprio individuale e sostenuto il diritto a farlo, ne ha ottenuta una, cinque anni prima. Comunque è una cosa che viene accordata solo a titolo eccezionale.
3) Alexandre si sposerà nel frattempo con una ragazza di cui sosterrà che era fidanzato da sempre (non importa chi, eccetto Rose, naturalmente, che, anche se uscisse in tempo da Beauvais, sarebbe troppo sospetta). Questa sposa volontaria lo raggiungerà, la tradizione vuole che l’Amministrazione non possa rifiutare una concessione ad un “prima classe” che viva con la moglie.
4) A partire da quel momento, costruire tranquillamente una zattera approfittando della solitudine della boscaglia. Vi si carica un barile d’acqua e uno di lardo, si fabbrica una rozza vela, si mette prua verso Nord-nord-est per tre giorni fino a raggiungere la corrente dei Caraibi e gli alisei che permettono di doppiare la Guyana olandese e inglese che vi restituirebbero all’Amministrazione. Si raggiunge il Venezuela, la Colombia o l’America centrale ed è la libertà! Duval, il militante della “Panthère des Batignolles”, il precursore in materia di recuperi, deportato anch’egli a Saint-Joseph non ha proceduto diversamente per la sua fuga. Adesso trascorre giorni pacifici tra i compagni di New York con la sua compagna. E Duval, contrariamente ad Alexandre, non era nemmeno un marinaio provetto.
Tutto comincia benissimo. Alexandre evita le punizioni. Da parte sua, Malato scova la moglie nella persona di una compagna di origine russa, Olga K., entusiasta all’idea di dedicarsi alla causa favorendo la liberazione del celebre Escande. Il denaro per il suo viaggio viene ottenuto con una colletta tra i gruppi parigini. Olga non aspetta che il segnale di Alexandre per andarlo a raggiungere.
Ahimé! La tranquillità dell’anarchico, invece di rassicurare i guardiani, appare sospetta. Un giorno di maggio 1908, perquisiscono l’angolo in cui dorme. Trovano una lettera cifrata sotto un’asse, i servizi di decifrazione la decrittano: il piano viene scoperto. Il ministro delle Colonie e quello dell’Interno vengono messi in allarme. Il capo della Sûreté conduce un’inchiesta. Manda i suoi segugi ad indagare su Marie, sulla sua padrona ed amica, la signora Bouillot e su Malato. Ma costoro hanno seguito alla lettera le istruzioni di Alexandre e, malgrado gli indizi raccolti, non si può dimostrare nulla.
Quanto a lui, il capo del campo si contenta di appioppargli quattro giorni di prigione notturna per “infrazione al regolamento” prendendolo in giro:
– Non ce l’hai fatta. Era pietoso, il tuo piano. Anche se la tua Olga fosse venuta a raggiungerti, non ti avrebbero rilasciato, con il fascicolo che hai! Andiamo, Jacob! Categoria A, aggiunta alla Categoria B, internato per omicidio! Anche dopo diciotto mesi di buona condotta, niente rilascio per un mascalzone del tuo genere. Tu creperai qui.
Jacob è indignato. Chiede a Marie di andare a trovare l’avvocato Lafont perché presenti ricorso per violazione di doveri d’ufficio presso la Corte suprema. Predica a più non posso la rivolta ai suoi codetenuti. Li tiene con il fiato sospeso per notti intere, raccontando quel che sarà il nuovo mondo libertario, senza giudici, senza gendarmi, senza spie, senza ladri e senza derubati. I condannati fanno domande:
– Ma allora avrò il diritto di ammazzare il secondino senza essere punito?
– Non lo farai, perché non ci saranno secondini.
Il tempo gli pesa. Per un anno intero s’è nutrito di speranza per quel progetto. Era un’utopia. Bisogna rassegnarsi all’azione diretta, con tutti i rischi che ciò comporta. Ma la cosa è impossibile senza l’aiuto di altri complici meno sorvegliati di lui.
Convince quindi tre “prima classe” a tentare la fuga con lui. Su sue istruzioni, costoro costruiscono una specie di zattera di tronchi di banano. Un’asse come timone. Un palo come albero. Dei sacchi per vele. Un barile d’acqua e un barile di lardo.
Nel settembre 1908, Alexandre sega le sbarre della sua baracca, ritrova i suoi accoliti e si dirige verso la “Pietra Piatta”, un grande scoglio che si protende sull’acqua a Nord dell’isola e da dove devono partire. Là, la malasorte vuole che essi s’imbattano in due secondini abbracciati. Alexandre estrae il pugnale. Gli altri tre tergiversano. Gli arabi giurano di tacere se egli li lascia vivi. Ma niente evasione: li comprometterebbe. Alexandre non crede ad una parola di quell’accordo tra furbi. I suoi compagni sì. Gli è dunque giocoforza riporre il suo pugnale.
L’indomani mattina, lo trasferiscono all’Isola Reale: è condannato a trenta giorni di segreta. Non conosce ancora la segreta. Un buco, o meglio una bara, grande appena quanto il corpo. L’oscurità assoluta. Una minuscola apertura rasoterra per lasciare passare l’aria. Le caviglie chiuse negli anelli situati alle estremità di una sbarra di ferro. Sotto il corpo, un’asse dura, che dilania la schiena. Ogni giorno due interruzioni a quel supplizio, di cinque minuti ognuna, per orinare. Alimentazione: due giorni su tre pane secco e acqua. Quando si esce vivi di là, si assomiglia ad una lumaca, non ad un uomo.
Per un mese, Alexandre ripete le frasi di Stirner, Nietzsche e Bakunin che conosce a memoria. Rivive le sue spedizione nelle chiese e nei castelli. Ne valeva la pena? Sì, cento volte. Per l’esempio e per la speranza. Un giorno, ce la farà a fuggire e ricomincerà in altro modo, più abilmente. Gli orrori che l’attorniano, che in ultima analisi sono il prodotto della società stessa, sono un motivo supplementare per trasformare il mondo. Un pensiero lo sostiene: Marie, che si sacrifica, che pensa a lui senza posa, che invia suppliche e domande di grazia a tutti coloro di cui sente parlare, ministri, procuratori o presidenti della Repubblica.
Egli tossisce. Lo riassale la febbre. Lo tirano fuori dalla sua tomba su una barella per depositarlo sul battello di Saint-Joseph e, da là, all’infermeria. Una piccola baracca molto graziosa, dall’esterno, con i muri di mattoni e la sua tettoia di tegole all’ombra di un mango e di un albero del pane.
Ma l’interno assomiglia ad una specie di grande bidone della spazzatura dove agonizzano resti di esseri umani. Due lebbrosi gemono e urlano in un angolo, con della tela di sacco sulle piaghe purulente: non esistono medicazioni. Ancora meno medicine. E quand’anche ci fossero, piuttosto che somministrarle ai pazienti, gli infermieri, appena andatosene il medico, le venderebbero per accrescere il gruzzolo. Invece, le razioni alimentari sono doppie.
In pochi giorni, egli ricupera miracolosamente la salute. C’è del resto qualcosa di misterioso nel fatto che quest’uomo malato sia sopravvissuto per vent’anni a delle prove fisiche che hanno avuto ragione di gente ben più vigorosa.
Ogni dimesso dall’infermeria ha diritto a qualche giorno di convalescenza in relativa libertà. Ma non Alexandre. L’ordine però non è stato trasmesso al guardiano capo Colombani che prende servizio quel mattino. Per un’intera mattinata, egli può quindi gironzolare pacificamente sulla riva del mare. Un lusso sconosciuto da molto tempo. Una buona occasione inoltre per meglio rendersi conto della topografia del luogo. All’improvviso, su degli scogli lontani da ogni passaggio, intravede una figura. Conosce quel volto. Il suo cuore sobbalza. I pugni si serrano. Affronta l’uomo.
– Ehi, tu! – fa lui – tu non eri il secondino a Saint-Martin nel dicembre 1905?
– Ma no, ti sbagli – farfuglia quello. – Sono arrivato qui nel 1903.
Alexandre guarda il numero di matricola inciso sul braccio del forzato. È proprio lui, quello cha ha sputato nella sua gavetta. Il luogo è deserto. Fa un balzo. Estrae il pugnale. Lo crivella di colpi; gli spacca la testa sulle rocce, poi getta il corpo in mare. I pescecani faranno il resto.
A mezzogiorno, il guardiano capo, finalmente avvertito che il temibile 34477 gira senza sorveglianza, lo rinchiude nella sua baracca. La sera, il secondino risulta assente. L’indomani mattina, un forzato incaricato della pesca scopre dei resti di carne umana. Li utilizza come esca.
– Bah! – conclude un guardiano a mo’ d’orazione funebre. – Sarà scivolato sugli scogli. I pescecani l’avranno preso.
Due mesi dopo, in novembre, ecco il terzo tentativo di evasione. Alexandre è ritornato all’infermeria per quattro giorni. Tre malati, che già vi si trovano, hanno preparato tutto per la fuga. Egli si unisce a loro. Un tunnel è scavato sotto il muro della baracca. Ancora una volta sono stati raccolti i viveri e sacchi per la vela. Ed anche un’uniforme completa da guardiano, compresi i kepi, preziosissimi nel caso in cui le correnti li avessero sbattuti verso il continente: un guardiano seguito da tre forzati non sarebbe stato sospetto. Rimane da costruire la zattera. Sarà l’affare di una notte.
Nel momento di uscire all’aria libera, Alexandre crede di sentire dei rumori. Si mette il sacco sopra la testa. Una gragnola di colpi di sciabola attraversa da parte a parte il sacco. Qualcuno ha fatto la spia. Quel qualcuno la pagherà. Nel frattempo, Alexandre viene rispedito nella segreta per due settimane soltanto, perché l’inchiesta non riesce a dimostrare la sua effettiva partecipazione.
* * *
Richiesta al signor Ministro della Giustizia
È una madre spezzata da eccezionali dispiaceri che sollecita presso la Vostra Alta Clemenza la grazia per il suo infelice figlio, Alexandre Jacob. Vorrei abbracciare mio figlio prima di morire, giacché sono prematuramente invecchiata e profondamente malata in tutto il mio essere. (...)
Ritengo che mio figlio sia una vittima, mio figlio che è sempre rimasto il più affettuoso, il più devoto, il migliore dei figli e che cominciò come il più serio e il più onesto dei lavoratori.
Una vittima innanzitutto di suo padre, mio marito, alcolizzato violento e pigro che non s’occupò mai dell’educazione di nostro figlio, lo martirizzò, obbligandolo così ad allontanarsi da casa dall’età di undici anni. Poi, questo povero piccolo, abbandonato, fu una vittima delle compagnie ch’egli aveva dall’età di sedici anni. Si abusò agevolmente della sua tendenza all’esaltazione, alla generosità morbosa e al suo gusto della lettura delle scienze e dei problemi sociali.
La nostra storia, sua e mia, è veramente pietosa. A diciassette anni, a Marsiglia, egli ha cominciato a conoscere il tremendo ingranaggio delle pendenze con la giustizia. (...)
Oggi, mi mantengo con lavori di sartoria, quando la malattia non mi abbatte... Voglio vivere di speranza...
* * *
La dissenteria non si attenua. Alexandre si vede costretto ad affidare il suo piano a Ferrand, matricola 34724, che è stato destinato alla sua stessa baracca e che ha preso del tutto naturalmente le funzioni di suo braccio destro. A questo piano egli tiene molto, giacché oltre ad un enorme gruzzolo di ottocento franchi, somma strabiliante per il bagno, esso comprende anche, come riferirà più tardi il dottor Rousseau: “Una canna di chiave in tre parti, dieci congegni che possono aprire quaranta tipi di serrature, una piccola cesoia a cinque lame per sega da metallo”. Il necessario per aprire la cassaforte del direttore del bagno senza bisogno di alcun altro strumento, come egli farà per sfida, quando costui, avendo perduto le sue chiavi, glielo chiederà.
Ferrand nasconde il materiale in un pezzo di sapone. Questo viene rubato. Alexandre sospetta immediatamente di un certo Ferranti, alias Capeletti, «una delle menti più losche che abbia conosciuto», secondo la testimonianza di un altro forzato di nome Antoine Mesclon, che ha scritto le sue memorie (Comment j’ai subi quinze ans de bagne, Paris 1931), «oltretutto gran spadaccino, il coltello sempre sguainato e che cercava qualsiasi occasione per seminare il terrore. E poi, invertito, attivo e passivo, soprattutto passivo. Come circostanze attenuanti: era entrato da bambino, verso i sette o otto anni, credo, nelle case di correzione, dov’era rimasto analfabeta».
Tutta Saint-Joseph odia Ferranti-Capeletti e questi non deve che alla sua ferocia velenosa di non essersi ancora fatto “bucare”. Egli ha denunciato Pellegrin, che è stato ghigliottinato per sua colpa. Viene sospettato di avere avvelenato due forzati con la Datura stramonium. Il suo vero posto sarebbe in un manicomio, tra gli psicopatici. Dall’età di sette o otto anni, nessuno, né i suoi genitori né la società l’ha educato. L’hanno castigato. Adesso è troppo tardi: s’è davvero preso la rabbia.
«Mi affascinava – scrive Mesclon. – Gli feci un giorno qualche domanda elementare. Conoscevo nei particolari il tentativo di furto a mano armata ch’egli aveva commesso a Valenza, da dove venivo anch’io e per il quale era stato condannato a vent’anni (...):
« – E cosa dici adesso della tua vita nelle isole? – gli chiesi.
« – Non sto male. Bevo, mangio, fumo, sto al gioco.
«All’arrivo di ogni convoglio nelle isole, s’informava dei condannati provenienti da Valenza. È così che ho fatto la sua conoscenza quando sono arrivato:
« – Tu vieni da Valenza?
« – Sì.
« – Bene, ma sei un bambino! Non starai male, qui.
«Uno che è lì presente gli dice: “Ti sbagli, è un uomo”, allora lui mi guarda con maggiore attenzione e si limita a dire: “Ah”.
«Non è difficile accorgersi di questo vuoto mentale mentre, a parte quegli occhi selvaggi, il suo corpo è ben proporzionato e dà l’impressione della salute».
Alexandre, dinanzi a tutta la baracca, accusa del furto questo “essere, senza alcun controllo su di sé, senza alcuna comprensione di alcunché”. In teoria, questo significa un duello a morte. Ma Capeletti è troppo astuto per misurarsi con Jacob. Preferisce avvelenarlo lentamente, insieme a Ferrand. Quel giorno stesso, comincia. Per fortuna, qualche giorno dopo, Taillefer lo scorge versare diverse gocce di liquido nella zuppa di lenticchie (il particolare è importante) dei due anarchici e li avverte. Mesclon ha assistito ai fatti: Capeletti fu sorpreso, nel momento in cui le gavette, disposte attorno al piatto, erano state servite, a farvi scivolare ciò che non poteva esser altro che veleno.
«Senza alcun preavviso, J. e F. si gettarono su Capeletti e senza fermarsi gli immersero parecchie volte ciascuno il coltello nulla schiena e nel petto, mentre questi, sconvolto, cercava scampo in fondo alla baracca.
«Là, ormai colpito a morte e lasciatosi cadere sul tavolaccio, gridò ai suoi uccisori con quel po’ di forza rimastagli: “Assassini! Assassini!” J. allora riprese a colpirlo finché quello cessò di respirare, cosa che non tardò a fare.
«Capeletti mori completamente dissanguato. Fu un sollievo, una soddisfazione generale nel campo.
«Un cane, a cui era stato dato un po’ del contenuto della gavetta, ne morì.
«J. e F. chiesero che ne venisse fatta l’analisi.
«Ma poiché nel bagno penale c’è sempre qualcuno interessato che qualcun altro, sia tra i forzati che tra il personale amministrativo, venga condannato, il contenuto della gavetta fu gettato o sostituito e l’analisi fu naturalmente negativa».
Per Alexandre, questa analisi negativa significa l’accusa di omicidio volontario senza legittima difesa, senza circostanze attenuanti: la ghigliottina. Lo sbattono in cella, prima di deferirlo dinanzi al Tribunale Marittimo Speciale che ha sede a Saint-Laurent-du-Maroni. Egli riflette. S’informa. Il guardiano che ha scoperto Ferrand e lui con il coltello in mano, ha portato la gavetta al capo del campo, Raymond, che da parte sua afferma di averla inviata al servizio sanitario dell’Isola Reale. Il dottor Benjamin dice di avere dato un po’ del suo contenuto a due polli e ad un cane che non ne hanno risentito. Chi mente? Perché, insomma, il cane di Saint-Joseph è proprio morto. Alexandre si sente vittima di una macchinazione infernale. Raymond e il comandante Michel da tempo volevano la sua pelle: ora ce l’hanno.
Malgrado tutto, egli riesce a inviare una parola a sua madre attraverso un forzato. Che lei vada a trovare Malato. Che gli chiedeva di nascondere un paio di revolver e delle munizioni in due scatole di conserva e di inviarle a Faulx, alias Madelon, meno sorvegliato, per la fine di settembre del 1909. Faulx gli consegnerà il regalo. Poiché anche lui non ha più niente da perdere, quando Ferrand e lui saranno sul battello che porta a Saint-Laurent, si sbarazzeranno delle catene grazie ai loro attrezzi. Liquideranno i guardiani. E sia quel che sia.
Marie, a Parigi, si dà da fare. Corre a trovare Malato, che s’incarica di eseguire quanto richiesto. Poi si precipita dall’avvocato Lafont: bisogna smuovere l’opinione pubblica. Suo figlio non ha fatto altro che difendersi. Chiede consiglio alla signora Bouillot. Assedia deputati, senatori, scrive di nuovo al Ministro della Giustizia, al Ministro delle Colonie, al Presidente della Repubblica. Ma chi si interessa di questa oscura storia che si svolge dall’altra parte del mondo, tra due pregiudicati?
A Reale, Alexandre compare dinanzi al magistrato istruttore. Quest’ultimo legge il rapporto del dottor Benjamin. All’improvviso il volto dell’accusato s’illumina: il medico parla di “brodo di manzo”, non di zuppa di lenticchie. Alexandre lo fa notare al sostituto, che mette in dubbio la sua affermazione. Jacob insiste perché il dettaglio venga controllato. L’uomo acconsente brontolando. Ritorna con il volto soddisfatto: il deportato 34477 ha ragione.
– D’altra parte, continua imperturbabile Alexandre, secondo un regolamento del 1869 e che non è mai stato abrogato, il medico, prima di redigere il suo rapporto, deve andare a prestare giuramento alla Caienna. Ora, nessun battello è andato sul continente o ne è ritornato tra il giorno della morte di Capeletti e la data nella quale il dottore ha firmato il suo rapporto.
II magistrato verifica una seconda volta. S’inquieta. Suda a grosse gocce: il forzato ha ancora ragione.
– In conseguenza di che, prosegue Alexandre, vogliate prendere atto che avanzo un reclamo presso il Ministro della Giustizia, innanzitutto contro il capo del campo Raymond per violazione di pubblici doveri, quindi contro il dottor Benjamin per falsa testimonianza. (Cfr. Alain Sergent, Un anarchiste de la Belle Epoque, Paris 1950).
Ed effettivamente presenta il reclamo, lui forzato di ultima categoria, contro il medico e il capo del campo. Per maggior sicurezza, avverte della cosa Marie, che continua a smuovere cielo e terra nei ministeri. Le settimane passano. Con i ferri ai piedi nella sua capanna senza tetto, taglia scope. Legge Epitteto, avuto clandestinamente. Aspetta.
I barattoli di conserva non sono arrivati allorché, il 2 ottobre 1909, il Maroni lo trasporta con Ferrand a Saint-Laurent. La seduta del Tribunale Marittimo Speciale si apre il 5. Sono costretti a riconoscere che c’è stato effettivamente un tentativo di avvelenamento. Raymond è confuso. Si scioglie in lacrime. Jacob, magnanimo, ritira il suo reclamo. Tuttavia, “considerato che l’imputato non deve farsi giustizia da sé”, non lo assolvono: Cinque anni di reclusione cellulare. Cinque anni con i ferri ai piedi, pane e acqua in una gabbia di un metro e quaranta di lunghezza. Questo verdetto significa all’incirca: “Bisognava innanzitutto che vi lasciaste avvelenare. Una volta morto, avreste avuto il diritto di difendervi”. Significa soprattutto la morte, perché nessuno è mai sopravvissuto a cinque anni di quella tortura.
Ferrand, meno accorto, s’è preso solo tre anni: durata tuttavia sufficiente per non sopravvivere.
Sul battello di ritorno, l’11 ottobre, avviene il dramma. Bonal, un sorvegliante creolo particolarmente sadico, vuole fare schierare i trasportati lungo il bastingaggio. Piove. Il mare è grosso. Il ponte è coperto da un miscuglio di spruzzi e vomito. Bonal ordina che si stendano lì. Vinci, un forzato italiano che rosicchia una crosta di pane, tergiversa, senza tuttavia alzare la voce pare, né adottare assolutamente alcun atteggiamento minaccioso. Bonal estrae il suo revolver e, freddamente, lo uccide: “Protestava, l’ho ammazzato”, dirà più tardi come una cosa del tutto naturale. Mormorii percorrono le file dei forzati.
– Qualcuno vuole altro piombo? – sogghigna Bonal.
Alexandre mantiene il suo sangue freddo. Se le rivoltelle fossero arrivate in tempo, sicuramente non reagirebbe allo stesso modo. Ma Ferrand, invece, si rivolta. All’improvviso, si sbarazza dell’anello che ha al piede e, in vista delle isole, si getta in acqua. Un gesto disperato: con i pescecani, non ha alcuna possibilità. E quand’anche potesse raggiungere la riva in una parte non abitata dell’isola, quand’anche riuscisse nella notte seguente a costruirsi una zattera, dove andrebbe senza acqua potabile, senza vele e senza cibo?
Le macchine del battello vengono fermate. Si mette in mare una scialuppa. Due guardiani vi montano, tra cui Bonal. In pochi minuti, Ferrand viene riacciuffato. Bonal estrae di nuovo il suo revolver, gli spara tre volte a bruciapelo e fa cilecca. Sta per ricominciare quando, nauseato, l’altro sorvegliante, Bessolo, interviene. Ferrand viene issato a bordo della scialuppa. Ritornano al Maroni. Immediatamente, Bonal si getta su di lui, gli strappa i vestiti, lo riempie di botte, esige i suoi soldi, minaccia di abbatterlo come un cane rabbioso se non glieli consegna. Ferrand, mezzo morto, ubbidisce.
La ferocia di questo Bonal non ha niente di eccezionale. Le cronache del bagno penale abbondano di gesti di questo genere. La mentalità dei sorveglianti è spesso più rozza di quella del più depravato dei forzati. Sono stati attirati in Guyana per vantaggi materiali: paga doppia di quella della metropoli, un anno di congedo retribuito ogni tre anni (con viaggio pagato), pensione elevata. E poi raddoppiano sempre il loro salario trafficando su tutto. Per loro tutto vale per fare denaro: anche a volte vendere le loro donne ai forzati. E poi soprattutto mentre in Francia quasi del tutto analfabeti essi sono all’ultimo gradino della società, qui diventano degli dèi. Il loro potere è forse ridicolo, ma assoluto. Hanno il diritto di vita e di morte sul forzato. Possono mentire, accusarlo quanto vogliono: sono pubblici ufficiali. La parola di un deportato non vale niente contro la loro.
Creando il bagno penale, sotto Napoleone III nel 1854, i legislatori pensavano, ispirandosi all’esempio inglese con l’Australia, di sbarazzare la Francia degli indesiderabili, di rieducare il criminale, infliggendogli una pena severa, faticosa, ma costruttiva. “Se l’espiazione del crimine, se la protezione della società sono meglio garantite della nuova legge”, argomentava il deputato du Miral, promotore di quella brillante iniziativa all’Assemblea, “questa permette anche una correzione più facile del condannato”. In realtà, la nozione di espiazione ha prevalso subito su quella di correzione. Il sistema (non i guardiani-capri-espiatori) ne è responsabile. E, al di là del sistema, l’immensa maggioranza dei Francesi ben felici di essersi liberati dei rifiuti sociali, che ha applaudito all’aggravamento del regime penitenziario dopo la III Repubblica, nel 1891 (quindi senza la scusa della dittatura) e che, in fondo, non vuole sapere quel che succede laggiù. Il criminale è un brutto tipo. Tanto peggio se dietro le sbarre la frequentazione di un tipo ancora più brutto di lui lo avvilisce invece di sollevarlo. E meglio se gliene fanno passare di tutti i colori: è là per quello.
La legge vendicatrice, che ha sostituito il Dio terribile della Bibbia, non deve avere pietà per quel pugno di delinquenti, quei maledetti, dotati di carattere malvagio e che minacciano l’esistenza dei buoni.
Protetto da tutta una gerarchia che va fino al ministro passando per il direttore del bagno o il procuratore generale, il guardaciurma lascia dunque impunemente libero corso ai suoi istinti. Diventa una sorta di Nerone in formato ridotto. Ogni suo sopruso viene moralmente giustificato dalla necessità di fare espiare il forzato. Derubare un forzato non è rubare. Perseguitare un forzato è legittimo. Uccidere un forzato rende un servizio alla società. Il sistema delle vessazioni è infinito. Liard-Courois, l’anarchico che la campagna pro-Dreyfus portata avanti da Faure, Malato e compagni ha permesso di liberare nel 1899, ne ha riferita qualcuna:
«Dire buongiorno ad un compagno in cura all’ospedale o all’infermeria: otto giorni di prigione.
«Procurare pane o tabacco ad un malato: otto giorni di cella.
«Dare pane ad un uomo punito: trenta giorni di cella.
«Corrispondere clandestinamente con l’amministrazione giudiziaria o con un ministro: da sessanta a centoventicinque giorni di segreta.
«Reclamare contro l’insufficienza o la cattiva qualità del cibo: da trenta a sessanta giorni di segreta.
«Reclamo non fondato al comandante del penitenziario: da trenta a sessanta giorni di segreta.
«Reclamo che ha provocato qualche noia o rimprovero ad un amministrativo: torture di ogni genere fino alla morte.
«Darsi malato alla visita e non essere riconosciuto come tale: da otto a trenta giorni di cella.
«Camminare a piedi nudi nel villaggio (quando l’amministrazione non distribuisce scarpe da diciotto mesi): quindici giorni di cella.
«Tagliare dalla propria coperta da letto una striscia in modo da proteggersi dalla dissenteria (quando l’amministrazione vi ha confiscato, per venderlo, un pacco postale contenente una pancera di flanella): sessanta giorni di cella.
«Avere una faccia che non garba al guardaciurma: seccature, finché quello trova un’occasione per spedirvi una palla nella schiena, ecc.».
Nonostante tutto, stavolta, malgrado tutta la sua padronanza, Alexandre si lascia prendere dall’indignazione. Quindici forzati, l’equipaggio del battello, il sorvegliante Bessolo sono stati testimoni dell’assassinio di Vinci e del tentativo compiuto su Ferrand. Sbarcando all’Isola Reale, egli domanda discretamente se tutti sono d’accordo perché lui inoltri reclamo contro Bonal. Ognuno dice la sua opinione. Bessolo giura di sostenerlo.
Dal fondo della sua cella, Alexandre dunque redige immediatamente il suo reclamo da inoltrare al Ministero della Giustizia contro Bonal per “omicidio volontario e tentativo di omicidio”. Uno dei più sorprendenti errori della sua vita. E per un fatto che non lo concerne direttamente. Quindici giorni dopo, egli viene a sapere che Bessolo si tira indietro: non può sostenere un forzato contro un collega. Gli costerebbe il posto. Quanto ai quindici passeggeri del Maroni (a parte Ferrand, naturalmente) sono stati minacciati di crepare nelle segrete se difendono Jacob. (Quando redigeva una lettera ufficiale di questo genere, Jacob faceva sistematicamente seguire la sua firma da tre punti a triangolo. Una quindicina di lettere lo testimoniano. Era per impressionare quelli cui si rivolgeva? Egli era davvero massone? Ma allora, da quando? L’ipotesi di un embrione di complotto anarco-massone ordito verso il 1900-1902 vi trova conferma? C’è stata al bagno penale una ricostruzione di logge? Anche questo è plausibile, in quanto parecchi sorveglianti, tra cui in particolare un certo Franceschi, erano iscritti al Grande Oriente. Purtroppo, gli archivi di rue Cadel sono scomparsi nell’ultima guerra ed è difficile fare il punto al riguardo).
Viene effettuata sul posto un’inchiesta da parte del procuratore generale, sulla base del reclamo di Alexandre. Si conclude che Jacob ha travisato l’episodio e deformato i fatti. L’atteggiamento minaccioso dei trasportati esigeva fermezza. Bonal ha commesso un errore, non un crimine. Ha avuto troppa precipitazione, ecco tutto. Del resto, l’hanno tradotto, come esige la legge, dinanzi al Consiglio di guerra, per il suo gesto. È stato assolto con i complimenti dei giudici per il suo coraggio, quindi destinato alla Martinica, in un posto cui aspirava da tempo, con una promozione. La malafede di Jacob e di Ferrand richiederebbe che essi venissero trascinati dinanzi al Tribunale Marittimo Speciale per calunnia. La Cancelleria deciderà sul caso.
Il 22 febbraio 1910, Marie viene informata che tutto va a rotoli.
«Mia cara mamma, se dovessi restare in reclusione, soprattutto per cinque anni, allora sarebbe la morte certa, lenta e dolorosa, senza rimedio. Certo, non mi pento di avere discusso con la legge per questo episodio, contrariamente alle nostre idee, perché il fine giustifica i mezzi. Se non vedo altro sbocco, lascerò da parte le sottigliezze e mi 62.33.7.12.34.43.26.87 (rivolterò) apertamente piuttosto che soffrire con rassegnazione. Aspetterò che tu mi dica la tua opinione al riguardo.
«Da quattro anni, il bagno è cambiato completamente.
«Come era facile, possibile, quando io sono arrivato, altrettanto è difficile e per così dire impossibile adesso. Parlo delle tre rose (le tre isole) naturalmente. Sono state erette delle mura di ronda, sono stati triplicati i guardiani, messi cani dappertutto. È una vera fortezza. Il mezzo sarebbe il microbo... Potrai senza dubbio procurartelo presso degli amici dell’ospedale Saint- Louis.
«Per l’affare B. (Bonal), ho agito senza riflettere, impulsivamente, per così dire, tanto ero indignato... Sono stato vittima di miserabili scellerati. Bessolo è un traditore... Faccio tutto ciò per dedicarmi completamente alla rivolta e per vendicare tutto ciò che mi fanno subire qui... Vai a trovare l’avv. Lafont...».
Questa lettera arriva a destinazione. È quasi completamente cifrata e inoltrata clandestinamente attraverso intermediari. Ma un’altra, pressoché simile, viene sequestrata nella fodera della veste di Alexandre: è la conseguenza dell’invio del revolver. Vedendo le etichette “aragoste” sulle scatole di conserva, un guardiano troppo sospettoso o troppo buongustaio le ha aperte. Faulx, alias Madelon, s’è buscato trenta giorni di segreta. Si sa che non c’entra niente, il vecchio Madelon, troppo abbrutito dal bagno per essere in grado di maneggiare un revolver. Si pensa che stia coprendo qualcun altro. Ma chi potrebbe essere se non il suo amico Jacob?
La parola “veleno” è riportata solo nella missiva confiscata e che è stata decrittata senza difficoltà dal servizio cifra, malgrado i progressi del sistema basato sulla parola “portoghese”. Ecco Jacob sospettato di volere sterminare tutta la popolazione delle isole. Revolver, veleno, denuncia per omicidio: tutto ciò si ripercuote tra le mura dei ministeri. Piovono le note. Si apre una seconda inchiesta su Marie, sulla signora Bouillot e su Malato: la signora Bouillot viene un po’ compromessa. Ma non saltano ancora fuori prove formali.
D’altra parte, la Corte di cassazione ha appena annullato il verdetto del Tribunale Marittimo Speciale. Nessuno può più ritornare su questa decisione. Il processo sarà discusso nuovamente a Saint-Laurent. Per fortuna. Perché se no...
Nel 1925, un giornalista avrà accesso al dossier di Jacob. Vi troverà in particolare questa annotazione dell’8 febbraio 1910:
«In conclusione, Jacob è uno dei più pericolosi criminali, in cui ogni buon sentimento è da tempo estinto. Egli costituirà sempre un pericolo certo per la società di cui resta un nemico dichiarato. Una misura di clemenza qualsiasi, soprattutto se dovesse intervenire pochi anni dopo il suo arresto, sarebbe a giusto titolo considerata come un deplorevole atto di debolezza. La società non praticava il perdono delle offese. Non era disposta a mollare la sua preda. O quel che restava. Il senso dell’umorismo di certe lettere di Alexandre non cancella le sofferenze subite:
«Se è permesso avere dubbi sull’effetto curativo di questo regime, si devono considerare probanti i suoi effetti preventivi. Così, di lacedemone memoria, io non credo che uomini siano stati sottoposti a sostentamento più frugale. Sarebbe forse una resurrezione delle idee care a Seneca, sotto forma di stoicismo alimentare? In ogni caso, stai ben certa, mia carissima, che la mia salute è al riparo da ogni complicazione dovuta all’acido urico...».
Attorno a lui, si apre la caccia. Lo braccano. Lo spiano, si vendicano. Quindici giorni di segreta nel 1909 “per avere parlato ad alta voce di notte nel quartiere speciale”. Otto giorni per “corrispondenza illegale”, dopo la scoperta del messaggio in codice. Gli rovinano il corpo, sperando di colpire lo spirito. Tuttavia, egli detta la sua volontà ai forzati delle isole. Con l’alfabeto Morse, con pezzetti di carta, con bisbigli, corrisponde con l’esterno. I confidenti del comandante Michel sono impotenti: «Sì, erano loschi figuri – scrive costui – ma ero costretto ad utilizzarli... Indovinavo che Jacob, rinchiuso nella sua cella, era più pericoloso di quei bravacci che imponevano le loro leggi nelle baracche a colpi di coltello... S’era impegnato a fondo nella lotta contro l’amministrazione... Se avessi potuto fare la pace con lui, l’avrei fatta».
Ma Jacob non patteggia con il nemico: egli si batte.
L’unica concessione che fa, non senza scrupoli, è di utilizzare le armi del nemico, per ritorcergliele contro. Del resto, non ha scelta. Sempre di più, egli dà consigli a quelli che hanno difficoltà sui passi da effettuare, sull’atteggiamento da assumere, sulla tesi da sostenere: «È doveroso dire che egli ha reso infiniti servizi alla popolazione penale con la sua conoscenza legale», scrive Jean Normand, il professore di diritto che l’ha preso in amicizia. «Numerosi sono i deportati, detenuti nelle isole della Salute, che gli devono notevoli diminuzioni di pena e se molti tra di loro adesso sanno difendersi, lo devono a lui e io per primo».
Né le sciabolate né la Datura stramonium, per due volte, hanno avuto ragione di lui. Non china più la testa nella morte lenta per fame. Rifiuta persino che Marie si umili invano in suppliche e in intrighi. Reclamare quanto gli è dovuto, il suo diritto ad una giustizia disprezzata: non pensa di agire altrimenti. Ma implorare chicchessia, neanche parlarne: «Mia cara mamma, credo di averti già detto che non volevo sentire parlare di favori. È molto deplorevole che tu non te ne sia ricordata. Ci sono elasticità, ginnastiche per le quali non ho né voglia né inclinazione (...). Per principio, vedi, non serve a niente contare sulla protezione di questo o sull’influenza di quello. È meglio non contare che su se stessi. Inoltre, è ugualmente preferibile non dare preoccupazioni a persone fortunate con delle richieste. Anche in caso di insuccesso, ciò impegna alla riconoscenza e questo sentimento è molto spesso una catena penosa da tollerare. Da parte mia, amo troppo la libertà per legarmi in questo genere di compromessi».
Il 13 aprile 1910, Ferrand e lui si presentano di nuovo dinanzi al Tribunale Marittimo Speciale di Saint-Laurent. La loro condanna viene ridotta a due anni. Perché questo verdetto equivoco quando è stata ammessa la legittima difesa? I quindici mesi che hanno appena trascorso con i ferri ai piedi vengono annullati da quella decisione. Quei due anni sono a partire da ora: 15 + 24 = 39. È moltissimo per degli agonizzanti che compaiono dinanzi ai giudici su una barella. Ricorrono nuovamente in Cassazione.
Il ricorso viene respinto. Marie tenta una domanda di grazia. Oh! Non per fare liberare suo figlio. Per quei due anni di supplizio, semplicemente. Con qualche ritardo, dal fondo della sua cella dell’Isola Reale, Alexandre, il 12 giugno 1910, la ringrazia per quel che ha fatto e, sia per pudore che per non metterla in ansia, le mente sulla sua effettiva situazione:
«Cara mamma, avevo parecchi sospetti che la tua salute non dovesse essere delle migliori; certo, dopo tutto quel che hai sofferto, era più che logico; e tuttavia, non ti credevo malata come sei effettivamente stata. Che cosa ti posso dire? Che hai fatto male ad avermelo tenuto nascosto; poiché se l’avessi saputo, non ti avrei incaricato di fare quelle commissioni, quei passi che forse sono stati la causa della tua ricaduta. Insomma, se è vero, come tu mi assicuri, che sei in piena convalescenza, che sei, per dire così, guarita, tanto meglio. Non chiedo di meglio che crederti e ti auguro migliore salute per l’avvenire. Quanto a me, sono felice di poterti confermare quel che ti ho comunicato nella mia ultima lettera. Sto bene, molto bene (!). Ho ricevuto un flacone di polvere Rocher e, senza attribuirle tutto il merito del mio miglioramento, credo che un po’ vi abbia contribuito. Per il momento, non ne ho più bisogno. A meno che non te lo chieda, non mi mandare più niente: me lo confischerebbero.
«I primi giorni del mese prossimo, mi aspetto di essere trasferito nei locali di reclusione cellulare dell’Isola Saint-Joseph, per scontarvi il resto della mia condanna che subirò integralmente, a meno che i tuoi passi non vengano coronati da successo, cosa del resto probabile se hai proceduto come ti ho raccomandato. In fondo, è una cosa che non mi piace molto, ma poiché fa piacere a te, poiché, in qualche modo, ti sei impegnata verso persone che sono state disponibili con te, fai come credi meglio: venendo da te, sarà sempre ben fatto. (...) Soprattutto non confondere: non si tratta della mia condanna ai lavori forzati a vita; si tratta di quella a due anni di reclusione cellulare, inflittami dal Tribunale Marittimo Speciale per lesioni e ferite volontarie che hanno causato la morte non intenzionale, con beneficio legale e di circostanze attenuanti.
«È per errore che il mio fascicolo riporta la menzione: assassinio, o, per meglio dire, è l’accusa che sosteneva questa versione; ma il Tribunale non l’ha ammessa, se no sarei stato condannato a morte. D’altronde se, come spero, l’avv. Justal ha studiato il fascicolo nella cancelleria della Corte suprema, deve già averti informato di ciò.
«Aspettiamo, quindi. Quale che sia la decisione, non potrei mai raccomandarti abbastanza di non rattristarti per me. Te lo ripeto, io sto bene e, davvero, con la salute si fanno e si sopportano molte cose.
«In attesa delle tue gradite novità, ricevi, mia cara, le mie più tenere ed affettuose carezze».
Da ottantacinque chili, il suo peso è infatti sceso a sessanta. Delusione dolorosa: la domanda di grazia di Marie viene respinta: “Jacob è uno dei soggetti più malvagi del bagno e non merita che ci si interessi a lui”. Quell’originale della signora Jacob racconta ai più pazienti “la triste vita del suo sfortunato figlio”! Se non avesse rubato, non sarebbe oggi al bagno. E poi, se lo ama tanto, non deve far altro che andare a raggiungerlo!
È quel che lei decide di fare. Andrà ad abitare alla Caienna. Troverà lavoro come sarta e, tutte le domeniche, prenderà un battello per andarlo a trovare. L’idea è accolta senza entusiasmo da Alexandre:
«Cara mamma rieccomi deluso nella mia attesa... Qualunque cosa succeda, non ha grande importanza. Quella che ne ha di più è che la tua salute sia davvero soddisfacente. Dopo tutto quel che hai sofferto, mia carissima, è ora che tu stia un po’ meglio. Se questo potesse durare...
«Non dimenticare di porgere i miei ringraziamenti alle persone che ti hanno aiutata con le loro premure: a Jeanne, alla zia, alla tua buona vicina soprattutto, così come a colei che non conosco. Come odierei chiunque ti facesse male, non posso che amare quelli che ti fan del bene, è logico. (“Jeanne”, “zia”, “vicina” sono altrettanti nomi in codice per le persone di cui Marie sollecitava l’aiuto. “Jeanne” è sicuramente il senatore Flaissières, che ha trasmesso la domanda e “zia” è l’avvocato Aron, che comincia ad interessarsi alla sorte di Jacob).
«Se invece che amarti come ti amo, più di chiunque al mondo, desiderassi la tua morte, oh! allora, alla buon’ora! Ti direi: vieni più in fretta che puoi. Ma poiché non voglio essere un matricida, giacché desidero che tu viva il più a lungo possibile, con la massima sincerità, dal fondo del cuore, ti supplico di non farne nulla. Perché non è alla tua età, mia carissima, con tutti gli assalti che le malattie ti hanno sferrato, che tu potrai impunemente affrontare un clima simile, questo ambiente sociale, un tale tipo di vita: non resisteresti sei mesi.
«Ecco quel che si sono sicuramente dimenticati di dirti, ecco perché credo giusto informarti...
«Ma non bisogna disperare... Lo scoglio, nel mio caso, è il timore della mia evasione, timore del resto giustificato, bisogna ammetterlo, per il mio precedente comportamento. (Non che Alexandre avesse rinunciato ai suoi progetti, ma la lettera doveva superare la censura).
«Di modo che se tu chiedi una concessione per me, si dovrebbe di certo pensare, se non rispondere, che il desiderio di questo beneficio è per me un mezzo piuttosto che un obiettivo.
«Tenessi pure la più esemplare delle condotte, il più sottomesso degli atteggiamenti, non servirebbe a niente. Invariabilmente, la risposta sarebbe negativa. È per questo che io non verrò mai liberato, ossia non lascerò mai le Isole della Salute...
«Se finora ho cercato di spezzare le mie catene, non è stato che per poter vivere vicino a te... Che m’importa di vivere a Roma o a Pechino? Il luogo mi è indifferente: quel che ho sempre desiderato e che desidero sempre, è di vivere al tuo fianco, in pace, lavorando del mio meglio...».
Seconda delusione, questa prevedibile: deve presentarsi dinanzi al Tribunale Marittimo Speciale per calunnia. E anche Ferrand, che deve rispondere inoltre dell’imputazione di tentativo di evasione: “I due peggiori soggetti del bagno hanno cercato di fuorviare il giudizio del Ministro della Giustizia. È necessario processarli”. Se egli sarà condannato, anche ad un solo anno supplementare non sopravviverà. La dissenteria lo tormenta. Non è neppure certo che resisterà per quei due anni. Ha dei momenti di assenza. Il delirio l’assale. Come predisporre la sua difesa in quel buco, mentre la guardia cammina sulle sbarre, al di sopra della sua testa? Egli tuttavia cerca di raccogliere le testimonianze necessarie. Il che si traduce in queste conseguenze: novembre 1910, otto giorni di segreta per avere parlato; febbraio 1911, trenta giorni di segreta per “Chiasso. Chiacchiere. Istigazione a mentire dinanzi alla Commissione disciplinare”.
È per aver voluto un po’ più di libertà per gli uomini che egli si trova in fondo a quel buco nero. Schiaccia macchinalmente le cimici attorno a lui. Le croste di pane che gli gettano, le sfrega contro i buchi dei topi: con un po’ di fortuna, si prenderà la lebbra. E, se affetto da lebbra, lo tireranno fuori di là. Lo manderanno nel lebbrosario dell’Acarouany. Di là, potrà filarsela... Tutto s’intorbida.
Finalmente, il 22 novembre 1911, incapace di tenersi in piedi, compare a Saint-Laurent dinanzi al Tribunale. Raccoglie le sue ultime forze. Difende il suo caso. Non l’ascoltano. All’improvviso, scorge il capitano Olive, che comandava il Maroni il giorno in cui Ferrand ha cercato di fuggire. Si erano ben guardati dal citarlo come testimone. Ma quell’uomo ha visto tutto. Jacob in un lampo si ricorda di un altro tribunale, quando aveva tredici anni, in cui sedevano ufficiali onesti... Chiede il permesso di fare interrogare il capitano. Il presidente non trova la maniera di rifiutare. Olive avanza verso la sbarra. Parla. Le orecchie di Alexandre ronzano.
Punto per punto, l’ufficiale conferma la sua deposizione. Con sorpresa generale, Alexandre viene assolto. Ferrand ha meno fortuna: il suo tuffo disperato gli vale un anno di cella. Non sopravviverà. È l’ultima volta che Alexandre lo vede.
Ritorno in cella. Dissenteria. “Gli uomini lavano i cessi a turno, con dell’acqua che prelevano da una grande vasca, ma con un barattolo che poi serve a loro per bere, le mani sudice”. (Mireille Maroger, Histoire du bagne de Cayenne, Paris 1933). Vi fa scivolare dei fiori secchi.
«Caspita! Se continui così, finirai per metterci un platano, nelle tue lettere! Naturalmente che mi fa piacere ricevere lettere da te. Ma perché uccidere quei fiori?...».
Un medico militare di passaggio nelle isole ha un sobbalzo di orrore vedendo la condizione in cui si trova ridotto il recluso. Chiede che venga trasportato in ospedale. Speranza vana. Il direttore rifiuta: un forzato punito non deve essere curato. Alexandre reclama almeno del latte condensato. Rifiuto da parte di un altro medico, dopo la partenza del primo. Del resto, non c’è latte. Non per lui. Egli scrive a sua madre perché chieda al ministero delle Colonie l’autorizzazione ad inviargliene. Rifiuto: “Il servizio sanitario dello stabilimento penitenziario si occupa della salute dei malati con ogni cura desiderabile. State certa che se il detenuto avesse bisogno di latte, gliene fornirebbero sul posto”.
Malgrado tutto, questo passo non è inutile. La risposta di Marie viene intercettata e mostrata al medico numero due. Forse costui all’improvviso teme che in Francia si scateni uno scandalo sulla stampa di sinistra se Jacob, che i suoi amici sembrano non avere dimenticato, morisse per mancanza di cure. Accondiscende a fare trasferire l’agonizzante in una cella dell’infermeria e a somministrargli finalmente il latte salvatore. Ancora qualche giorno e sicuramente sarebbe stato troppo tardi.
Per parecchio tempo ancora Alexandre vaga nella penombra ossessionante del delirio. Il latte gli restituisce un po’ di forza. Ma le forze gli restituiscono la fame e con la fame la tortura. Ad una ad una, strappa le palline di mollica di pane secco e ammuffito di cui i suoi predecessori si sono serviti per tappare, lungo i muri, i fori delle cimici. E le mangia. A volte, fa degli inaspettati banchetti: un topo smarritosi; una fricassea di banane verdi nella morchia raschiata su un’asse... Lucidamente, a volte, egli si sente morire. Perde quarantadue chili, un po’ meno della metà del suo peso normale.
Poi la vita, ostinata, ritorna nella carcassa. E con essa, il gusto della libertà. Quando finisce l’incubo, nel maggio 1912, dopo quasi quattro anni di cella o di segreta, scarno, tremante, mentre le autorità lo immaginano spezzato, il suo obiettivo non è mutato: la fuga. Ha imparato molto su se stesso. Ha visto la morte da molto vicino. Questa vicinanza non gli ha fatto paura. La sua frequentazione l’ha invece spinto a riflettere sul senso delle sue imprese di un tempo. La loro impetuosa utopia gli pare adesso un po’ prematura.
Luglio 1912. Il comandante Michel ha fatto piazzare una garitta all’entrata, per proteggere dalle piogge torrenziali i guardiani di sentinella. Se la trasformasse in barca? Resa impermeabile, munita di chiglia, un’asse fissata di traverso come albero, un’altra a guisa di timone, potrebbe affrontare le onde dell’Atlantico.
Cinque uomini, in una notte senza luna, escono dalla Baracca Rossa. Avanzano fino all’imbarcadero. La ronda, ahimé, è continua e il guardiano Simon scorge delle ombre. Jacob guida la loro marcia. Simon estrae il revolver, scarica l’arma su di lui e lo manca. Viene dato l’allarme. Alexandre galoppa fino alla baracca. Quando i secondini e guardiani vi entrano, armi in pugno, lui russa già sul tavolaccio, come due suoi complici. Gli altri due sono stati riacciuffati. Non faranno nomi. Quanto ai sessanta forzati presenti, essi non hanno visto né sentito nulla.
Benché Simon non possa provare la partecipazione di Alexandre, il comandante Michel lo fa comunque isolare. Di notte, egli dormirà in cella, catena al piede. Di giorno, attenderà alle sue normali mansioni. Ma un secondino lo seguirà passo per passo e gli impedirà di comunicare con chiunque. Nessuna traccia ufficiale di punizione. Così il deportato 34477 non potrà stavolta invocare alcun articolo del regolamento, né gridare allo scandalo, secondo la sua abitudine, presso i ministri. Il metodo non è forse ortodosso, ma è abile.
Ottobre 1912. Alexandre è riuscito, attraverso la corrispondenza, ad accordarsi con un infermiere e un distaccato (forzato che lavora come domestico presso privati) tutt’e due relativamente liberi nei loro movimenti. Costoro hanno rubato un vecchio canotto mezzo marcito e raccolto il materiale necessario per una evasione. Ma non sono riusciti a risolvere i mille problemi tecnici specificamente marittimi. Punto per punto, Alexandre dà loro le istruzioni necessarie. In cambio, perché egli possa unirsi a loro, l’aiuteranno ad uscire dalla cella uccidendo il guardiano.
Arriva la notte fissata per la spedizione. Le ore passano. Quelli non vengono. Dopo avere utilizzato la sua competenza, hanno in realtà pensato di non aver bisogno di lui. Mal gliene incoglie. La loro scialuppa s’è rovesciata. L’indomani, vengono recuperati.
Alexandre ne sarebbe quasi contento, se le sue lettere e i suoi disegni non fossero stati ritrovati tra le loro cose. Viene aperta un’indagine. La sua complicità parrebbe indubbia. Michel si frega le mani: lo tiene senza avere dovuto far nulla.
Ma non tiene conto del suo genio inventivo. Egli spedisce un messaggero a due testimoni compiacenti. Questi ultimi affermeranno di aver ricevuto un’ultima lettera da lui, nella quale egli comunicava che rifiutava di partecipare alla spedizione. Essi accettano. Poi, lo stesso messaggero ruba una bussola tra gli oggetti ritrovati a bordo della barca.
Quando il sostituto interroga Alexandre, costui giura di aver rinunciato al progetto all’ultimo momento. La sua ultima lettera lo dimostra.
– Ma, insomma, Jacob, questa lettera non esiste!
– Dovrebbe esserci, perché io l’ho scritta. Tutto ciò è un’altra macchinazione per incastrarmi.
– È possibile, ma vi accuso di complicità in tentativo d’evasione. Spiegherete questa tesi che non sta in piedi di fronte al Tribunale Marittimo Speciale.
Il 17 gennaio 1913, Jacob compare per la quarta volta dinanzi ai giudici di Saint-Laurent-du-Maroni. Nessuno dà un soldo per la sua pelle. Lì ripete con cocciutaggine la sua difesa.
Non viene creduto. Per meglio provare la serietà di quel tentativo d’evasione, il procuratore fa rileggere l’elenco dei corpi di reato. Immediatamente, Alexandre chiede la parola.
– Avete detto una bussola. Io non la vedo, questa bussola.
La cercano. Si stupiscono. Ha ragione lui.
– Ecco la prova della macchinazione. – grida. – Qualcuno ha rubato la mia ultima lettera per compromettermi. Ma questo qualcuno, vedendo la bussola, non ha saputo resistere a portarsi via anche quella!
È davvero strano. La sua indignazione appare sincera. Non si può condannare, nemmeno un forzato, con degli indizi così precari. E poi, c’è il precedente della falsa testimonianza del capo del campo Raymond... Insomma, ci si rassegna ad assolverlo.
Il che non impedisce al comandante di tenerlo in regime di semi-reclusione. Poiché, tra questo tentativo abortito ed il processo, un altro tentativo ha avuto luogo. Il direttore delle isole è venuto a saperlo dai suoi confidenti.
Un armadio contenente fucili e munizioni era stato messo nella postazione del capo del molo. Alexandre aveva deciso di impadronirsene. Il progetto pareva relativamente agevole. Erano stati reclutati sei complici tra i più sicuri. Essi sarebbero usciti dalla loro baracca e sarebbero andati ad aspettarlo davanti alla sua cella.
Alexandre si sarebbe sbarazzato delle catene (un gioco da ragazzi) ed avrebbe aperto la porta grazie ad un misterioso sistema di ganci e di cordicelle già sperimentato e che funzionava perfettamente. Se fosse sopraggiunto un guardiano, l’avrebbe accoppato. Poi, avrebbero strisciato fino al capo del molo. L’avrebbero tolto di mezzo e svestito. Alexandre avrebbe indossato la sua uniforme; avrebbe preso i fucili Lebel e sarebbero saliti su una scialuppa, pronti a fare fuoco al minimo allarme. Il piroscafo della Caienna, l’Oyapock, che fa scalo tra le undici e mezzanotte, sarebbe stato all’ancora nel porto. Grazie alla divisa, li avrebbero lasciati salire senza difficoltà. In cinque minuti, l’equipaggio sarebbe stato buttato fuori bordo, l’ancora levata, le macchine spinte a pieno regime. E via per il Brasile!
Era esaltante e perfettamente realizzabile, per individui i pronti a tutto.
Purtroppo, uno stupido imprevisto, un granello di sabbia, ha impedito la realizzazione di quel magnifico piano. Un vero granello di sabbia che s’è introdotto nella serratura della porta e che ha impedito al sistema di cordicelle di funzionare. Senza il loro capo, coscienti di non essere in grado di portare a termine l’operazione senza di lui, i sei, contrariati, sono ritornati alla baracca. Salvo due, che si sono fatti prendere dalla ronda e che sono stati condannati a trenta giorni di segreta. Quanto ad Alexandre, dopo che gli altri hanno parlato, viene eseguita una perquisizione a fondo della sua cella, ma invano. Non una ombra di prova. Il comandante, dopo quel giorno, tende a considerarlo un temibile stregone.
Dicembre 1913. Marie torna ad insistere per venirlo a raggiungere: «Ti dirò di non riparlarmi mai più di un viaggio in Guyana. Perché non rassegnarsi alla realtà, per quanto triste possa essere? Perché vivere di illusioni?... Ti lasci prendere dall’entusiasmo, mia buonissima; vai un po’ troppo in là. Non mi rilasceranno. Non possiamo far nulla contro il fatto compiuto... Quanto a venire a sprofondarti in questo inferno...».
Gennaio 1914. Quindici giorni di segreta per malevoli insinuazioni nella corrispondenza a sua madre.
Il tempo passa. Il tempo pesa. I pensieri via via si elevano:
«Oggi, 2 luglio 1914.
«Mia buonissima, è una sorpresa, una bella sorpresa la tua foto. Mi sembri sempre la stessa. Ma i tuoi poveri occhi hanno dovuto spesso versare delle lacrime. Esprimono molta sofferenza. Ed è quel che bisogna evitare, quello contro cui occorre reagire.
«Le cose sono quel che possono e devono essere; sono come la fatalità della vita e noi stessi le abbiamo fatte. La vita è una guerra, la mischia sociale è una battaglia senza pietà né misericordia e, quando si è sconfitti, non sono le lacrime che bisogna versare; bisogna riprendersi. Bisogna superare quel fermento di nichilismo che è in noi e tener duro fino alla fine, energicamente, senza curarsi della morte.
«Sono contentissimo che ti sia un po’ convinta di queste idee, poiché la tua ultima lettera me ne dà l’impressione...
«Bandisci la tristezza dal tuo cuore. È una conseguenza dell’ignoranza e della religiosità mettere un se davanti ai problemi. A che scopo? Poiché è così, non può essere altrimenti. Se lo potesse, lo sarebbe. Che diavolo! Ci sono occasioni in cui occorre avere il coraggio, la fermezza del coraggio di pronunciarsi categoricamente per un’affermazione, oppure non rimane che prendersi gli schiaffi. Bisogna accettare il disprezzo di se stessi? Mai.
«Non ti dirò niente della mia situazione, faresti altri passi a destra e a sinistra e questo mi dispiace moltissimo. Non domandare niente, non accettare niente, ciò dà la misura di quel che s’è in diritto di accordare a se stessi. Niente compromessi. Ognuno dalla parte sua.
«La mia salute non è cattiva. Ho sì qualche crisi di cardiopatia, la necrosi ossea mi molesta un po’, ma è sopportabile. Ne ho sopportate ben altre...
«Saluti da parte mia, anche alla tua buona vicina e ai compagni».
Sabato primo agosto 1914. L’ordine di mobilitazione generale è attaccato ai muri di Parigi. I primi contingenti partono immediatamente verso l’Est, un fiore nella canna del fucile, a fare fuori i crucchi. Negli ambienti anarchici è il crollo. Le belle idee ereditate dall’Associazione Internazionale Antimilitarista, nel 1904, quando Malato s’era così duramente accapigliato con Darien (vedere a questo riguardo La Belle France, di Darien), non hanno resistito alla forza della realtà. Gustave Hervé il rinnegato lo constata: “Le nostre ali si sono spezzate all’urto delle dure realtà ed eccoci ricaduti al suolo, ognuno sul nostro suolo natale, con l’unica preoccupazione per il momento di difenderlo come fecero i nostri antenati”.
Sì, ci si era cullati nella speranza. Lo spirito patriottico soffia più alto che l’internazionalismo, dalle due parti della frontiera. Il primo agosto, “la Bataille Syndicaliste”, organo della CGT, supplica su otto colonne: “Proletari di tutti i paesi, unitevi”, ma il 3 si unisce alla cricca dei guerrafondai, con alla sua testa quasi tutti i capi del movimento, tra cui Griffuelhes e Léon Jouhaux, applauditi, colmo del disonore, da Maurice Barrès; Malvy, il ministro dell’Interno, non ha neppure bisogno di fare applicare rigidamente le norme del “comma B”, che prevede l’incarcerazione immediata dei socialisti, siano essi autoritari o libertari, in caso di mobilitazione.
La tesi dello spontaneismo rivoluzionario crolla. La maggior parte degli anarchici si unisce agli autoritari nel bellicismo. Quasi da solo, Sébastien Faure si batte nel suo angolo. Louis Lecoin e il suo amico Pierre Ruff sono gettati in prigione. Benoît, Girard e pochissimi altri sindacalisti rivoluzionari, tra cui Monatte, che ha dato le dimissioni dalla CGT e che sarà immediatamente spedito in prima linea, si raduneranno a Zimmerwald. In Germania, la situazione è identica. Liebknecht e Rosa Luxemburg, isolati, lottano invano. Del resto, fin dal marzo 1915, il primo si ritroverà al fronte e la seconda in prigione. In Inghilterra, tre o quattro irriducibili. In Italia, quattro o cinque Malatesta. Per il resto...
Gli emigrati russi, bolscevichi o no, spingono alla battaglia. Trotsky si riconcilia con Lenin; questa guerra è secondo lui un male orribile ma necessario. Il kaiser e lo zar crolleranno. Il Socialismo infine potrà nascere dalle rovine dei loro regimi. Kropotkin parla di una “guerra in difesa della libertà”... “Bisognerà difendersi come bestie feroci”, dice. “Un annientamento della Francia sarebbe una disgrazia per la civiltà... Facciamo la Rivoluzione sociale e corriamo alle frontiere”... Nel febbraio 1916 compare il Manifesto dei Sedici che chiama alla lotta contro l’autoritarismo pangermanico, sia sociale che militare, come un tempo Bakunin lottava contro Marx. In calce a questo testo, c’è la firma di Jean Grave, del dottor Pierrot, di Paul Reclus. E di Malato.
I proletari di tutti i paesi si uccidono ben presto tra di loro a maggior vantaggio dei commercianti di cannoni, con gli applausi della maggior parte dei dirigenti socialisti. Lecoin, in fondo alla sua prigione, è disperato. Marie, invece, s’infiamma contro la ferocia teutonica. Spedisce lettere esaltate a suo figlio. Ma le prove attraversate, le letture, la spaventosa solitudine, l’eterna lotta per sopravvivere condotta contro l’Amministrazione come contro i malviventi che, mescolati agli anarchici, affollano Saint-Joseph («Non puoi credere quanto sia malvagia e vile, la maggior parte di questi marsigliesi che chiamano “apaches”. Costituiscono una specie di “mafia” e non hanno rispetto che per le randellate»): tutto ciò ha spinto Jacob ad un allontanamento progressivo dalle ideologie, quali che siano. Trasformare il mondo? Un bel sogno. Lui ci ha creduto a venti anni. Adesso ne ha trentacinque, di cui dieci passati al bagno. Non rinnega nulla di quel che ha fatto. È disposto ad assumersene la responsabilità fino alla morte, integralmente. Ma certamente non ricomincerebbe più. Non nella stessa maniera. Gradualmente, egli si è evoluto. L’individualismo di Stirner e di Nietzsche ha sostituito il socialismo di Hugo e il messianesimo libertario. Trasformare il mondo? Fare la rivoluzione? Creare una società senza classi, senza sfruttatori né sfruttati? È la natura umana che bisognerebbe innanzitutto trasformare. Tutte le cause si equivalgono, compresa quella che lui chiamava la Causa. I valori hanno fondamento nell’Io individuale. Il patriottismo? Un valore come altri. Perché dovrebbe sposare l’odio della Francia contro i tedeschi quando è la Francia che l’ha condotto là dove egli è? Egli non si sente di alcun Paese, di alcuna nazione. Lui è Alexandre Jacob. Ed ha i ferri ai piedi.
Il risultato più palpabile, in Guyana, di quel macello accuratamente organizzato, di cui si sentiva la lenta preparazione maturare da venti anni, a colpi di proclami, di sfilate, di parate, di Agadir, di Alsazia-Lorena e di “viva la Patria!”, è che i rifornimenti si fanno più rari e la posta più irregolare. E anche che il comandante Michel, con grandi strombazzamenti, è partito per la Francia a conquistarsi galloni e medaglie. Marie si avvolge nella bandiera tricolore. Trova una cattiva accoglienza: «Che cosa mi vai raccontando? La Belva? I Barbari? Ma ogni comunità, come ogni individuo fa altrettanto. Non esiste traccia di giustizia nella Storia. Vince il più forte. Biologicamente, il sentimento è una degenerazione, una carie, il più nefando degli errori. E sì che, a credere a certa letteratura, i Tedeschi sarebbero dei cantanti d’arie con chitarra, dei sognatori di fiorellini blu! Vai a fidarti della fama! È vero che, oltre a Schiller, Goethe, Madame de Staël, ci sono stati Stirner e Nietzsche: questi indicano un’altra tendenza. Io non sono antimilitarista, per il semplice motivo che non ci possono essere società senza difensori o aggressori, secondo le circostanze, ma non sono patriota perché non posso esserlo, non avendo alcun patrimonio. La parola non mi basta, ho bisogno anche della cosa... La vita è una guerra. Che la si combatta per una parola, per un’idea, per una bandiera, per un interesse prosaico o per un interesse ideologico, che si sia Sancio Panza o Don Chisciotte, bisogna sempre o dare i colpi o riceverli. È ineluttabile. Questo non cambierà...».
Marie non ci sente da quell’orecchio. Gli Unni dilagano. Bisogna fermarli o morire. E morire se necessario, per fermarli.
Anche nelle isole, gli spiriti si accalorano. Clandestinamente, dei fogli di giornali vecchi di due mesi circolano per le baracche. Si crede di scorgervi tra le righe una vaga speranza... Giacché tutti gli uomini validi vengono inviati in trincea, perché non loro? Nulla può essere peggiore dell’inferno in cui essi marciscono. Combattere, uccidere, rischiare di essere uccisi, questa è vita. Infatti. Li manderanno al fronte in battaglioni disciplinari, affideranno loro missioni più pericolose, pochi tra loro ritorneranno, ma i superstiti avranno uno sconto sulla pena nell’euforia della vittoria. E ognuno, naturalmente, dà per scontato di fare parte dei superstiti.
Suo malgrado, queste voci scuotono Alexandre: «...Così la tragedia continua e continuerà sicuramente fino all’estinzione delle risorse. Qui, le notizie arrivano sempre, più o meno esatte s’intende. Per il momento e salvo l’intervento di nuovi fattori (cosa possibile), Parigi non mi pare minacciata. Per me, è l’essenziale, perché ci stai tu. Non avendo alcuna pietà per me, come vuoi che io ne abbia per gli altri? E poi, non vedo per che cosa dovrei intenerirmi. Non è forse la cosa più bella, la più sublime delle sensazioni morire con le armi in pugno? A parte qualsiasi questione di soggettivismo e di metafisica, quelli sono da invidiare e non da compiangere. Quel che è triste, quel che fa compassione, che è sommamente pietoso è questo suicidio di ogni mattino, è questa morte graduale, goccia a goccia, che chiamano vita tranquilla, questa vita cenobitica da cappuccini, da lumache e da forzati...».
Insidiosamente, l’idea compie il suo percorso. L’essenziale, dopo nove anni, è di sfuggire alla vita delle lumache. E poi, lo spingono da ogni parte. I deportati di tutta la Guyana hanno abbandonato da tempo il gioco delle tre carte e la Marsigliese per occuparsi esclusivamente della guerra. Quando ne parlano, gli occhi brillano. Alcuni si sono già suicidati per la disperazione, per non essere stati inviati nelle Fiandre. Lui che sa scrivere così bene, bisogna che spedisca una petizione al ministro delle Colonie a nome dei detenuti di Saint-Joseph:
– Dai, Jacob, scrivi...
Egli finisce per scriverla. Quattro pagine fitte, in grande formato. Sviluppa tutte le argomentazioni possibili. La riabilitazione dei puniti, l’onore disperato di morire per la patria. Nessun rischio per l’ordine pubblico, anzi: si manderanno a morire nei posti più difficili. Il loro coraggio fisico, invece di essere utilizzato per fare il male, si rivolgerà verso il nemico, ossia a favore del bene nazionale. La Francia non ha il diritto di rifiutare dei volontari rastrellatori di trincee. La Legione Straniera non è composta da chierichetti... In fin dei conti, non c’è da spremersi troppo per scrivere tutto ciò. La cosa peggiore nelle torture è proprio l’angoscia di sentirsi inutili finché rimane un po’ di energia dentro.
Marie, da parte sua, implora il Ministro della Giustizia di mostrare un gesto di clemenza a favore di lui, che è tanto buono. Scrive con ingenuità, di cuore, con il suo candore e la sua fede come se il suo amore materno fosse un argomento sufficiente per scuotere le colonne del palazzo di giustizia, come se la sincerità potesse commuovere le pietre. Proprio lo stile di suppliche che dà fastidio ad Alexandre quando lo viene a sapere.
* * *
Signor Ministro,
È una povera madre che vi implora per suo figlio, giacché il mio più ardente desiderio sarebbe di vederlo al fianco dei suoi fratelli a combattere per il diritto e la giustizia contro le barbarie... Abbiate, ve ne prego, una parola di perdono per il mio povero piccolo che è di carattere retto, coraggioso ed energico: non lo lasciate morire inutilmente...
Sono già undici anni ch’egli è detenuto, di cui nove alla Guyana, nelle isole della Salute. Sapete, egli non può viverci ancora molti anni. Il regime ed il clima sono mortali. È un ribelle, ma quando si è giovani, si è ardenti e focosi e molto spesso certe letture fuorviano le idee. Mio figlio non ha ucciso; ma è stato condannato alla detenzione a vita.
Voi, signor Ministro, che ritengo giusto e buono, dando uno sguardo al suo dossier, del tutto falso in certi punti, vi supplico di cancellare l’odio di parte: poiché mio figlio, prigioniero comune, è molto spesso stato considerato come politico. Non se n’è mai tenuto conto. Qual era il primo giorno, undici anni fa, così egli è ancora adesso: nessun miglioramento, nei suoi confronti, neppure un cambiamento di classe, niente. Resta però il fatto che c’era il tempo per ottenerlo, ma per lui niente, mai nessuna clemenza (...).
Si rimprovera forse a mio figlio di non essersi lasciato trascinare dalla tendenza esistente al bagno: la completa sottomissione che fa un buon forzato. Non posso spiegarmi, sarebbe troppo lungo; ma quando si è uomini, in qualunque ambiente ci si trovi, persino al bagno penale, si mantiene la propria dignità di uomini ed ecco perché (so che su questo mio figlio non ha mai mancato) vi voglio dire, Signor Ministro, senza alcuna pretesa, che mio figlio è un uomo. Ed in quest’ora oscura e tuttavia piena di una luce di speranza, la Francia ha bisogno di tutte le sue energie. Getto un ultimo grido di speranza e vi prego, Signor Ministro, di pensare al mio povero bambino che muore lentamente. Se deve morire combattendo, che sia per la giustizia e per il più sacro dei diritti: la libertà.
* * *
La risposta è secca, brutale. È un no. I forzati sono indesiderabili sul suolo francese. Non meritano l’onore di difendere un paese che li respinge. La società non ha neppure quella generosità. Alexandre non è sorpreso del risultato dell’iniziativa materna:
« ...Mia buonissima, tu ti fai di questa questione il centro della terra mentre i dirigenti hanno altre gatte da pelare... Non te la prendere per niente. Abbiamo fatto quel che abbiamo potuto, sinceramente, senza secondi fini... Poco importa quel che pensano o non pensano gli altri...
«Quando, come noi, s’è arrivati al tramonto della propria vita ed esaminando la propria coscienza si può francamente affermare che non si è mai tradito alcuno e s’è sempre rispettata la parola data, questo va ben al di là delle inutili approvazioni altrui. Senza l’onore, penso che non varrebbe la pena vivere...
«Abbracci a tutti e a te, mia carissima, le mie più tenere ed affettuose carezze».
1916. Attacco tedesco su Verdun, in febbraio. Battaglia navale dello Jutland, in maggio. Conquista del forte di Vaux, in giugno. Offensiva della Somme, in luglio. Esplodono gli Zeppellin. Muore Gallieni. Viene nominato generalissimo Nivelle. Louis Lecoin è alla Santé. E la Lega dei diritti dell’uomo interviene invano a favore del forzato Jacob.
Dopo aver mancato, per stizza, di far saltare con la dinamite il Maroni con il governatore della Guyana, il direttore del bagno ed il procuratore generale a bordo, un bel fuoco d’artificio fallito perché le cartucce erano troppo umide, il rammarico di non aver visto dei pescecani divorare altri pescecani, ma anche, in fondo, una bella assurdità evitata, Alexandre si fa mandare da Marie millecinquecento franchi, due revolver, una vela e dei salvagenti (del tipo che si chiamerà poi “Mae West”), il tutto all’indirizzo di un forzato di nome Firbos, che verrà presto inviato come relegato a Saint-Laurent. Alexandre, per edificare la mente di Firbos, gli presta L’unico e la sua proprietà, la sua bibbia stirneriana. Firbos, che non ha mai aperto un libro in vita sua, prende le frasi alla lettera. Da quell’apologia dell’Io, egli trae una giustificazione per tutti gli egoismi e per tutti i tradimenti (come tanti altri hanno fatto un tempo, come i nazisti, più tardi, vorranno trovare la loro giustificazione in Nietzsche) e si tiene per sé denaro e materiale.
Deluso per l’ennesima volta, Alexandre non crede più alla possibilità di evasione collettiva. Nemmeno Dieudonné, il falegname anarchico di Nancy, coinvolto nel caso della banda Bonnot, con il quale egli ha stretto amicizia al suo arrivo, nel 1913, verrà più associato ormai nei suoi progetti. Con un’audacia disperata, egli gioca la sua ultima carta.
Una notte di ottobre del 1917, dopo aver segato le sbarre della sua cella, si butta in acqua. In mancanza dei “Mae West”, s’è fissato dei galleggianti alle caviglie, alla cintola e alle spalle. S’è anche munito di una pagaia. Niente revolver, niente acqua potabile, poco denaro nel suo cilindretto. Suo obiettivo: fare il giro dell’isola, arrivare in una zona selvaggia, costruire una zattera e partire da là. I pescecani? Sempre meglio che la vita d’ogni giorno al bagno. Del resto, non ne incontra nessuno, ma scopre invece una corrente più forte di quel che aveva immaginato. Il mare è gelido. Le ondate gli colpiscono la faccia. Dei mulinelli lo trascinano. Sviene.
Quando si riprende, capisce che è stato sbattuto sulla spiaggia, a pochi metri da dove è partito. Spunta l’alba. Non ha alcuna speranza di riguadagnare il suo buco senza essere preso. Allora si sbarazza dei suoi vestiti, tira fuori il suo cilindro e inghiotte una dose massiccia di cloridrato di morfina: quel famoso veleno che Marie si era procurato all’ospedale Saint-Louise e di cui egli aveva letto su un libro scientifico che provoca una morte apparente. Prima di cadere in catalessi, egli va un po’ più distante sugli scogli.
Lo scoprono. Lo portano all’ospedale, quindi all’obitorio. Questo è stato da lui previsto in caso di fiasco con i galleggianti. Pensa di approfittare della notte successiva per segare una sbarra, recuperare la vela, machete e corde nascoste sotto una roccia e costruire una zattera.
Ma ha assorbito troppa morfina, la paralisi non scompare che ventiquattr’ore più tardi, in pieno giorno, mentre un infermiere gira per l’obitorio. Viene preso da un’incontrollabile tremito nervoso. Lo trasportano in ospedale. Il medico sonda il suo stomaco, gli somministra una lavanda e scopre nel cilindretto un resto di cloridrato di morfina. Alexandre non risuscita che per essere ancora una volta trasferito in una cella dell’infermeria.
Per quindici giorni, il suo corpo rifiuta qualsiasi nutrimento. Per quindici giorni delira. I più orribili, i più minacciosi incubi che siano possibili per un essere umano l’assalgono. Urla nel sonno. Dei mostri gorgogliano in lui e gli divorano il cervello. Si sente diventare pazzo.
Il sostituto l’interroga: Alexandre sostiene il tentativo di suicidio. Inoltre, la notte stessa in cui si sono svolti quei fatti, un altro forzato, di nome Soccodato, che tentava autonomamente di evadere in compagnia di tre kapò, s’è fatto assassinare da loro. Alexandre utilizza questa coincidenza: lui doveva unirsi a Soccodato. Ma ignorava la presenza dei kapò. Quando l’ha saputa, ha pensato che la barca nella quale dovevano fuggire non avrebbe potuto contenere cinque uomini egli quindi ha ceduto il suo posto, poi, per la disperazione, ha tentato di mettere fine ai suoi giorni. Inoltre, un articolo del regolamento afferma che un’assenza di dodici ore dal luogo di detenzione non può essere considerata come un’evasione.
Il sostituto, senza credere a una parola, prende per buono tutto ciò. Il nuovo direttore, Crucioni, informato, viene preso da una collera furiosa e gli infligge trenta giorni di cella per dichiarazione menzognera.
Il 10 aprile 1918, neppure il Tribunale Marittimo Speciale davanti al quale viene deferito gli crede e lo condanna a due anni di cella.
Forte di un paragrafo del regolamento riguardante l’assenza di meno di dodici ore che persino i giudici ignorano, egli ricorre in Cassazione: il primo agosto, la Corte suprema gli dà ragione. Rimane da affrontare un’altra volta il Tribunale Marittimo.
Ad ogni modo, la notizia gli dà nuova forza, poiché è ancora a un passo dalla morte.
«Ti ricordi quando t’ho detto che assomigliavo ad un baobab? Povero me! Il baobab s’è trasformato in salice piangente! Quando cammino, sembro un accento circonflesso alla ricerca di una vocale!». Indebolito da tanti anni di detenzione, eroso dal veleno ingoiato, il 12 maggio l’hanno dovuto operare di emorroidi: «Ho dovuto decidermi ad andare in cala secca. Raddobbato il 12, la falla non è stata ben turata...».
Lo operano di nuovo. Il suo fisico si scava, il ventre gli si gonfia; non si tiene più in piedi. I muscoli si sono sciolti. Le ossa quasi bucano la pelle. Si manifesta una tubercolosi ossea. Terzo intervento chirurgico, che gli consente almeno di essere trasportato dalla cella all’ospedale, dove trascorre sei mesi. L’apache Manda, ex amante di Casco d’oro [famosa ballerina delle “Folies Bergères”, n.d.t.], condannato ai lavori forzati nel 1902 e promosso infermiere, non gli risparmia nulla. Come può sopravvivere ad un simile trattamento? Mistero. Ma guarisce
«Santa donna, ti rattristi proprio a sproposito. Mi credi disgraziato e io lo sono molto meno di quanto tu pensi. La disgrazia non è conseguenza delle situazioni, ma delle idee che ci si è fatti. Ed è proprio perché io vedo le cose sotto un’altra luce rispetto al comune mortale che sono meno disgraziato in una segreta che molti altri nei loro salotti. Attualmente, ho il sangue ringiovanito, i nervi solidi e la carne dura. I buoni semi, si dice, non ammuffiscono mai. È sicuramente questo il motivo per cui, anche se da anni cuocio a fuoco lento nella segreta del bagno, non sono tuttavia roso dai vermi. Mi tengo su in tutte le maniere... Mi lascio morire alla dose di un milligrammo al giorno: vedi dunque che non sono pronto a rendere l’anima... Il che è un male per i caratteri deboli e al contrario un bene per i caratteri forti...».
Il 31 marzo 1919, il Tribunale Speciale, di malavoglia, deve assolverlo definitivamente: il regolamento è il regolamento. Se lo si rispetta, non c’è effettivamente stata alcuna evasione.
Il 10 aprile, per ricompensa, il direttore Crucioni lo gratifica di dodici giorni di cella: giacché non c’è stata evasione, c’è stata, quanto meno, assenza non giustificata. Alexandre protesta presso il ministro: come può permettersi il direttore di farlo condannare in dispregio alle decisioni della Corte di cassazione e del Tribunale speciale? L’11 novembre, viene siglato l’Armistizio con la Germania. In dicembre, nella gioia della vittoria, viene decretata un’amnistia generale per i piccoli reati: Alexandre se ne avvantaggia. Ha vinto. Non che quei dodici giorni gli importassero granché; del resto, egli li ha già largamente scontati quando giunge la notizia all’Isola Reale. Ma, dal dicembre 1917, egli non è legalmente incorso in alcuna condanna. Il suo fascicolo penitenziario è vergine da più di diciotto mesi.
Con la sua calligrafia migliore, redige una domanda di promozione alla prima classe. Il direttore, ricevendola ha un colpo. Si fa portare Alexandre nel suo ufficio:
– Jacob, la pazienza ha un limite. Segate le sbarre, fabbricate zattere, ingoiate veleno, sobillate un’atmosfera di rivolta nel campo, riuscite a prendervi gioco del Tribunale Speciale e avete il coraggio di credere che potrete passare in prima classe!
– Signor Direttore, il regolamento è il regolamento – risponde Alexandre. – Se non ritenete giusto accogliere la mia domanda, posso riferirne al ministero...
Malgrado un rapporto estremamente sfavorevole di Crucioni (“Il detenuto non pare essersi sufficientemente emendato per farne oggetto di una promozione”), il 1° aprile 1920, dopo settantanove mesi di bagno, di cui quarantatre passati in cella o in segreta, la matricola 34477 viene nominata di prima classe. Potrà essere assunto come domestico in una famiglia, mangiare un po’ meglio, godere di una libertà relativamente maggiore. Non è l’attribuzione di una concessione (questo favore il ministero non glielo accorderà sicuramente mai) ma, dopo diciassette anni di internamento, è una vittoria. In verità, dopo il fiasco di diciassette tentativi d’evasione, le isole della Salute hanno anche dimostrato che non mollano tanto facilmente la loro preda. Bisogna allora rassegnarsi a morire li?
* * *
Isole della Salute – Dicembre 1920
Mia buonissima,
tu ti sforzi di consolarmi, di prepararmi al risultato delle tue iniziative come se non avessi superato l’età dei sogni. È un peccato tormentarsi invano...
Non ti angosciare per me, mia carissima. Come il diavolo, io mi sono fatto eremita e, benché la mia tebaide sia disseminata di lunghe spine, posso però gustarmi delle grandi e sane gioie intellettuali. Imporsi volontariamente qualche “tu devi” imperativo, ridere quando gli altri gemono, sopportare dignitosamente l’indigenza, cercarla perfino, vergognandosi di aver vergogna, ecco quel che si chiama vivere e, all’occorrenza, può giustificare il saper morire. Rendersi conto dell’assoluta vanità delle cose e, nonostante questo (o proprio a causa di questo), convenire che è ancora più vano parlare di vanità. In questo conflitto di pensiero, è l’Ecclesiaste ad avere ragione: “Un microbo vivo vale più di un elefante morto”. Tutto il resto non sono che chiacchiere vane. Su, mia carissima, non te la prendere per niente. Non siamo più al tempo meraviglioso in cui si abbattevano le mura al suono delle trombe. Oggi, a questo scopo, si utilizzano mortai da mille chili. È l’eloquenza dell’ora. È quindi? dirti che una volgare supplica, quali che siano le sue basi e la sua sincerità, non saprebbe aver ragione dei pregiudizi di tutto un popolo...
* * *
Alexandre viene dapprima assegnato per diciotto mesi ad un sorvegliante militare, il vice capo Pascalini. Di origine corsa, come la maggior parte dei suoi colleghi, costui, al contrario di quelli, non è né troppo brutale né troppo sanguinario. Poi al signor Abric, “vice direttore di ragioneria delle materie prime delle colonie”, un bordolese pacifico e generoso. Egli è quasi felice. Si occupa delle faccende domestiche e di lavare i piatti; lava, cuce, stira e serve a tavola: il paradiso o quasi.
Ha patito tante disgrazie e la sua salute è tanto malferma che sente il bisogno di recuperare un po’, adesso. La sua nomina alla prima classe può essere rimessa in questione ogni anno. Ogni sbandata, ogni gesto sospetto, ogni tentativo abortito sarebbe catastrofico.
Del resto, non ha il tempo di annoiarsi. Da quattro anni, un’idea gli frulla per la mente: scrivere un libro sulla criminologia. Nei suoi rari momenti di tempo libero, ha già accumulato gran quantità di note. Ha consultato tutte le opere che si possono leggere a questo riguardo. In tutte, egli ha ritrovato le stesse aberrazioni: «Come una formica potrebbe scoppiare in una risata omerica dinanzi a questa o quella affermazione di un naturalista, così le deduzioni dei criminologi potrebbero apparire temerarie ad un criminale». Dopo aver frequentato ogni tipo di malfattori possibile, la differenza tra le teorie, i testi e la realtà gli salta all’occhio con evidenza. Quel che lui stesso ha sopportato è un esempio significativo dell’atteggiamento della società nei confronti di quelli ch’essa giudica nocivi. Raccontare i patimenti subiti, di cui del resto egli non si lamenta mai e che hanno contribuito a forgiare l’uomo che egli è diventato, può sicuramente aiutare certuni a prendere coscienza. Trasformare il mondo? Jacob non ci pensa decisamente più. Se non ne ha avuto il mezzo nel suo sotterraneo, nessun altro ne ha: quel che è venuto a sapere in frammenti, della rivoluzione russa dell’ottobre 1917 e della sua evoluzione dopo il 1919, gli sembra molto chiaro. Era davvero il caso di rapinare la banca di Tiflis, per finire alla dittatura dei burocrati sul proletariato? Più modestamente, egli vuole portare la sua testimonianza su certi oscuri meccanismi di questa civiltà industriale che un tempo egli attaccava così presuntuosamente. Una cronaca sulla parte nascosta dell’iceberg.
Il nodo del problema penale è questa idea mostruosa di cinismo ipocrita, secondo cui il criminale è un’eccezione mentre la maggioranza è costituita da “gente onesta”. È vero il contrario. Ognuno ha per lo meno qualche delitto da rimproverarsi, tradimenti, furti, prepotenze, delazioni, menzogne, ossia dei crimini non fosse altro che per indifferenza. I santi, i puri, gli angeli non esistono. Quelli che vengono chiamati onesti hanno semplicemente avuto fortuna: non si sono fatti prendere. O hanno astutamente utilizzato la protezione della legge, o la loro pigrizia personale e forse l’influenza generosa e comprensiva di parenti ed amici ha loro impedito di commettere troppi danni; o ancora le conoscenze della famiglia hanno messo riparo ai guai: insomma, si vedono meno figli di papà trascinati dinanzi ai tribunali che figli delle periferie.
Ancor meglio: alla base di tutte le fortune, sta il crimine. I nobili un tempo assassinavano i servi; i padroni d’industria, oggi, affamano i loro operai; Rockefeller manda in rovina i suoi concorrenti quando non li fa abbattere dai suoi scagnozzi; Rothschild costruisce la sua fortuna su qualche centinaio di milioni di morti. Chi se non Schneider o Renault è colpevole, quando un impiegato muore per tubercolosi a causa della sottoalimentazione, mentre lui possiede quattro castelli? E le guerre, questi fenomeni che si pretendono irrazionali, non sono forse un massacro deliberato, ordinato dalla volontà di potenza di pochi?
Rimangono i disgraziati, quelli che la società respinge in un gesto di dignità oltraggiata, quelli che la giustizia e i benpensanti chiamano più propriamente criminali. Gli uni sono tarati, degenerati che non si sarebbe neppure dovuto lasciare in vita, un’infima minoranza il cui posto non è né al bagno né in prigione, ma nei manicomi (come il Grand Chiquet che riempie le sue file con cadaveri di bambini); gli altri costituiscono la massa dei malvoluti: un padre che beveva, una madre che sbraitava, una catapecchia insalubre, il disonore a cinque anni e, ovviamente, l’umiliazione a dieci, sentita crudamente, la mancanza di studi, le “cattive compagnie” che non furono che emulazione nella sete di rivincita, l’ingranaggio. Finché alcuni bambini saranno dei signori ed altri si vestiranno di panni logori, esisterà l’invidia.
Ma Jacob, a quarant’anni, rifiuta ormai ogni sistematizzazione: gli è costata troppo. Vuole parlare semplicemente delle migliaia di casi che conosce bene e spiegarli. Utilizzerà, secondo le sue parole, un “metodo sperimentale” o, per meglio dire, empirico. Allineerà fatti che basteranno da soli a battere in breccia le idee preconcette.
Se la parità sociale alla nascita è un’utopia, la società potrebbe almeno compensare la sfortuna dei più sfavoriti dispensando un’educazione realmente democratica. Permettendo a tutti i figli di vagabondi di avere accesso al Politecnico, allo stesso titolo del rampollo del capomastro o dell’impiegato d’ufficio. Ma essa non lo fa. Un pastore nato a Boulloc, villaggio di cinquecento anime situato nell’Aveyron, un figlio di serva nativo di Rueil, vedono il loro avvenire ostruito da una serie di ostacoli tanto più difficili da superare in quanto sono nascosti. L’istruzione gratuita ed obbligatoria per tutti è stata un tentativo; rimane una trappola.
Da adolescente, per rivolta, si ruba una bicicletta; ci si fa acciuffare. Il gesto non è da grandissimo criminale. Ma si verrà buttati in prigione. Si verrà insultati dai secondini, si scoprirà il prestigio dei duri matricolati. Se ne uscirà peggiori di quanto si è entrati. Si diventerà recidivi.
E anche se per miracolo il colpevole ammette la malvagità o, almeno, la goffaggine del suo gesto, anche se egli si “pente” sinceramente, nella stragrande maggioranza dei casi, non troverà più lavoro, almeno decente, una volta liberato. Sarà un pregiudicato, marchiato per tutta la vita. Invece di rieducare, di emendare, di cercare di recuperare i colpevoli, li si punisce. È sicuramente un’economia nel bilancio nazionale al capitolo delle prigioni e del personale penitenziario. Ma a quanto ammonta lo spreco di energie per il paese, i danni commessi da individui sistematicamente messi nella condizione di diventare criminali e che, a volte, lo sono stati solo perché erano meno deboli di altri?
Questi teppisti (oggi si direbbero gangster) di cui Alexandre si lagna tanto al bagno sono senz’altro divenuti irrecuperabili. Ma il fatto è che sono stati spinti in questa direzione. E quelli che potrebbero emendarsi vengono ostacolati sistematicamente, con tutti i mezzi. Sono le concessioni distribuite con il contagoccie: centocinquanta in tutto nel 1920, per seimila detenuti; sono l’assurdità, l’inutilità consapevole del lavoro; è la sorte dei relegati, come Baudy o Bonnefoy, peggiore forse di quella dei deportati: senza denaro, senza possibilità di guadagnare, essi sono condannati a morire (crepare, sarebbe più esatto) o a scappare; è la legge del “raddoppio” che costringe alla “relegazione” per un periodo uguale a quello della propria detenzione un uomo condannato a meno di otto anni di lavori forzati; è la sorte di quelli liberati sul posto dopo il “raddoppio”, privati anch’essi con scuse varie della possibilità di trovare un impiego, incapaci di pagarsi il viaggio di ritorno in Francia, destinati all’insabbiamento, all’alcolismo, alla perversione, all’agonia, alla morte.
Ci sono quei relegati moribondi che alla Caienna caricano sui tender delle locomotive finché muoiono in seguito agli strattoni. C’è il caso di Roussenq, condannato a vent’anni di lavori forzati, oltre al raddoppio, per aver dato fuoco al suo pagliericcio un giorno nei battaglioni d’Africa. C’è quel sergente maggiore di fanteria coloniale, condannato a trent’anni per aver rubato duecentocinquanta franchi e che è diventato cieco. C’è “Charvein”, il campo dei cosiddetti incorreggibili dove i guardaciurme organizzano tra i detenuti duelli a morte con il pugnale per una mela. C’è dappertutto l’ignominia, dinanzi alla quale quelli per bene nascondono la faccia. L’esempio grottesco della Guyana è significativo. Il punito fa da alibi al non punito per considerarsi una persona onesta. Il forzato rassicura i galantuomini sulla loro probità, forse più apparente che reale.
Tutto ciò, Jacob l’ha chiaramente esposto, un po’ più tardi, in una lettera all’avv. Lafont, l’ex difensore di Ader, diventato deputato: «Mi chiedete a che titolo io mi occupo di problemi penitenziari? Ma per diritto di competenza. Credete che se gli storni avessero diritto alla parola, non sarebbero competenti a parlare di gabbie e di voliere? Non ho subito prigione e reclusione per venticinque anni, due mesi e otto giorni? Ho il proposito di partecipare, seppure con mezzi modestissimi, ad ogni miglioramento della pratica penitenziaria allo scopo di alleviare, di mitigare la sorte dei miei fratelli di disgrazia...
«Conosco la più angosciosa delle miserie, non ignoro le più dure sofferenze. E quindi alleviare, mitigare la sorte dei miserabili è per me una grande soddisfazione, una delle mie ragioni di vita...
«Se si pensa che il criminologo più rappresentativo della scuola francese, Gabriel Tarde, non ha saputo uscire da questo vicolo cieco: “Fare soffrire senza far morire, oppure fare morire senza far soffrire”, meditazione cino-latina o medievale, che pena! Tutti questi scienziati da biblioteca non sanno niente del grande libro della vita. Tutti i loro sistemi sono costruiti in funzione delle loro idee personali, delle loro convinzioni e soprattutto dei loro interessi di classe...
«Un codice da cui bisognerebbe sradicare questa menzogna: “La delinquenza è l’eccezione, l’onestà è la regola”, che è la pietra angolare di ogni repressione barbara, un codice che facesse tabula rasa dei concetti di punizione e di espiazione, un codice che tendesse a prevenire piuttosto che a reprimere, sorretto da una scienza penitenziaria preoccupata innanzitutto dell’emendamento, questo sì che onorerebbe un paese civile. Emendare significa bonificare, rendere migliore. Ora, in Francia... il legislatore non si preoccupa che del castigo. Nell’esporre la sua mozione, il vostro collega (ho dimenticato l’onorevole, scusatemene) il signor Maurice Drouot riconosce che il bagno è una ignominia... E sapete quel che il vostro collega, l’onorevole collega, intende con ignominia? Rassicuratevi, non sono le torture del regolamento e del clima, non sono i furti e i crimini commessi dagli agenti e dai funzionari contro i forzati, non è lo spreco, è semplicemente la pederastia! Ma, destino infame, non hanno quindi niente tra le gambe, i vostri colleghi? Che cosa diavolo volete che facciano i forzati dei loro gameti? È una cosa naturale. Naturale come bere, mangiare, respirare. È una conseguenza delle condizioni particolari alle quali sono assoggettati, piuttosto che della loro volontà... E in cella, il detenuto forse non si masturba fino a perdere la ragione? Io ne so qualcosa. Ho passato nove anni di segreta, i ferri ai piedi e in totale tredici anni di regime cellulare...
«Certo, sono perfettamente convinto che in materia di legislazione penale in Francia soprattutto, in cui l’opinione pubblica è all’oscuro di questi problemi, la legislazione si mostra opportunista, procede lentamente per brevi tappe ed esige poco allo scopo di realizzare qualcosa piuttosto che niente. E tuttavia, questa “reclusione aggravata” di cui si parla sarebbe una vergogna se venisse definitivamente approvata. I professori Garçon e Hugueney che ne sono i padri non hanno dovuto consumare molta materia grigia per partorire questa barbarie!».
Questa attività intellettuale gli permette di riprendere un po’ di forza. La fuga ritorna al centro delle sue preoccupazioni. Ha ricominciato ad accumulare del materiale. Ma i suoi insuccessi l’hanno reso fin troppo prudente. Una fuga dalle isole sarebbe l’ultima risorsa, da non tentare che se tutto il resto fallisse e l’ideale rimane uno spostamento alla categoria B, che permetterebbe di ottenere finalmente una concessione sul continente. Da là con l’aiuto di commercianti cinesi che trafficano di tutto, barche e viveri, potrebbe partire nelle migliori condizioni possibili. Meglio subire un anno di più e non fallire il colpo. Jean Normand descrive Jacob a quell’epoca: «È un uomo vivace, abile, dall’intelligenza superiore, in grado di assimilare rapidamente qualunque cosa, coraggioso e combattivo, contemporaneamente entusiasta e freddo, leale con i suoi simili, astuto con il nemico (è così che lui chiama il suo padrone). Purtroppo, egli è stato finora fin troppo fantasioso e complicato nei suoi progetti, che sarebbero stati eccellenti se avesse avuto a che fare con degli altri Jacob ma che, con una popolazione come quella penale, si sono rivelati manchevoli. Se n’è d’altronde accorto a sue spese, poiché è stato molto spesso ingannato da costoro, il che lo blocca adesso nella sua capacità di decisione che era rapida quand’era giovane... Adesso sta invecchiando perché saranno presto vent’anni che sta nelle Isole della Salute. In questa lunga detenzione è sostenuto dal pensiero della madre che egli ama profondamente. Ha letto e legge ancora enormemente... Insomma, è uno degli uomini più interessanti da studiare e, secondo me, uno degli uomini più notevoli del bagno. Non è stato mai neppure sfiorato da qualcuno dei vizi così numerosi inerenti alla categoria penale...
«Dal suo arrivo al bagno, come chiunque cambi ambiente, Jacob ha avuto profonde evoluzioni... Appena ha un momento di tranquillità, si sprofonda nei suoi libri, nei suoi numerosi affari con la giustizia e nei problemi giuridici. Richiede a sua madre, che glieli invia, tutti i libri di diritto che riguardano problemi criminali e si mette a studiare...
«Quel che c’è in lui dell’eredità meridionale traspare da qualche gesto esuberante, da una mimica tra le più espressive. Le sue idee adesso non sono più eccitate, entusiaste come in passato: oggi egli è impregnato da troppo tempo e con troppa persistenza dal pensiero freddo, meditato, posato dei giuristi...».
L’arrivo del dottor Louis Rousseau all’Isola Reale, il 1° settembre 1920 gli restituisce coraggio e pazienza.
Il fatto è che Rousseau è un uomo. Il primo che Alexandre incontri da lunghissimo tempo. Medico militare spedito in Guyana con il grado di comandante per lasciare morire i forzati, egli li cura e li tratta come esseri umani, cosa che non s’era mai vista.
Il forzato e il comandante fanno conoscenza sulla piazzetta dell’isola. Il primo sta spazzando, il secondo si riposa su una panca. Il dottore gli rivolge qualche parola. Affascinato dalla cultura di questo stupefacente detenuto, ritorna l’indomani, quindi tutti i giorni. Nasce una straordinaria amicizia. Le barriere sociali cadono. Rousseau gli manifesta la sua ribellione, la sua delusione. Alexandre lo calma. Gli racconta le astuzie giuridiche che utilizza ogni settimana per dare coraggio ai suoi compagni; gli spiega i testi di legge, la giungla dei decreti e dei regolamenti; la mentalità dei sorveglianti e dei porta-chiave, la perfidia delle relegazioni e della liberazione, l’imbecillità di vedere un così bel posto insozzato dalla Tentiaire, l’ingranaggio che ha sbattuto qui la maggior parte di detenuti, la ferocia naturale degli altri, la follia sado-masochistica generalizzata, l’ossessione sessuale, predatrice, scapestrata, sudicia ed abietta che guida il gioco. Gli confida il suo progetto sulla criminologia.
– Anch’io – risponde con aria sognante Rousseau – vorrei scrivere un libro. Una testimonianza su tutto ciò che avviene qui e che non si conosce in Francia. Ma mi mancano moltissimi elementi. Queste leggi di cui parlate, quegli aneddoti che citate...
– Forse potrei aiutarvi – propone Alexandre.
Il suggerimento viene accolto con entusiasmo. La collaborazione inizia immediatamente. Durerà fino al 1923. Alexandre, pur rimanendo l’impiegato di Abric, lavorerà per una o due ore al giorno con Rousseau. «Jacob fu per me la più abbondante e anche la più sicura fonte di informazioni. Senza di lui, non avrei mai potuto terminare di scrivere Un médecin au bagne, che fu opera sua quanto mia», scriverà Rousseau ad Alain Sergent nel 1950. Invero, il forzato s’è dedicato tutt’intero a quest’opera che è la più impressionante delle requisitorie.
«I bagni della Guyana sono essenzialmente dei carnai dove, alleandosi alla sifilide e alla tubercolosi, tutti i parassiti tropicali (ematozoi del paludismo, anchilostomi, amebe della dissenteria, bacilli di Hansen, ecc.) diventano gli aiutanti più sicuri di un’amministrazione il cui ruolo è di guardare morire gli uomini che le sono stati affidati. I teorici più feroci della “eliminazione” possono essere soddisfatti...
«Infatti, il condannato non ha che un diritto, quello di stare zitto. Frustrato in ogni campo, nell’abbigliamento, nell’abitazione, nell’igiene personale così come nell’alimentazione, egli non si lamenta, per evitare le punizioni di una commissione disciplinare dinanzi alla quale chi reclama è obbligatoriamente convocato e che, per sistema, rifiuta ogni credito alla sua parola...
«Per i nostri vicini Olandesi, Inglesi e Venezuelani, è uno scandalo vedere arenarsi parecchie volte ogni anno sul loro litorale quelle zattere di fortuna cariche di evasi affamati che, sfidando i rischi del mare, hanno tentato tutto per sfuggire alla morte lenta, fatale, in penitenziario.
«Quanto ai metodi di riabilitazione, sono qui una cosa sconosciuta. E che dire del trattamento verso i pregiudicati, per la maggior parte psicopatici, sotto il sole dei tropici?
«In verità, i bagni penali della Guyana sono la negazione della profilassi criminale, dei metodi di rieducazione medica e pedagogica, della psichiatria, della biocriminologia, insomma del buonsenso!». (Louis Rousseau, Prefazione a Mireille Maroger, Histoire du bagne de Cayenne, op. cit.). Il trasferimento di Rousseau alla Martinica nel 1923 provoca un grande vuoto nella vita di Alexandre. Non che la sua sorte sia peggiorata: adesso fa il domestico, o piuttosto il segretario presso il signor Boulard, vice capo dell’ufficio, aiutante del comandante Crucioni. È lui che sbriga gli affari complicati; lui che fa lo spoglio dei fascicoli; lui soprattutto che indica le procedure da seguire agli altri forzati. Tutti, a un dato momento, hanno bisogno dei suoi servigi; tutti devono a lui qualche miglioramento nella loro sorte. Adesso non è più soltanto il capo dei forzati delle isole, ma è anche una persona importante, curiosamente rispettato dai sorveglianti corsi più patibolari. Tuttavia, il tempo passa e non succede niente. Marie si accanisce a Parigi dinanzi alle porte chiuse, sostenuta da un ridottissimo manipolo di fedeli, tra cui l’avv. Aron e la signora Bouillot. Jacob, malgrado il recentissimo sostegno dell’amministrazione locale che lo considera rassegnato perché, meno perseguitato mostra meno i denti (con l’età, gli è venuto anche il senso della diplomazia), si scontra con rifiuti ogni volta che chiede lo spostamento. L’aiuto promesso da Chanel, governatore della Guyana, non si rivela per nulla efficace; a Parigi, il ministero si ostina: “Capo di una banda anarchica e individuo pericoloso... Il suo emendamento parrebbe dei più inverosimili... Archiviare”.
Il senso dell’umorismo è la migliore difesa di Jacob in questo tipo di circostanze: «Non bisogna disperare – scrive a Marie nel gennaio 1924. – Così, credo che, tra quindici o venti anni, una simile richiesta verrà presa in considerazione. Non è, capisci, che una questione di tempo. È un peccato che non possa ricevere niente da te, se no, avresti potuto inviarmi qualche litro, se necessario una botte, di elisir di lunga vita...».
Tutto è pronto per l’ultimo tentativo di fuga. Corde, vele, viveri, cesti di legno, nascosti in un casotto in cui non va mai nessuno. Giocherà la sua ultima carta; in ogni caso, non ritornerà più lì. Non vivo.
Sta per partire quando qualcosa sembra muoversi. Un impercettibile fruscio, dapprima. Una petizione della Lega dei diritti dell’uomo, alla fine del 1923, alla quale sono allegate testimonianze elogiative dell’aiuto capo Pascalini, di Abric, del dottor Rousseau, del sotto capo Boulard e che provoca un po’ di rumore. E poi l’arrivo del grande giornalista Albert Londres, parecchie conversazioni con lui, la sua inchiesta comparsa su “Le Petit Parisien” e la sua lettera aperta ad Albert Sarraut, ministro delle Colonie, sullo stesso giornale, il 26 settembre 1924, che ha l’effetto di una bomba: «Non è di riforme che c’è bisogno in Guyana, ma di un rivolgimento generale...». Segue un intervento alla Camera del deputato Louis Marin, in novembre, che solleva l’entusiasmo: «Non esiste nel mondo intero un professore di diritto, un criminologo, un moralista che, riguardo al confino e alla deportazione, non vi dica che quelle pene sono superate e che è veramente sorprendente che la Francia, unica tra le grandi nazioni, ne mantenga ancora l’applicazione!».
Poi, l’arrivo successivo a Reale di due giornalisti Le Fèvre e soprattutto Louis Roubaud, che trascorre lunghe ore con Alexandre e riparte con un servizio che fa scalpore... Non sono che indizi, naturalmente, ma l’opinione pubblica, ridestata all’improvviso, sembra interessarsi alla sorte di quegli autentici dannati della terra.
A Parigi, assecondata, preceduta, sostenuta dall’avv. Aron e da sua moglie, Marie fa pressioni. È un assedio in piena regola nelle anticamere. Una pioggia di richieste: 10 gennaio 1925: «Una madre disperata... sessantacinque anni... la Vostra Clemenza...», 19 gennaio: «Il mio povero figliolo... padre alcolizzato violento... Costretto a navigare da quando aveva undici anni, trascinato da compagni esaltati... Non desidera più che una cosa, soccorrere gli ultimi giorni della sua vecchia madre... ».
La commissione per la grazia respinge un’altro ricorso. Ma Edouard Herriot, presidente del Consiglio, dà un segnale favorevole. Pierre Laval, che della questione del bagno penale ha fatto il suo cavallo di battaglia, soffia sul fuoco.
E poi, il 27 febbraio 1925, c’è l’esplosione. Un grande articolo su due colonne di Francis Million, il direttore del “Peuple”, organo della CGT: «Dopo aver riconosciuto lo sbaglio commesso e quale che ne sia la gravità, si deve ammettere che Jacob sia definitivamente allontanato dal mondo dei vivi e che sua madre debba considerarlo come morto?... Sarebbe eccessivo considerare che una pena di vent’anni di lavori forzati è una punizione sufficiente per un esordiente nella vita che ha preso una cattiva strada?... Punizione meritata, diranno i galantuomini. E sia. Ma è l’Irreparabile? La parola “mai” può essere gettata in faccia a questa povera madre che tende le braccia verso colui che, nonostante tutti i suoi errori, non ha cessato di essere suo figlio carissimo? Avremmo forse lasciato in vita questo disgraziato solo per torturarlo più a lungo?».
Sul “Quotidien”, Louis Roubaud raccoglie il testimone: «Che cosa pensereste della medicina se fosse stata codificata e si basasse unicamente sulla temperatura del malato? Ad ogni grado di febbre corrisponderebbe un solo e identico trattamento per tutte le affezioni... Ecco a che punto siamo e non, grazie a Dio, in medicina, ma in criminologia... Potete scavare in tutta la vita di Jacob, riportata nelle centosessantuno pagine dell’accusa del processso di Amiens, potete leggere i resoconti di questi dibattimenti come li ho letti io su vecchi giornali, spulciare le duecentoquaranta lettere che il forzato ha scritto a sua madre in vent’anni... Non troverete una malvagità né una viltà... Egli ha soprattutto commesso un delitto di orgoglio giudicandosi tanto grande da essere un ribelle e un delitto contro la logica realizzando individualmente la sua rivolta. Egli da vent’anni sta espiando la sua duplice follia ed ha molto sofferto per meglio comprendere che non si corregge l’opinione pubblica svaligiando dei castelli... Uomini maggiormente colpevoli sono stati trattati meno duramente perché si sono fatti umili. La grazia per Jacob! Egli ha sfidato la giustizia, ma non sfiderebbe il perdono!”. Albert Londres e il dottor Rousseau portano le loro testimonianze. Piovono lettere. Circolano le petizioni. Vecchi compagni, del tempo eroico dell’“Agitateur”, diventati tipografi, maiolicai, vetrai (“gente onesta”, insomma) intervengono: “Affermo che se egli fosse stato un egoista non avrebbe abbracciato le teorie che l’hanno rovinato...”. “Quando è stato arrestato dal commissario Fabre, Jacob era innocente. A partire da quel giorno, come per Liabeuf, di un bravo ed onesto lavoratore l’ingiustizia ha fatto un brigante...”. “Jacob s’è messo a rubare come avrebbe potuto militare tra il popolo; il movente sarebbe stato identico...”. Sautarel si mette a tuonare su “le Bonnet catalan”: “Quante persone, che godono della libertà e del rispetto non valgono una delle sue dita dei piedi? Per me, l’ho giudicato da vicino; è il più delicato e il migliore degli uomini...”. Si pubblicano suppliche di Marie, lettere di Alexandre, a manciate, racconti di superstiti del bagno che l’hanno conosciuto. “Un errore giudiziario?” riprende Roubaud. “No. Ma forse un errore sociale. Jacob non è innocente. Egli è stato condannato per crimini che ha commesso. Venti anni fa, ad Amiens, in una gabbia troppo stretta per contenere gli imputati e le loro guardie, un giovane si ergeva, levava la voce per rivendicare a sé ogni responsabilità. Arringava a favore di ognuno dei suoi complici e rivolgeva una requisitoria contro se stesso. Era il capo: Jacob!».
Marzo, aprile: la campagna di stampa si gonfia. Tutta la Francia conosce di nuovo il suo nome. Lui, sul suo scoglio ai Tropici, tenuto al corrente di quel baccano da Marie, rimane scettico. Troppe volte ha sperato invano!
Tutto quel chiasso finisce tuttavia per avere un effetto. La cancelleria riesamina il suo caso. Gilbert, il giudice istruttore della Banda Bonnot che, diventato direttore degli Affari criminali, si occuperà dell’affare Landru, studia il fascicolo e, l’8 luglio 1925, lo commenta favorevolmente. La sua condanna viene commutata in cinque anni di reclusione da scontare in Francia.
Il 26 settembre viene imbarcato, manette ai polsi, sul Biskra, con rotta Saint-Nazaire: «Gli tolgono i ferri ai piedi per condurlo al battello», scrive il giornalista Alexis Danan. «Non riusciva più a camminare. Lo issano a bordo del Biskra come un moribondo, a piedi nudi, gonfi, appiccicosi di sangue nero, il corpo che balla in una tuta blu. Si era in settembre. Aveva i capelli bianchi di un vecchio che vuol rivedere il suo villaggio prima di morire». Arriva in Francia il 18 ottobre. Lo trasferiscono immediatamente al carcere di Rennes. Marie supplica che lo riportino a Parigi: lei è troppo povera per pagarsi continui viaggi in Bretagna. Acconsentono: inviano suo figlio a Fresnes, poi a Melun, dove lavora alla tipografia. Ultimo guizzo: si rifiuta di denunciare un detenuto tedesco. Lo mettono in cella, dove trascorre parecchi mesi. Il bagno non ha scalfito il raddrizzatore di torti che è in lui.
Ma non sono che ultimi fuochi. I1 19 giugno 1926, un decreto del presidente della Repubblica riduce la sua carcerazione a due anni. Marie si dà da fare ancora un po’: «La grazia per il 14 luglio... Ho sessantasette anni...». L’avv. Aron, diventato direttore della Società Marittima e Commerciale di Francia, promette di assumerlo nella sua azienda se gli viene accordata la libertà condizionale. Questo favore viene respinto. Egli deve subire integralmente i suoi ultimi due anni di detenzione: perché non ha fatto la spia...
Quando le porte della prigione si aprono finalmente dinanzi a lui, il 30 dicembre 1928, sono esattamente venticinque anni, due mesi e otto giorni, un po’ più di un quarto di secolo, che non vede sua madre. Che non fa un passo per strada. Che non respira liberamente. Ha quarantanove anni. La madre e il figlio si abbracciano semplicemente, come se si fossero lasciati il giorno prima.
Rose è morta da cinque anni.
V. Il padre tranquillo
Ora a Jacob rimane un altro quarto di secolo di vita: la fine di una fiaba, quando l’eroe è felice, si sposa e non rimane altro da raccontare.
In seguito ad un breve soggiorno in un ospedale parigino, dove lo “rimettono a nuovo”, s’improvvisa per qualche tempo infermiere. Poi, racconta Alexis Danan, «gli trovano immediatamente un’occupazione presso un amico caritatevole. Ma Jacob non s’accontenta della cortesia. Troppo fiero per stare alle spese dell’amicizia, egli intende restituire dieci volte il valore del salario ricevuto. Studia il procedimento di fabbricazione dell’officina, lo corregge, prende dei brevetti, fa raddoppiare il giro d’affari della ditta e, un bel giorno, saluta e se ne va. L’atmosfera di un laboratorio chiuso lo opprime. Uomo libero, ha bisogno di spazio».
A dire il vero, Parigi lo soffoca. Neanche Marie si sente a suo agio. Non sono mai stati parigini per adozione. Gli imbottigliamenti, i passaggi pedonali, il brulichio indaffarato della folla, gli danno le vertigini. Tutto è cambiato: la moda, le carrozze, le vetrine e i vecchi amici. I superstiti dell’epopea dei Lavoratori della notte, se non sono morti, conducono una vita pacifica da padri di famiglia, come Vaillant, che è diventato macellaio.
Quanto all’anarchia, essa fa (alcuni sperano provvisoriamente) la parte della perdente dall’ottobre 1917. In Russia, i bolscevichi hanno deportato orde di bakuninisti in Siberia; ne hanno giustiziato altri, hanno massacrato in Ucraina i partigiani di Makhno, che tuttavia li avevano salvati dalle truppe del generale Wrangel; hanno schiacciato la rivolta di Kronstadt. In tutto il mondo, gli “autoritari” godono di un prestigio incontestabile presso gli intellettuali come presso le masse. Anche in Francia, i tragici banditi della Banda Bonnot hanno provocato nell’opinione pubblica un’incresciosa confusione tra gangsterismo e anarchismo. I metodi d’azione collettiva hanno preso il sopravvento sull’individualismo. I sindacati si sono profondamente infiltrati tra il proletariato e la CGT si è sbarazzata dei suoi ultimi resti libertari per passare sotto il dominio marxista.
Anche molti vecchi compagni si sono lasciati prendere, come Pierre Monatte (che del resto vi è entrato nel 1924), dal fascino della vittoria di Lenin a Mosca. Agli occhi dei puri, essi sono rinnegati. La grande spaccatura, definitiva, ha avuto luogo durante un comizio alla Grande-au-Belles, nel gennaio 1924, allorché i bolschevichi hanno sparato sui libertari e ne hanno ucciso uno.
Il piccolo manipolo di quelli che non sono contaminati dall’idea della necessità di una dittatura del proletariato prima dell’avvento della società senza classi si sono raccolti in seno alla “Union Anarchiste”, creata nel 1920. Hanno un giornale, il “Libertaire”, di cui è diventato segretario di redazione Louis Lecoin. Loro obiettivo? L’antimilitarismo. L’obiezione di coscienza. La liberazione dei compagni spagnoli Durruti, Ascaso e Jover, arrestati nel 1926 a Parigi mentre si preparavano ad abbattere il re Alfonso XIII; l’infaticabile accanita difesa di Sacco e Vanzetti, gli anarchici italiani, la cui esecuzione, il 22 agosto 1927, ha provocato uno scandalo mondiale, in occasione del quale per una volta si sono ritrovati gomito a gomito i seguaci dell’“Humanité”, del “Libertarie”, del “Sillon” di Marc Sangnier, la Lega dei diritti dell’uomo e la Grande Loggia di Francia. Un episodio che fa scalpore. Un’incredibile abnegazione. Pochi seguaci attorno a Sébastien Faure e a Louis Lecoin.
Jacob ritrova con piacere quegli uomini per i quali non è morto l’ideale ch’egli ha difeso a suo modo. Custodi o profeti: l’avvenire lo dirà. In ogni caso tocca a loro continuare la lotta. L’attuale sconfitta della Causa su tutti i campi o quasi lo rende un po’ triste. Gli uomini sono dovuti diventar matti per credere alle virtù dell’intruppamento, per immaginarsi che la conquista della libertà debba passare attraverso la soppressione delle libertà acquisite. Lui, rientrato a cinquant’anni dal fondo della notte, deve rifarsi un posto al sole. Nella capitale s’intristisce tra il laboratorio, le riunioni e la stanzetta che divide con Marie, in passage Etienne-Delaunay 1, nell’XI arrondissement. Rifarsi una vita, o piuttosto farsi quella vita personale che egli non ha mai avuto? Sarebbe mai possibile, dopo quel che ha subito?
Non esita. Con il piccolo gruzzolo che ha accumulato sua madre (diecimila franchi, a cinquanta centesimi l’ora dal tempo della guerra), egli acquista uno stock di maglieria e, con gli scarponi da militare ai piedi, la sua paccottiglia in spalla, se ne va per i mercati “a grandi falcate, le narici larghe da marinaio che fiutano il vento”, dice Danan.
Prima di lanciarsi nel commercio, tuttavia, prova il bisogno di compiere un gesto simbolico. A Fresnes ha letto nella “Veillée des Chaumières” la descrizione di una vecchia casa, verso la Loira, il cui picchiotto sulla porta d’entrata sarebbe d’oro massiccio. Quel particolare lo stuzzica. È una provocazione. Immediatamente, raggiunge la città in questione, controlla la qualità del metallo con una pietra di paragone e sostituisce l’oggetto con un altro, dello stesso aspetto, che si è fatto fabbricare su misura. Quella piccola rapina lo rassicura su se stesso: non è un vecchio. L’occhio, la mano, il sangue freddo sono sempre ben vivi. Ha abbastanza forza per sfidare ancora una volta l’autorità. È tutto quel che vuol sapere. Non ruberà mai più. La strada, le fiere, la campagna: comincia per lui una vita da uomo libero. L’hanno tenuto segregato tanto a lungo che non si stanca del semplice piacere di girare per il paese. Lui conosce il valore di una siesta sotto una quercia, del bighellonare in una strada deserta, di una conversazione con compagni incontrati per caso. Dapprima si stabilisce con Marie nell’Yonne, poi nell’Indre, a Bois-Saint-Denis, una frazione vicino a Reuilly. I suoi affari vanno subito bene, tanto che può acquistare un grande tela da tenda sotto cui riparare la sua bancarella, una vettura e una piccola baracca. Egli è ormai “Marius Jacob – Maglierie, tessuti, confezioni – Casa fondata nel 1931 – Reuilly (Indre). Registro del commercio n. 4361 – Issoudun”.
Alexis Danan è andato a trovarlo nel 1935:
«Sua madre m’aveva detto:
« – Lo troverete sabato a Blois, domenica a Amboise, lunedì a Montrichard; vi sarà facile riconoscere il suo tendone. È blu e azzurro, con l’insegna “Marius”.
«Ho trovato Jacob, venditore ambulante, domenica ad Amboise, sul viale lungo la Loira... Lo sguardo acuto dietro gli occhiali d’acciaio, dei ciuffi bianchi che scivolano fuori da un copricapo bizzarramente messo di traverso, come la berretta di un pasticcere, un fazzoletto marrone attorno al collo, con indosso una tuta da meccanico e degli zoccoli ai piedi. Richiamava la clientela con una voce melodiosa che sapeva d’aglio, di mare e di sole.
« – Date un’occhiatina alla merce, signore, già che ci siete!
«Una contadina rubiconda si avvicina, tirando sul prezzo di una camicia da ragazzo che le pare un po’ corta, per strappare uno sconto.
« – Troppo corta – protesta Jacob – boh... Se fosse più lunga, credete che la lascerei a cinque franchi? Del percalle d’Alsazia, sapete?...
«Un altro trova la camicia troppo lunga. – Troppo lunga? Ci fate una piega e siete a posto!
«È così gioviale, così travolgente, così onesto che alla fine i contadini della Turenna, senza accorgersene, gli rispondono con l’accento della rue du Paradis... La sua vettura è il suo fiore all’occhiello, l’altra metà della sua vita (la prima rimane sua madre)...
« – Sedici bigliettoni, m’è costata – mi dice – e qui c’è merce per venti.
«È orgoglioso per il suo successo, per la libertà meravigliosa che gli permette di andare e venire, più che per quel che gliene viene in tasca. Non ha nemmeno bisogno di più, come quando aveva ventitré anni. Beve acqua, fuma due o tre pipate al giorno, non mangia che frutta, quando gli è possibile. La Turenna è il posto che preferisce, con numerosissime fiere. Va in giro per quei luoghi per dimostrare a se stesso la propria forza, ormai insensibile al richiamo dei castelli e delle cattedrali. Non lo tenta più alcunché, oltre alla strada, malgrado i gendarmi che, ogni tanto, vi scorge.
«Ma i gendarmi vanno in bicicletta ed è lui che gli dà la polvere, una volta tanto. È un uomo felice. Mi ha fatto una confidenza:
« – Metto su famiglia, credo.
« – A cinquantacinque anni, signor Jacob?
« – E be’? Si decide stamattina a Montrichard. È la donna di un compagno. Lui è talmente preso dalle sue idee che la trascura, poveretta. Allora io vado a dire così, schiettamente: “Senti, vecchio, quando ci vuole ci vuole. Se riesci a renderla felice, tienila. Se no, bisogna capire le cose, insomma, me la porto via...”.
E se l’è effettivamente portata via. Ma non è stata un’idea felice. Lei rubacchiava dalla cassa. Lui lo sapeva bene. All’inizio, ha fatto finta di non accorgersene: se a lei faceva piacere! Ma ben presto ha scoperto che lo disprezzava, lo prendeva per un merlo. Lei aveva, oltretutto, due figlie, due smorfiose, alte, ben fatte, che mentivano, litigavano, battevano il marciapiede, o quasi.
Avevano certamente il diritto di fare del loro corpo quel che volevano, le piccole, se così piaceva loro. Ma l’animo non era onesto. Lui era disposto a lavorare per tutte e tre, volentieri, fornire loro casa, cibo e guardaroba e farsi anche prendere per coglione. Ma quelle non sapevano distinguere tra la vera rivolta che ringhia, demolisce e costruisce e lo stupido imbrogliare. Insomma, troppo interessate per essere interessanti e lui troppo disinteressato per non passare per un buffone e il malinteso si approfondisce. Un bel mattino, sbatte fuori il terzetto.
Poi, Marie, l’unica donna della sua vita, muore, a settantacinque anni compiuti. L’aveva aspettato per venticinque anni. In seguito, avevano avuto quasi dieci anni di felicità insieme: sciocchezze, grandi silenzi, una parola “ti ricordi?...”. Quell’amore era di qualità troppo buona per dare spazio ad altri. Naturalmente, doveva succedere. Era improvvisamente invecchiata. Passava il tempo facendo i suoi piccoli acquisti, i suoi piccoli sauté di lepre, le sue piccole faccende, a Reuilly. Il suo passo s’accorciava. Trotterellava dietro alla sua scopa. È stata seppellita nel cimitero di Bois-Saint-Denis, dove è stata preparata la tomba anche per lui.
Alexandre, diventato Marius Jacob, certamente per meglio sottolineare la frattura con il passato, ha da tempo raggiunto la saggezza. Le rivolte di un tempo si sono rappacificate per lasciare il posto a un’indulgenza sconfinata. Quella gran belva metodica che era ha ceduto il passo ad un monaco buddista. S’è distaccato dalle apparenze. Le illusioni vitali si sono dissipate. Il velo di Maia è caduto completamente. Secondo i criteri cristiani, egli è ateo. Tranquillamente, superbamente. La religione fa parte dei travisamenti. Orpelli per paurosi. Ma è un mistico. Saggio e santo insieme. Zen, si potrebbe dire, se questa parola non fosse tanto svilita in Occidente. Ha scelto di “seppellirsi” a due passi da Issoudun, questa città che, secondo Balzac, “avrebbe impigrito Napoleone”, giacché non vi accade niente. Così l’assenza di avvenimenti non disturba la contemplazione delle foglie, degli uccelli e degli intrighi degli uomini. L’aneddoto non perturba la comprensione. La palpitazione di ogni istante. La succulenza dei secondi dinanzi al nulla. La ferma, splendente proiezione di una coscienza luminosa che ha vinto sulla meccanica delle associazioni di idee per assumere il suo destino.
Fare fortuna, prendersi la rivincita: queste idee gli sono completamente estranee. Socraticamente, egli ha trovato un modo di vivere secondo i suoi bisogni e i suoi gusti. Il momento prezioso è quello della meditazione. Egli s’è realizzato. Pierre-Valentin Berthier, allora giornalista a Issoudun, dice ch’egli riuniva in sé il personaggio di Jean Valjean e quello di Monsignor Myriel. Si può pensare anche a Francesco Saverio e a Giovanni della Croce. Del resto, egli sarebbe scoppiato a ridere se glielo avessero riferito.
Spento, finito, rassegnato, Jacob? Niente affatto, se nel luglio 1936 scompare per qualche mese. “È partito per andare a trovare degli amici”, è tutto quanto si sa.
In effetti, egli ha seguito molto da vicino l’evoluzione degli avvenimenti di Spagna. Il colpo di mano dei generali. La liberazione dei militanti della FAI. imprigionati, l’insurrezione armata delle masse. Per la maggioranza appartenenti alla Confederazione Nazionale del Lavoro, onnipotenti a Barcellona, perfettamente strutturati attorno alla FAI, gli anarchici dominano il Frente Popular. La speranza di un’autentica rivoluzione libertaria risorge in lui con dei ricordi passati, del secolo precedente, quando andava a portare messaggi e denaro ai compagni iberici perseguitati.
All’improvviso commosso, il vecchio capitano risponde all’appello e salta sulla sua Peugeot. L’animale da combattimento s’è risvegliato. Troppo vecchio per sparare con il fucile e arrampicarsi all’assalto di una fortificazione, egli può ancora rendere dei servigi.
Va a trovare sir Basil Zaharoff, il petroliere e mercante di cannoni. Dopo un lungo incontro, i due stipulano un accordo: tanti chili d’oro contro tante mitragliatrici, da consegnarsi in Francia, in Svizzera o in Inghilterra.
Egli studia poi gli itinerari da seguire per fare entrare le armi in Spagna: una flottiglia di battelli requisiti, in regolare convoglio, ininterrotto, gli pare la soluzione migliore.
L’oro? È la cosa più facile da trovare. Le chiese spagnole ne traboccano. Lui ne sa qualcosa. I militanti della FAI anche, che l’utilizzano come bottino di guerra. Ma questi giovani benintenzionati sono dei dilettanti. Nei loro colpi, falliscono una volta su due, mancando delle conoscenze tecniche necessarie. Inoltre, non s’è organizzato nulla di tutto ciò. Si perdono fortune. I trafficanti a cui si rivolgono i rivoluzionari li stanno turlupinando in modo vergognoso: quelli consegnano loro a peso d’oro dei camion riempiti di sassi e in cui solo lo strato superiore è composto di armi, fuori uso la maggior parte delle volte.
Una volta messo minuziosamente in piedi il suo sistema, Alexandre arriva finalmente a Barcellona. Un’immensa delusione l’attende: Ascaso è morto, Durruti è morto. I comunisti divenuti maestri nell’arte della delazione e dell’infiltrazione, tengono la capitale dell’insurrezione. Federica Montseny, ministro della Sanità e l’italiano Berneri, su “Guerra di classe”, pressocché soli, denunciano il pericolo. I compagni, troppo occupati a battersi su tutti i fronti, sembrano non comprenderli. Jacob viene rimandato da un’autorità all’altra. Rimbalza da un ufficio all’altro. Neanche un responsabile. I comunisti gli fanno perder tempo. I socialdemocratici si mostrano evasivi. Dove sono gli anarchici? Nelle fosse comuni. Traditi nelle retrovie, essi si sacrificano al fronte.
Il vecchio signore capisce allora d’esser stato vittima dell’ultima trappola della Maia. La rivoluzione spagnola non ci sarà. Gli autoritari sono pronti alla coesistenza con i capitalisti, piuttosto che permettere la reale instaurazione dell’autogestione. Le “Brigate internazionali” non sono state che un soprassalto della coscienza mondiale dinanzi alle gesta dei totalitari di ogni genere. Stalin, invece, fa il gioco di Franco.
– È normale – pensa Jacob. – Io sono un utopista. La storia non è questione di sentimenti, ma di rapporti di forza. Finché la coscienza individuale di tutti gli uomini non si sarà evoluta maggiormente, la volontà di potenza di pochi avrà la meglio.
Allora risale sulla sua vettura e riprende il suo posto al mercato di Issoudun, bonaccione sorridente, enigmatico.
È in questo periodo che fa la conoscenza di Paulette, più giovane di lui d’una buona quindicina d’anni. Un cuore d’oro, abbastanza maniaca ed autoritaria, ma solo con il cane. Si piacciono. Si sposano. La felicità, sempre la felicità. Avendo rinunciato a tutto, tutto lo meraviglia, lo sorprende, lo stupisce.
La dichiarazione di guerra li trova nell’Indre. Nel settembre del 1939, quasi solo Lecoin ha cercato di fare un ultimo gesto contro lo spargimento di sangue: un volantino tirato in centomila copie, “Pace immediata”. «Il costo della pace non sarà mai rovinoso quanto il costo della guerra. Perché non si costruisce nulla con la morte; si può sperare tutto con la vita...».
Jacob ha sessant’anni. Se non s’impegna nella Resistenza, non è per l’età. È che il movimento è spartito tra gollisti e comunisti: né gli uni né gli altri lo convincono. Lottare perché in caso di vittoria un nuovo Stato, capitalista o autoritario, rinasca a portare gli stessi virus, gli stessi germi. I campi di deportazione nazista? Certamente. Una cosa atroce. Lo sa. Sorride impercettibilmente. Quelli che da una parte o dall’altra parlano adesso della “Liberazione del Paese” hanno gettato in cella quelli che come Lecoin non volevano più in alcun modo che la persona umana venisse schiacciata. Li stanno decimando dal 1871. Dal 1848. Da quando la borghesia ha preso il potere, per non rifarsi all’inizio del mondo.
Lungi da lui, invece, l’idea di collaborare con il nemico. Qualche partigiano braccato potrebbe testimoniare oggi di dovere la vita ad un ex forzato anarchico la cui porta era sempre aperta. A Reuilly, nell’Indre. L’ospitalità è una legge. Non si fanno domande. Si ospita, si nasconde e si tace. Impegnarsi in un esercito, fosse anche di guerriglia, è un’altra cosa, anche se si odia il nazismo.
Quanto al mercato nero, egli lo pratica talmente poco che probabilmente è stato uno dei rari commercianti di Francia rovinati dalla guerra per aver rifiutato di aumentare i prezzi tanto che con la svalutazione vendeva la sua merce a un prezzo più basso di quanto l’aveva acquistata.
È in quel periodo, del resto, che ha avuto a che fare ancora con la giustizia: il suo unico scontro con la legge fino alla sua morte. E per quale motivo!
Ispettori del fisco arrivano a casa sua per controllare le fatture corrispondenti alla merce che possiede. Questi funzionari, che dovrebbero impedire le frodi, non hanno in realtà che l’unica preoccupazione di infilarsi in tutti i traffici possibili. Il lusso indecente del loro tenore di vita in un periodo in cui il cittadino normale non riesce a procurarsi un paio di calze è molto eloquente. Jacob, naturalmente, prova verso tali personaggi ben scarsa simpatia.
Tuttavia, se le sue scorte si prosciugano dall’inizio dell’occupazione, non sono calate abbastanza perché non manchi la fattura corrispondente ad uno scampolo di viscosa da trentacinque metri.
– Il mio fornitore abitava a Toulouse – spiega. – Gli ho scritto cinque volte per chiedergliela. Non m’ha mai risposto. Ho finito per venire a sapere che era stato deportato. Scrivetegli in Germania, se riuscite a trovarne traccia. Forse avrete più fortuna di me.
L’ispettore si sente offeso nella sua autorità, sfidato nella sua funzione, leso nel suo onore:
– Benissimo – dice. – Non rispettate il regolamento. Lo spiegherete al correzionale.
E così accusa Jacob di detenzione illegale di merce. Quando arriva il giorno del processo, Alexandre Marius rifiuta di presentarsi:
– Con i miei precedenti – dice a Berthier – non vale neppure la pena che tenti di difendermi. Verrò condannato. Ma vacci tu. Mi racconterai come se la sbroglia il mio avvocato.
Berthier dunque va al palazzo di giustizia di Issoudun. Dal banco della stampa, assiste alla requisitoria del pubblico ministero, che subissa il suo amico, lo denuncia come uno dei più temibili trafficanti che la Francia abbia conosciuto, lo ritiene responsabile delle disgrazie del nostro paese, ma non fa alcuna allusione al suo passato.
È poi la volta dell’avvocato di Jacob, Fernand Boudrand. Egli non ha mai avuto tra le mani altro che un estratto dal casellario giudiziario del suo cliente, redatto dopo la sua riabilitazione e quindi vergine. Non sa chi è stato Jacob. S’infervora per “quest’uomo dai capelli bianchi, questo cittadino esemplare dal passato irreprensibile”. Implora l’indulgenza del presidente. Un largo sorriso rischiara il volto di costui che conosce, lui sì, il dossier di Jacob. Sentenza: un mese tondo tondo.
Alexandre Marius un bel mattino si presenta tranquillamente alla prigione di Châteauroux, dov’è stato convocato. Ci trascorre i trenta lunghi giorni, “più duri di tutta la mia carriera di forzato”, dirà. La clausura gli è diventata insopportabile. In cella s’è preso le pulci e una specie di tifo, il che la dice lunga sulla salubrità delle prigioni francesi. Questo perché la Giustizia non può supporre che in mezzo secolo qualcuno abbia potuto cambiare. Perché è normale infliggere un mese a un ex forzato in una circostanza in cui un “uomo onesto” avrebbe avuto un’ammenda con la condizionale. Queste riflessioni disincantate hanno assillato il vecchio anarchico per lungo tempo.
Poi, ancora una volta, il perdono l’ha avuta vinta sul rancore. Gli è salito un sorriso indulgente, raccontando quella storia agli amici, come se fosse una barzelletta.
Paulette è morta di cancro poco dopo la Liberazione con una lenta agonia. È stata sepolta vicino a Marie. La malinconia lo avvolge. Non è la solitudine che lo colpisce. La vita consiste nel vivere. La morte nel morire. La prendano per un’ovvietà quelli per i quali la vita è una morte lenta, un’ebbrezza cangiante, un oblio di ciascun istante, un pigia-pigia di altri mondi, mentre il cuore è cloroformizzato da tempo.
L’attività di Jacob è incessante. I mercati. Il suo cane Negro, i suoi gatti, tutto quello che galoppa, striscia, salta o vola. Conferenze. Riunioni con gli amici, quelli che hanno seguito Lecoin alla “Défense de l’homme” e in particolare Berthier, il compagno di strada incontrato al mercato di Issoudun. Jacob redige per loro degli articoli firmati in genere con pseudonimi.
Si dà continuamente da fare a favore dei vecchi compagni di reclusione che aspettano la salvezza da lui; che vanno a cercare asilo nella sua capanna di Reuilly, che lo sfruttano, che lo imbrogliano, se occorre svuotano la sua cassa. (“E be’, a loro fa tanto piacere!... Io non ho bisogno di niente!...”). Una corrispondenza degna di un ministro. Con giovani, scrittori, giornalisti, militanti, deputati, ministri; con Alain Bombard, dopo che gli è stato inviato il suo libro Naufragé volontaire, con il rev. padre Riquet, perché questi ha pronunciato una conversazione sullo stato teocratico del Paraguay tra il 1640 e il 1757 ed ha passato sotto silenzio due fatti importantissimi, ossia l’esclusione della pena di morte e la possibilità per il delinquente di scegliersi la propria pena; con criminologi, ogni volta che si tratta di una nuova legge penale ed egli è costretto a constatare che se le modalità sono andate migliorando, la mentalità dell’espiazione non è cambiata.
Ha pochi amici, ma indefettibilmente fedeli. (“Niente compagni, solo amici”). Louis Briselance, il venditore ambulante; i Denizeau, i d’Amboise, che hanno cercato di tenerlo in casa con loro perché si senta meno solo, si può mettere in gabbia una fiera, anche se a riposo? Bernard Bouquereau, di Issoudun; Rodriguez, il fondatore del Centro individualista di studi sociali; Berthier, la cui madre, nel 1934, comprò da lui un impermeabile (lei aveva dimenticato il portamonete e lui le aveva dato il soprabito quasi a forza, pur non avendola mai vista e benché i due uomini non si conoscessero ancora); Alain Sergent, ha scritto nel 1950, il suo Alexandre Jacob anarchiste de la Belle Epoque. (“Quasi una delusione quando l’ho visto la prima volta”, disse Sergent. “E poi, si parla e salta fuori il lato proteiforme del personaggio. Una vivacità di espressione straordinaria. L’aria di un vecchio giurista scaltro, e poi, senza soluzione, quando evoca un ricordo del bagno penale, un’espressione di una violenza terrificante. Dietro tutto questo, la serenità di un induista...”).
* * *
20 aprile 1951
Mio Caro Berthier,
non riesco praticamente più a camminare. La gamba sinistra è morta. I reumatismi... Fai prendere per me dei libri alla libreria “cattolica”. (Questa libreria non aveva niente di specificamente cattolico. Jacob l’aveva rinominata così perché, situata di fianco ad un pensionato religioso, vi si vendeva qualche oggetto di devozione).
Giugno 1951. Mi servo del braccio sinistro con difficoltà... la sciatica... Mi cura il signor Appert... I miei vicini mi fanno la spesa... Berthe e Briselance sono venuti a trovarmi con la 302 di Toto... Le mie forze sono scarse...
5 dicembre 1952. Sto allevando un superbo cane da caccia. Ha l’aspetto di Clemenceau. Non è da vendere, ma da regalare. Se tra i tuoi amici conosci qualcuno che ami gli animali...
23 dicembre 1952. Da tre settimane sono ammalato, spesso costretto a letto. Diagnosi di Appert: erisipela. È un errore. È un molare della mascella superiore che mi avvelena... L’uragano del 13 ha procurato un buco profondo nella tettoia.
6 maggio 1953. Dei canadesi sono venuti a cercare il cane... ho appena letto il libro di Wogt sul neomalthusianesimo... Quanto alla fame nel mondo, ho idea che prima che gli uomini si ripartiscano equamente le ricchezze, passerà dell’acqua sotto i ponti. Si preoccupano piuttosto di ripartirsi i cannoni... Negro ha compiuto diciott’anni e le infermità di quell’età lo inquietano. Anche i gatti. Di modo che io sono tutto il giorno occupato in cure veterinarie...
Alle elezioni, la lista dei ricchi, dei culi-santi ha vinto su quella dei comunisti, formata da operai e artigiani...
Alcuni “cavalieri dell’ozio” (Balzac chiamò così, in La Rabouilleuse, la gioventù dorata e turbolenta di Issoudun, che, all’inizio della Restaurazione, vi faceva scherzi di cattivo gusto), hanno svaligiato la gendarmeria, due medici, il farmacista, un fabbricante di maglieria. Magro risultato. Il notaio pare ne sia stato male, retrospettivamente e non è stato visitato...
* * *
A partire dal 1952, Jacob non riapprovvigiona più le sue scorte. Non spendendo nulla o quasi, ha di che vivere tranquillamente per molti anni. Ma parecchie malattie lo consumano. Degli allarmi preoccupanti, che colpiscono il fisico, se non il morale. I segni dell’ineluttabile vecchiaia. Presto verrà il decadimento, se non vi pone rimedio.
Nel 1952, scrive il suo testamento. Non che abbia fortune da lasciare: forse cinquemila o diecimila franchi (valore del 1969), contando il terreno e la baracca. Ma un’idea fissa lo ossessiona: il timore che, non avendo eredi, lo Stato, suo vecchio nemico, possa recuperare un soldo dalla sua eredità. A questo scopo, lascia da vivo la sua casa a Briselance con il pretesto di una vendita come vitalizio e i suoi magri beni immobili, fino all’ultima forchetta, a Berthier, a colpi di false fatture e di inverosimili frodi.
Una battaglia ridicola e simbolica: ha la soddisfazione di turlupinare un’ultima volta quell’autorità contro la quale non ha smesso di lottare in tutte le sue forme. E Dio sa che la guerriglia non è mai cessata tra loro, dopo la sua libertà ritrovata e malgrado la saggezza acquisita: nel 1935, viene convocato dal commissario per aver definito la guardia campestre “testa di capitello” (“Un capitello, ma è un oggetto artistico e, di conseguenza...”: la guardia campestre, tutto commosso, lo ha ringraziato); il certificato elettorale richiesto per Negro un po’ più tardi (“ho ricevuto un avviso di tassa per Negro, il mio cane. Io farò il mio dovere di contribuente, ma chiedo un certificato elettorale per Negro. Egli non ha mai mentito, non s’è mai ubriacato e penso che non ci sia un elettore in tutto il dipartimento di cui possiate dire altrettanto”); le noie con gli agenti del fisco durante la guerra perché egli rifiutava di aumentare i prezzi al livello delle tasse; quella perquisizione delle F.F.I. (Forces Francaises de l’Interieur) al momento della Liberazione, che s’immaginavano di trovare presso di lui scorte di merce considerevoli. Non si finirebbe mai.
Nel 1953 chiede a Berthier, divenuto due anni prima libraio a Parigi, di inviargli un libro di tossicologia, il Baumetz e Dujardin. Berthier glielo spedisce. Poi gliene chiede degli altri: Berthier, sospettoso, non glieli manda. Poco importa. Lui se li procura altrove. Come anche della morfina.
– Le dita cominciano ad essere deformate dai reumatismi – dice con noncuranza agli amici. – Compagni, vedete, io voglio andarmene in piena lucidità. Se aspetto, non avrei forse più il coraggio di farlo. Non voglio correre il rischio della vecchiaia. È troppo brutta.
Tutte le sue cose sono in ordine. Il suo cuore, il cervello sono intatti. Solo il corpo dà segni premonitori di debolezza. Tutto a posto? Ah! Ma no!
* * *
Luglio 1954
Signor Procuratore,
il 18 gennaio 1954 avevo spedito al vostro subordinato, il cancelliere capo del tribunale civile, una richiesta di estratto del mio casellario giudiziario allegando un vaglia di centottanta franchi, oltre ad un francobollo di quindici franchi per l’affrancatura della busta. E il 22 di quel mese, ho ricevuto quanto richiesto. Ora, quel documento indica da sé, in carattere a stampa, il costo di centoquaranta franchi... Orbene, penso che, per esser giusti, il vostro subordinato avrebbe dovuto restituirmi quanto in più che, con il presente reclamo, ammonta alla cifra di settanta franchi.
Fin da giovanissimo, mi è stato inoculato il virus della giustizia e ciò mi ha causato parecchie noie. Ancora oggi, al declino della mia vita, la benché minima ingiustizia mi infastidisce e risveglia in me il Don Chischiotte delle mie giovani primavere. Mentre in voi, signor Procuratore, che siete, se posso dirlo, del mestiere, le reazioni devono essere ben diverse. Voi dovete ritenere ridicolo un reclamo per una somma così modesta; dovete pensare e credere che io sono un rompiscatole unicamente preoccupato di attaccar briga con i servitori dello Stato. Errore. Io cerco di capire. Frugo e desumo i motivi che hanno potuto determinare il fatto che un mercenario del Principe, d’altronde ben provvisto di onorari superiori a quelli concessi ai lampisti, sgraffigni i miei cinquantacinque franchi...
Nella vostra corporazione, signor Procuratore, ci sono gli aguzzini, i duri, quelli che interpretano più la lettera piuttosto che lo spirito, quelli nei quali il riso non ha mai tracciato una ruga sul volto. I giudici della Santa Inquisizione, neri o rossi, erano e sono ancora di questa tempra. Ci sono quelli, più colti, dal carattere meno rigido, più disposti ad apprezzare umanamente, a comprendere, quindi ad eseguire piuttosto che ad infierire...
Mi piacerebbe potervi classificare in quest’ultimo tipo e quindi vi prego, signor Procuratore, di voler fare buona accoglienza alla mia richiesta facendomi restituire la somma che mi è dovuta e vi prego di gradire i miei ossequi.
Marius-Alexandre Jacob,
svaligiatore in pensione.
* * *
Questa lettera, non occorre precisarlo, non ha mai ricevuto risposta. Invece è stata pubblicata a cura di Berthier su “l’Unique”, il mensile individualista di Emile Armand. Forse il procuratore in questione ha avuto occasione di leggerla lì.
E poi gli rimane un desiderio da soddisfare. Una cerimonia di addio alla vita. Un’invocazione. Una messa. Le vibrazioni dell’armonia universale da attirare su di sé: amare, “fare l’amore” un’ultima volta. Purificarsi prima della partenza.
Da ormai parecchio tempo aveva voglia di una certa giovane donna, sposata e di trenta anni minore di lui. Il rimorso di non avere compiuto quel gesto lo ossessionava. Fintanto che non si trattava che di vivere, la cosa era sopportabile: il timore di potere turbare la felicità di una coppia compensava l’assalto del desiderio.
Ma adesso, come sarebbe possibile affrontare il Grande Regolamento di conti finale senza aver esplorato tutte le possibilità del cammino? Come osare pretendersi in regola dinanzi al tribunale della propria coscienza, quando non si è andati fino in fondo a se stessi? E cosa importa il rispetto umano, di fronte al Nulla?
Alexandre Marius, con la sua andatura un po’ pesante, va a trovare la giovane. Maliziosamente, la tenta. La attira; l’aggancia; sarà sua. Ma non vuole più saperne di imbrogli. Così va subito a parlare con il marito:
– È da parecchio tempo che non sai come rendermi un servizio – gli dice. – Oggi mi puoi aiutare a soddisfare la mia ultima volontà. Se sei onesto, dovrai anche riconoscere che quel che ti chiedo non ti toglie niente, non ti priva di nulla, non ti turba. Lo vuoi ancora?
– Sì – risponde l’amico.
E ancora “sì”, anche se certamente meno volentieri, quando gli viene spiegato il tipo di piacere che gli chiede di fare. Ma i criteri di morale e di onore ordinari non sono più validi dinanzi a Jacob. L’amico è disarmato. Costretto a dire la verità, deve confessare che non è tanto innamorato da rifiutare di fare un piacere alle due persone che egli ama di più sulla terra.
Allora si può predisporre la notte d’amore. Avrà luogo tra lunedì 16 e martedì 17 agosto. Fidanzamento con la morte. Addio alla meccanica del corpo. Promesse dell’anima. Un’apoteosi.
L’indomani Jacob scrive qualche rigo ai suoi amici: « ...Ed ecco, miei cari amici, le bazzecole che vi devo comunicare. Mi rimane da ringraziarvi molto sinceramente per tutti i segni di amicizia che mi avete prodigato. Voi siete ancora giovani. Sembra che seguiate una via non troppo irta di spine: procedete con decisione e buona fortuna! Io sono stanco, stanchissimo. Mi ero ripromesso di finirla nel 1953. (...) Ho avuto una vita piena di alti e bassi ed ho avuto la felicità di concluderla con una tale apoteosi che mi ritengo appagato. E poi vi lascio senza disperazione, con il sorriso sulle labbra, la pace nel cuore. Voi siete troppo giovani per poter apprezzare il piacere che consiste nell’andarsene in buona salute, facendo uno sberleffo a tutte le malattie che insidiano la vecchiaia. Sono tutte lì riunite, quelle puttane, pronte a divorarmi. Troppo poco per me. Rivolgetevi a quelli che si aggrappano alla vita. Io ho vissuto. Posso morire».
Venerdì 27, qualche altra pagina: «Oggi ho fatto un piccolo ricevimento per i bambini del villaggio. Ce n’erano nove, dai venti mesi ai dodici anni. Si sono ben rimpinzati. (...) Se ho tempo, farò un po’ di bucato domattina, per non lasciare niente di sporco. Se la biancheria non è asciutta, la troverete stesa ad asciugarsi».
Poi, ha tirato fuori la sua cara vettura un’ultima volta per andare ad imbucare un grosso fascio di lettere. «Quando riceverai questa lettera, io non ci sarò più. Mi suicido sabato perché la gente si occupi del corpo domenica e la vestizione e le pratiche da fare non le arrechino disturbo».
Ha trascorso una notte tranquilla. Sabato 28, all’alba, ha steso sul suo letto coperta e lenzuola. Vi ha disposto sopra Negro, il vecchio cane cieco e malato. Gli ha preso la zampa. Gli ha infilato l’ago e gli ha regalato la metà della morfina. Quindi, ha controllato che il fuoco di carbone di legna fosse acceso perché liberasse dell’anidride carbonica per completare, all’occorrenza, l’effetto della puntura. Nel momento di distendersi a sua volta, ha avuto ancora un rimorso. Ha preso un pezzetto di carta e vi ha scarabocchiato: «Biancheria lavata, sciacquata, asciugata ma non stirata. Sono fiacco. Scusate. Troverete due litri di rosato di fianco alla dispensa. Alla vostra salute».
Allora si è allungato anche lui sul letto, a fianco di Negro ed ha preso la siringa.
Quando i suoi amici entrarono nella casa, qualche ora più tardi, si sarebbe detto che dormiva quietamente.
Negro non era morto. Bisognò finirlo.
Postfazione alla terza edizione
Nous aimerions être Jacob, mais...
Ci piacerebbe essere Jacob, entrare e uscire dalle case dei ricchi con facilità, mettere le mani sui loro tesori accumulati grazie allo sfruttamento dei poveri disgraziati costretti a sudare sotto la sferza della necessità, ma.
Appunto c’è un “ma”.
Ed è ciò che spiega la fortuna di questo libro.
Bernard Thomas, un giornalista, lo ha scritto e, in fondo, si è documentato per bene, facendo perfino un gran lavoro d’archivio, cosa che per un giornalista deve avergli fatto venire la scoliosi prima del tempo, ma non per questo ha cambiato mestiere.
Non che il mestiere dello storico sia migliore, le barriere ideologiche e culturali del primo si riflettono nelle idiosincrasie tecniche del secondo, le cocciutaggini accademiche rimpallano i voli lirici della cronaca avventurosa, “nera”, certo, ma con una prouderie d’avanspettacolo.
Se sullo sfondo non ci fosse stato Maurice Leblanc e la sua marionetta Arsène Lupin, non credo che il buon Thomas si sarebbe tanto dato da fare con le sue encomiabili (?) ricerche.
Perché pubblicarlo allora? Perché tante migliaia di copie vendute? Potrei rispondere in veste di responsabile delle nostre edizioni: non che se il mercato chiede qualcosa noi delle Edizioni Anarchismo siamo disposti a fornirlo, ma qui non si è voluto tanto assecondare una sottile ambiguità di lettura, quanto vedere fin dove ci si poteva spingere con la tematica del furto.
Nella precedente edizione, la seconda, pubblicata in tremila copie (il dato è importante per le nostre striminzite abitudini), non ho potuto affrontare questo problema perché mi trovavo in carcere, tanto per cambiare. Adesso voglio prenderlo fino in fondo.
Mettere le mani sulla proprietà altrui non è uno scherzo. Non lo è dal punto di vista pratico, altrimenti detto «tecnico», ma, prima di tutto, non lo è dal punto di vista morale. Morale? Qualche anarchico più anarchico degli altri potrebbe ribattermi sulla voce. Appunto morale.
Nel mio vecchio articolo, di cui non ricordo la collocazione bibliografica (che importa, qui stiamo facendo una discussione amichevole fra compagni), dal titolo “La frattura morale”, prendevo questo argomento. La barriera da superare è legata al nostro essere permeati dal radicale e profondo concetto di proprietà. Consideriamo nostre le cose che ci stanno a cuore, perfino la donna amata consideriamo “nostra” (a scanso di essere linciato prego notare che ho messo le virgolette nella parola che precede questa parentesi), e quindi non siamo d’accordo che qualcuno, sia pure per un attimo, ce la porti via, diciamo, la prenda in prestito. No, non siamo d’accordo. Preferiamo che lei (la donna che amiamo) si sfianchi a causa del lavoro ma non accetteremmo mai che ricavi danaro da una (esempio, sto facendo solo un esempio) prestazione sessuale. Ignominia!
Ho, a lungo, discettato, con protervia degna di migliore causa, sulla differenza tra possesso e proprietà. Degno di stima il primo, di condanna il secondo. Distinzione plausibile, è ovvio, c’è una differenza enorme tra i libri della mia biblioteca personale, che venderei con dolore e rammarico perché considero miei, e i libri che si trovano in una eventuale libreria di mia proprietà che mi causerebbero rammarico e dolore solo nel caso inverso, cioè se restassero invenduti.
Gli oggetti che posseggo arricchiscono la mia personalità, l’arredano e la rafforzano, caratterizzandola nell’ordine del tempo e dei sentimenti che a questo decorrere lento ma sensibile sono collegati, gli oggetti che ho in proprietà mi rendono occhiuto e insensibile, attento solo al denaro che dalla loro alienazione posso ricavare.
È ovvio che collocare la donna da me amata nell’ordine dei miei possessi è quanto meno discutibile. La sua autonomia di scelta è la sola misura della sua crescita ed è di questa crescita che io sono innamorato, ed è questa crescita che mi avvince nel contratto amoroso che non abbisogna né di sigilli né di annotazioni notarili.
Superare la barriera del possesso, dopo quella (ovviamente da eliminare per prima) della proprietà, è indispensabile per accedere al diritto di mettere le mani su ciò che gli altri hanno, in proprietà e in possesso: gli altri che queste proprietà e questi possessi hanno accumulato nel tempo a danno degli sfruttati.
Non c’è una strada maestra per superare questi ostacoli, non sono un battistrada, caso mai posso considerarmi un piccolo artigiano miniaturista, commisurando quello che ho fatto in questa direzione di fronte all’immane compito che resterebbe da fare.
Jacob ha svaligiato centinaia di case borghesi, ha ricavato una ricchezza che si potrebbe senz’altro definire enorme, e l’ha messa a disposizione del movimento anarchico internazionale. Il suo progetto era utopicamente insensato, tendendo ad allargare il numero dei “Lavoratori della notte” e quindi a svuotare dall’interno, con questi prelievi coatti, la forza repressiva della classe borghese. Utopie, siamo d’accordo, ma non è qui il punto.
Rubare è indispensabile per un rivoluzionario, rubare ai ricchi, non occorre sottolinearlo. È indispensabile perché altrimenti non potrebbe trovare i mezzi per la propria attività rivoluzionaria diretta a sovvertire l’ordine esistente, ordine oppressivo in maggiore o minore misura, questo è secondario perché nessun potere è accettabile, e perché altrimenti dovrebbe andare a lavorare e quindi sottrarre tempo ed energie alla propria attività rivoluzionaria.
Le critiche del passato (e del presente), critiche anche con i baffi, per carità, erano tutte infondate. Lo si è visto in mille occasioni. La disponibilità di soldi, anche di tanti soldi, non travia i compagni che sono veramente rivoluzionari anarchici, non li porta via dalla loro strada attiva di attacco all’esistente, viceversa, anche pochi soldi, quali potrebbero essere quelli che si traggono da un qualsiasi lavoro in banca, fanno di un rivoluzionario un coglione perbenista e codino.
Ecco che taglio dare alla lettura di questo libro sulla vita, e sulle azioni di esproprio, di Jacob. Non è un libro di avventure, anche se ciò può aver cercato Thomas. È un momento di riflessione, un’occasione per chiedersi: che vogliamo fare? Vogliamo lasciare nelle casseforti dei padroni i loro ninnoli dorati, le loro banconote da 500 euro, una sull’altra, i loro buoni del tesoro al portatore, o vogliamo portarceli via con qualsiasi mezzo? Jacob era un ladro, Bonnot era un rapinatore, che cambia? Lo scopo era il medesimo.
E, poi, l’altro lato della questione. Non illudiamoci. La vita di un ladro, o di un rapinatore, non è una vita eccitante, di adrenalina continuamente in circolo nelle vene. È fatta, per il novanta per cento, di lavoro stressante e meticoloso, ore e ore di pedinamenti, di appostamenti, di misurazione di percorsi e di tempi, di addestramento (più tecnico per il ladro, più grossolano per il rapinatore), di pazienza e di educazione alla calma e alla freddezza nel corso del lavoro. Non c’è niente, o quasi niente, di quell’aura romantica che molti si immaginano ci sia, i momenti in cui occorre far fronte a situazioni di tensione sono pochissimi e durano istanti.
Poi viene il progetto rivoluzionario. I soldi non sono niente, i gioielli anche meno (qui occorre un buon ricettatore che non cerchi di fregarti e che non sia un confidente della polizia), quello che conta è la speranza in un mondo migliore, la capacità di tornare sempre daccapo senza perdersi d’animo.
Quando, come in questi ultimi anni, la miseria sembra battere alle porte, e lo starnazzare in cortile sembra assordante, non bisogna perdere la forza e la volontà di ricominciare. La rivoluzione è sempre dietro l’angolo, siamo noi che dobbiamo soltanto svoltare questo angolo e vederla in faccia. E se non dovessimo trovarla proprio a portata di mano, ebbene continuiamo con l’angolo successivo. Ma non sia mai che a impedirci questa capacità di svoltare sia la rassegnazione o la penuria di mezzi.
Questo proprio no.
Trieste, 29 agosto 2008
Alfredo M. Bonanno
Questo sito, oltre a informare i compagni sulle pubblicazioni delle Edizioni Anarchismo, archivia in formato elettronico, quando possibile, i testi delle varie collane.
L’accesso ai testi è totalmente libero e gratuito, le donazioni sono ben accette e servono a finanziare le attività della casa editrice.
