Prima edizione: maggio 2015
Manifesto dei Sedici
Critiche di Malatesta, Galleani, Borghi e di alcuni anarchici russi
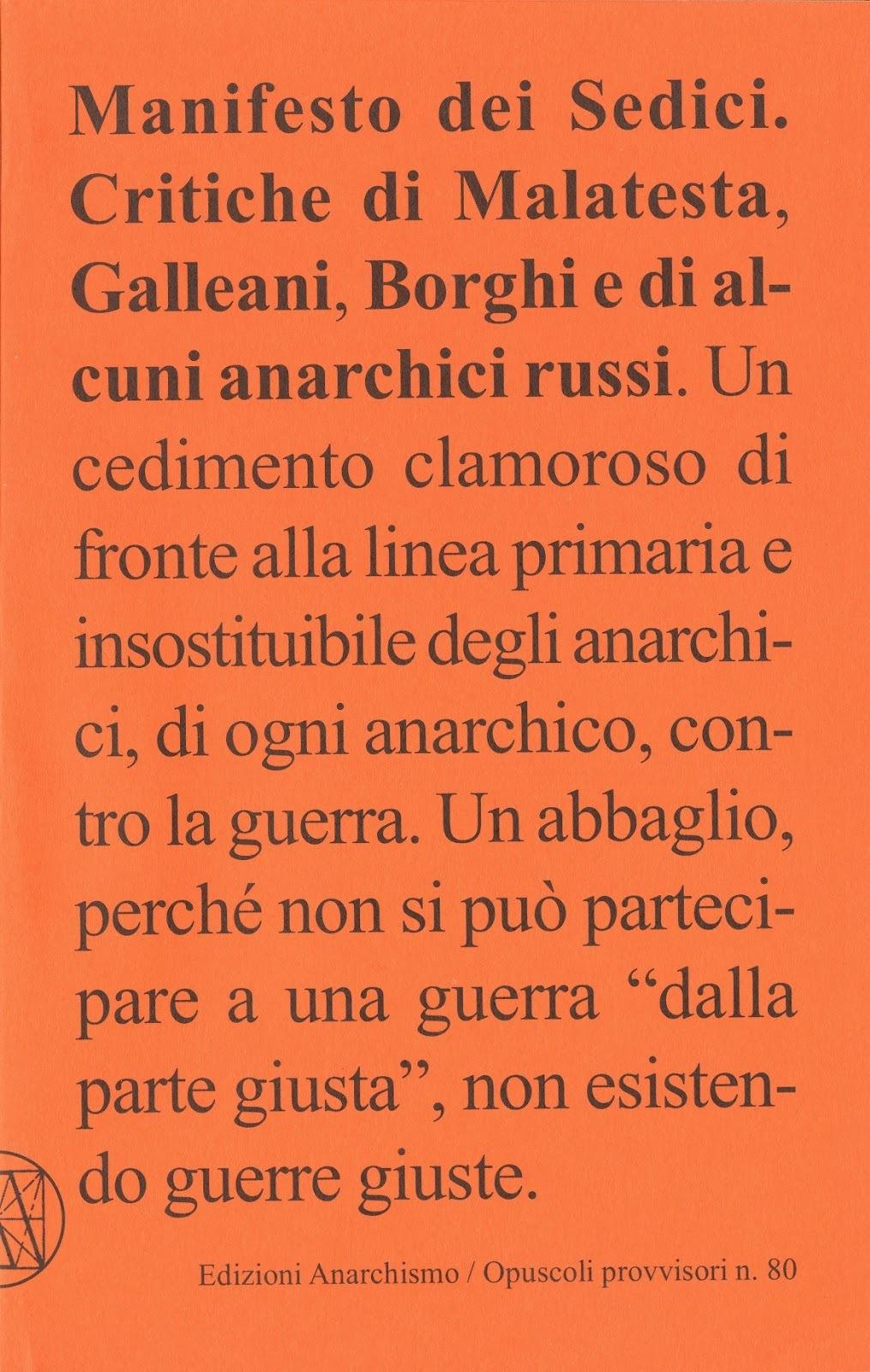
Nota introduttiva
Il Manifesto chiamato “dei Sedici”, dal numero (errato) dei firmatari, costituisce un cedimento clamoroso di fronte alla linea primaria e insostituibile degli anarchici, di ogni anarchico, contro la guerra. Su questo sono tutti concordi, non ci sono anarchici, oggi come ieri, che trovano giustificazioni alla sua stesura. E allora? Come mai uomini del calibro di Grave, Cornelissen, Malato e Kropotkin, per limitarsi ai compagni più conosciuti, lo stesero e lo firmarono? La risposta non può essere che una sola: fu un abbaglio, ma un abbaglio consequenziale.
Un abbaglio, perché credere di partecipare a una guerra “dalla parte giusta” non è possibile, non esistendo guerre giuste. Consequenziale, perché derivante logicamente dall’ipotesi quantitativa fondata sulla logica dell’aggiunta o, come l’abbiamo definita, dell’“a poco a poco”. Il determinismo, in salsa marxista o positivista, risulta sempre indigesto.
La risposta di Malatesta costituisce una critica esemplare. Non solo per la sua ortodossia antimilitarista e, in una parola, anarchica, ma per il modo garbato e non polemico che seppe prendere. Il gioco aveva una posta altissima, i compagni firmatari del “Manifesto” erano noti in tutto il mondo e godevano di un credito rivoluzionario di tutto rispetto, non si poteva liquidare la faccenda come un errore di valutazione. Occorreva prendere le mosse da lontano e andare al nocciolo della questione senza revocare in dubbio il grande contributo che uomini come Kropotkin e altri avevano saputo dare, e avrebbero continuato a dare, alla rivoluzione anarchica. E Malatesta ci riesce pienamente.
Anche a prescindere dal contenuto di questa sottile schermaglia, che oggi potrebbe sembrare ovvio, c’è anche il metodo con cui essa venne condotta, metodo che nelle chiacchiere odierne, spesso e volentieri, viene messo da parte per ricorrere agli attacchi personali piuttosto che sostanziali. La piattezza dei tempi in cui vivo si coglie anche in tante grossolanità che continuano a rotolarmi a fianco senza nemmeno sfiorarmi.
La risposta di Galleani a Kropotkin è uno dei suoi testi più famosi e importanti, dal titolo: “Per la guerra, per la neutralità o per la pace?”. Malgrado l’artificiosità del suo stile, questa volta il retore è messo in secondo piano. Il problema era durissimo: controbattere a un grande amico e a un compagno, fra i non pochi, di enorme influenza in tutto il mondo, conosciuto e ammirato, compagno che, contro tutte le aspettative – quante volte succederà di poi una cosa del genere? – aveva preso una strada insostenibile e inaspettata.
La risposta di Borghi è più intima, quasi colloquiale, eppure rende benissimo – e per questo l’abbiamo inserita – il clima che si respirava in quel momento fra gli anarchici, di fronte alla defezione dalla linea antimilitarista di tanti compagni conosciuti e autorevoli.
Il tema dell’autorevolezza e del bisogno di guardare al compagno che questa veste finisce per assumere, quasi sempre per corrispondere ai bisogni degli altri compagni e non certo per una sua smania di primeggiare, che in quest’ultimo caso si sentirebbe il lezzo lontano un miglio, è sempre aperto. Non dimentichiamolo.
Trieste, 15 maggio 2014
Alfredo M. Bonanno
Manifesto dei Sedici
Da diverse parti si levano voci che reclamano una pace immediata. “Basta con il sangue versato, basta con le distruzioni”, si sente dire, “È ora di finirla, in un modo o nell’altro”. Noi, più di chiunque altro e già da molto tempo ci siamo espressi, sui nostri giornali, contro ogni guerra di aggressione tra i popoli e contro il militarismo, senza badare se aveva in testa un elmetto di qualche impero o uno repubblicano. Per questo saremmo più che felici se si intavolassero discussioni di pace (se questo fosse possibile) tra i lavoratori europei riuniti in un congresso internazionale. Tanto più che, se il popolo tedesco è caduto nell’inganno nell’agosto 1914 e se ha creduto davvero di essere chiamato alle armi per la difesa del proprio territorio, ha avuto ormai tutto il tempo per capire di essere stato imbrogliato e trascinato in una guerra di aggressione.
In effetti i lavoratori tedeschi, almeno nelle loro formazioni più o meno avanzate, devono oramai avere capito che i piani di invasione della Francia, del Belgio, della Russia erano stati preparati con largo anticipo e che se questa guerra non è scoppiata nel 1875, nel 1886, nel 1911 o nel 1913, è solo perché le relazioni internazionali non si presentavano ancora in modo così favorevole e i preparativi militari non erano ancora abbastanza avanzati da lasciare presagire una vittoria tedesca (andavano completate le linee strategiche, c’era il Canale di Kiel da ampliare, si dovevano perfezionare i cannoni a grande gittata). E adesso, dopo venti mesi di guerra e terribili perdite, dovrebbe anche essere chiaro che le conquiste fatte dall’esercito tedesco non hanno nessuna possibilità di essere mantenute. Tanto più che sarà necessario riconoscere questo principio (già riconosciuto dalla Francia nel 1859, dopo la vittoria sull’Austria): consentire o meno l’annessione di un territorio è diritto che spetta esclusivamente alla popolazione che vi abita.
Se i lavoratori tedeschi cominciano a rendersi conto della situazione, come ce ne rendiamo conto noi e una piccola minoranza dei loro socialdemocratici, e se riescono a farsi sentire dai loro governanti, potrebbe esserci un terreno d’intesa che permetta di avviare trattative di pace. In tal caso, però, essi dovrebbero dichiarare il proprio assoluto rifiuto a fare e ad accettare le annessioni, la propria rinuncia alla pretesa di esigere “contributi” dalle nazioni invase; dovrebbero riconoscere che lo Stato tedesco ha il dovere di riparare, per quanto possibile, ai danni materiali provocati dalle invasioni nei paesi vicini e che deve rinunciare alla pretesa di imporre condizioni di sudditanza economica sotto il nome di trattati commerciali. Sfortunatamente, fino a oggi non si scorgono sintomi di risveglio, in questo senso, del popolo tedesco.
Si è parlato della conferenza di Zimmerwald, ma a questa è mancato l’essenziale: la rappresentanza dei lavoratori tedeschi. Si è anche fatto un gran parlare di qualche tafferuglio che si verifica in Germania a causa del carovita. Ma ci si dimentica che disordini del genere ci sono sempre stati nel corso di grandi conflitti, ma non ne hanno mai influenzato la durata. Così, tutte le scelte che il governo tedesco sta facendo attualmente dimostrano che ha intenzione di riprendere le aggressioni con l’arrivo della primavera. Siccome, però, sa bene che in primavera gli Alleati gli opporranno nuovi eserciti, dotati di nuovi armamenti e di un’artiglieria molto più potente rispetto al passato, esso opera anche col fine di seminare la discordia tra le popolazioni alleate. A tale scopo si serve di un metodo antico come la guerra stessa: quello di diffondere voci di una pace imminente, che avrebbe come soli oppositori, tra gli avversari, i militari e i fabbricanti di armi, come ha fatto Bulow, con i suoi segretari, nel corso del suo ultimo soggiorno in Svizzera.
Ma a quali condizioni propone di concludere la pace?
La “Neue Zürcher Zeitung” ritiene di sapere (e il quotidiano ufficiale, la “Norddeutscher Zeitung”, non la contraddice) che gran parte del territorio belga sarà evacuata, ma solo a condizione che il Belgio dia garanzie concrete di non ripetere ciò che ha fatto nell’agosto 1914, quando si era opposto al passaggio delle truppe tedesche. E in che cosa consisterebbero queste garanzie? Le proprie miniere di carbone? Il Congo? Non lo si dice. Si richiede, però, un forte contributo annuo. Il territorio conquistato in Francia sarebbe restituito, come la parte francofona della Lorena. Ma, in cambio, la Francia trasferirebbe allo Stato tedesco i propri crediti con la Russia, che ammontano a diciotto miliardi. In altre parole, si pretende un contributo di diciotto miliardi, che dovrebbe essere rimborsato dai lavoratori agricoli e industriali francesi, che sono quelli che pagano le tasse. Diciotto miliardi per riacquistare dieci dipartimenti che erano stati resi ricchi e opulenti dal lavoro francese e che verranno restituiti in uno stato di rovina e di devastazione...
Per dire che cosa si pensa in Germania delle condizioni della pace, un fatto è indubbio: la stampa borghese sta preparando la nazione all’idea di una annessione pura e semplice del Belgio e dei dipartimenti del nord della Francia. E, in Germania, non esiste una forza in grado di opporvisi. Chi avrebbe dovuto levare la propria voce contro le conquiste, i lavoratori, non lo fa. Gli operai dei sindacati si fanno travolgere dalla febbre imperialista; il partito socialdemocratico, troppo debole per influenzare le scelte del governo sulla pace, anche se rappresentasse una classe compatta, si trova diviso, su questo argomento, in due fazioni ostili e la maggioranza viaggia di conserva con il governo. Il Reich tedesco, che sa che le proprie armate sono da diciotto mesi a novanta chilometri da Parigi, e che è sostenuto dal popolo tedesco nei suoi sogni di nuove conquiste, non vede perché non dovrebbe approfittare di conquiste già fatte. Si considera in grado di dettare le condizioni di pace, che gli permetterebbero di sfruttare i nuovi miliardi di contributi per nuovi armamenti, per attaccare la Francia quando gli parrà opportuno, per portarle via le colonie e anche qualche altra provincia, per non dover più temere la sua opposizione.
Parlare di pace in questo momento significa appunto fare il gioco del partito filogovernativo tedesco, di Bulow e dei suoi agenti.
Per quanto ci riguarda, noi ci rifiutiamo assolutamente di farci partecipi delle illusioni di qualche nostro compagno rispetto alle intenzioni pacifiche di coloro che dirigono le sorti della Germania. Preferiamo guardare in faccia il pericolo e cercare di fare il necessario per fronteggiarlo. Ignorare questo pericolo significherebbe accrescerlo.
Siamo profondamente consapevoli del fatto che l’aggressione tedesca era una minaccia (messa in pratica) non solo contro le nostre speranze di emancipazione, ma contro tutta l’evoluzione umana.
Per questa ragione noi anarchici, noi antimilitaristi, noi nemici della guerra, noi sostenitori appassionati della pace e della fraternità fra i popoli, ci siamo schierati dalla parte della resistenza e non abbiamo ritenuto giusto separare il nostro destino da quello del resto della popolazione. Ci sembra superfluo ribadire che avremmo preferito vedere questa popolazione assumersi direttamente l’impegno della propria difesa. Visto che questo non è stato possibile, non rimaneva che accettare il fatto compiuto. E, insieme a coloro che sono in lotta, noi consideriamo che, a meno che la popolazione tedesca, ritornando a più sani princìpi di giustizia e di diritto, la smetta finalmente di servire ancora da strumento ai progetti di dominio politico pantedesco, non sia proprio il caso di parlare di pace. Certo, nonostante la guerra, malgrado le tante uccisioni, non ci dimentichiamo di essere internazionalisti: vogliamo l’unione dei popoli, la cancellazione delle frontiere. Ed è proprio perché auspichiamo la riconciliazione fra tutti i popoli, compreso quello tedesco, pensiamo che si debba resistere a un aggressore che rappresenta l’annientamento di tutte le nostre speranze di liberazione. Parlare di pace mentre il partito che da quarantacinque anni ha trasformato l’Europa in un enorme campo trincerato è in condizione di dettare le proprie condizioni, sarebbe l’errore più spaventoso che si possa commettere. Resistergli e fare fallire i suoi piani significa aprire la strada alla parte rimasta sana del popolo tedesco e offrirle i mezzi per sbarazzarsi di questo partito. Se i nostri compagni tedeschi capiranno che questo è l’unico esito vantaggioso per entrambe le parti, noi siamo pronti a collaborare con loro.
Christian Cornelissen, Henri Fuss, Jean Grave, Jacques Guerin, Pëtr Kropotkin, A. Laisant, F. Le Lève (Lorient), Charles Malato, Jules Moineau (Liegi), Antoine Orfila (Husseindey, Algeria), Marc Pierrot, Paul Reclus, Richard (Algeria), Ichikawa (Giappone), Varlan Tcherkesoff
26 febbraio 1916
Anarchici pro governo
È apparso un manifesto firmato da Kropotkin, Grave, Malato e una dozzina ancora di vecchi compagni, in cui, facendo eco agli organi dei governi dell’Entente i quali chiedono che la guerra continui fino all’annientamento della Germania, ci si erge contro ogni idea di “pace prematura”.
La stampa borghese pubblica, naturalmente con soddisfazione, degli estratti del manifesto e lo annuncia come un atto compiuto dai “dirigenti del movimento anarchico internazionale”.
Gli anarchici, i quali pressoché al completo sono rimasti fedeli alle loro convinzioni, debbono protestare contro questo tentativo di compromettere l’anarchismo nella continuazione di questa feroce carneficina che non ha mai permesso alcunché di buono alla causa della giustizia e della libertà, e che d’altronde, si mostra completamente sterile e senza vie d’uscita anche dal punto di vista dei governi dell’una o dell’altra parte.
La buona fede e le buone intenzioni dei firmatari di questo manifesto sono fuori questione. Ma, quale che sia il dolore di trovarsi in conflitto con dei vecchi compagni che hanno reso tanti servizi alla causa che ci è stata comune, non si può, per rispetto della sincerità e nell’interesse dell’avvenire del nostro movimento emancipatore, non separarsi nettamente dai compagni che credono possibile conciliare le idee anarchiche e la collaborazione con i governi e la borghesia di certi paesi nelle loro rivalità contro le borghesie e i governi di altri paesi.
Abbiamo visto, nella crisi attuale, dei repubblicani mettersi al servizio dei re, dei socialisti fare causa comune con la borghesia, dei lavoratori fare gli interessi dei capitalisti; ma in fondo tutte queste persone sono, in gradi diversi, dei conservatori, dei credenti nella missione dello Stato e si può comprendere che abbiano esitato e fuorviato fino a cadere nelle braccia del loro nemico, il giorno in cui il solo rimedio non era che la dissoluzione di tutti i legami governativi e lo scatenamento della rivoluzione sociale. Ma non si comprende più quando si tratta di anarchici.
Gli anarchici pensano che lo Stato è incapace di impedire il male, se non commettendo un male ancor più grande: tanto nel campo delle relazioni internazionali che in quello privato egli non può combattere un’oppressione senza opprimere, egli non può reprimere un crimine senza organizzarne e perpetrarne uno più vasto.
Anche supponendo (ciò che è ben lontano dalla verità) che il governo tedesco sia il solo responsabile della guerra attuale, è dimostrato che, restando fermi ai metodi di governo, non gli si può resistere che opprimendo e rimettendo in piedi tutte le forze reazionarie. Al di fuori della rivoluzione popolare, non v’è altro mezzo, per resistere alla minaccia di un’armata disciplinata che di avere un’armata ancora più forte e disciplinata; di modo che i più feroci antimilitaristi, se non sono anarchici e non credono nella dissoluzione dello Stato, sono fatalmente destinati a diventare degli ardenti militaristi.
In effetti, nella problematica speranza di abbattere il militarismo prussiano, si è rinunciato allo spirito e ad ogni tradizione di libertà, si è prussianizzata l’Inghilterra e la Francia, ci si è sottomessi allo zarismo, si è ridato prestigio alla vacillante monarchia italiana.
Possono gli anarchici, anche per un solo istante accettare questo stato di cose senza rinunciare a dirsi tali? Per me, meglio ancora la dominazione straniera che si subisce per forza e contro la quale ci si rivolta piuttosto che la dominazione indigena che si accetta docilmente, quasi con riconoscenza, credendo in questo modo di essersi garantiti da un male più grande.
E non ci si dica che si tratta di un momento eccezionale e che dopo aver contribuito alla vittoria dell’Entente si ritornerà, ciascuno nel suo campo, a lottare per i propri ideali.
Se è necessario oggi agire di concerto con il governo e la borghesia per difenderci contro la “minaccia tedesca” ciò sarà tanto più necessario dopo che durante la guerra. Quale che possa essere la disfatta dell’esercito tedesco (se è vero che sarà vinto) non si potrà mai impedire che i patrioti tedeschi pensino e preparino la rivincita; e i patrioti degli altri paesi, cosa naturale dal loro punto di vista, vogliano tenersi pronti per non essere ancora una volta colti di sorpresa. Vale a dire che il militarismo prussiano diventerà un’istituzione permanente e regolare in tutti i paesi.
Che cosa diranno allora i sedicenti anarchici che oggi vogliono la vittoria di uno dei belligeranti? Continueranno a dirsi antimilitaristi e a predicare il disarmo, il rifiuto al servizio militare, il sabotaggio della difesa nazionale, per diventare, alla prima minaccia di guerra, i sergenti reclutatori dei governi che avevano tentato di disarmare e indebolire?
Si dirà che tutto ciò finirà quando il popolo tedesco avrà saputo sbarazzarsi dei suoi dominatori e avrà smesso, distruggendo il militarismo di casa sua, d’essere una minaccia per l’Europa. Ma, posta in questo modo, i Tedeschi che pensano, e con ragione, che la dominazione inglese e francese (per tacere della Russia zarista) non sarà più dolce di quello che ai Francesi e agli Inglesi sarà quella tedesca, vorranno attendere prima che i Russi e gli altri distruggano il proprio militarismo e nell’attesa continueranno a rinforzare l’esercito del loro paese?
E allora a quando la rivoluzione? A quando l’Anarchia? Dovremo attendere che siano gli altri a cominciarla? La linea di condotta degli anarchici è tracciata dalla logica medesima delle loro aspirazioni: si dovrebbe impedire la guerra facendo la rivoluzione o almeno incutendo ai governi la paura della rivoluzione.
Fino ad oggi non si è potuto o saputo farlo. Ebbene non vi è che un rimedio: fare meglio nell’avvenire. È necessario più che mai evitare i compromessi: scavare l’abisso fra capitalisti e operai; predicare l’espropriazione della ricchezza privata e la dissoluzione dello Stato come il solo mezzo per assicurare la fraternità fra i popoli, la giustizia e la libertà per tutti e prepararsi a realizzarla.
In questa attesa, tutto ciò che tende a prolungare la guerra (che massacra gli uomini, distrugge la ricchezza e impedisce la ripresa della lotta per l’emancipazione) mi sembra criminale. Mi pare che predicare la guerra a oltranza faccia veramente il gioco dei governanti tedeschi, i quali ingannano i loro sudditi e li incitano alla lotta facendogli credere che si vuole schiacciare e ridurre in schiavitù la nazione tedesca.
Oggi come sempre il nostro grido sia: Abbasso i capitalisti e i governi, tutti i capitalisti e tutti i governi!
Errico Malatesta
[“Freedom”, aprile 1916]
Per la guerra, per la neutralità, o per la pace?
Per la guerra, intanto, no.
Per nessuna guerra, dovunque e comunque sia accesa od abbia ad accendersi.
L’avversione di ieri – in cui si comunicava tutti quanti, almeno da questo lato della barricata, ed in cui irriducibili, non persistono, oggi che gli anarchici – emersa lentamente, dolorosamente, dal mezzo secolo di disinganni che di scherni, di fame, di catene ripagò il sacrifizio della generazione eroica da cui l’unità, l’indipendenza della patria erano state edificate; temprata alla critica che dal disinganno erompeva acerba ed inesorata a ricercarne le cause desolanti, si è fatta più tenace, irremovibile oggi che alle guerre, a tutte le guerre, comunque mascherate, viene a mancare il contenuto ideale che agli assertori, ai confessori, agli araldi ed ai soldati dell’idea e della causa nazionale dava la generosa nostalgia dell’olocausto, la tenacia che non abdicava dinnanzi al boia, al tradimento, a la sventura e a Mantova, a Brescia, a Novara, ad Aspromonte, a Mentana trovava nella sciagura la ragione dell’unanime consenso solidale e dei rinnovati ardimenti vittoriosi.
La guerra non è più oggi che un’operazione di borsa, un affare, sui cui avvolgimenti torbidi le faci della civiltà, i labari del progresso, gli orgogli nazionali si rovesciano a nascondere la frode inconfessabile e svergognata, a mietere pel sacco, per la taglia, per la fortuna dei grandi ladri il necessario tributo d’energia e di sangue che il proletariato soltanto può dare e, pur docile, pur tardo, non darebbe altrimenti coll’ardore, l’abnegazione, l’impeto cieco che del successo sono condizione essenziale.
Aneliti civili, intolleranza di tirannidi straniere, fremiti di nazionale risurrezione le guerre che insanguinano il vecchio ed il nuovo mondo da vent’anni? la guerra della Cina al Giappone nel 1895; la guerra degli Stati Uniti contro la Spagna nel 1898; dell’Inghilterra contro i Boeri nel 1899; dell’Europa coalizzata contro l’Impero Cinese nel 1900; del Giappone contro la Russia nel 1904; dell’Italia contro la Turchia nel 1911; degli Stati balcanici l’anno scorso; ora quella che divampa nel vecchio continente?
Quando dagli organizzatori stessi delle paradossali carneficine si concede – ed è, del resto, anche ai meno sagaci confermato dall’esperienza immediata – che esca dalle competizioni ora il monopolio dei mercati industriali finanziari commerciali della Corea, della Manciuria, della Cina, di Cuba, del Transvaal, o l’accaparramento delle Sirti alle rapaci speculazioni del Banco di Roma? Quando la presunzione dell’Inghilterra, della Francia, del Belgio, della Germania, dell’America a portare oltre i propri confini altra civiltà che non sia d’estorsioni, di sfruttamento, di corruzione, affoga nei Campi di Concentramento del Transvaal come nel Congo, negli orrori repubblicani del Tonkino o del Madagascar come nell’inquisizione puritana delle Filippine, ed assume nei riguardi della Russia autocratica e dell’Italia pellagrosa ed analfabeta il senso di una atroce ironia impudica?
Arrembaggi di pirati, furor di sciacalli, rovello di borsaioli infuriati all’usura, di bottegai, di preti, di fornitori, di biscazzieri ansanti il dividendo la decima i subiti guadagni, le guerre d’oggi, del domani, le guerre d’ogni nazione e d’ogni stirpe, d’ogni terra e d’ogni continente.
I dividendi, le usure, le decime si tagliano soltanto sul groppone di Giobbe, che egli sia bianco o nero o giallo, che egli sia nato sotto la croce, la mezzaluna, il tricolore, che egli sia tenuto alla lassa dal padrone da Cecco Beppe o da Guglielmone, da Gennariello, da Wilson o da Poincaré.
E porre a Giobbe l’alternativa di essere pro o contro la guerra parrebbe ozioso senza i sofismi che scendono dai pergami e dalle tribune più diverse, maramaldi o ingenui, a truffarne la buona fede, a scuoterne l’inerzia fatta di diffidenza assai più che d’ignavia, a sconvolgerne gli animi semplici ed i giudizi sinceri.
Quanti i sofismi! Quanti, a scusare le dedizioni fragili, a nascondere le defezioni sfacciate!
Lasciamo da banda i cialtroni che mutano coscienza secondo che mutano padrone, e la fede, gli ideali, gli entusiasmi attingono alla greppia e misurano alla biada. Insurrezionalisti, antipatriotti, antirazzisti fino a rassegnarsi al leggendario bastone tedesco nell’eventualità cervellotica dell’invasione straniera, ieri, – quando a colmar la ciotola della sbobba quotidiana, leccavano il deretano ai “compagni” – sono nazionalisti, patriottardi, guerrafondai oggi che il nazionalismo borsaiolo della patria li ha assunti a sparafucili della banda, appresta lo strame alla loro vanità cianciona, e compensa della pagnotta tricolore le pedate che di mezzo a noi ha vendemmiato il loro girellismo equivoco e mercantile. Lanzichenecchi di chi li paga, barattano il pane colla menzogna consapevole e col vituperio professionale, troppo stranieri a qualsiasi brivido di sentimento perché i loro lazzi sguaiati, le loro capriole invereconde, i loro spudorati voltafaccia possano muovere più che a compassione od a schifo, perché possa aver peso in un dibattito sincero il loro mercenario camaleontismo, la loro disperata latitanza intellettuale e morale, anche se posino a filosofi ed a censori.
La gente passa e tura le narici: anche noi.
Fosse tutto lì il dissenso, che nessuno se ne sarebbe accorto!
Ma la guerra è stata prima ed avanti ogni cosa la liquidazione repentina e definitiva del socialismo militante. I grandi industriali della Westfalia, della Sassonia, della Slesia nella guerra mortale agli industriali di Birmingham, di Glasgow e di Manchester – che nell’aspra competizione delle due industrie antagonistiche è la ragione fondamentale dell’aspro conflitto europeo – non sognavano certo di avere alleati nella guerra mortale i rappresentanti parlamentari del proletariato tedesco, né Guglielmo d’Hohenzollern d’avere stretto al suo fianco, più fida e più devota dei suoi Usseri della Guardia, la centuria dei deputati socialisti al Reichstag.
Neppure l’ombra d’un contrasto, neanche il più pallido tentativo d’opposizione: Deutschland über alles! La grande patria tedesca soprattutto; mentre dall’altra parte della frontiera l’estrema socialista che il 7 luglio osava ancora opporsi alla Camera all’approvazione dei quattrocento mila franchi bilanciati per la visita del [Raymond] Poincaré a Pietroburgo, non trova più un uomo a ricordarsi dell’internazionalismo socialista, a ricordarsi, nell’imminenza della guerra, dei truculenti discorsi e degli eretici ordini del giorno acclamanti alla riunione del Segretariato del Partito Socialista Internazionale a Bruxelles la settimana innanzi.
Neanche uno, neanche [Gustave] Hervé.
L’uomo che aveva abbandonato sul letamaio la patria di lor signori gridando sotto il serenar della bonaccia che il proletariato francese avrebbe risposto coll’insurrezione alla dichiarazione di guerra, inscriveva fra i doveri sociali, al primo lampeggiar de l’uragano, quello di rassicurare il governo “che non si sarebbe fatto lo sciopero generale contro la guerra minacciata, che non si sarebbe fatto lo sciopero generale insurrezionale a guerra dichiarata.
“Che i socialisti, i sindacalisti, i libertari avrebbero marciato come un sol uomo alla frontiera dando ai nazionalisti l’esempio del coraggio e della disciplina, confidando alla sollecitudine della Repubblica la cura delle donne e dei bambini”. (“Guerre sociale”, anno VIII, n. 31, 31 luglio 1914).
Un sagace rimpasto ministeriale ha sbaragliato ogni più lontana minaccia di opposizione. Il 26 agosto [René] Viviani ricompose il suo ministero chiamandovi i rappresentanti delle diverse gradazioni del socialismo radicale ed unificato: Jules Guesde, Marcel Sembat, Bienvenu Martin, Gaston Thompson, Alexandre Millerand, Aristide Briand, Victor Augagneur, ecc. Per una parte si ammutoliva la opposizione togliendone in ostaggio al governo i caporioni meno docili, si addossava per l’altra al partito socialista la responsabilità della guerra e delle sue sorti cui sono strettamente legati i destini, le fortune della Banca di Francia, del Creusot, della Chatillon Commentry, del Crédit Lyonnais, della grande finanza e della grande industria francese.
Se la borghesia non è stata mai così arruffianata, non poteva essere né più obliqua né più stupida l’opposizione socialista; bisogna convenirne.
In Inghilterra il socialismo era nei ranghi, dispersa e sana la sola voce dissenziente, quella di Keir Hardie, come in Francia, vox clamantis in deserto, presto soffocata dall’insano urlo delle folle: a Berlino! a Berlino! non vibrava che la voce di protesta solitaria di qualche giornale anarchico.
Nel Belgio il socialismo era alla frontiera, per la patria, in armi e bagagli.
In Italia machiavelleggia.
La parte minore che, su la via di Damasco, ripete da anni, ad ogni crisi, i suoi omaggi alla classe dominante nel suo simbolo più augusto, è per la guerra, per la conquista di Trento e di Trieste, per l’annessione dell’Albania, per la rivendicazione di Tunisi, di Malta, della Corsica, del Nizzardo, dei quattro quinti d’Europa; la parte maggiore è per la guerra pure. Non è chi non veda che nella neutralità imposta al governo sia soltanto un alibi sagace. I trattati dinastici hanno legato le sorti politiche del popolo italiano a quelle dei governi centrali, contro la tradizione, contro la storia, contro le proteste vive d’un angoscioso passato storico recentissimo, sulla implicita rinunzia all’integrazione dell’unità nazionale; e la politica socialista è contro l’Austria contro la Germania, ribelle agli impegni dal governo assunti colla triplice alleanza. Ma è chiaro che sarebbe col governo per la guerra contro l’Austria, per la redenzione italiana dell’Istria e del Trentino; non contro la guerra in sé e per sé, non contro la guerra che, riconfondendo in nome della patria o della stirpe gli interessi irreconciliabili del capitalismo e del proletariato, oblitera nega investe e perverte tutta la critica, l’anima, l’azione, la ragione stessa d’essere, dell’aspirazione socialista e dell’emancipazione proletaria.
Non siamo qui di fronte al solito caso d’aberrazione o di corruzione individuale: siamo di fronte al fallimento di un metodo.
Il socialismo ha la sua ragione d’essere nel fatto economico dell’irriducibilità dell’antagonismo fra gli interessi proletari e gli interessi borghesi; è movimento di lotta e di redenzione di classe, e se questa redenzione è subordinata alla distruzione del monopolio economico e del privilegio politico della borghesia, non occorre spendere parola a dimostrare che il movimento socialista sarà movimento rivoluzionario non soltanto perché è rivoluzionaria la sua aspirazione remota, ma perché rivoluzionaria di tutte le irreconciliabilità quotidiane dovrà essere necessariamente l’opera sua di ogni ora d’ogni giorno. Un socialismo che, nell’attesa remota della espropriazione della borghesia, con questa s’intenda a sbarcare il meno peggio il lunario, e stabilisca, su le basi di compromessi assidui nel Comune, nella Provincia, nel Parlamento, sui mercati più ardui della mano d’opera, una cooperazione qualsiasi in vista della conservazione delle sparute libertà fino ad oggi conquistate, e dell’ordine sociale, sia pur provvisorio, in cui maturi la graduale elevazione intellettuale e morale del proletariato, è movimento socialista che si riassorbe senza pensarlo, senz’accorgersene, senza volerlo, nella vecchia democrazia contro cui era insorto, protesta e reazione. È il movimento socialista che, dopo il lampeggiante e perseguitato periodo delle origini, è venuto, traverso la cooperazione riconciliandosi col capitale, traverso il parlamento riconciliandosi con lo Stato, traverso le riserve mentali riconciliandosi colla Chiesa, disarmando i sospetti di tutti gli istituti dell’ordine ed abilitandosi, traverso la rinunzia, a prendere nel governo della cosa pubblica la successione politica che i vecchi partiti minacciano, essi, di compromettere e di sovvertire col loro immobilismo assurdo ed ostinato. Eccitate, esasperate quest’azione colla lusinga d’una conveniente partecipazione nell’azienda governativa, coll’esca delle maggiori influenze che vi si connettono, e l’involuzione sarà precipitata dalla preoccupazione delle responsabilità del domani.
Come meravigliarci se, giunta alle soglie del potere, questa gente che per trent’anni ha speso intelligenza, studio, parola, tenacia a persuaderci che i nostri interessi non erano gli interessi dei nostri padroni; che erano altri, diversi, opposti, irreconciliabili cogli interessi dei nostri padroni; che essi non potevano avvantaggiarsi, trionfare, se non sullo sbaraglio della classe padronale, perché non v’è margine, terreno neutro su cui possa stringersi un’alleanza, venire ad un compromesso; e ci ha ispirato il sospetto, innestata la sfiducia, imposto il divorzio da ogni partito politico cui si doveva opporre la classe assisa sull’identità degli interessi economici, cinta di una solidarietà, di una forza cui nessuna forza avrebbe potuto resistere – sia venuta poi di ruzzolone in ruzzolone a dirci che nel nome della stirpe o della civiltà o della patria quegli interessi si potevano, si dovevano anzi conciliare e confondere: che nel nome della nazione o della civiltà o della patria i padroni, gli sfruttatori, coloro che campano del nostro sudore e grandeggiano sulla nostra servitù, potevano anche, se nati di qua dall’Isonzo o dal Brennero, essere fratelli nostri; e che i miserabili, anche i miserabili della nostra stessa miseria, della nostra stessa abiezione, potevano essere nostri nemici a dispetto della identità del destino e della solidarietà degli interessi, se fossero nati, se fossero accampati di là dal Quarnaro, perché di là, pur dolente come noi, la progenie di servi ha altra bandiera, altro re. Ed è l’Austria di Francesco Giuseppe d’Asburgo, mentre noi, noi siamo l’Italia di Vittorio Emanuele di Savoia. E che è triste, è miserando, ma dobbiamo, noi vilipesi, noi sfruttati, noi straccioni che non ci siamo visti mai, che ci siamo sentiti fratelli anche ignorandoci, avventarci gli uni sugli altri, sgozzarci senza pietà né misericordia se tra Gennariello e Cecco Beppe lampeggia un contrasto, se tra i padroni di là che per gli edificatori della loro fortuna non ebbero mai che disprezzo, galera, pedate nel ventre, e quelli di qua, che nella nostra pelle si sono tagliata l’onnipotenza e la boria, s’accende la più stupida querela di rigattieri.
Il proletariato assunto alle eucaristie dell’Internazionale per un’ora, cittadino per un’ora della patria universale, riprecipita tra i gretti confini della gente, si riconcilia col suo aguzzino millenario, ne veste la livrea, ne cinge le armi e le insegne, ne debella cantando i nemici, lieto di dare la vita sua, il pane dei suoi pel trionfo della gente, della patria, della civiltà, senza ricordarsi neppure che delle tre matrigne adunche è il bastardo tre volte ripudiato.
Ci ha abituati all’Eliseo ed al Quirinale, il socialismo ben pensante; l’abbiamo visto bisbigliare desolato il miserere ai funerali di Umberto di Savoia e del Cardinale Bonomelli; ci ha smaliziato a Châlons ed a Draveil nelle socialiste stragi dei senza pane; possiamo ben vederlo assunto con [Alexandre] Millerand alla suprema magistratura della guerra, anelante con Bissolati, con Turati, con Ferri, coi diversi Corridoni mocciosi – riconciliato nel gran nome della patria – a Trento a Trieste, all’organizzato sterminio dei miserabili di qua e di là della frontiera.
Nel nome della Patria e della civiltà...
Si capisce che, accantonate nel sofisma della civiltà, le ragioni della guerra non potevano interessare il proletariato.
Dove l’hanno mai incontrata la civiltà, i paria? Donde e quando ha lasciato essa cadere su le loro pallide fronti riarse le rugiade e le speranze de la risurrezione?
Così non comunicano i servi negli entusiasmi di lor signori anche se subiscano, ancora una volta, disperati incerti diserti la violenza d’un destino contro cui non hanno la necessaria forza concorde di insorgere.
È di accademici, di dottrinari, di politicanti la cagnara. Scroscia dalle chiese, dai concili, dagli aeropaghi consacrati della scienza, della letteratura, dell’arte, la protesta contro la barbarie guerriera delle stirpi; e poiché cieca ottusa bestiale essa si attenda con ogni duce a l’ombra di ogni bandiera, con Lord [Horatio] Kitchener consacrato cavaliere nelle stragi esotiche e recidive del continente nero; con [Joseph] Joffre, superstite fosco delle restaurazioni versagliesi del 1871; coi Cosacchi dello Zar cresciuti nei progrom assidui, nei sistematici eccidi di vecchi di donne di bambini, alla grande guerra, alla grande gloria sui campi d’Occidente; coi due imperatori, curvo l’uno sotto mezzo secolo di infamie di delitti d’impiccagioni di carneficine, prono l’altro a la tortura quotidiana delle schiatte indocili al suo giuoco – scienza, arte e poesia, al vasto orizzonte squarciato dall’indagine temeraria nelle tenebre del dogma e del mistero, al vasto dramma umano sanguinante in ogni cuore, oltre ogni frontiera del tempo e dello spazio, alla grande speranza umana liberata dalle stupide predestinazioni alla conquista della verità, della bellezza, della giustizia, della redenzione, hanno posto, squallido esoso termine, l’arcigna e bramosa erma degli Indigeti, cortigiane impudiche di mercanti e di birrai.
Gabriele D’Annunzio nostro “per la quercia e per il lauro e per il ferro lampeggiante, per la vittoria e per la gloria e per la gioia”, invoca pronubo alle fortune della nuova Italia – l’Italia di Bava Beccaris e di Piazza del Pane – custode alto dei fati, Dante Alighieri, parlando con poco rispetto; mentre da Londra Rudyard Kipling altro più vasto, più assiduo tributo di sangue d’inedia di figli chiede al grembo delle madri britanniche per salvare la patria che gli Unni del ventesimo secolo vogliono ridurre, umiliare, ad un’oscura provincia tedesca; e Maurice Maeterlink, il puro e fine e mite poeta dei bimbi e dei semplici, dinnanzi allo strazio della sua eroica terra fiamminga, non contro i feticci orrendi che al loro giogo infausto piegano, prima che lo straniero, il suddito ed il cittadino, avventa il giambo avvelenato, ma alla gente conclama la “risoluzione inesorata: lo sbaraglio delle perfide forze profonde segrete irresistibili che innervano tutta l’anima tedesca e vogliono essere schiacciate sotto il tallone senza misericordia, poiché nessuna potenza umana potrà ammansarle, attenuarle, trascinarle sulla via del progresso, neppure colla più severa delle lezioni, e vogliono essere distrutte come un nido di vespe che noi sappiamo non potranno mutarsi mai in nido d’api benefiche ed industri. Lasciate passare un migliaio d’anni di civilizzazione, migliaia d’anni di pace con tutte le possibili raffinatezze d’arte e di cultura: lo spirito tedesco rimarrà immutato, sempre pronto ad esplodere, non appena l’occasione si presenti, cogli stessi aspetti, colla medesima infamia”, per cui la guerra, la guerra d’oggi, è urto di due correnti fondamentali dell’anima del mondo: l’una fosca d’iniquità, d’ingiustizia, di tirannia; l’altra anelante alla libertà, alla vita, al diritto alla gioia.
Delenda Germania!
Sono passati due millenni quasi da Tacito a Maeterlink, ma nella mente del poeta fiammingo, dei molti che ne battono le orme e ne dividono gli orrori, la Germania è rimasta come ai tempi di Tacito “tutta selve orride e paludi, tra cui la gente continua, come allora, ad allevarsi col bestiame sulla terra medesima spregiatrice d’ogni civile mollezza, feroce alle guerre, avida alle prede, briaca, turbolenta, ladina alle ferite ed alle morti in tempo di pace” solvendo il dubbio che angustiava lo storico ternano, se i Germani avessero volto d’uomini e membra e cuore di fiere, come allora si favoleggiava ed oggi non osano escludere più né Maeterlink, né D’Annunzio, né Rudyard Kipling che in nome della civiltà del diritto della vita e della gioia ne deprecano lo sterminio finale.
Delenda Germania!
Bisogna esser giusti: dall’altra parte della frontiera non scoscendono meno irosi gli anatemi: La barbarie è dell’Inghilterra. Al fariseismo ipocrita dell’Inghilterra, invidiosa della grandezza e della potenza tedesca, bisogna addossare le responsabilità della guerra che devasta il continente. Roentgen butta nel cestone dei fondi per la guerra la medaglia decretatagli dalla British Royal Society per la scoperta dei raggi X; Ernst Haeckel e Rudolf Eucken, che sono senza contrasto le menti più vaste, i cuori più generosi, le glorie più fulgide del mondo scientifico moderno, in nome di tutti gli uomini di lettere e di scienza della vecchia Germania, denunziano nella “Wossische Zeitung” di Berlino il fariseismo ipocrita dell’Inghilterra che ha tolto pretesto dall’invasione del Belgio così necessaria alla Germania (!) per sfogare il suo brutale egoismo nazionale, l’odio antico e l’invidia marcia che essa cova della grandezza della Germania che vorrebbe distruggere senza riguardo ai diritti, senza riguardo a moralità od immoralità, pel suo esclusivo avvantaggio.
“Deprimente spettacolo” – commenta Frank Jewet Mather della Princeton University – “quello di due grandi pensatori, grandi figure cosmopolite ambidue, i quali indulgono ad un nazionalismo violento, inconsiderato e maligno... rompendo un vincolo che tra i due popoli si era stretto traverso l’influenza che Goethe aveva esercitato su Carlyle e Carlyle su due generazioni d’inglesi, e pel trionfo che alle dottrine darwiniane avevano assicurato in Germania la temerità e la pertinacia degli scienziati tedeschi quando in Inghilterra Thomas Huxley lottava con dubbia fortuna ad ottenerne una qualsiasi considerazione”.
Tanto più triste lo spettacolo che dall’aspra contesa il nazionalismo perfido delle quattro grandi patrie in armi, trae l’obliqua giustificazione del suo bestiale furore di sterminio e di desolazione. Difendono la gloria dei saggi, dei pensatori, dei poeti, della cultura tedesca gli ulani gialli, i foschi usseri della morte, gli holzer da quarantadue pollici del Kaiser! portano per le arcaiche strade di Lovanio e di Bruges il ghigno amaro e la fine ironia, chi l’avrebbe pensato mai? di Schopenhauer e di Henrich Heine! E sulle paradossali dreadnought britanniche da cinquantamila tonnellate, riparte alla conquista del mondo, che durante due secoli vibrò alla sua parola ed alla sua passione, William Shakespeare; parte Darwin a ripascere la sua gioia serena nella confusione dei dogmi e dei confini sgominati. Oltre la Vistola non portano lo strazio, l’angoscia dell’immane mina i cosacchi del Don, portano su le picche il dubbio tormentoso di [Shaul] Cernichovskij, le eretiche annunziazioni di Turgenev, rassegnato o scaltro il vangelo di Tolstoj; mentre le rosse legioni della Terza Repubblica ribenedicono sulle ecatombi di Ypres per la convertita voce d’Anatole France, la passione di libertà, il voto di fratellanza che all’antico regime costernato in ogni terra, che ai servi dolenti d’ogni patria, aveva gittato, morendo, la prima!
E tanto più infausta è l’abdicazione, la dedizione miseranda, che penetrano lente lente le voci nuove traverso la coscienza proletaria rassisa da millenni di rinnovate devozioni, le voci insolite ed il temerario ingrato spirito d’indipendenza e di libertà. Mutano credo e santi, ma la fede rimane cieca dinnanzi ai lampeggiamenti delle verità remote ed inaccessibili alla coscienza universale. Si giura oggi in Galileo, in Newton, nella teoria di Laplace e di Darwin, come si giurava ieri sulle parole di Mosè, della Genesi o del Sillabo. La scienza è rimasta mistero, privilegio scarso la conoscenza, il saggio un sacerdote ed un profeta, e quando la guerra la strage la mina sono invocate, necessità di suprema salute, da Anatole France o da Maksim Gor’kij, da Haeckel, da Rudyard Kipling o da Gabriele D’Annunzio, dal fior fiore dell’intelletto, della coscienza, dell’amore, dell’orgoglio, della gloria d’ogni stirpe, possono i servi, chiusi dal giogo quotidiano fuor della vita che freme e pulsa e cerca e spera, sul solco, giù nella miniera, per le officine, ludibrio perenne della tenebra, della macchina, del vento e del mare, possono avere i servi la libertà di dissentire, il diritto d’insorgere, di rifugiarsi alla men peggio nel tardo buon senso o nell’orgogliosa presunzione che – relegati essi pure nel mondo, senza dubbio migliore ma altrettanto esclusivo della speculazione e dell’astrazione, altrettanto sordo alle bestemmie, alle imprecazioni, alle minacce che prorompono e s’incrociano su l’urto perenne ed irreconciliabile, su la competizione caina su la spregevole volgarità dei piccoli interessi quotidiani, sono esteti e savi così destituiti d’ogni lume, d’ogni libertà a giudicare dei grandi uragani collettivi come il volgo a discernere nell’inviolato enigma dell’universo, nel chiuso mistero delle origini?
– Hanno studiato ed appreso, sanno da soli quello che millenni di storia, milioni d’abitanti del pianeta non hanno mai intraveduto; alla verità hanno dato i raggi, al progresso le ali essi soli. Le olimpiadi civili si numerano e s’intitolano dai loro nomi gloriosi; non possono errare, ed errassero pure, non noi potremmo sorprendere una verità che si fosse ad essi ricusata. E quando per la guerra è il vasto consentimento degli eletti, quando contro l’unanimità del consenso nessuna grande voce insorge, nessuna delle grandi voci che nelle ore tragiche del comune destino risvegliano gli echi oltre gli oceani, oltre i continenti, oltre i secoli; e non squilla nel cielo corrusco, per gli animi ebbri di passione e di perdizione, che la protesta vostra sfiduciata flebile incerta, per la guerra bisogna essere anche se vuole nuovi e più esosi tributi di miseria, tributi orrendi di sangue e di lacrime, e, più inesorata di ogni maledizione del Levitico, condannerà alla servitù ed al pianto i figli, ed i figli dei figli quanto lontana durerà nei secoli la memoria dell’irredimibile ferocia umana; per la guerra sono tutti; non senza ragione certo.
Bisogna chinare il capo, essere per la guerra anche noi...
– È il ruggito dell’armento.
– È il grido d’ogni anima, irresistibile; fruga anche in mezzo a voi ogni cuore, scuote ogni fede, turba ogni mente, assilla ogni coscienza, mina e sovverte l’edifizio della dottrina; è come la folgore di Damasco sulla via delle aspettazioni redentrici.
Passate pur sdegnosi fra il pidocchiume in busca d’una fede e d’un padrone che l’appalti per la broda; passate disprezzando fra la clientela lazzarona e mercenaria che, salvando la pancia al sacco coscrive, ai rischi della guerra, la pelle altrui; di mezzo ai deboli, ai fiacchi, troppo pigri, troppo squallidi per avere il coraggio o la forza d’un pensiero, d’una volontà propria, travolti oggi dalla bufera nel comune delirio; ma se oltre la schiera obliqua o fragile degli apostati minori su le vie della guerra trovate Amilcare Cipriani e Pëtr Kropotkin dolenti che i settant’anni tolgano ad essi d’imbracciar una carabina e di marciar contro il nemico, non direte certo che all’uno manchi la fermezza della volontà, all’altro la sagacia, la sincerità ad entrambi del consenso alla grande guerra, e del voto fervido e conserto perché su la feudale barbarie teutonica trionfino gli eserciti collegati di Francia e d’Inghilterra, del Belgio, della Russia e del Giappone.
– Abbiamo trovato su la via della grande guerra, erti contro di noi, oltre la breve schiera degli apostati minori, Amilcare Cipriani e Pëtr Kropotkin di cui nessuno oserà mai impugnare la probità mentale e la sincerità adamantina.
Ci ha attristati l’incontro, non ci ha smossi né scorati: Contro la guerra oggi come ieri, come sempre, dovunque e comunque sia accesa od abbia ad accendersi!
E ve ne daremo qui le nostre modeste ragioni.
Premettiamo subito una dichiarazione così sincera come necessaria: non abbiamo idolatrie, non devozioni stagnanti, non feticismi ciechi; ma non abbiamo neanche la più lontana nostalgia d’inquisizione e non sappiamo proprio che farci della pelle di coloro che, di mezzo alle falangi più o meno sovversive del proletariato internazionale, sono stati travolti dalla fiumana ed incapaci di tenersi ritti, di raccomodarsi la testa sulle spalle, e, dentro, libera la propria ragione, sereno il proprio giudizio, hanno nel coro briaco mesciuto il loro inno alla guerra, il loro appello fervido alla grande crociata civile contro la feudale invadente barbarie teutonica. Infierire sarebbe iniquo: non soltanto non è da tutti, ma non è neanche di tutte le ore, non è di tutti i problemi, meno ancora dei problemi che si affacciano impetuosi, lusingatori di orgogli irresistibili, minacciosi d’orrori ineffabili, irti di contraddizioni penose, l’indipendenza mentale, il coraggio morale, l’angosciosa insurrezione contro lo sfolgorare d’un’epica menzogna convenzionale e la smagliante rievocazione d’un tradizionalismo ordito di martirio e d’abnegazione, d’ardimento e d’eroismo; contro il rigurgito improvviso di collettivi stati d’animo appena superati, vibranti sempre, sempre vivi sotto le ceneri calde; contro l’urlo del gregge che prorompe cieco, violento, incoercibile al richiamo; coraggio ed indipendenza cimentati dal dubbio intimo prima che dalle brutali sopraffazioni esteriori, è condizione fondamentale del giudizio che sarà spassionato e sereno quanto più alla passione sarà estraneo se non superiore.
Perché non siamo particolarmente toccati dalla grazia noi che oggi possiamo sottrarci senza sforzo al baratro in cui gli altri hanno buttato l’ispido bagaglio delle loro convinzioni in un’eclissi disperata della parte più densa, più gagliarda, più luminosa, anche se più dolorosa, della loro vita. Quelli non sono peggiori di noi, noi non siamo migliori, siamo soltanto più lontani, in un’atmosfera meno turbolenta; e di lontano l’insieme dei paesaggi e dei fenomeni si sorprende nelle grandi linee e nei rapporti essenziali senz’ombra e senza deviazioni mentre su la mente, su l’anima abbonacciate, l’onda che laggiù ribolle di tutte le passioni ed è torbida d’ogni ansia, densa d’ogni turbamento e d’ogni aberrazione s’abbatte fioca, stanca, innocua, come purificata traverso i due continenti d’ogni sua acredine, d’ogni sua ingrata amarezza.
Vi possono torcere le labbra in una smorfia di disgusto supremo il lazzo sguaiato, la capriola impudica degli istrioni che ieri dalle cuspidi dionisiache dell’egoarchismo irridevano alla platea sciatta, obliqua di ibridismi nazzareni e democratici, ed oggi, per la paura o per la mancia, alla guerra democratica ed ai trionfi della cristianità, ribenedetta sotto la torva minaccia barbarica, allo Stato – ludibrio e scherno ieri, oggi arca e presidio immarcescibile – coscrivono nelle prefetture regie sicofanti e guerrieri.
Ma se vi appaia improvvisa dinnanzi, rudere magnifico d’un’era che nella storia si è fatta luce traverso il martirio e l’eroismo, esuberante di tutta la forza, vibrante di tutta la fede, quando la fede si confessava in cospetto del patibolo tra la corda il ferro e il piombo, se v’appare domani bianca, bianca, incisa di rughe, le rughe di Nouméa, di Portolongone e di Regina Cœli, serena nei grandi occhi leonini, la figura di Amilcare Cipriani troppo vasta perché si possa costringere nel credo breve ed arcigno, troppo alta perché si possa chiudere sotto la cappa de la congrega, ed Amilcare Cipriani che d’ogni guerra ha durante mezzo secolo numerate le diane, ne ha vissuto i cimenti angosciosi, ne ha sempre nella retina il baleno orrendo, nel cuore il brivido fratricida; e vi dice, egli che oltre le stragi immani oltre l’immane ruina d’ogni guerra, d’ogni battaglia, intravide sanguigna, lontana, e pur fatale, l’aurora delle grandi eucarestie della fratellanza e dell’amore, che bisogna riprendere il sacco, la carabina, dare ancora l’entusiasmo, la giovinezza, la vita, per salvare il conserto destino della civiltà e della Francia dalla conserta minaccia della Germania e del feudalismo imperiale, non potete né disdegnare né compatire.
– Nessuno l’osa, nessuno lo potrebbe, senza sacrilegio, perché comprende agevolmente ognuno che non diserta oggi la Francia l’uomo che nelle rosse falangi garibaldine le fece scudo del suo petto tra Montretout ed Autun, quarantatre anni fa. Non diserterebbe la Francia, non diserterebbe la repubblica oggi Amilcare Cipriani, rinnegherebbe tutto il suo passato corruscante tra le propiziazioni vittoriose di Digione e l’ecatombe comunarda espiatoria; e di quel passato egli è il prigioniero perenne e rassegnato. Ve lo lega più saldo d’ogni vincolo codesta sua romagnola magnanimità impenitente per cui all’abbandono, all’ingratitudine, alla bassezza, non si può, non si deve rispondere che colla spontaneità irresistibile, impetuosa ed obliosa del sacrifizio: a Bordeaux ripaga l’abnegazione il disinteresse e l’eroismo delle camicie rosse collo scherno e col bando, la clericanaglia repubblicana campagnarda. È naturale. Può far altro la chericanaglia? Ma all’appello della repubblica minacciata, della patria adottiva in angustia, i superstiti di Satory e del Pére Lachaise tornati dalla Nuova Caledonia, non possono rispondere che marciando all’avanguardia; può fare altro un garibaldino?
E l’unico rimpianto del vecchio Amilcare Cipriani in quest’ora di passione, è che la ferita di Domokos gli tolga di fare oggi “come nel 1870 argine del suo petto alla Francia repubblicana contro l’imperialismo militarista”.
Non lo tormentate di domande odiose che non incresperebbero d’un dubbio la sua devozione inamovibile. Non chiedete a lui, scampato pur ieri alle tenaglie dell’inquisizione repubblicana ed alle bieche vendette del militarismo francese, se l’imperialismo da conio e da forca, quello che si arma soltanto per arrembaggi borsaioli dell’alta finanza non sia su le rovine della Bastiglia accampato sornione cinico vorace così solidamente almeno che nel ghetto di Francoforte, nelle acciaierie di Essen o nelle caserme di Strasburgo o di Berlino. Non gli chiedete se abbia osato mai ai Piombi, allo Spielberg l’imperiale e regia cancelleria austriaca quel che le patrie egerie stagionate di Villa Ludovisi hanno osato a Regina Cœli frugando del roseo artiglio fino alla follia il cuore ed il cervello del povero Acciarito; non ha disperato della patria ad Aspromonte a Mentana a Portolongone; della Francia non ha disperato dinnanzi al plotone di esecuzione, non ha disperato a Nouméa, e la Francia è per lui la repubblica che ghigliottina con Capeto le monarchie nobiliari e grida la dichiarazione dei diritti, mentre la Germania rimane in lui a dispetto di Giovanni Leida e dell’anabattismo comunista, a dispetto del suo 1848, a dispetto di Fichte, di Marx o di Haeckel, la Germania del Barbarossa e del Bismark, della grazia di dio e delle leggi eccezionali: “va ‘n po’ la, burdlass che i todesch, boja d’...”.
Venticinque anni dell’esistenza turbinosa ha speso per l’ideale quando l’ideale era la patria, sua o d’altri; venticinque ha consumato in galera. Tornando al mondo, dopo un quarto di secolo d’eclissi, ravvisa nel nemico – che nei cinque lustri turbinosi è mutato – i lineamenti leggendari, e torna alle implacate fobie tradizionali.
Come lo volete lapidare se i garzoncelli dell’estetismo sovversivo che pei seminari hanno sciupato l’intelletto e la salute guardandosi l’ombellico, centro dell’universo gravitante modestamente intorno all’immensa vanità della loro erudita miseria, traggono gli oroscopi delle genti, e vi conchiudono nelle sicumere magniloquenti collo stesso semplicismo garibaldino – colla sincerità in meno – che, in ogni caso, e da qualunque punto di vista il conflitto europeo voglia giudicarsi, forza sarà riconoscere che la lotta è tra feudalismo ed industrialismo, tra imperialismo ed intellettualismo. Il feudalismo e l’imperialismo accantonato tra gli ulani del Kaiser, l’industrialismo e l’intellettualismo presidiato dagli Indu di Giorgio V, dai Cosacchi dello Zar e dai dragoni della repubblica borsaiola.
Come se il feudalismo spostandosi dal primo degli ordini, dall’aristocrazia neghittosa, corrotta, imbelle, al terzo stato irrequieto, avido, corruttore, avesse mutato più che la pelle ed i riti, e ad un vassallaggio più bieco che non ai giorni più tristi dell’antico regime non avesse soggiogato ogni ordine della società laddove la grande industria, l’alta finanza ha più agile lo strumento della produzione e più rassisa, più antica, più esperta la complice organizzazione.
“L’uomo anche più ignorante in materia finanziaria non può sottrarsi ad una legittima apprensione pensando che gli otto miliardi di riserva metallica della Francia si trovano nei forzieri di poche grandi banche, che è quanto dire a discrezione di un ristrettissimo numero di finanzieri i quali, all’infuori di ogni questione di probità o di disonestà, dispongono così, senza il minimo controllo, del più formidabile mezzo d’azione che esista dal punto di vista economico, politico, sociale”.
Così, non un sovversivo, ma un ex presidente del Consiglio dei ministri, un finanziere arruffianato, un conservatore scaltrito ad ogni cautela anche se rugginoso di tutti i pregiudizi, un patriottardo maniaco, [Jules] Méline, delinea nella “République Française”, il nuovo feudalismo ben più infausto che quello del Kaiser, altrettanto funesto ai vassalli – ed i vassalli più sciagurati, i servi siamo noi, sempre, immutatamente – quando di là dalla frontiera il feudalismo dei Krupp, dei Bayers, della Deutsche Bank e delle diverse Disconto-Gesellshaft che consacrano in Germania, così come altrove similari istituti di privilegio, il monopolio dei nuovi signori, i signori del dollaro, del dividendo, i signori dell’usura e del miliardo, succeduti ai signori della terra, della grazia di dio, delle crociate, egualmente oziosi, egualmente voraci; egualmente esosi a chi lavora, a chi suda, a chi crea, a chi geme in ogni patria, tra ogni gente, all’ombra complice di ogni bandiera, perché si possa oggi dire Francia o Germania o Inghilterra od Italia, perché alla gloria d’un nome a cui non corrisponde la realtà, che stride anzi la più violenta delle antinomie; perché al trionfo di un simbolo di comunanze ideali e di tradizionali solidarietà che si dissolvono nel più feroce antagonismo, s’invochi da questa parte della barricata l’entusiasmo e l’olocausto.
Non c’è più la Francia; ci sono, di là dal Cenisio, la Banca di Francia, Rothschild o Schneider, ed alla loro lassa artigiani e villani che muoiono di fame, che affogano, ad ingrassarli, nell’ignoranza nell’abiezione e nel dolore; non v’è più la Germania; sono di là dal Reno o dalla Mosella bande svergognate di grandi corsari che a quelli d’oltremonte e d’oltremare contendono la corsa la spiaggia il mercato il sacco i subiti guadagni opimi, e vogliono dai minatori anchilosati, vogliono dai fabbri riarsi, vogliono dai tessitori anemici, dai contadini pellagrosi della Slesia della Sassonia della Westfalia l’ultima goccia di sangue e l’ultimo rantolo. Hanno creato col loro lavoro, coi loro sudori, coi loro digiuni, troppa dovizia i morti di fame, troppa ricchezza non pagata, debbono ora dar la pelle per squarciare, nei ranghi d’altri servi che li custodiscono ignari e gelosi, i mercati del mondo.
Ed è così dappertutto, oltre la Vistola, oltre la Manica, oltre le Alpi, oltre l’Oceano.
Non v’è più patria.
Lor signori la vendono a chi meglio la paghi: i reietti, dei derelitti, dei bastardi d’ogni patria vogliono edificare la patria universa e libera, senz’odi né frontiere in cui l’amore e la libertà trovino il rifugio, irradiino la gioia.
Nessuno ha diritto di tacere, di nascondere ai miseri la verità iconoclasta, e gli araldi della fratellanza internazionale non hanno alcun diritto di turbare, di sviare dall’aspro cammino a cui s’affaccia incerta e malsicura, la coscienza proletaria ai suoi primi passi.
Compito loro d’illuminarla, di sorreggerla per l’erta scoscesa; e Cipriani e Kropotkin hanno torto di sacrificare alla febbre effimera, pregna di disinganni, del sentimento, l’insegnamento della ragione e della storia.
Kropotkin sopratutto.
Kropotkin, no. Kropotkin non trova attenuanti se non nella sentimentale impulsività che sarà la sua disgrazia o la sua ventura, ma per la quale, se trovi nei giornali del mattino l’eco d’un’insurrezione plebea, incendia le intime speranze al consueto pronostico della rivoluzione sociale imminente, colla stessa improntitudine con cui le spegne al tramonto se gli rechino i giornali la mala nuova che il movimento è stato soffocato e l’ordine ristabilito.
Di queste sue climateriche oscillazioni vertiginose è un recidivo abituale.
Nel marzo del 1904 dallo scoppio improvviso della guerra tra la Russia ed il Giappone traeva frettoloso l’oroscopo della rivoluzione che, disgraziatamente e per ragioni le quali sono all’infuori ed al disopra del puro accidente, non accenderà nel campo economico neppure la guerra attuale dal cui esito – vittorioso con ogni probabilità per le potenze alleate – sarà allontanata anche l’ipotesi di una rivoluzione politica sovvertitrice dello zarismo che dalla lunga guerra e dai suoi trionfi sanguinosi sortirà prevedibilmente restaurato, riabilitato, esperto.
E ancora tre anni fa, chiuso agli ammonimenti severi della storia un orecchio, chiuso l’altro alle voci della sua esperienza vasta ed antica, non metteva il suo evviva! a quello dei filibustieri che dalle comode cuccie sicure inneggiavano alla rivoluzione sociale messicana la quale non è – e non è mai apparso così chiaro come a questi giorni – se non una competizione losca d’appetiti volgari, d’avventurieri spudorati, di interessi inconfessabili a cui da Huerta, a Carranza, a Villa, a Zapata, a Morgan, ad Harriman, a Wilson, a Hearst, – s’arrovellano da ogni covo un po’ tutti, a cui, indifferente o sospettoso, rimane tuttavia ostinatamente straniero il proletariato messicano devastato fino all’abiezione dal medio evo industriale superstite e da qualche secolo di cultura religiosa intensiva?
È fatto cosi; è sempre l’uomo che licenziando al “Révolté” i suoi primi articoli trent’anni fa, vedeva la rivoluzione rompere ad ogni minuto dai pori, dagli sdegni della vita collettiva, e raccogliendo un decennio di poi gli ultimi suoi studi nella Conquista del pane vedeva almeno così lontana come il nuovo periodo glaciale la rivoluzione dei servi, nella quale crede poi sempre, ed al cui avvento, che è meglio, lavora colla sua formidabile forza e con immutato fervore.
Crisi violente e fugaci del sentimento su cui ripiglia poi, sotto l’urto delle conseguenze immediate, il suo dominio la ragione.
Ma intanto, disastrose.
Disastrose. Egli ne miete di questi giorni la testimonianza mortificante.
Nessuno dei grandi giornali che pur presumono tenere i propri lettori al corrente di quanto avviene nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, ha mai mostrato di accorgersi di lui, del suo prodigioso cinquantenario di ricerche, d’indagini, di nobile fatica da cui son pur fiorite opere letterarie, filosofiche, scientifiche che basterebbero alla gloria d’uno scienziato meno eterodosso: Il mutuo appoggio e lo studio sulla Letteratura russa.
Non se ne sono occupati mai; hanno intorno alla sua opera al suo nome, ordito concordi la congiura del silenzio non rompendola che per denunziarne le sobillazioni eresiarche alla polizia internazionale.
Lo levano sugli scudi, oggi che egli è per la guerra, oggi che egli è per la Francia per l’Inghilterra per la Russia contro la barbarie teutonica, tutti i pennivendoli che egli sa legati alle greppie dell’alta finanza, che egli, Kropotkin, ha bollato nei recenti articoli su “La Guerra” come la peggiore canaglia che sia mai ingrassata della miseria della rovina della strage della povera gente semplice e buona che egli, Kropotkin, diffidava, pochi mesi sono, a non lasciarsi abbacinare dalle apparenze, a non credere cioè alle profonde cause politiche, agli odi nazionali con cui si tenta giustificare ogni guerra la quale non è mai che il complotto fosco d’un pugno di ladri d’alto bordo.
E Kropotkin non è uomo da illudersi fino a credere che sia tarda riparazione al congiurato oblio cotesto scoscendere d’improvvise e postume apologie. Non certo al suo acume alla sua dottrina alla sua cultura alla sua fierezza, al sogno generoso – a cui ha dato, prezzo la galera di Pietro e Paolo e di Clairvaux, prezzo il bando perpetuo da ogni terra, tutta la sua vita – benedice concorde la stampa bordelliera e borsaiola; benedice ghignando alla sua contraddizione, benedice a Kropotkin che ripudia nell’inno guerriero per la Francia e la repubblica ed affoga nella democratica menzogna della nazionalità e della patria, la lotta di classe, la solidarietà proletaria, la rivoluzione sociale, l’anarchia.
Turibolando, ghigna.
Scorati, guardano a lui i giovani che dall’imbelle torpore si risvegliarono e dal convenzionalismo obliquo s’affrancarono alla magica carezza della sua parola, e nei delubri misteriosi che agli ignavi custodiscono la dovizia e la gioia, e dagli umili esigono, tributo perenne, il sudor d’ogni fatica, le lacrime d’ogni dolore, il sangue d’ogni olocausto, videro le sue bianche mani sacrileghe strappare al tabernacolo venerato i complici veli denudando la frode nefasta che vende all’ozio la gioia, le bilance de la giustizia ai ladri, il vangelo ai farisei, l’ordine agli assassini, la pietà al boia, ad un pugno inverecondo di parassiti e di manigoldi la parte maggiore e la più degna del genere umano.
Non egli dunque ci aveva nel torpido viluppo della storia che sgomina dei suoi enigmi il nostro acume ed il nostro coraggio, non egli ci ha imparato a discernere oltre ogni frontiera della tradizione, della fede, della lingua, amici, e nemici? Nemici irreconciliabili di qua dalla frontiera quanti il vincolo della fede, della lingua, della tradizione, di ogni comunanza hanno brutalmente spezzato edificando sul nostro squallore l’insolente fortuna, su la nostra servitù la loro tirannide, su la nostra abiezione il loro orgoglio, su lo scempio delle carni, delle anime, dei cuori nostri, il loro privilegio?
Nemici con cui, non che la pace, nessuna tregua è possibile, sarà sperabile mai finché i frutti del pensiero, del lavoro umano – condizione o guarentigia della civiltà, del progresso che nel tempo e nello spazio non hanno confine – non siano dall’artiglio mozzo degli accaparratori esosi, dimessi, tornati patrimonio di tutti, strumento della rigenerazione di tutti, arra della libertà e del benessere di tutti?
Fratelli quanti al di qua e al di là di ogni frontiera, nati sullo stesso strame, cresciuti nella stessa tenebra, lacerati dalla stessa angoscia, proni sotto la stessa croce, hanno, a dispetto della diversa tradizione, della fede, della lingua, della bandiera diversa, identità d’interessi, solidarietà di speranze e di destino?
Egli, con voce con fervore con pertinacia che nessuno conobbe più ardente più viva più ostinata, disarmando gli odi fratricidi ne addensò in uragani espiatori sul nemico secolare l’inesausto furore; egli, col gesto largo del veggente, sull’inabissarsi lento d’ogni barriera, ci additò unico limite d’orizzonte alla grande patria redenta del domani; egli, gridandoci la guerra santa della liberazione finale strinse disciplinate conserte incontro ad ogni guerra di rapina e di sterminio le riluttanze istintive degli sfruttati.
Perché nel nome della patria, bugiardo simbolo d’una comunanza tradizionale che mal nasconde il disperato antagonismo d’interessi ond’è ogni stirpe dilaniata; perché nel nome di una civiltà eretta su la nequizie, su la menzogna, su la frode, ci chiede egli oggi la tregua agli oppressori, l’odio agli oppressi, agli sfruttati, ai fratelli di cui, nel nome di una più grande civiltà, di una più grande patria, propiziava ieri le irresistibili eucarestie, e dinnanzi agli animi nostri, incerti nel turbine, rievoca oggi, custode l’uno d’ogni fiamma civile, truculento l’altro d’ogni forca, gli spettri della Francia e della Germania quando ci diceva egli, ieri, pure ieri, che la Germania avida di guerra è la Germania senza scrupoli della Banca, della Borsa, del Krupp, che la Francia pronta alla guerra è la Francia che ha barattato la Dichiarazione dei Diritti per le azioni del Creusot, del Crédit Lyonnais, della Banca di Francia; ed a fare la guerra dei finanzieri dei banchieri dei grandi armatori dei grandi fornitori, di qua e di là del Reno, e a pagarne lo scotto in tante giovinezze, in tanto sangue, in tanti amari bocconi di pane, sono i senza tetto i senza patria i senza pane delle due nazioni?
Certo non è egli tornato dal giudizio che ieri a mente serena, a ciel sereno, esprimeva con tanta sagacia con tanto spregiudicato coraggio: egli è certo oggi l’uomo di ieri, e dove non sia una pedissequa aberrazione, dove il suo giudizio non sia stato travolto dall’impeto del folle ciclone, l’uomo di ieri e l’uomo di oggi dovranno avere, buona o povera, la loro ragione se si trovano d’un tratto fronte a fronte, l’uno da un lato, l’altro dal lato opposto della barricata.
Il compagno Pëtr Kropotkin – di cui i lettori conoscono, per saggi che la “Cronaca” ne ha recentemente pubblicato, l’acuta analisi dei moderni conflitti internazionali – riassume in un fatto unico, di esclusivo carattere nazionale, le cause originali della guerra presente: nell’annessione dell’Alsazia e della Lorena all’impero germanico nel 1871.
Lì, tutti i fermenti della guerra.
Perché, la necessità di conservare il suo dominio sulle due Province, violentemente usurpate, ha sospinto la Germania verso gli armamenti paradossali che, costituendo una minaccia costante alla pace ed all’equilibrio europeo, hanno indotto di contraccolpo, la militarizzazione di tutto il vecchio continente, una costante vigilia d’armi che di anno in anno è andata inasprendosi fino ad essere la preoccupazione esclusiva di ogni stato, rendendo impossibile ogni ulteriore progresso, ogni vita di pensiero, ogni tentativo proletario d’emancipazione.
Fissate con tanto ingenuo candore le cause della guerra, al compagno Kropotkin le ragioni di schierarsi per la Francia, per l’Inghilterra e, necessariamente, per la Russia contro i due imperi centrali, non mancano più; e quantunque – come a placare un rimorso – egli si auguri che “i lavoratori possano dalla guerra imparare quale e quanta parte a scatenare i conflitti armati fra le diverse nazioni, esercitano il capitale lo Stato” considera primo dovere d’ogni uomo di libertà e di progresso “dei proletari coscritti sotto i vessilli dell’internazionale del lavoro sopratutto, fare quanto è in loro potere e secondo le loro capacità rispettive per schiacciare codesto invasore”.
La Germania a Metz, un campo trincerato a propositi aggressivi, può nello stesso giorno della dichiarazione di guerra avventare duecentocinquantamila uomini su Parigi. Ed in tali condizioni non soltanto non è la Francia libera di attingere il proprio sviluppo, ma i lavoratori del Belgio della Francia della Svizzera dell’Olanda non potranno mai, in condizioni siffatte, iniziare un movimento di liberazione.
La Germania feudale scenderebbe in massa a schiacciarli.
E fossero tutti lì i mali dell’imperialismo tedesco! Che v’è di peggio: l’autocratismo russo tornato audacemente alla reazione, il servizio militare obbligatorio instaurato in quasi tutte le nazioni d’occidente; nella Germania stessa la sopravvivenza d’istituti feudali superati, l’irrisione costituzionale d’un parlamento asservito al monarca, la furia guerriera corrusca di lampi e di minaccia, non ripetono se non dagli atteggiamenti provocatori della Germania imperiale la loro causa e la loro ragione.
Guai se non si fa argine, subito, alla fiumana: l’Olanda, il Belgio, la Francia orientale, la Finlandia, la Danimarca saranno domani Province tedesche. Anversa e Calais saranno domani le basi navali delle nuove operazioni militari che metteranno l’Inghilterra alla mercé del Kaiser rendendo impossibile, nella inquietudine della minaccia perenne, anche nel Reame Unito ogni palpito di vita civile.
Non bisogna dimenticare che la Germania da sola o coll’accordellato della Russia non ha mai coltivato che odio alla Francia della Rivoluzione ed è stata sempre il gendarme, lo strumento di tutte le restaurazioni; e che dovremmo particolarmente ricordarlo
noialtri italiani che “nel 1860 quando si sono cacciati dalla Toscana, dal Modenese, dal Parmense gli Asburgo ed i Lorena, e Firenze divenne la capitale d’Italia, abbiamo trovato nella Germania la più tenace opposizione”.
In conclusione, avverte il Kropotkin, se nello sforzo comune di tutte le nazioni d’Europa la Germania non sarà schiacciata, avremo, se non più, un altro mezzo secolo di reazione.
Questi, fedelmente desunti dalla sua lettera al prof. Steffen nel “Freedom” dell’ottobre scorso [1914], gli argomenti del compagno Kropotkin che, agitando lo spettro della reazione imperialistica tedesca contro la quale vorrebbe – insieme alle falangi degli alleati, ai dragoni della repubblica ed ai cosacchi dello Zar – opporre la coalizione fervida di tutti gli uomini di libertà, dell’Internazionale del lavoro, prima d’ogni altra, è costretto a prevedere da parte dei compagni un’inquietudine ed un’obbiezione.
– Ma può essere crociata sincera di civiltà e di libertà questa che ha in fronte i vessilli e nella bilancia la spada e nella partita, posta decisiva, le orde cosacche del Piccolo Padre? E nelle mani dell’autocrazia, del Santo Sinodo, dei Cento Neri, della Duma – irrisione costituzionale almeno quanto il Reichstag – i destini della civiltà e della libertà staranno meglio che sotto i cannoni del Krupp ed i talloni del Kaiser? E non prepari tu, vecchio compagno incanutito sotto la raffica dell’esperienza più dolorosa, ancora un atroce disinganno, il disinganno mortale di cui s’abbevera nella storia ogni generazione proletaria ansante a ricostruire su la rovina d’una tirannide la fortuna d’ una tirannide più esosa, più infame?
– Non v’abbuiate! – rassicura il buon Kropotkin in cui l’intimo desiderio assurge alla solenne sicurezza del vaticinio. – Non v’allarmate! “Quanti seguono attenti e studiosi il movimento rivoluzionario russo possono dirvi quale sia il sentimento della Russia moderna e vi possono assicurare che in nessun caso l’autocrazia sarà restaurata nelle forme preesistenti al 1905, e che una costituzione russa non assumerà mai le forme e lo spirito imperialista di cui si è vestito in Germania il regime parlamentare”.
Il vasto consenso che nei cenacoli del liberalismo democratico hanno riscosso le dichiarazioni del Kropotkin spiega di per sé il senso di doloroso stupore con cui vennero accolte dai compagni. I quali pur non ignorano, e si sono fino ad un certo punto spiegate, le sue preferenze per le tradizioni la cultura il proletariato francese.
S’era dissetato, giovane, alle fonti superbe della filosofia del XVIII secolo Pëtr Kropotkin che al movimento rivoluzionario è venuto sotto la carezza delle voci, dei ricordi, degli uomini della Comune gloriosa; e, per la stessa natura geografica del movimento rivoluzionario, colla Francia intellettuale e proletaria ha coltivato per quarant’anni assidua famigliarità di rapporti. Non avrebbero essi mai preveduto tuttavia che dell’antico melanconico ufficiale dei cosacchi dell’Amour fosse tanto sopravissuto da farsi giorno, traverso l’antimilitarismo dichiarato, coll’eccitamento agli amici di Francia – che a cuor sereno ed a ciel tranquillo l’avevano aspramente ripudiata – a non contrastare la legge sulla ferma triennale, ed avevano diritto di ritenere che alle aspirazioni dei mugichi verso la terra e la libertà egli vedesse in una qualsiasi costituzione russa, fosse pure a differenza di quella tedesca immune dalla lebbra imperialista, un ostacolo almeno così arduo, così erto come nell’autocrazia sempre superstite e vigorosa.
Ma tant’è; sul terreno dei compromessi è così: spostato il punto di partenza le deviazioni vanno divaricando fino all’antitesi senza perdere l’apparenza logica relativa. Quando escludete la patria siete costretti a dire classe, a non vedere più che la rivoluzione sociale; quando invece, degli antagonismi selvaggi che si urtano all’ombra del simbolo etnico voi riedificate l’unità fittizia ed assurda che chiamate Francia o Germania o Russia od Italia, voi obliterate, senza pure accorgervene, il processo di differenziazione in cui il simbolo era andato dissoluto, e della nazione riavrete gli orgogli e le ansie, gli odi e gli amori, solidali con ordini istituti interessi che vi ripugnano, armati incontro a fratelli di cui non sapreste disconoscere nel tempo e nello spazio l’identità delle sorti e del destino; fantaccini squallidi d’una democrazia che avete speso il meglio della vita a debellare, soldati del Kaiser o dello Zar quando credevate di non aver più entusiasmi e sangue che per la rivoluzione sociale. Sono ruzzolati per quella china i socialisti tedeschi, gli antimilitaristi francesi, i sindacalisti italiani e... Pëtr Kropotkin.
È la logica della contraddizione, la quale è in principio.
Cercare chi abbia scatenato la guerra è ad un tempo ozioso e sterile. Kropotkin che ne addossa la responsabilità alla Germania vede levarsi di contro Keir Hardie e Bernard Shaw che ne accusano il governo del proprio paese, l’Inghilterra; mentre in Francia [Francis] Delaisi alla rescissione del sindacato franco-tedesco per la ferrovia di Bagdad seguita dalla convenzione militare anglo-francese di [Théophile] Delcassé, inasprita dalla legge sulla ferma triennale, conferisce i caratteri d’una vera e propria provocazione alla guerra; e contro Kropotkin che l’ora della guerra vede scoccare col compimento del canale di Kiel, altri, non senza fondamento, ritiene che all’Inghilterra urgesse sorprendere la Germania avanti che questa avesse esaurito il suo programma navale del 1915 da cui la sproporzione tra le due flotte rivali sarebbe stata attenuata.
Navigheremmo nel mare delle congetture e delle ipotesi senza speranza di giungere a conclusioni positive. I trattati di alleanza, le convenzioni militari, le combinazioni finanziarie che di ogni guerra sono l’ordito preliminare necessario, si stipulano, si consumano nel chiuso arcigno dei circoli di corte, tra gli Stati Maggiori, negli istituti di credito direttamente interessati ed ugualmente sbarrati ad ogni malsana indagine plebea. Contribuenti ed elettori, generali e deputati, la così detta nazione, l’ignorano come noi, e quanto ai raggiri dell’ultima ora, insegna la guerra del 1871 che deve passare qualche decennio avanti che al pubblico ne trapeli.
Di positivo, di reale, di tangibile non rimane che la voragine beante degli armamenti in cui, non la Germania sola, ma tutti i governi del vecchio e del nuovo mondo, dall’Inghilterra al Giappone, hanno precipitato durante trent’anni ogni più generosa risorsa. – Reazione ineluttabile agli armamenti tedeschi spianati contro la civiltà d’occidente, interrompe il Kropotkin.
– Anche il Giappone, anche la Cina, anche la Spagna e le due Americhe? chiederemmo a lui se non sapessimo che nessuno meglio di lui conosce quale sia oggi il compito dei grandi eserciti e delle armate formidabili che sui boccon di pane e col sangue dei diseredati stipano i governi in servizio del capitale insaziato.
Che nessun governo abbia osato spingere gli armamenti al parossismo attinto dall’impero germanico, è verità che al Kropotkin bisogna accreditare; ma tra il generale [Friedrich] Von Bernhardi che sogna per la patria tedesca una missione civile a cui la spada soltanto può squarciare il cammino così e Paul Louis che in uno studio recente mette in rilievo la potenza industriale raggiunta dalla Germania in questi ultimi quarant’anni, presunzioni diverse che sottintendono la stessa necessità, propendiamo sulle orme luminose segnateci dallo stesso Kropotkin ad indurre che a trovare uno sfogo a codesti tesori della patria industria, a conquistarne ed a proteggerne i mercati coloniali, si raccogliessero l’esercito e l’armata del Kaiser contro i concorrenti che le vie della formidabile conquista avessero a sbarrare.
Quanto più la guerra si delinea nei suoi obbiettivi fondamentali, tra gli antagonisti diretti e reali, l’ipotesi nostra trova sempre più vasta e più decisa conferma. Diremo di più: le ragioni vere della guerra, i suoi caratteri ed i suoi fini inconfessati, balzano improvvisi ed irrecusabili anche a coloro che chiudono gli occhi per non vedere.
La guerra che è tra la Francia e la Germania; e non appare, no, l’urto dell’Inghilterra, arca del patto costituzionale, contro la Germania custode del diritto divino; ma selvaggia competizione di due mercanti esosi di cui l’uno ha tenuto fino ad oggi incontestato il dominio dei mari, il monopolio del mercato internazionale, l’altro dalle sue terre, dalle sue miniere, dalle sue officine prodigiose, dal sudore, dalla fatica, dalla rassegnazione squallida dei servi, ha tratto in quarant’anni soverchia dovizia e gli vuole contendere la signoria secolare dei mari e dei mercati.
Arrembaggio svergognato di corsari! così remoto, così estraneo ad ogni preoccupazione di civiltà e di barbarie che non contro il feudalismo tedesco – mutato nome e maschera il feudalismo è d’ogni terra dalla Russia di Nicola II alla Spagna d’Alfoncito od all’America dei Rockefeller e di Wilson – ma contro l’industria tedesca invadente, incoercibile s’appuntano gli anatemi ed i cannoni degli alleati; contro la Germania che ha progredito, contro la Germania che trent’anni fa estraeva dalle sue miniere settanta milioni di tonnellate di combustibile e ne rovescia oggi duecentotrenta milioni sul mercato; contro la Germania che nell’ultimo trentennio ha elevato da uno a tre la produzione del ferro, da uno a sette la produzione della ghisa, da uno a diciotto la produzione dell’acciaio, a venticinque miliardi il suo traffico coll’estero, che nel 1875 non attingeva agli otto miliardi; contro il made in Germany per il made in England, è la guerra che strazia il vecchio continente, come ci riserviamo di meglio illustrare al seguente capitolo.
Ma intanto che cosa hanno a vedere, che cosa hanno a spartire con cotesti banditi della finanza e della borsa, compagno Kropotkin, gli uomini di libertà, i proletari di qua e di là della Manica o del Reno?
Che cosa?
Nella ricerca delle cause misteriose e profonde che possono aver determinato l’attuale conflitto europeo abbiamo visto la maggior parte dei compagni e dei giornali di parte nostra, da P. Kropotkin alla “Bataille Syndicaliste” attingere criteri, dati, cifre agli studi ed all’opera di Francis Delaisi. Non soltanto perché in materia di finanza – il presupposto d’ogni guerra – egli sia una competenza riconosciuta, non soltanto perché egli sia politicamente uno spregiudicato sempre disposto a tuffar le mani nel raggiro complicato dei grandi finanzieri, dei grandi borsaioli per dimostrare come sbarazzate le tasche dei contribuenti diretti ed indiretti, l’avida genia si aggioghi l’ingranaggio politico dello Stato, e sia di fatto, all’ombra della magistratura repubblicana, il solo vero onnipossente governo della Francia; ma anche e sopratutto perché nessuno come lui ha saputo dai vari sintomi inosservati o trascurati trarre con intuito meraviglioso, fin dal 1911, della guerra attuale, delle sue fasi primarie, una previsione così lucida e così sicura.
“Parlare d’una guerra possibile, probabile, prossima, sembra a prima vista una follia” – scriveva Francis Delaisi ne La guerre qui vient, tre anni fa – “e certo se si consultasse unicamente il sentimento popolare in tutti i paesi del mondo, non sarebbe da temersi. I proletari tedeschi hanno altra voglia che di tirar al bersaglio sui nostri... la grande massa dei lavoratori inglesi non chiede che di lavorare con tutta tranquillità nei campi, nei magazzini, nei cantieri; e quanto ai francesi, operai o contadini, proletari o borghesi, socialisti internazionalisti o radicali patriotti, non hanno che un desiderio: la pace. Tutto andrebbe a meraviglia, e noi potremmo starcene tranquilli se i popoli fossero padroni dei loro destini... Disgraziatamente nessun popolo in nessun paese del mondo fa la sua politica estera”.
Dopo di aver dimostrato che questa funzione rimane l’appannaggio della diplomazia, abilmente scelta tra gli aristocratici del nome e del denaro, a servire l’oligarchia finanziaria che spadroneggia nel paese; che la responsabilità ministeriale è una burla, che l’interpellanza parlamentare è una lustra, che la grande stampa è alla greppia dei borsaioli, e che in queste condizioni “nella nostra democrazia ombrosa una guerra può essere sfrenata, precipitato il paese nella più terribile avventura da un uomo o da un’esigua camorra di finanzieri”; dopo di aver dimostrato cogli intrighi anglo-francesi del Delcassé che non v’è nulla di temerario nelle sue affermazioni, il Delaisi conchiude:
“Una guerra terribile si prepara tra l’Inghilterra e la Germania. Su tutti i punti del globo i due avversari si misurano e si minacciano. Gli incidenti della ferrovia di Bagdad e delle fortificazioni di Flessinga mostrano a quanto grado d’acutezza la crisi sia pervenuta. Per battersi le due potenze hanno bisogno della Francia: la Germania ha bisogno dell’oro francese, l’Inghilterra che non ha eserciti stanziali, ha bisogno delle truppe francesi. Il governo francese è dunque arbitro della situazione: non dia a Guglielmo i denari, non dia a Giorgio V i soldati, e la pace sarà pressoché assicurata. Invece il governo francese negozia coll’Inghilterra una convenzione militare, e se essa sarà firmata, noi (i francesi) dovremo andare a farci rompere la testa nei piani del Belgio per assicurare alla gente di Londra il possesso d’Anversa, e saremo di colpo esposti ai pericoli d’un’invasione tedesca. […] Tra qualche settimana, forse, i finanzieri di Francia avranno venduto per qualche ferrovia turca od etiopica la pelle di centomila francesi. È il momento” – conchiudeva allora, nel 1911, il Delaisi – “è il momento per quanti non vogliono essere trattati come bestiame, d’aprire gli occhi, di considerare freddamente la situazione d’Europa e vedere l’intrigo pericoloso in cui l’oligarchia finanziaria si appresta a precipitarli”.
Ma le ragioni del conflitto anglo-tedesco?
“Una volta le nazioni erano popoli di contadini, ed era politica di contadini quella dei loro capi. I conflitti eran di frontiera; le guerre, di annessione o di conquista: Napoleone si annette il Belgio, Bismarck l’Alsazia e Lorena... Tutto è cambiato oggi. Le grandi nazioni europee sono governate da uomini d’affari: banchieri, industriali, negozianti, esportatori. Lo scopo di questa gente è di trovare uno sbocco alle proprie rotaie, ai propri coloni, ai propri capitali. […] Le nostre grandi oligarchie moderne non sanno che farsene dei sudditi, vogliono clienti. Gente d’affari, fa guerre d’affari”.
Così nel caso specifico.
“L’Inghilterra, un macigno di ferro su di un macigno di carbone, è stata durante tutto il XIX secolo la regina del mondo industriale. Aveva il minerale con cui le macchine si fanno, il carbone con cui si attivano, i mezzi di sviluppare un meccanismo industriale incomparabile, mentre il mare da cui è circondata le permetteva di sviluppare una marina senza uguali... era la padrona incontrastata del commercio mondiale”.
Riprodurre in esteso non mi è possibile: le proporzioni di questo studio ne andrebbero sconvolte, e queste considerazioni che della grande guerra, delle sue intime ragioni, dei suoi caratteri, non vogliono essere più che un riflesso sincero, più che un’analisi modesta in contrapposto delle epiche menzogne e degli orpelli fraudolenti con cui si raccomanda agli entusiasmi ed ai consensi della massa ingenua e tradita, diventerebbero eterne.
Condenso dunque del Delaisi fatti ed argomenti, sforzandomi di essere rigidamente fedele e di rendere sempre che torni possibile colle sue stesse parole il suo pensiero, i fattori ed i termini dell’antagonismo industriale che egli mette in rilievo e sul quale asside della guerra presente le cause determinanti, le ragioni irrecusabili.
Contro la britannica signoria del mare e del mercato internazionale, dopo la guerra franco-prussiana del 1871, sorge lenta inattesa quanto pertinace una rivale formidabile, la Germania, che Bismarck sospinge fuori dell’antico feudalismo terriero su per le vie, le conquiste, le audacie dell’industrialismo moderno il più evoluto: sulle rive del Reno, nella Westfalia, nella Sassonia, nella Slesia sorgono, come per incanto, cantieri, officine, arsenali; serpeggiano ferrovie e canali, rigoglia e canta la resurrezione mentre nei grandi porti di Brema e d’Amburgo s’organizza la più meravigliosa flotta mercantile che abbia mai solcato gli oceani a recare su tutti i mercati del globo i tessuti, le macchine, i prodotti chimici, i manufatti d’ogni genere dell’industria tedesca miracolosa. L’aquila del Kaiser contende alla croce di San Giorgio le vie, il secolare dominio dell’oceano.
Non v’è nulla d’esagerato o di fantastico nella vertiginosa ascensione avvertita dal Delaisi. Ne potete trovare la riprova nel censo della popolazione industriale eretta da Paul Louis nel suo “Syndicalisme Europeen”, sui dati ufficiali.
Nel censimento del 1907 la parte della popolazione che vive dell’industria conta per 26.386.537 unità contro i 20.253.421 del 1895, contro i 16.098.000 del 1882. La popolazione che vive del commercio e dei trasporti (sarebbe forse più esatto dire che fa vivere l’industria i trasporti i commerci) che era di 4.531.080 nell’anno 1882; che è di 5.966.846 nel 1895, sale nel 1907 ad 8.278.229; si è cioè duplicata nell’ultimo ventennio senza contare i tesori di energia che nella nuovissima attività economica della Germania ha versato la donna. Secondo il censimento eretto da Lily Braun i 4.408.000 di donne che erano in Germania occupate nel 1882 nei campi, nelle fabbriche, negli uffici, sono diventati 5.203.000 nell’anno 1895, sono otto milioni e duecentomila nel 1907; mentre nel complesso indice dello sviluppo impetuoso la popolazione di Amburgo aumenta nei cinque anni dal 1905 al 1910, del 17%, quella di Colonia del 19%, quella di Francoforte del 22%, quella di Essen del 27% , quella di Dusseldorf del 41%!
So, e non m’illudo: lo sviluppo nel mezzo, nello strumento di produzione finché ci arrovelliamo schiavi rassegnati od imbelli nel girone affannoso del regime borghese, il quale non ha altra funzione che di torcere, l’un contro l’altro armati ed irreconciliabili nella stessa persona, il produttore ed il consumatore, rinsaldando nella provvida contraddizione il dominio, la fortuna sua, i ceppi nostri più esosamente, il progresso rimane, peggio che vanità, tormento ed irrisione; siamo perfettamente d’accordo.
Ed io non amo mettere il nostro bravo compagno Kropotkin, ormai travolto dal suo dirizzone paradossale, in amara angustia con se stesso, chiedendogli se possa ripudiare questi dati di fatto su cui ha fermato altre volte la sua attenzione ed il suo consentimento, e se, questa condizione irrecusabile ammessa, egli possa ancora parlare di un feudalismo tedesco, di un imperialismo tedesco diverso e più temibile di quello che egli sperimenta personalmente da tanti anni in Inghilterra, l’Inghilterra delle Indie dell’Egitto del Transvaal, ed ha in più ristretto campo, nel campo esclusivamente finanziario militare, il suo fedele riscontro nella repubblica d’oltre Manica; e se proprio, a questo feudalismo industriale di cui tutto l’Occidente d’Europa, tutto l’oltremare americano sono oggi gli angosciati vassalli, sia preferibile il... feudalismo russo, ad esempio, rimasto nella Chiesa sovrana, nel privilegio aristocratico, nello squallore industriale; in pieno anno mille, insuperato; ed a fianco del quale egli, il recluso di Pietro e Paolo, il bandito perpetuo, il perpetuo candidato alle forche sante della santa Russia, viene a riconciliarsi, a schierarsi con tanto ingenuo ed inconsapevole entusiasmo.
Non gliene chiederò mai, anche perché sarebbe assolutamente superfluo.
Pëtr Kropotkin è in fondo perfettamente d’accordo con Paul Louis, con Francis Delaisi e colla “Cronaca Sovversiva” nel convincimento che lo sviluppo industriale e commerciale della Germania pervenuto al suo attuale parossismo non poteva non urtarsi violentemente nella concorrenza inglese, costituendo la più grave minaccia, la sola grave minaccia alla pace internazionale, il solo pericolo d’un conflitto che nessun intervento per quanto autorevole, nessuna corte arbitrale per quanto veneranda, sarebbero mai riusciti a dirimere, a placare, ad attenuare: il mortale duello che il vecchio mondo dilania e spaura di tanti primordiali selvaggi ritorni, ed oscura di tanta barbara eclissi l’orizzonte remoto della civiltà e della libertà; e del cui losco antagonismo fondamentale diremo anche più lungamente in seguito.
Urla oggi nella parola smarrita e sorpresa, di Pëtr Kropotkin l’eco d’una voce che non è la sua, rugge negli impeti del suo effimero entusiasmo la bufera dell’universale insania.
Sulle inutili stragi, sugli sgomenti, sui singulti tardi del domani, tornati al covo i corsari, nel disperato silenzio, nella tregua morta dell’esangue passione, troverà egli i segni, i lividi segni della realtà desolata ed acerba; e rotta la maglia d’aberrazioni, di perfidie che oggi l’avviluppa e lo soggioga, dolente d’un più amaro disinganno ma cinto d’una vasta, più tragica esperienza, in fronte alle schiere obliate tornerà araldo, maestro e guida.
Troverà immutati, ardenti, fedeli gli animi liberi ed i cuori buoni, insorti ribelli ingrati oggi alle sue inaspettate esortazioni.
Oggi, no. Squilla più poderosa della sua, sommergendone le smarrite esortazioni, la voce brutale della realtà.
I cantieri le fabbriche le officine che d’ogni valle trasognata rompono i silenzi ignavi, che nelle vecchie città patriarcali ansano affannose l’inno della resurrezione, e vi addensano turgide inviolate le energie dei servi della gleba, e vogliono intorno – ordito necessario di vene e di arterie – canali ferrovie e navi che d’ogni piaggia esotica portino i frutti della terra e degli armenti, ed ai quattro orizzonti disperdano insieme col nome e colla gloria della grande patria tedesca, le dovizie accumulate dall’inesausto fervore; e vogliono, pietre miliari dell’ascensione trionfale, arsenali ed armate che ne assicurino il ritmo e la fortuna, rimangono della guerra la fonte e la ragione.
La ragione involontariamente confessata: “Noi avremo fra 10 anni una popolazione di ottanta milioni di abitanti i quali, nell’ambito degli attuali confini de l’impero, non riusciranno più a trovarsi lavoro rimunerativo, se non avremo la rete di colonie che oggi, salvo qualche trascurabile eccezione, ci mancano. Ed, anche, oggidì, è ammissibile che sessantacinque milioni di tedeschi, il loro commercio con tutto il mondo, rimangano alla mercé di quarantacinque milioni d’inglesi, e ad essi consentano la tutela del vecchio mondo, la supremazia del mare?” si domanda il generale Von Bernhardi il quale – smessa la durindana ed il morione del don Chisciotte che sul genio su la coltura su la superiorità della gente tedesca, di cui si era istituito araldo e cavaliere, raccoglievano più beffe e più torsoli che non el ingenioso hidalgo de la Mancha – si è deciso a dirci in linguaggio meno cavalleresco ma meno astruso l’angoscia che rode nel suo paese i grandi ladri, ed a mostrarci dietro i mulini a vento d’un nazionalismo smaliziato la realtà degli interessi che vogliono sul mercato la precedenza e nel grande strozzinaggio internazionale la loro parte di bottino.
“E la conclusione, la sola conclusione che possa rispondere a questo antagonismo d’interessi e riassumerne il furore, non può essere se non quella che egli ne trae:
“Una guerra tra la Germania e l’Inghilterra è inevitabile. L’Inghilterra ha il maggior interesse a scatenarla quanto prima può”... e d’altronde “la nostra aspirazione ad un più vasto posto nel mondo ci porterà sicuramente ad una guerra come quella dei Sette anni, nella quale saremo certo vittoriosi quanto l’eroico re di Prussia” . (“Il nostro avvenire” nella traduzione di J. Ellis Barker, “Boston Sunday Post”, 13 dicembre 1914).
Le previsioni della vittoria finale lasciamole da banda. Sono così inseparabili dagli stipendi dagli orgogli dalle responsabilità del guerriero professionale che nessuno saprebbe farne caso: un generale tedesco non può arrischiare previsioni malaugurate; non ne ha l’interesse il coraggio la libertà. È interessante invece rilevare la parte fondamentale delle dichiarazioni del generale von Bernhardi: l’esercito tedesco, la marina tedesca non hanno altra missione che di assicurare uno sbocco all’industria tedesca, le vie del mare ed i mercati del mondo all’industria ed alla finanza tedesca.
Ed è denunciata con tanta cinica brutalità che davvero non si comprende come il buon Kropotkin abbia potuto trovare nel vassallaggio politico dell’Alsazia-Lorena le scaturigini e le ragioni degli armamenti tedeschi e, non so bene, qual sogno di feudali propositi alla guerra attuale; nella difesa della repubblica o del costituzionalismo inglese le preoccupazioni di civiltà e di libertà per cui ci vorrebbe coscrivere in servizio degli alleati. L’Alsazia? La Lorena? Ma i capitalisti repubblicani non le rivogliono. Nota bene il Delaisi, che a Mulhausen si sono sviluppati lanifici, cotonifici, acciaierie così poderosi che contro la loro fecondità si sono dovute in Francia escogitare le più severe protezioni doganali, e che tornate francesi, quelle officine farebbero tale concorrenza alle officine del Creusot, alle filande dei Vosgi, di Lille, di Rouen da portare un disastroso turbamento in tutta l’economia dell’industria nazionale.
Ci spieghiamo ancora meno la cantonata del Kropotkin che nel suo ultimo studio su “La Guerra” egli mostra d’aver attinto ad un’opera che or sono sei anni ha suscitato in Francia le più legittime inquietudini. È un grido d’allarme alla borghesia francese, Contre l’Oligarchie Financière, contro un pugno di banditi della Borsa che mentre soffocano nei loro tentacoli insaziati l’industria paesana mettono le enormi riserve del risparmio francese in servizio dell’industria straniera.
Chi ha dato l’impulso meraviglioso all’industria tedesca oggi insuperata, incoercibile? Chi le rinnova il sangue nelle vene affaticate se non l’oligarchia finanziaria repubblicana che pur di far quattrini venderebbe al Kaiser la Francia e la Repubblica settanta volte e sette?
“La politica delle nostre grandi banche non soltanto antidemocratica, è antinazionale... La Banca di Parigi e dei Paesi Bassi conchiude un prestito con lo Stato di San Paolo, Brasile. Il prestito è destinato al riscatto delle strade ferrate. I francesi sottoscrivono, i tedeschi raccolgono le ordinazioni del materiale mobile e delle linee... Sul mercato di Parigi s’introducono le azioni della Banca Commerciale Italiana. Che cosa è la Banca Commerciale Italiana? È un istituto fondato dalla Deutsche Bank, dalla Dresdner Bank, dalla Disconto-Gesellschaft, una banca tedesca insomma che ha per scopo di finanziare commercialmente la Triplice e conquistarle il mercato italiano... La Compagnia Francese delle Miniere d’oro... conchiude una alleanza colla Metallgesellschaft di Francoforte per smerciare in Francia i titoli tedeschi. Sui primi del 1908 la Banca Unione Parigina prende parte alla costituzione d’una società di carbone nella Lorena tedesca con un capitale di diciotto milioni di marchi. La finanza francese ne dà per otto milioni. Il Credito Industriale e Commerciale costituisce il primo ottobre 1905 a Colonia la Società Anonima Tedesca dei Carboni col capitale di quattordici milioni di marchi... Ma su questo terreno dell’antinazionalismo delle banche francesi v’è di peggio... Una parte considerevole del denaro depositato negli istituti francesi di credito è prestato in modo permanente alle banche tedesche e serve di fond de roulement al commercio ed all’industria tedesca... Non imprecate, non dite che non sia vero, non dite che è impossibile. Precisiamo. Tra le grandi banche tedesche e quelle francesi v’è una convenzione scritta, un vero e proprio trattato d’alleanza, ai termini del quale le banche francesi forniscono alle banche tedesche capitali liquidi: le banche tedesche danno a quelle francesi delle cambiali a tre mesi, che non pagano alla scadenza ma rinnovano ogni trimestre col pagamento dell’interesse supplementare... Che è quanto dire: le banche francesi accordano alle banche tedesche un credito a lunga scadenza che negano all’industria francese. Non soltanto le banche tedesche non rimborsano alla scadenza, ma chieggono nuovo denaro. Nel 1900 i capitali francesi a disposizione delle banche tedesche raggiungevano il miliardo e mezzo. Nell’ottobre del 1906 le banche di Berlino hanno mandato a Parigi per avere nuovi crediti... Alla sola Deutsche Bank, il Crédit Lyonnais ha prestato trecento milioni di franchi. La Société Générale, le Crédit Industriel et Commercial, l’Union Parisienne hanno depositi considerevoli a Berlino. La statistica dei prestiti francesi alle banche tedesche raggiunge una cifra inconfessabile”. (Lysis [E. Le Tailleur], Contre l’oligarchie financière en France, Paris 1908, p. 191-192).
Se Pëtr Kropotkin dovesse pei lettori della “Cronaca”, profani ai misteri dell’alta finanza tradurre in lingua volgare il significato e la portata di queste operazioni di borsa, direbbe semplicemente che i banchieri francesi, quelli che oggi hanno nelle mani le redini della repubblica, adoperano i piccoli risparmi dei lavoratori, delle domestiche, dei minuti bottegai della Francia, ad affamare il proletariato francese, ad ingrassare gli accaparratori, gli sfruttatori, i negrieri del proletariato tedesco.
Non potrebbe dirvi altrimenti, anche se le sue esortazioni alla difesa proletaria della repubblica dovessero andarne decapitate.
– Ma se i capitalisti francesi, come dite voi, hanno a Berlino, ad Amburgo, a Dresda, a Francoforte così prospera vigna ai subiti guadagni, così fruttifero campo alle loro speculazioni, perché la guerra tra la Francia e la Germania che la vendemmia devasta di irrimediabili rovine?
– Anzitutto i borghesi, i capitalisti, i grandi finanzieri si rivalgono largamente in patria – la guerra aiutando – dei rovesci patiti oltre confine. Ad allestire un esercito, a mobilizzarlo e tenerlo per qualche mese, per parecchi anni alla frontiera, in guerra, occorrono grani e foraggi, scarpe e coperte, cavalli, automobili, aeroplani, armi e munizioni, forniture improvvise e continue di milioni, di miliardi su cui la speculazione si esercita senza misura, senza limite, senza controllo; poi, come è già avvenuto in Germania, in Inghilterra, in Francia, in Austria, in Italia, sono i prestiti che si numerano a miliardi, i prestiti che i grandi istituti di credito fanno coi depositi dei poveri diavoli raccattando commissioni, senserie, realizzando guadagni paradossali; poi domani, dopo i primi disastri come dopo l’epilogo finale, sono le dreadnought da ricostruire, gli armamenti da rinnovare, le artiglierie da rifare, le riserve e le fortificazioni, tutto l’esercito da rifornire, l’armata a riedificare.
È la ridda folle dei miliardi, dei miliardi che si e-storceranno ancora, sempre e soltanto dalla fatica, dal sangue, dai sudori, dai digiuni dei bastardi, a ritessere della patria più grande, la porpora ed i vessilli, a rifare agli sciacalli la preda, l’orgia, la boria.
Chi grida: “Viva la guerra?”.
Coloro che alla guerra non vanno, che alla guerra non hanno nulla da perdere, che alla guerra hanno tutto da guadagnare.
Chi sente più acre la prurigine degli orgogli l’impeto delle rivendicazioni della patria e della stirpe?
Coloro che della patria ignorano i cimenti, le gesta, le glorie; coloro che della stirpe irrisero al calvario eroico, contesero in ogni tempo l’ascensione civile servendo al Papa ed al Sant’Ufficio, all’Austria ed alle forche, al giallo Carignano avantieri, quando buttava il capestro a Garibaldi ed a Mazzini, al Padre della Patria ieri quando su pel Golgota dell’Aspromonte nelle carni del Duce dei Mille straziava il sogno di Luciano Manara e di Goffredo Mameli, ad Umberto il Buono quando su la rivoluzione italiana debellata agognava alla restaurazione delle “ordinanze” e dell’antico regime mitragliando per le vie di Milano i superstiti delle Cinque Giornate, i continuatori della redenzione; e l’indomani di Gibilrossa, l’indomani del Volturno o di Lissa si facevano liquidare dai nuovi padroni in regie chincaglie ed in moneta sonante i trenta scicli dell’Iscariota, l’eroismo della sesta giornata; coloro che la patria concepiscono sotto la specie commestibile del pane e del vino, coloro che la patria hanno nella cassa forte e ad impinguarla venderebbero insieme col natio loco i loro penati, gli indigeti, il padre e la madre; coloro che della patria sono stati in ogni tempo l’onta, l’obbrobrio, la rovina, e la stirpe tennero e tengono in ispregio ed in vassallaggio.
La guerra è, come la pace, la loro cuccagna.
D’altronde – e l’abbiamo esaurientemente documentato nel corso di queste nostre modeste considerazioni attingendo alle testimonianze più diverse e meno sospette – più che nei rapporti tra la Francia e la Germania, le ragioni della guerra debbono ricercarsi nei rapporti fra la Germania e l’Inghilterra, negli antagonismi irriducibili fra i banchieri, gli industriali, i mercanti dei due paesi; apparendo manifesto, anche a chi osservi superficialmente, che la Russia non costituisce fino ad ora nell’arringo industriale, commerciale, finanziario, un concorrente temibile per nessuno, e che la Francia ha cessato di esserlo da gran tempo.
Non i termini, ma la necessità istessa della competizione, sono in quei rapporti, in quell’antagonismo, come illustra, meglio forse d’ogni cifra e d’ogni considerazione questo lamento di un console britannico in Siria: “Una volta tutti i prodotti europei smerciati qui venivano dall’Inghilterra, oggi vi scrivo con una penna tedesca, su carta tedesca, su uno scrittoio fabbricato in Germania; e tra poco d’inglese non rimarrà qui che il vostro rappresentante umilissimo”.
Era l’evizione violenta, rapida, inesorabile. I rimedi doganali di [Arthur] Chamberlain non apparivano soltanto inefficaci e tardivi, ma si urtavano all’insurrezione decisa del proletariato inglese, così come gli appelli di Lord [Frederick] Roberts alla coscrizione, alla necessità immediata del servizio militare obbligatorio, si abbattevano sterili, inascoltati contro l’unanime repulsione dei lavoratori inglesi.
Bisognava raccomandarsi al cannone, trovare coi sapienti raggiri diplomatici nazioni a tradizione, ad organizzazione e a preparazione militare così antica così salda così densa che potessero sul continente fronteggiare gli eserciti tedeschi, ed allestire un’armata che agli scopi economici della guerra, alla distruzione dell’industria e del commercio tedeschi, provvedesse fin dal primo giorno dell’entrata in campagna.
Furono le grandi dreadnought, che, bloccando il canale della Manica ed il Mare del Nord, contendono ai porti di Brema e di Amburgo il ferro che viene dalla Spagna, il cotone che viene dagli Stati Uniti, le lane che vengono dal Capo, dall’Argentina e dall’Australia, che negano all’industria tedesca l’alimento ed il sangue di cui vive, che le tolgono di esportare i prodotti propri, e la costringono al fallimento disperato ineluttabile, mentre sola, padrona oggi delle vie dell’oceano, l’industria inglese raccoglie le ordinazioni, coscrive la clientela che in trent’anni di sforzi e di progresso meraviglioso gli industriali tedeschi si erano accaparrata.
Il “Vorwärts!”, l’organo ufficiale del partito socialista tedesco mostrava d’aver limpida la visione di queste immediate conseguenze della guerra quando, nel suo numero del 12 settembre scorso, era costretto ad ammettere che “pericolo più grande della disfatta militare era per la Germania il prolungamento delle ostilità. Per la Germania il grande pericolo è nella possibilità che la flotta inglese riesca ad impedire l’importazione del cotone, della seta, del rame, dell’olio, del piombo, dei pellami, delle gomme, delle materie prime che sono indispensabili alla continuazione della sua vita industriale; e che essa sia costretta a chiudere le proprie officine”.
Ed a conferma delle melanconiche previsioni del “Vorwärts!” il Ministro del Commercio e Lavoro di Washington compendiava il 25 settembre scorso in una prima statistica le subitanee depressioni che la guerra, la quale non durava che da un paio di mesi, aveva determinato nelle importazioni e nelle esportazioni. Pel solo mese d’agosto e per l’America del Nord, le esportazioni tedesche che nel 1913 avevano attinto un complessivo di dollari 21.301.274 si riducevano nell’agosto del 1914 a dollari 68.737; e, sempre e soltanto pel mese d’agosto e per l’America del Nord, le importazioni tedesche che nel 1913 sommavano a un totale di dollari 15.626.176 si riducevano nell’agosto del 1914 a 9.400.043. Queste ridotte della metà quelle annichilite completamente fin dall’agosto scorso; ora, nulle od irrisorie l’una e l’altra.
Mettete sul conto i risultati dell’atroce guerra di corsa in cui gli incrociatori tedeschi nell’Atlantico e nel Pacifico, quelli inglesi in ogni mare, in ogni stretto, sotto ogni latitudine ansano alla caccia dei piroscafi, dei postali, dei trasporti della pacifica rivale flotta mercantile, meno per amore di preda o di bottino che di distruzione dei rispettivi mezzi di scambio, e negate poi che la guerra – esule disperatamente ogni preoccupazione di libertà, di civiltà, di progresso – non sia una feroce competizione d’usurai nella quale la Francia democratica e repubblicana, la Russia assolutista e medioevale, oggi, domani l’Italia né carne né pesce, sono chiamate a far da lanzichenecco, a far da svizzero ai borsaioli di Londra, ai corsari d’Inghilterra, così come il proletariato tedesco, austriaco o turco è chiamato – esule ogni senso di progresso e di libertà, ogni coscienza della propria forza e del proprio destino – a farsi massacrare pei grandi pirati, pei grandi affamatori pei grandi assassini della borsa di Berlino, della Deutsche Bank o del Krupp raccolti come lupi in agguato alla voce ed alle spalle del tragico istrione imperiale.
Ma nell’attuale conflitto, Pëtr Kropotkin vede, particolarmente designato dalla storia, accanto agli alleati, il posto dei lavoratori, degli uomini italiani di libertà; e questa sua presunzione richiederà ancora un commento.
Secondo Pëtr Kropotkin gli Italiani hanno verso la Francia un particolare debito di gratitudine ad assolvere, hanno colla Germania un vecchio conto di tradimenti e di raggiri da liquidare: la Francia è accorsa in aiuto dell’Italia quando la patria nostra si batteva con eroismo disperato per l’indipendenza, l’unità, per la propria liberazione, mentre la Germania di Guglielmo I insieme colla Russia di Alessandro II sulla Francia, “a causa dei suoi sforzi per liberare l’Italia” rovesciava tutto il suo odio, ed agli italiani stessi quando “nel 1860 mandarono via i dominatori austriaci di Firenze, Parma e Modena, e Firenze divenne la capitale d’Italia” così non fece mai mistero della sua ostinata, implacata opposizione.
Il momento di liquidare la doppia partita scocca ora, ed intorno alla situazione dell’Italia non può essere equivoco: deve schierarsi per la Francia contro la Germania.
Se venisse da un altro, dagli storici del calibro di Luigi Cibrario o magari di Guglielmo Ferrero, da quanti, nel girone del cinquantenario dei fasti e dei nefasti dell’ultima rivoluzione italiana attingono nelle cronache auliche e nelle apologie cortigiane salariate, il richiamo non ci stupirebbe più che tanto; ma da Pëtr Kropotkin che ci ha dato nella Grande rivoluzione la misura delle sue attitudini magnifiche alla critica ed all’indagine storica, noi abbiamo diritto ad una meno temeraria interpretazione dell’epopea nazionale.
Della quale non tenteremo qui, neanche nelle sue grandi linee, la ricostruzione, sia perché della presente discussione essa non è che un episodio, sia perché non lo consentono i limiti di questo studio modestissimo.
Noi vorremmo soltanto che il Kropotkin si rifacesse un momento agli uomini di libertà del periodo storico a cui accenna, ad uomini cui si può tutto contendere fuorché l’amore immenso della patria, fuorché la sincerità della fede cresimata dal sangue dal sacrificio dal martirio, ad Alberto Mario od a Giuseppe Mazzini, ad esempio, sicuri che egli sorprenderebbe nelle ansie, nei dubbi, nelle rivolte, in tutto il pensiero di quegli edificatori della patria italiana, non soltanto lo spirito animatore dell’ultima rivoluzione, ma schietto e limpido il carattere dei rapporti tra il popolo d’Italia anelante all’indipendenza ed all’unità coi suoi nemici di fuori... e di dentro.
Non ci farà Pëtr Kropotkin l’ingiuria di crederci nemici della Francia, e noi non gliene offriremo il pretesto riabilitando – da Carlo Magno che or sono undici secoli gittava in Roma le fondamenta ed i presidi del potere temporale dei Papi, ai preliminari di Leoben od al trattato di Campoformio che ai boia d’Asburgo consegnavano, legata piedi e mani, la più generosa delle popolazioni italiane – le acide irose querimonie dei misogalli tradizionali. Non lo rimanderemo neanche al “Moniteur”, ai resoconti parlamentari della tempestosa seduta del 7 marzo 1849 in cui la sinistra repubblicana chiedeva che fosse posto in istato di accusa il ministero Odillon Barrot il quale, autorizzato dal parlamento a proteggere in Roma la libertà italiana, mandava il generale [Nicolas] Oudinot a Civitavecchia “a far da cosacco alla repubblica romana” come denunziava dalla tribuna Etienne Arago, “a restaurarvi il papa” come deplorava scandalizzato, ed è tutto dire, Jules Favre.
Napoleone il piccolo nel suo messaggio del 12 novembre 1850 chiariva come si intendesse nella Francia dei Bonaparte la difesa della libertà repubblicana della terza Roma: “A Roma le nostre armi hanno abbattuto quella demagogia turbolenta che aveva compromesso la causa della vera libertà in tutta la penisola italiana; e i nostri bravi soldati ebbero l’insigne onore di rimettere Pio IX sul trono di S. Pietro”.
Non abbiamo interesse a rovesciare sugli altri colpe e vergogna che sono di casa nostra, in istrazio di una verità che soffocata allora violentemente, ed anche oggi, con ogni più subdolo raggiro, con ogni più compassionevole pretesto contrastata, ha fatto soverchio cammino oramai perché nella fede di uomini come Pëtr Kropotkin non trovi ospitalità e cittadinanza.
E la verità è questa: che i contrasti, gli ostacoli peggiori all’indipendenza ed alla unità italiana non vennero ai patrioti della prima ora, dell’ora tragica in cui l’amore alla patria si scontava colla forca, dalla Germania o dalla Russia o dalla Francia; ma dai Savoia, ma dagli uomini di Stato piemontesi per cui ogni pensiero, ogni atto, ogni passo all’affrancamento delle Province italiane dal gioco dei Borboni o del Papa, degli Asburgo o dei Lorena era delitto se nella generosa temerità non portasse sottinteso od esplicito l’assenso preliminare alla nazionale investitura sovrana di Vittorio Emanuele II. Ond’è che, prima di essere contrasto violento di patriotti e di stranieri, l’epopea nazionale è lotta acerba, implacata tra coloro che, ripudiata ogni sordida ipoteca, vogliono franca la patria nei suoi confini storici, e quelli che vogliono la conquista piemontese dell’Italia; tra quelli che l’indipendenza vogliono assicurata sullo sbaraglio delle tirannidi piovute esoticamente d’oltr’alpe come di quelle cresciute e vivaci all’ombra delle patrie forche, e coloro che mossi soltanto dalla libidine e dalla cupidigia e dalla rapina, al basto ed al bastone tedesco volevano sulle reni del buon popolo d’Italia adattare e sferrare ugualmente esoso ed atroce il basto loro, il loro bastone.
Paterino, avventuriero o brigante chi osasse l’impresa scellerata: meglio in Sicilia il Borbone che Garibaldi, meglio a Roma il Papa ed il potere temporale che la repubblica di Saffi e di Mazzini, meglio l’Austria a Venezia che le camicie rosse nel Trentino, ed un autorevole giornale italiano di parte moderata (Spectator nell’“Illustrazione Italiana” dell’ottobre 1914, p. 318) così si compiaceva giorni sono di ricordare le parole che Camillo Cavour ripeteva al gran re in Bologna il 2 maggio 1860, tre giorni avanti la partenza dei Mille da Quarto: se non ci va nessuno a prendere Garibaldi pel colletto ci vado io; e con maggiore soddisfazione le parole con cui Visconti-Venosta inaugurava in Roma la prima seduta del parlamento italiano: “Noi non siamo venuti a Roma né con la rivoluzione né al seguito suo, ma prevenendola. Noi vi vogliamo rimanere, non colla rivoluzione ma con uno spirito di libertà e di considerazione larga e tollerante che intende di garantire al pontefice il diritto e la libertà delle coscienze e di assicurare al pontefice il rispetto in condizioni tali che alcun altro paese non glie ne possa offrire né di più sicuro né di più degno”. (Ib., 6 dicembre 1914, p. 479).
Erano la rivoluzione Giuseppe Garibaldi che levando a Palermo la bandiera “Italia e Vittorio Emanuele” non era riuscito a disarmare le diffidenze e le paure della camorra sabauda, Giuseppe Mazzini esule nella patria della cui indipendenza ed unità era stato il confessore l’araldo il milite della prima ora, di tutta la vita intemerata e gloriosa.
Il liberatore brecciaiolo era Vittorio Emanuele II di Savoia al quale era mancato sui gioghi dell’Aspromonte l’onesto proposito di assassinare Garibaldi sulla via di Roma, ma d’accordo colla Francia di Napoleone, cui aveva denunziato le mene rivoluzionarie di Garibaldi, i lividi odi pinzoccheri aveva potuto saziare nelle stragi garibaldine di Monterotondo, di Villa Glori e di Mentana.
Il contrasto era naturale come era naturale e logica la diffidenza degli elementi democratici verso l’intervento francese nelle cose d’Italia.
Sia tradizione dei liberi comuni, orgoglio delle sue vecchie repubbliche gloriose, sia coscienza istintiva della varietà etnica dei suoi elementi costitutivi, complicata dalla eccentricità geografica delle sue regioni, la gente nostra – nella cui storia la tradizione monarchica, eccezione fatta per la Sicilia, ha soluzioni violente e frequenti di continuità – non poteva concepire che in senso repubblicano la ricostruzione nazionale, e codesta aspirazione non poteva non abbattersi irreconciliabile sull’egemonia piemontese.
E questa, cui mancava il suffragio della fiducia e della cooperazione popolare, doveva necessariamente cercare allo straniero, a Napoleone Bonaparte, alla Francia, come scrive Kropotkin, l’aiuto che in patria non trovava.
Pëtr Kropotkin non ispenderà certo una parola in difesa dell’uomo del 2 Dicembre, e comunque giudichi l’opera sua non mi dirà certo che fosse un uomo da preoccuparsi della indipendenza d’Italia, se non in quanto in Italia potesse realizzare la mal celata ambizione di rifare ai napoleonidi dispersi dalla restaurazione i regni di Etruria o del Napoletano.
“L’alleanza della Francia col Piemonte rende irrisoria l’efficacia della volontà nazionale, turba negli italiani la coscienza di sé e dei loro doveri, li ha resi immemori del loro decoro”, scriveva Alberto Mario nell’ottobre del 1859; e soggiungeva: “Prima di quell’alleanza l’Italia era dominata dall’Austria, dopo si trovò in balia ad un tempo dell’Austria e della Francia. Due imperatori se la contendono; l’austriaco vuole il corpo, il francese l’anima...; e la dipendenza morale... è modificata da cinquantamila soldati che dio sa se e quando rivalicheranno le Alpi”.
E non si nascondeva affatto le intenzioni dell’Imperatore dei Francesi.
“Napoleone III è un imperatore in embrione: possiede la corona senza le gemme, e le cerca. Napoleone zio le ha trovate per primo e della miglior acqua in Italia: il nipote... calò in Italia a ripescarvele, smarrite nel 1815. Lo zio le ha incastonate di sua mano nella corona d’oro senza cerimonie, il nipote lascia questa cura ai compatrioti di Benvenuto Cellini orafo. Più tardi impareranno l’arte anche i Napoletani”.
Il “Moniteur” del 28 settembre 1859 sentiva l’obbligo di rassicurare gli italiani; ma la malleveria del “Moniteur” era negli impegni di Villafranca e nella parola del boia del 2 Dicembre.
Più brutale il Mazzini, a cui pure ogni forma di violenza ripugnava: “Quell’uomo”, – scriveva da Londra nel 1858 – “è l’assassino di Roma; ei vi mantiene senz’ombra di diritto un esercito, quasi avamposto ad incarnare un giorno disegni di grandi ambizioni; ei cospira celatamente a prò di una insurrezione Muratiana a Napoli...”.
E del conte Camillo di Cavour, cui l’intervento si doveva, smascherava i subdoli avvolgimenti gridando sdegnato: “Noi crediamo nella iniziativa del popolo d’Italia, voi la temete, e vi studiate d’allontanarla... Noi vogliamo che il paese, sorto una volta che sia, scelga libero la forma di istituzioni che dovrà reggerlo; voi negate la sovranità popolare e fate della monarchia una prepotente condizione d’ogni aiuto nell’impresa. Noi cerchiamo i nostri aiuti fra i popoli che hanno con noi comunione d’intenti, di dolori, di lotte, voi li cercate fra i nostri oppressori, fra i poteri deliberatamente, necessariamente contrari alla nostra unità. Noi consacriamo tempo, mezzi, anima, vita a persistere in una guerra che attraverso una serie inevitabile di sconfitte educa il nostro popolo a combattere... voi consacrate tempo, mezzi, politica ad attraversarci la via, a perseguitarci dovunque... a denunziarci alle polizie dei governi assoluti...”. (Mazzini, Politica ed Economia, Milano 1896, vol. II, p. 184).
Si potrebbe abbondare, ma ci pare che bastino le sommarie citazioni precedenti a persuadere il Kropotkin che, se proprio è soggiogato da questo suo democratico ritorno ai simboli collettivi, è giustizia essere più esatto, parlare cioè della alleanza dell’Impero colla Monarchia del Piemonte, ed assolverci dal debito di gratitudine come italiani, anche senza pensare ai compensi territoriali che allora all’Impero furono pagati, anche senza approfondire i reconditi fini per cui l’ultimo Bonaparte aveva, in aggiunta al presidio di Roma, portato in Italia tante legioni di fanti e di cavalli. E senza ricordarci sopratutto i disastri del 1866, voluti dal conserto proposito di Napoleone e di Vittorio Emanuele ad impedire che la Prussia ruinando da Sadowa a Vienna diventasse fin d’allora la terribile Germania che doveva quattro anni più tardi cingere a Versailles la corona imperiale.
Senza fermarci al 1866 che segna il più torbido e fosco raggiro di cui si adombri la storia italiana degli ultimi cinquant’anni, ed il tradimento più infame di cui si sia macchiata la dinastia savoiarda in cui il tradimento e la vigliaccheria sono tradizione e storia; tradimento insieme delle più fervide speranze italiane, e dei soli alleati da cui potesse, da cui abbia realmente avuto la causa dell’indipendenza italiana efficacia vera di cooperazione e d’aiuto.
A Custoza e a Lissa volute, imposte dalla paurosa complicità del Bonaparte e del Padre della Patria perché l’Austria avesse man franca contro il suo nemico del Nord, non la Germania ha tradito l’Italia, buon amico Kropotkin, se non faccia velo alla tua serenità la disgraziata crisi del sentimento, ma Vittorio Emanuele e Napoleone III hanno tradito la Germania e l’Italia.
Noi ce ne appelleremmo alla tua lealtà della quale non abbiamo dubitato mai, della quale non dubitiamo neanche ora che i nostri nemici ti inalberano contro di noi rampogna tanto più dolorosa che essa è immeritata, se intorno a cotesto superato momento di storia la discussione avesse altro valore che di chiarire una trascurabile contingenza.
Perché se nell’episodio storico della polemica ci siamo indugiati, le denominazioni astrattamente collettive e simboliche di Francia di Germania di Russia di Austria d’Italia, che per un momento ti abbiamo rubato, non rimangono della polemica se non un espediente che non infirma né intende emendare in alcun modo la impenitenza nostra a distinguere, sotto il velame fraudolento dell’unità etnica, la doppia patria di chi opprime e di chi è oppresso, di coloro che creano nella pena sotto la croce della sanguinante passione, e coloro che nell’ignavia fanno cinico strazio del sangue e del sudore proletario; e noi persistiamo a ritenere che la guerra comunque s’accenda, dovunque imperversi, sia la forma più sciagurata di quella collaborazione di classe contro la quale con ogni tua parola, colla parola e coll’esempio, con ogni tuo gesto, col meraviglioso fervore della tua giovinezza superstite ad ogni strazio ad ogni lusinga a tutte le insidie corrosive agli anni, hai risvegliato diffidenze e disdegni, proteste e rivolte, suscitando fra gli umili di ogni terra da Angiolillo a Bresci, da Vaillant a Masetti, nell’olocausto, la nostalgia della giustizia e della rivoluzione sociale.
Dopo di averci asciugato stilla a stilla il sudore d’ogni fibra come a dannati, nelle miniere, nelle officine, nei cantieri, in tutti i suoi bagni industriali il sangue ed il sudore, la borghesia ci chiede nelle ecatombi paradossali sulla Vistola e sul Reno l’estrema salvezza dal fallimento che contro il suo regime abbominevole ha inesorabilmente pronunziato il tribunale della ragione maggiorenne, della ragione inesorata.
Vi sapremmo tanto meno indulgere che quelli che vorrebbero essere nel tuo linguaggio i termini di un sillogisma si riducono ad una deplorevole ambiguità, per non dire ad un’obliqua inversione.
Alla Francia di Diderot, di Voltaire, di Beaumarchais, alla Francia della Rivoluzione, della Dichiarazione dei Diritti, della Comune, tu poni, antitesi irreconciliabile, la Germania medioevale del diritto divino del Kaiser, del Krupp, invocando per quella le braccia, le armi degli uomini di libertà, dell’internazionale proletaria, conclamando su la seconda la distruzione e la morte necessariamente.
La logica non è che apparente; navighiamo in pieno sofisma, in un equivoco sciagurato.
Alla Francia di Lamarck e di Pasteur, alla Francia dell’Enciclopedia e della libertà, non devi tu logicamente, onestamente opporre la Germania di Goethe e di Schopenhauer, di Lassalle e di Marx, di Wirchow, di Haeckel, di Kock?
Ed alla Germania del Kaiser, del diritto divino, del Krupp non trovi tu la Francia corrispondente delle Congregazioni, dello Stato Maggiore, dello Schneider, del Comptoir National d’Escompte che ieri rinnovava le Sanbartolomeo dell’antisemitismo domenicano ed oggi gioca in Borsa il sangue dei lavoratori massacrati a Ypres?
Ristabiliti equamente, logicamente i termini contraddittori della tua proposizione non potresti più chiedere, certo, le simpatie libertarie per codesta Francia, la sola che, come la Germania dall’altro lato del Reno, abbia voluto la grande guerra, la triste guerra che non dobbiamo sorreggere anche se non l’abbiamo saputa evitare; ma non ne trarresti tu, il fratello nostro più grande e più caro, nell’angustia di questi giorni, al morso della coscienza – che alla follia travolgente dell’ora insana può indulgere, ma non è morta e non dimentica e riprenderà domani intiero il proprio dominio – tu che raccogli sotto ogni cielo, in ogni cuore, tanta sincera confidenza, così profondo affetto di umili, la forza di dire ai proletari di qua e di là dalla frontiera: nelle vostre mani incallite sono i destini della civiltà e del progresso, tra i lavoratori del mondo ha il suo rifugio inviolato la civiltà che non guarda alle bandiere, alle frontiere, alle livree, agli idiomi, sterpi effimeri, barriere fugaci sotto l’agile piede, sulla via luminosa, dinnanzi al progresso incoercibile; non l’abbandonate, non la precipitate sotto le zampe ferrate degli ulani o dei dragoni o dei cosacchi, non la prostituite ai giocatori di borsa che ne conieranno moneta o ritorte, moneta per sé, ceppi per voi; opponete alla coalizione degli oppressori e degli sfruttatori la coalizione degli oppressi e degli sfruttati, e nel girone ardente della patria frontiera affogate il nemico secolare, il comune nemico per sempre, per la salvezza vostra, per la salvezza di tutti! Vox clamantis in deserto?
Dal Battista della leggenda all’ultimo fucilato di Montjuich è nelle voci clamanti nel deserto l’auspicio dell’avvenire.
Luigi Galleani
[Otto articoli pubblicati su “Cronaca sovversiva”. Dal 7 novembre 1914 al 2 gennaio 1915]
Da Ravachol a Barrère
Il fulmine di Serajevo mandò all’aria le mie vacanze. Oggi sembra di pensare a un altro mondo. Quanti secoli sono passati? Non è tanto la quantità quanto la qualità del tempo trascorso. Metamorfosi di uomini, grandezze improvvisate sull’infamia e poi precipitate nel sangue e nel fango, amicizie lacerate, urti asprissimi, raffinate insidie, raggiri d’ogni specie, fede e sacrifizi senza fine in pochi!
È difficile rievocare lo scompiglio che si manifestò in tutti i movimenti di sinistra al crollo delle illusioni sulla azione rivoluzionaria del proletariato innanzi alla guerra, mentre uomini, più vecchi e più addottrinati di noi, e che noi amavamo, ci lasciavano soli a difendere princìpi che tanto più avrebbero dovuto affermarsi quanto più il mondo nemico era interessato a seppellirli.
Che avrebbe fatto l’Italia?
In un primo tempo la coalizione che si era formata nella Settimana Rossa, si trovò concorde nell’idea della “neutralità”. Ma che cosa significava “neutralità”?
Per prima cosa significava protesta contro gli impegni triplicisti della monarchia. Ma poi? Era rifiuto assoluto a qualunque guerra, oppure tempo guadagnato dal governo per “contrattare” l’intervento magari a fianco degli Imperi Centrali? Era un rifugio per riformisti bonaccioni che non volevano seccature, oppure un’attesa per arrivare alla rivoluzione, tanto contro i neutralisti quanto contro gli interventisti, senza distinzione?
Maria Rygier mi chiamò da Bologna. Era stata in Francia un anno prima in un giro di propaganda pro Masetti, che io le avevo combinato attraverso le conoscenze fatte da me a Parigi durante la mia permanenza colà. Vi era tornata subito dopo la Settimana Rossa, per precauzione contro un eventuale arresto. A guerra scoppiata, eccola di ritorno.
Io la sapevo portata alle decisioni estreme, ed ero preparato ad ascoltare da lei le proposte più impensate contro la guerra. Rimasi di sasso quando mi trovai di fronte ad una Rygier, che con la massima semplicità mi parlava di guerra ad oltranza. Per lei non c’era altro da fare che buttarsi a corpo morto in favore della Francia, metter tutto a soqquadro per imporre alla monarchia questo intervento. Io la guardavo, e mi domandavo se era proprio lei. Il suo accento era convinto come quando in passato parlava di rivolta e di rivoluzione. Si dichiarava sicura che io sarei stato con lei. Che era dunque avvenuto? Si falsifica una moneta, ma non si può falsificare un essere umano. No, era sempre lei: e sempre anche nella nuova veste, col suo terribile temperamento esplosivo. Gli altri incominciarono coi ma e coi se. Lei si buttò subito dall’altra parte della barricata. Strepitava che io mentivo a me stesso; dovevo capire che l’asse della rivoluzione si spostava dalla barricata alla guerra, dai popoli ai governi, dalle cospirazioni alla diplomazia. Per più giorni non mi dette pace, tenace, paziente, insistente come una zanzara, piena di arguzia polemica e di risorse sofistiche. Se la seguivo, diceva, sarei stato l’anima di un grande evento storico, un nuovo Pier l’Eremita, e tante altre cose che mi facevano pena. Dirò che mi parve sincera. Conoscendone l’ostinatezza caparbia, non le feci la minima concessione, non accennai a preferenze per un “male minore”. Quella era capace di aggrapparsi ad una parola sola per proclamare che io le avevo dato ragione. Di lì a poco si mise in giro a fare pubblica propaganda interventista, e non la ebbi più dattorno.
Un secondo assalto lo tentò Alceste De Ambris, uomo ponderato, circospetto, prudente : “anti-Rygier” per temperamento. Come sappiamo, era l’esponente massimo dell’Unione sindacale italiana, alla quale aderiva la nostra Camera del Lavoro di Bologna. Mi aveva contrariato, ma non meravigliato, la candidatura così detta “antiparlamentare” che aveva fatto di lui un deputato. Ma, dopo tutto, era “sindacalista” e non anarchico, e diceva di essere onorevole solo pro forma, e infatti non andava mai alla Camera e usava i privilegi di deputato per la propaganda sindacalista antiparlamentare. Tutto sommato, avevo per lui rispetto e simpatia. Sulla guerra si era già a mezzo scoperto in una conferenza a Milano, nella quale, scontentando non pochi dei suoi, aveva domandato che cosa sarebbe avvenuto se vincevano i tedeschi.
Mi telegrafò che, recandosi a Imola per una conferenza, desiderava incontrarmi a Bologna. Ci incontrammo alla stazione. Non mi affrontò alla maniera della Rygier. Sapeva già della mia posizione. Si destreggiò accortamente per sondare e capire i miei propositi d’azione di fronte all’interventismo militante. Lui era sindacalista e quindi, discutendo con lui, non potevo partire dalle mie concezioni dottrinali. Ma mi pareva che, come sindacalista, avrebbe dovuto rimanere fedele a quel tanto di antistatalismo che era implicito nel sindacalismo. Gli parlai col cuore in mano. Ricordo che gli domandai se oltre a preoccuparsi di ciò che sarebbe avvenuto se vincevano i tedeschi, non si domandasse quel che sarebbe avvenuto se vincevano gli antitedeschi; intanto una prima vittoria i tedeschi l’avevano ottenuta colla conversione al militarismo di tanti sovversivi. Gli dissi che se si lanciava per quella via, ci saremmo presto trovati l’uno contro l’altro. Mi propose di accompagnarlo ad Imola. Gli risposi che sarei andato, se non gli dispiaceva di avermi di fronte in contraddittorio. Mi fece capire che non lo desiderava, e io gli usai il riguardo di starmene a casa.
Mussolini dalle colonne dell’“Avanti!” sparava a mitraglia contro la guerra, per l’Internazionale, per la rivoluzione, contro i rinnegati. Mi incoraggiava per lettera a tener duro.
A tanta distanza di tempo, balzano ancora alla mente con evidenza i fatti salienti, gli scontri maggiori, e le rotture più clamorose. Ma a soffermare più a lungo il pensiero, affiorano i ricordi malinconici: amicizie che, maturate nella lotta, bisognava strappare, mentre pesava sull’animo doverle strappare.
Il serra serra attorno a noi per farci “cascare” nell’interventismo si faceva ogni giorno più aggressivo. Dall’estero arrivava la stampa francese giubilante per l’Unione sacra. Non una voce contraria poteva arrivare in Italia. Si seppe di Kropotkin, e di un manifesto chiamato dei “sedici” dal numero delle celebrità anarchiche che l’avevano firmato fra le quali Malato, Cornelissen, Grave. Ma poco si sapeva di Malatesta e di un gruppo di Londra, Rudolf Rocker, Alessandro Shapiro, amicissimi di Kropotkin, che non avevano seguito il maestro. Si strombazzava quale modello per noi l’atteggiamento della Confédération Générale du Travail francese e del suo segretario, Leon Jouhaux. Persino Amilcare Cipriani aveva dato il suo nome amato alla causa dell’interventismo. Amava nella Francia la patria della Rivoluzione. Si ingannò certo ma non ingannò mai e poi mai. Si accorse in piena guerra, prima di morire, che si era illuso? Ci sarebbe da crederlo dal silenzio che si fece attorno a lui e alla sua morte. Dopo la guerra, quando in Italia gli interventisti a pretese rivoluzionarie cercavano l’avallo di grandi nomi per giustificare la loro politica, il nome di Cipriani nessuno lo ripescò per rinfacciarcelo.
Il blocco della Settimana Rossa andò in frantumi. I repubblicani non tardarono a ingolfarsi nell’interventismo, i socialisti bissolatiani altrettanto. De Ambris uscì dalle riserve, e predicava apertamente la necessità di imporre la guerra. Erano con lui gli elementi più in vista dell’Unione sindacale italiana. I seguaci del partito socialista ufficiale, da cui Bissolati e i suoi erano stati espulsi nel 1912, erano disorientati dai loro pontefici massimi, i deputati socialisti tedeschi, che al Reichstag avevano votato i crediti per la guerra, dando così ai deputati socialisti francesi e belgi la spinta a fare lo stesso ed entrare nella Union sacrée. Ma oscillavano fra il neutralismo internazionalista e rivoluzionario e sanguinario di Mussolini, il neutralismo internazionalista e rivoluzionario a parole ma inerte a fatti di Lazzari, e il pacifismo riformista di Turati, che dopo Caporetto doveva slittare verso il bissolatismo, mentre molti, in cuor loro, non erano alieni dall’interventismo bissolatiano. Si diceva che per questo fosse anche Anna Kuliscioff.
Jouhaux varcò la frontiera e venne a Milano a invocare l’aiuto per la Francia, a nome, diceva, non di Poincaré, ma del proletariato sindacalista e libertario francese. Doveva recarsi anche a Parma, e anch’io ero là, a spiare, si può dire, ogni sua mossa. Ma la minoranza antiunionsacrée della Confederazione francese aveva ottenuto da lui l’impegno che in Italia non si sarebbe occupato delle direttive dell’Unione sindacale italiana. Così egli mancò all’ansiosa attesa dei deambrisiani, che avevano annunziato il suo arrivo con grandi manifesti nella città e nella provincia.
Dietro a lui scese Marcel Cachin, munito, per Mussolini, con qualcosa di più persuasivo che parole. E Mussolini verso la metà di settembre cominciò a oscillare.
L’Unione sindacale italiana era la pietra agognata dell’interventismo. Alceste De Ambris, Tullio Masotti, e gli altri che la dirigevano, sembravano averla accaparrata alla politica di guerra. Corridoni, dal carcere, poteva diffondere messaggi e interviste guerresche.
Che fare?
L’Unione sindacale italiana godeva di grande prestigio fra le masse d’avanguardia per le lotte combattute nelle varie località nei suoi due anni di vita rigogliosa e audace, per la campagna prò Masetti, e per la Settimana Rossa. In nessun sindacato sarebbe stata presa sul serio l’idea di “distaccarsi” dall’Unione dopo tanto affannarsi per l’unificazione. Uscirne noi personalmente equivaleva a lasciar mano libera a De Ambris e C. Se insieme coi repubblicani e coi socialisti bissolatiani, anche l’Unione sindacale italiana avesse aderito all’intervento, Mussolini avrebbe potuto esercitare una pressione formidabile sul Partito socialista, e, se non l’intero partito, larghe sezioni di esso, tanto fra i riformisti quanto fra i rivoluzionari, avrebbero aderito all’intervento. In conseguenza la Confederazione del Lavoro avrebbe fatto senza dubbio altrettanto. Dalla Francia compagni, che non seguivano Grave e Jouhaux nella politica dell’Union sacrée, ci supplicavano che tenessimo duro contro ogni deviazione; se De Ambris e compagni l’avessero vinta, questo sarebbe stato in Francia un aiuto ai guerraioli nella Confederazione e negli altri gruppi dell’estrema sinistra.
Intanto l’interventismo dilagava, la polemica si inaspriva, emissari viaggiavano di nazione in nazione, il danaro compiva i suoi antichi miracoli.
In questa atmosfera, nel bel mezzo del settembre 1914, i deambrisiani credettero giunto il momento per convocare a Parma, loro centro indiscusso, il Consiglio generale dell’Unione sindacale italiana, e sottoporre a collaudo il loro atteggiamento. Dall’una parte e dall’altra chiamammo a raccolta le forze migliori. Accanto a De Ambris v’erano Livio Ciardi, Umberto Pasella, Michele Bianchi, Cesare Rossi, Tullio Masotti, Di Vittorio era profugo a Lugano per i fatti della Settimana Rossa a Cerignola, ma era guerraiolo alla pari di tutti gli altri.
Il convegno ebbe luogo nei locali della Camera del Lavoro di Parma. De Ambris, segretario dell’Unione, fece la sua relazione. Secondo lui, la guerra, che si combatteva in Europa, sarebbe stata l’ultima. Il militarismo sarebbe stato liquidato, se vinceva la Francia. Noi avevamo il dovere di fiancheggiare il sindacalismo francese schieratosi per la guerra. Dovevamo costringere la monarchia ad intervenire accanto alla “sorella latina”. L’astro della pace avrebbe illuminato il mondo, una volta atterrato il militarismo prussiano.
Non c’è opera più miserevole che dimostrare che due e due continuano a far quattro a chi ha sempre sostenuto che due e due non potevano fare che quattro, ma ora vi dice che due e due fanno cinque. Come far crollare tutti i loro argomenti sul tradimento esclusivo dei tedeschi, sul libertarismo dei francesi, sulla difesa dei principi dell’89 da parte della Francia ufficiale, sul sangue latino e quello teutonico, sulla certezza della liquidazione della monarchia e sulla certezza ancora più certa della rivoluzione sociale nel dopoguerra, qualora l’Italia fosse intervenuta, e su altre certezze ancora? Parlai a quegli uomini, che vedevo voltarci le spalle nell’ora del pericolo, come amico che voleva trattenerli e non come censore che li accusava. Cercai di metterli in guardia contro se stessi. Ammisi in essi una allucinazione di buona fede. Cercai di mostrar loro i vantaggi che la monarchia e la reazione e il nazionalismo avrebbero ricavato da una guerra. Noi non facevamo il processo a chi, altrove, aveva subito la guerra caduta come fulmine sul suo paese, né a chi aveva saputo resistere alla velleità di arruolarsi contro l’aggressore. Noi ci rifiutavamo di funzionare come impresari dell’interventismo, fantocci dell’Unione sacra, firmatari della cambiale in bianco di questo o di quel militarismo. Nella fattispecie, era spaventoso vedere che rivoluzionari, i quali fino a ieri erano stati così esperti nel denunciare le frodi delle diplomazie e degli Stati, oggi si offrivano come garanti per le promesse da marinaio pronunciate, nel mezzo della burrasca mondiale, dalle stesse diplomazie e dagli stessi Stati. È vero che noi non avevamo potuto evitare la guerra; ma dove saremmo finiti se facevamo nostro tutto ciò che non potevamo evitare? Possiamo forse evitare il dominio dei preti sul popolo? Possiamo evitare lo sfruttamento dei padroni? Leggevo sul viso dei convenuti che pochi dissentivano dalle mie idee, malgrado il rispetto che tutti provavano per il De Ambris, e il dolore di trovarsi separati da lui.
De Ambris difese le sue vedute con eleganza e maestria. Tullio Masotti fu cagnesco come il suo viso. Michelino Bianchi miagolò cose risibili. Cesare Rossi badava al resoconto, nel che era maestro, e non apriva bocca, ma era contro di noi. Alcuni compagni presero la parola per brevi dichiarazioni. Al voto i deambrisiani fecero la amara constatazione che si trovavano in infima minoranza, sindacalisti senza sindacati. Le Camere del Lavoro e le sezioni sindacali erano con noi. De Ambris non era preparato a questa sconfitta. Contava sul suo prestigio personale. Dopo il voto vi fu l’intervallo della colazione, che servì, come di solito, alle intese di corridoio.
Nella seduta del pomeriggio colpo di scena: De Ambris e i suoi si presentarono dimissionari. Era la storia di chi scendeva da cavallo... a ruzzoloni. Era la speranza di indurre almeno una parte di noi, data la situazione anormale, a pregarli di restare. Si ritenevano insostituibili. Pensavano che nessuno, con la guerra che si sentiva nell’aria, avrebbe osato prendere il loro posto per rimanere fedele alle vecchie idee dell’internazionalismo operaio. Dopo che loro fossero rimasti padroni del vapore, la mobilitazione, la prigione, il confino li avrebbero sbarazzati di parecchi fra noi. Avrebbero allora potuto far credere che l’Unione sindacale italiana, malgrado lievi dissensi, era sempre con loro. Avrebbero parlato a nome di una organizzazione, che si sarebbe investita da sé con le funzioni che avrebbero fatto loro comodo, ma che sarebbero state la negazione di quelle per cui era stata creata. E se i più intransigenti fra noi se ne fossero andati, tanto meglio! A lasciarli fare, De Ambris e C, anche se fossero rimasti in non più che quattro, avrebbero continuato a usare della nostra vecchia bandiera. Non mancarono fra i deambrisiani quelli che fecero intendere che si sarebbe potuto lasciar da parte la questione della guerra; noi, dopo tutto, non eravamo un partito politico; i sindacati potevano rimanere in disparte nella contesa. Era una manovra per guadagnar tempo e convocare, a montatura bellica più inoltrata, o ad intervento avvenuto, un Consiglio generale e farsi acclamare issando la bandiera tricolore con la croce di Savoia.
Che fare? Le posizioni erano chiarissime. Essere o non essere. Presi la parola e, con loro stupore, dissi che le loro dimissioni erano la conseguenza logica del voto della mattina. L’entusiasmo, con cui le mie parole vennero accolte, valse più delle parole stesse. Il problema divenne allora dove trasferire da Parma la sede dell’Unione sindacale italiana. Tutti guardavano a Bologna. I compagni di Bologna presenti accettarono. Ma poi, chi avrebbe accettato il peso del segretariato? Tutti capivano (io per primo) che se avessi detto di no, il piano sarebbe caduto. Io dissi di sì.
Così, fu ceduta a Bologna e alla nuova segreteria l’Unione sindacale italiana. Ma questa che cosa era? Era un nome! Non un soldo, non un timbro, non un pezzo di carta. De Ambris e compagni si associarono subito alle forze repubblicane sindacali della Romagna e poche altre, e costituirono l’Unione italiana del lavoro, con Edmondo Rossoni (“Immondo”, come lo chiamavano in America) segretario generale. Questa neonata Unione italiana del lavoro si attribuì tutto il patrimonio collettivo dell’Unione sindacale, al quale pur noi avevamo contribuito. “L’Internazionale”, settimanale portavoce dell’Unione sindacale italiana (giornale ben fatto e diffusissimo) se lo tennero loro, e continuarono a servirsene per la propaganda interventista.
Noi dovemmo metterci in cammino con nuovi mezzi, raccolti tutti da noi. Ma la bandiera dell’Unione sindacale italiana era nelle nostre mani ed era sfuggita alla loro contaminazione. Questo era l’importante.
Così nacque la leggenda di un Borghi “fondatore” dell’Unione sindacale italiana (parlo a quelli che applaudirono e a quelli che fischiarono). Se si intende dire che nel settembre 1914 io ricreai in un certo senso l’Unione sindacale italiana, con la mia decisione, perché ero in quel momento il militante più indicato per suscitare lo slancio, l’entusiasmo e la volontà di quanti anelavano a salvare quel movimento da una fine ignominiosa, non ho niente da dire in contrario. Dico anzi che sembra anche a me la verità. Mi vergognerei, se si dicesse che la mandai in malora, quando anche solo come vessillo di internazionalismo o di antiunionsacrée la nuova Unione sindacale italiana aveva la sua ragion d’essere, in quel momento storico in cui ogni governo voleva ai suoi piedi un operaio vestito da pagliaccio, che battesse con l’ossa dei morti, sul tamburo della guerra, l’inno al militarismo liberatore.
Potevo fare diversamente? Era un’ora tragica nella storia, l’ora in cui i malfattori dello Stato si offrivano a stringere la mano ai malfattori dell’anarchia. Avremmo dovuto essere meno tolstoiani, dicevano di noi i più gentili. Gli altri ci accusavano di essere venduti alla Germania.
A mezzo ottobre, Mussolini cessò di oscillare, e saltò il fosso. Maria Rygier pubblicò in Francia nel 1929 un opuscolo nel quale ci mostra Mussolini messo all’incanto.
– “Io non fui estranea”, dice, “a questa subitanea conversione di Mussolini, grazie al consiglio che avevo dato a Barrère, ambasciatore francese presso il Quirinale, di fondare a Milano, importante centro industriale e, per conseguenza, proletario, un quotidiano socialista dedicato agli interessi dell’Intesa, rinunciando alla creazione allora progettata dal governo francese di un giornale democratico a Roma. Io ritenevo infatti che l’essenziale per la causa dell’interventismo era di portare la discordia e la confusione fra i socialisti, che erano nella grande maggioranza ostili alla guerra”.
La Rygier continua spiegando che lei non aveva pensato di indicare al Barrère l’integerrimo direttore dell’“Avanti!”; ma aveva proposto un noto sindacalista (chi, se non De Ambris?), e quando apprese che la Francia era riuscita ad impegnare Mussolini, concepì una vivissima ammirazione per la diplomazia francese, ben sapendo che questa conversione le era costata un grosso rotolo di biglietti da mille.
In quell’ottobre incontrai Mussolini in piazza del Duomo a Milano. L’aveva rotta col suo partito, ma si professava ultrarivoluzionario. Accortomi di lui a distanza, gli attraversai la strada e lo affrontai. Me lo vedo ancora davanti. Mi lasciò parlare senza mai guardarmi negli occhi. Cercai di fargli sentire in me il vecchio amico, senza arie solenni e senza rimproveri. Gli parlai, spesso in dialetto, della nostra giovinezza, dei nostri vecchi che erano vissuti e morti fedeli alla nostra idea, dell’abisso morale e politico che ci divideva dal mondo dei dominatori, dei doveri che avevamo verso i più giovani di noi; li avevamo trascinati dietro di noi nell’antimilitarismo, e oggi non dovevamo ributtarli in pasto al nemico.
Egli non assunse mai arie da offeso. Mi lasciò dire. Si guardava la punta delle scarpe. Cercò ogni tanto di adescarmi, dandomi ragione e inveendo contro quei “vigliacchi dei socialisti ufficiali”, che posavano da antimilitaristi ma avevano avuto paura di compromettersi per Masetti più che non avesse avuto paura di Masetti il colonnello Stroppa. Gli obiettai che essere contro le vigliaccherie dei suoi ex-compagni, non doveva significare buttarsi nelle braccia dei nazionalisti, non doveva traviare i democratici sinceri con un guerraiolismo rivoluzionario che non aveva nessuna consistenza. E lui a insistere sulla vacuità dell’internazionalismo più vero e più coerente; quello di chi difende gli ideali dell’Internazionale umana; credeva egli che quegli ideali fossero rappresentati dal guerraiolismo antitedesco, in cui si rimescolavano confusamente nazionalisti, reazionari e uomini di sinistra?
– Sai che farò un nuovo quotidiano?
– Lo so.
– Lo intitolerò “Il Popolo d’Italia”.
– Lo so.
– Vieni in via Paolo da Cannobio a visitare i locali e gli impianti.
– Grazie, non ho tempo.
– Potrai collaborare liberamente.
– C’è un inconveniente.
– Parla...
– Non ti offendere: chi ti fornisce il danaro? Mi fissò, secco, occhi sbarrati:
– Hai fiducia di me? Era il ricatto all’amicizia!
Gli avevo parlato fraternamente, con l’illusione di trattenerlo dalla mala deriva. Non potevo dirgli “no, non ho fiducia in te”. Risposi : “Sì, fino a prova contraria”.
– Ebbene, vedrai.
Fu l’ultima volta che c incontrammo.
Armando Borghi
[Mezzo secolo di anarchia (1898-1945), II ristampa, Catania 1989, pp. 153-161]
Anarchici russi
Risposta al Manifesto dei Sedici
Son quasi trascorsi due anni dall’inizio di questa terribile guerra, una guerra quale l’umanità non aveva mai sperimentato, cui si debbono milioni di tombe senza nome, milioni di storpi, milioni di vedove e di orfani. Beni per un valore di miliardi, prodotto di lunghi anni di umana fatica, sono stati gettati alle fiamme, inghiottiti da un abisso senza fondo. Un inumano dolore, sofferenze terribili, una profonda disperazione per l’umanità – eccone il risultato.
Ora, quando ovunque si odono grida di disperazione – “Basta spargimenti di sangue! Basta distruzioni!” – guardiamo con grande tristezza a quelli che un tempo erano i nostri compagni, P. Kropotkin, J. Grave, C. Cornelissen, P. Reclus, C. Malato ed altri anarchici e antimilitaristi che nel loro recente manifesto hanno dichiarato: “No, c’è stato ben poco spargimento di sangue, poca distruzione. È troppo presto per parlare di pace!”.
In nome di quali princìpi, a quale scopo pensano sia possibile proclamare la necessità del fratricidio? Che cosa ha portato questi fervidi partigiani della pace a sostenere il conflitto armato? Non riusciamo a capirlo, poiché, leggendo il loro manifesto, colpisce lo squallore di quell’idea nel cui nome chiedono che la guerra continui fino in fondo.
Gli autori del manifesto dichiarano che la colpa del conflitto è da attribuire alla Germania, che mira ad annettersi il Belgio e i dipartimenti settentrionali della Francia e ha richiesto a quest’ultima pesanti indennizzi e intende, in futuro, sottrarle le colonie. Essi biasimano il popolo tedesco per aver obbedito al governo e dichiarano che, fin quando la Germania non rifiuterà i progetti di conquista dei suoi governanti, non si può parlare di pace. In tutto il manifesto è chiaro l’atteggiamento parziale nei confronti dell’Intesa. E questa parzialità, originata da una grossolana sopravvalutazione della dubbia superiorità dei regimi democratici, ha inevitabilmente portato gli autori del manifesto a non parlare di molte cose che hanno seriamente compromesso le potenze alleate, ad applicare criteri diversi nel valutare le medesime azioni intraprese dai belligeranti, infine a confondere i desideri del popolo con quelli del governo di cui erano schiavi.
I firmatari del manifesto considerano il governo germanico come il maggior responsabile del conflitto. Ma non è un segreto che tutte le grandi potenze si stavano preparando già da tempo a una guerra europea. E non a una semplice guerra di difesa, non solo per proteggersi da un’invasione tedesca. Si preparavano, piuttosto, a una guerra di conquista, alla conquista di un nuovo territorio o alla dominazione economica degli Stati confinanti. L’aver ragione della Germania come rivale sui mari non è forse da sempre il sogno dell’Inghilterra? E non è ormai di pubblico dominio il desiderio della Russia di esercitare la propria sovranità sulle rive del Bosforo? Forse che la Russia non guarda con occhio famelico alla Galizia? Ed è forse tramontato il sogno della Francia di divenire una grande potenza coloniale?
Tutti gli Stati si stavano preparando alla guerra. E se questa non scoppiò prima del 1914, fu solo perché il canale di Kill, in Germania, non era stato ancora allargato, non era stata ancora completata la costruzione della flotta inglese, l’esercito francese non era ancora perfezionato e in Russia non erano ancora state create nuove divisioni. E se, grazie alle loro capacità organizzative, i pirati coronati della Germania sono riusciti a prepararsi prima degli altri e prima degli altri hanno deciso di dare l’Europa alle fiamme, questo non diminuisce in alcun modo la responsabilità morale dei pirati coronati dell’Inghilterra, della Russia e delle altre nazioni per l’alto numero delle vittime sacrificate sull’altare del militarismo.
Gli autori del manifesto protestano contro la possibile annessione alla Germania dei territori occupati senza il consenso delle popolazioni indigene. Ma perché non hanno protestato per l’annessione dell’Egitto, che l’Inghilterra aveva già effettuato nel corso del conflitto senza il consenso della popolazione egiziana? Perché non hanno stampato un manifesto che incitasse i lavoratori ad insorgere contro l’Inghilterra schiavista? Non è forse perché un atto del genere toglierebbe il tappeto da sotto i piedi di questi anarco-militaristi? Non sarebbero costretti a dire chiaramente che questa guerra è una guerra tra due gruppi di predatori ugualmente nemici della libertà? Gli autori del manifesto sono sicuri che parlare di pace in questo momento significherebbe incoraggiare i progetti della fazione belligerante germanica, che comprendevano l’invasione delle nazioni limitrofe, invasione che compromette ogni speranza di liberazione e di progresso umano. Noi invece crediamo che non l’invasione germanica, ma la guerra in sé, di cui sono parimenti responsabili tutte le nazioni che vi prendono parte direttamente o indirettamente, costituisca una minaccia per ogni speranza di liberazione e di umano progresso. E noi esortiamo il popolo a lottare non solo contro il governo germanico, ma a insorgere contro tutti coloro che vogliono farlo schiavo. Salutiamo con gioia la dimostrazione delle donne di fronte all’edificio del Reichstag per difendere la pace e il pane. Tutto ciò che è sano e puro si è manifestato in queste seppur flebili proteste. Chiamiamo i lavoratori di ogni paese a una tempestosa protesta, a una sollevazione popolare, perché solo con questi mezzi possiamo sperare di rigenerare l’umanità, e non continuando la guerra. Gli autori del manifesto chiamano alla rivolta solo il popolo germanico e, nel contempo, chiamano il popolo degli Stati alleati alle trincee. Siano pure coerenti e rifiutino ad un tempo l’antimilitarismo e la rivoluzione. Perché l’antimilitarismo in Francia o i fermenti rivoluzionari in Russia o in Inghilterra non faranno che favorire la Germania. E qualsiasi forma di antimilitarismo o rivoluzione al di fuori della Germania favorirà i disegni della nazione germanica. Tuttavia, questo è precisamente ciò che Kropotkin ha fatto. Con orrore abbiamo scoperto che anche prima della guerra era contrario alla lotta contro la legge che stabiliva tre anni di servizio militare obbligatorio in Francia.
Ma gli autori del manifesto non riescono veramente a capire che non solo in questa, ma in tutte le guerre si può trovare – in un senso puramente formale – una percentuale di colpa presumibilmente più o meno grande di democrazia? Così si appelleranno sempre al meno colpevole per difendersi; rimarranno sempre schiavi del vergognoso slogan: “Fabbricate i cannoni e rimetteteli al loro posto!”. Anche adesso mentre passano da frasi generiche sul progresso e sulla minaccia germanica a dichiarazioni concrete sulle possibili conseguenze di una vittoria tedesca, temono solo che la Germania si impadronisca delle colonie francesi e, per mezzo di accordi commerciali, riduca la sua vicina ad una soggezione in campo economico. E dopo tutto ciò, Kropotkin e gli altri autori del manifesto si dichiarano ancora anarchici e antimilitaristi! Chi esorta il popolo alla guerra non può essere né anarchico, né antimilitarista.
Essi difendono una causa estranea ai lavoratori. Essi vorrebbero mandare i lavoratori al fronte non in nome della loro emancipazione, ma per la gloria del capitalismo nazionale progressivo e dello Stato. Vorrebbero distruggere lo spirito dell’anarchia e gettarne i resti ai servi del militarismo.
Noi, però, rimaniamo al nostro posto. Esortiamo i lavoratori di tutto il mondo ad attaccare i loro nemici più prossimi, chiunque siano i loro leader – l’imperatore di Germania o il sultano turco, lo zar russo o il presidente francese. Sappiamo che quando si tratta di corrompere la volontà e la coscienza dei lavoratori, la democrazia e l’autocrazia non sono seconde l’una all’altra. Non facciamo alcuna distinzione tra guerre accettabili e inaccettabili. Per noi, esiste un solo tipo di guerra, la guerra sociale contro il capitalismo e i suoi difensori. E ripetiamo i nostri slogan, che gli autori del vergognoso manifesto hanno rinnegato: Abbasso la guerra!
Abbasso il potere dell’Autorità e del Capitale! Viva la fratellanza del popolo libero!
Gruppo degli Anarchici Comunisti di Ginevra
[Otvet, in “Put’k Svobode”, Ginevra, maggio 1917, pp. 10-11]
Questo sito, oltre a informare i compagni sulle pubblicazioni delle Edizioni Anarchismo, archivia in formato elettronico, quando possibile, i testi delle varie collane.
L’accesso ai testi è totalmente libero e gratuito, le donazioni sono ben accette e servono a finanziare le attività della casa editrice.
