Prima edizione: maggio 2016
Pëtr Kropotkin
Memorie di un rivoluzionario
Introduzione di Alfredo M. Bonanno
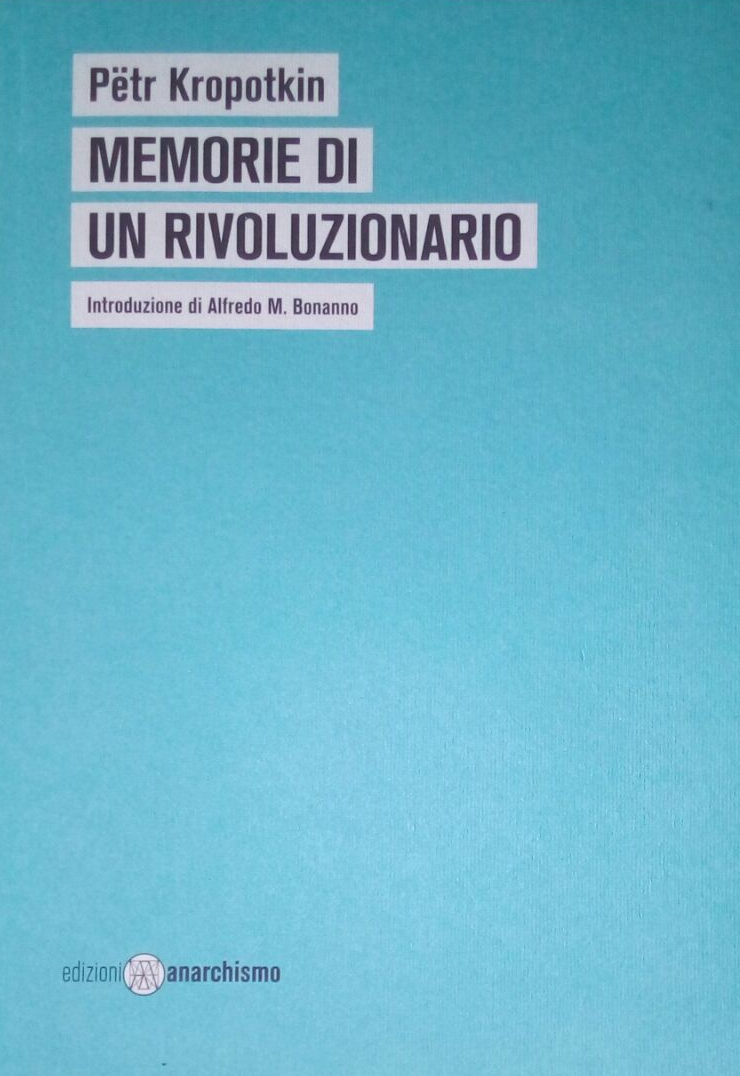
Introduzione vivamente sconsigliata
Parte seconda
Il Corpo dei Paggi
Introduzione vivamente sconsigliata
Ecco uno dei più bei libri di Kropotkin. Lo lessi per la prima volta nel carcere di Catania, nel 1972, e ne rimasi affascinato. Vi si colgono i pregi, e purtroppo anche i limiti, di questo compagno, e preferisco, più che i secondi, qui, tenere conto dei primi. Dei pregi, per l’appunto.
È lo sguardo di un uomo meravigliato del mondo che qui si vede, ingenuamente sorpreso di trovarsi di fronte alla grandezza della natura, al sogno di un futuro migliore, di un mondo più giusto. Che poi, da un punto di vista concreto, diciamo attivamente rivoluzionario, trasformativo, questo entusiasmo non si traduca in indicazioni per noi significative, meno che mai oggi, con le mutate condizioni in cui soffochiamo, questo è un altro discorso.
Kropotkin non se ne preoccupa e, in fondo, nemmeno ai miei occhi di entusiasta lettore di quei lontani giorni della mia prima carcerazione la cosa fa velo. Capisco la gioia del bambino e del giovane, capisco la gioia dello studioso che vuole scoprire i segreti di un mondo ancora quasi sconosciuto, di foreste, e fiumi, e montagne, e ghiacciai, inesplorati, e capisco anche il rapido maturare della coscienza rivoluzionaria, l’impegno continuo, la propaganda, l’azione, il carcere.
Capisco meno l’incapacità operativa, la concretezza vacillante, il continuo scappare via nel sogno di un mondo ormai inconciliabile con gli sviluppi moderni, e capisco ancora meno il chiudere gli occhi davanti alla cattiveria, alla radicale cattiveria dell’uomo. L’ottimismo, e chi scrive è un ottimista, si racchiude tutto nel ritenere possibile quello che si vuole realizzare nell’azione, non nel sognare un meccanismo determinista che sia in se stesso buono e quindi in grado di dare man forte al proprio vedere il futuro in modo positivo.
Sono un ottimista, odio le letture che faccio spesso di pessimisti dichiarati, alla lunga ho scoperto però che sotto il loro cupo rifiuto della speranza ci sta un modo diverso di riproporre una sorta di fiducia nel futuro. Un disperato pessimista spera che le cose non vadano tanto male, è un ottimista come me, alla fine ci differenziamo solo perché non pongo molta importanza nell’accumulo dei possessi. Lui, al contrario, è scornato dalla disillusione che qualunque possesso non può fare a meno di portare con sé. Allo stesso modo mi sento obbligato a entrare in sospetto nei riguardi dei panottimisti come Kropotkin, questo senza nulla togliere alla bellezza di questo libro.
L’eccesso che avvolge la notte della desolazione mi fornisce una grande energia distruttrice, mi esalta e mi rende euforico davanti a ogni ostacolo. Non posso retrocedere o arrendermi, non conosco più i significati di queste parole, sono un partigiano dell’annientamento. Un silenzioso guaritore di malattie, come lo è il coltello. Anche lui non strepita e non estenua, lavora in profondità e in silenzio. L’eccesso non ama le macchinazioni, le menti stanche e annoiate nell’attesa, non inciampa mai in un ostacolo, non rimastica, non resta incerto e indifferente. Non ha paura di ritrovarsi a spingere un corpo martoriato dai dubbi e non sa nemmeno quale sarà la conclusione del suo andare avanti. Nell’eccesso non c’è futuro. O, se si parla in termini di possibilità, c’è un’apertura nel destino, una possibilità, ma l’eccesso non lavorava in quella direzione, non faceva che la sua strada, del tutto remota a qualsiasi influsso sulla modificazione.
Kropotkin, invece, è per la distruzione che sistema le cose una volta per tutte. Ma come è possibile una simile distruzione? Non bisogna ricominciare ogni volta daccapo?
Certo che bisogna. Non ha senso, mi si potrebbe rispondere, riprendere qui questo discorso – che poi sarebbe quello sulla grandezza della sconfitta e sulla pochezza della vittoria – quando si è davanti a un libro che apre il cuore ed esalta all’azione, sì, proprio all’azione.
Può essere che la mia sia una deformazione, ma non posso non entrare in sospetto. L’azione mi conduce oltre il livello significativo della modificazione, colgo quello che la qualità contribuisce a trasformare, l’abbaglio distruttivo perfino, ma non so penetrare dentro i riflessi rappresentativi. La sconfitta invece di umiliarmi mi esalta, l’abbandono mi prende per mano e inizia a condurmi, la luce è silenzio e l’oscurità mi parla sia pure grazie alla voce della desolazione. Il mio furore non mi fa più schermo, non devo selezionare e produrre chiarezze, sono travolto ed è di questo sbatacchiare che sto discutendo, mentre il furore monta e la trasformazione mi indica nuovi orizzonti. La qualità mi fa valutare equanimi perdite e vittorie, non c’è scorcio trascurato che io trascuri, ora sono solo in gara con me stesso.
Sono stato intento per anni a scardinare, a capovolgere, a schiudere, penetrare fino alle radici, svitare, martellare sonoramente, dappertutto ho picchiato, ho inteso picchiare, ma con una persistente e sospettosa sorveglianza. La distruzione deve continuare, andare oltre il fare. E qui non è più questione di potenza, il volume di fuoco non c’entra più. La mostruosità del mondo, anchilosata nell’accumulo della conoscenza, deve andare spezzata, se non si vuole riverniciare i muri perimetrali del cimitero. Nella complessità della partecipazione e dell’abbandono occorre schiettezza, altrimenti ancora imbrogli passeranno di contrabbando.
Ecco, quello che voglio dire si può riassumere in queste due parole: Kropotkin è rimasto sempre al di qua, non è mai andato oltre, non ha mai oltrepassato se stesso. Questo libro è un grande libro perché capace di far vedere dove è possibile arrivare per potere continuare, oltrepassare il punto in cui Kropotkin si è fermato, forse perché troppo buono per andare al di là della propria stessa visione ottimista del mondo, sia pure di questo mondo colmo di sangue e di melma.
Nell’oltrepassamento io cerco sempre la perdita, ho smesso da tempo di desiderare il possesso. Nell’azione mi si prospetta la pienezza dell’uno, per quello che posso intuire, ma so che alla fine questa pienezza sarà anch’essa effimera, e che mostrerà la sua estranea condizione proprio nel momento in cui vorrò stringerla da vicino. Sono arrabbiato e sconfitto, ma è proprio questa la condizione più vicina a essere quello che veramente sono. Tutto ciò non c’è in questo libro e non so nemmeno se possa veramente interessare qualcuno, e non me ne importa. In fondo scrivo queste righe per me stesso.
Sconsiglio quindi a tutti la lettura di questa introduzione, che ci si goda il piacere di questo meraviglioso libro. Per il resto, arrivederci altrove.
Trieste, 22 maggio 2014
Alfredo M. Bonanno
Parte prima
L’infanzia
La città di Mosca ha avuto un lento sviluppo storico e oggi ancora i suoi diversi quartieri hanno conservato in modo straordinario i tratti caratteristici impressivi dal lungo passare dei secoli. Il quartiere che si stende oltre la Moscova, con le sue strade larghe e sonnolente, le case dai tetti bassi di un grigio monotono, i portoni accuratamente chiusi e sprangati notte e giorno, è sempre stato la tranquilla dimora del ceto mercantile e la fortezza della setta scismatica, formalista e dispotica dei “vecchi credenti”. La fortezza, o Kremlino, è ancora la roccaforte della Chiesa e dello Stato, e l’immensa piazza che gli si apre dinanzi, con le sue migliaia di botteghe e di magazzini, è da secoli l’affollato alveare che costituisce il centro del commercio e del grande traffico che si stende su tutto il vasto Impero.
La Tverskaja e il Ponte dei Fabbri da secoli sono il centro dei negozi più eleganti, mentre il Plušika e il Dorogomilovka, i quartieri popolari, conservano oggi ancora le caratteristiche che distinguevano i loro chiassosi abitanti al tempo degli Zar moscoviti. Ogni quartiere costituisce un piccolo mondo a sé, ognuno ha una propria fisionomia e vive la propria vita. Persino le ferrovie, quando irruppero nell’antica capitale, si raggrupparono a parte, formando un loro quartiere, alla periferia della vecchia città, con i loro depositi, le loro macchine, i loro carri pesanti.
Ma di tutti i quartieri di Mosca nessuno forse è più tipico di quel labirinto di vie e viuzze, pulite, tranquille e intricate, che si stende dietro il Kremlino, fra le due grandi arterie, l’Arbat e il Prečistenka e che ancora si chiama Vecchio Quartiere degli Scudieri Reali: lo Staraja Konjušennaja.
Una cinquantina di anni fa in questo quartiere viveva, e lentamente si spegneva, la vecchia nobiltà moscovita, i cui nomi ricorrono tanto di frequente nella storia russa avanti Pietro I, ma che sparirono poi per far posto ai nuovi venuti, – “uomini di ogni rango” chiamati a partecipare alla vita pubblica dal fondatore dello Stato russo. Accorgendosi di essere soppiantati alla Corte di Pietroburgo, questi nobili di antica stirpe si ritirarono a vivere o nel Vecchio Quartiere degli Scudieri Reali, a Mosca, o nelle loro pittoresche tenute di campagna nei dintorni della capitale, osservando di là, con un misto di disprezzo e di segreta gelosia, la folla variopinta di famiglie che venivano Dio sa da dove, a impossessarsi delle alte cariche dello Stato, nella nuova capitale sulle rive della Neva.
Quasi tutti avevano tentato in gioventù di far fortuna al servizio dello Stato e soprattutto nell’esercito, ma ben presto, per una ragione o per l’altra, avevano abbandonato il servizio prima di raggiungere i gradi più elevati. I più fortunati avevano ottenuto qualche tranquillo impiego, quasi una carica onoraria, nella loro città natale – e mio padre fu di questi – mentre gli altri, la più gran parte, si erano semplicemente messi a riposo. Ma dovunque li avesse portati la loro carriera, riuscivano sempre a trascorrere la vecchiaia in una casa di loro proprietà, nel Vecchio Quartiere degli Scudieri Reali, a due passi dalla chiesa dove erano stati battezzati e dove erano state recitate le ultime preghiere ai funerali dei loro genitori. Nuovi rami si innestavano al vecchio tronco. Alcuni si guadagnavano fama più o meno grande nelle varie province della Russia, alcuni possedevano case moderne e lussuose in altri quartieri di Mosca o di Pietroburgo; ma il ramo che abitava nel Vecchio Quartiere degli Scudieri Reali, vicino alla chiesa verde, gialla, rosa o bruna, cara per i ricordi familiari, era considerato il vero rappresentante della famiglia, secondo l’albero genealogico. Il suo capo era trattato con un grande rispetto, non privo, dobbiamo ammetterlo, di una leggera ironia, anche da quei rampolli più giovani che avevano abbandonato la città natale per una carriera più brillante nei reggimenti della Guardia a Pietroburgo o alla Corte. Egli rappresentava per loro l’antichità della famiglia e le sue tradizioni.
In queste strade tranquille, lontane dalla folla rumorosa della Mosca dei traffici, tutte le case più o meno si assomigliavano. Erano costruite generalmente di legno, con i tetti di ferro dipinti di un verde chiaro, le facciate di stucco decorate di colonne e portici, tutte dipinte di colori vivaci. Erano quasi tutte case a un piano solo, con sette o nove grandi finestre che si aprivano sulla strada. Un secondo piano era tollerato solo sul lato posteriore della casa, e dava su un largo cortile circondato da piccole costruzioni che servivano da cucina, stalla, cantina, rimesse, e altre camere per i clienti e i servi. Un grande portone dava accesso a questo cortile e, all’ingresso, una targa di rame portava quasi sempre l’iscrizione: “Casa del Tal dei Tali, tenente, o colonnello o comandante”, ben di rado Generale maggiore, o qualche grado civile di pari importanza. Ma se una casa più ricca, abbellita da un’inferriata dorata e da un cancello di ferro, si trovava in una di queste strade, si poteva esser certi che la targa di rame portava inciso il nome di un console o dell’onorevole cittadino Tal dei Tali. Erano gli intrusi che venivano non si sa di dove a stabilirsi in questo quartiere, rigorosamente evitati, quindi, dai loro vicini.
I negozi non erano ammessi in queste strade privilegiate, fatta eccezione di qualche piccola costruzione di legno, addossata alla chiesa parrocchiale, dove si poteva trovare qualche botteguccia di ortaggi o di droghe; ma in compenso la garitta della sentinella era là di fronte; e, di giorno, la guardia armata di alabarda si affacciava alla porta a salutare con l’arma inoffensiva gli ufficiali che passavano, e la sera rientrava per mettersi a lavorare da ciabattino, o a preparare qualche speciale tabacco da naso prediletto dai servi più anziani del vicinato.
La vita trascorreva tranquilla e pacifica, almeno esteriormente, in questo Faubourg Saint Germain di Mosca. Durante la mattinata non si vedeva anima viva per le strade. Verso mezzogiorno uscivano i ragazzi, accompagnati da maestri francesi e da bambinaie tedesche, che li portavano a passeggio per i viali coperti di neve. Più tardi si vedevano le signore nelle loro slitte a due cavalli, con un servo in piedi sulla traversa dietro la slitta, o sprofondate in una vettura antica, larghissima ed alta, sospesa su grandi molle ricurve e tirata da quattro cavalli, con un postiglione davanti e due valletti in piedi dietro. La sera quasi tutte le case erano sfarzosamente illuminate, e siccome non vi era ancora l’abitudine di chiudere le imposte, il passante poteva ammirare le partite di gioco o i valzer nei saloni. Non si usava allora avere delle “opinioni”, ed erano ancora lontani i giorni quando, in ognuna di queste case, incominciò una lotta fra “padri e figli”, una lotta che terminava di solito in una tragedia domestica, o in una visita notturna della polizia di Stato. Cinquant’anni fa non si sognavano cose simili: tutto era pace e calma, almeno apparentemente.
In questo Vecchio Quartiere degli Scudieri nacqui nel 1842 e qui passai i primi quindici anni della mia vita. Dopo la vendita della casa dove era morta nostra madre e la compera di un’altra, e dopo la vendita anche di questa, passammo in diverse case di affitto, finché nostro padre ne trovò una di suo gusto vicino alla chiesa dove era stato battezzato. Con tutti questi cambiamenti non si uscì però mai dal Vecchio Quartiere degli Scudieri Reali, che si abbandonava solo durante l’estate per andare in campagna.
Una camera spaziosa e alta, la stanza d’angolo della nostra casa, con un grande letto sul quale giace nostra madre; i nostri seggiolini da bimbi là vicino e la tavola apparecchiata con cura e coperta di dolci e gelati in bei piatti di cristallo; una camera nella quale noi ragazzi fummo introdotti a un’ora insolita: questo il mio primo vago ricordo.
Nostra madre moriva di tubercolosi; non aveva che trentacinque anni. Prima di lasciarci per sempre aveva voluto averci vicini per accarezzarci, per godere un momento di felicità nella nostra gioia, e aveva fatto preparare questa piccola festa per noi presso il letto, che non poteva ormai più abbandonare. Ricordo il suo viso pallido e affilato, i suoi grandi occhi scuri. Ci guardò amorosamente, ci invitò a mangiare e ad arrampicarci sul letto, poi a un tratto dette in uno scoppio di pianto accompagnato da un colpo di tosse, e noi fummo portati via.
Trascorse qualche tempo e un giorno noi ragazzi, cioè mio fratello Aleksandr e io, fummo condotti dalla casa grande in una più modesta nel cortile. Il sole d’aprile rallegrava le stanzette con i suoi raggi tiepidi, ma la nostra governante tedesca, Madame Burman, e la bambinaia russa, Uliana, ci fecero coricare. Avevano il viso bagnato di lacrime mentre ci cucivano delle camicie nere dalle lunghe frange bianche. Non potevamo dormire; il mistero ci spaventava e stavamo ad ascoltare i loro sommessi discorsi. Sentivamo parole che si riferivano a nostra madre e che non ci riusciva di capire. Saltammo giù dai nostri letti domandando: “Dov’è la mamma? Dov’è la mamma?”.
Tutte e due incominciarono a piangere e ad accarezzare le nostre teste ricciute, chiamandoci “poveri orfanelli!”, finché Uliana, che non riusciva più a contenersi, ci disse: “La vostra mamma è andata là – in cielo – dagli angeli”.
“Come in cielo? Perché?” – chiedeva invano la nostra fantasia infantile.
Questo fu nell’aprile del 1846. Non avevo che tre anni e mezzo e mio fratello ne aveva cinque. Non so dove fossero il nostro fratello maggiore e nostra sorella, Nicola ed Elena, forse erano già a scuola. Nicola aveva dodici anni, Elena undici; stavano sempre insieme e li conoscevamo poco. Così io e Aleksandr restammo nella casetta, affidati alle cure di Madame Burman e di Uliana. La buona vecchia tedesca, senza famiglia e assolutamente sola al mondo, ci fece da madre. Fece del suo meglio per educarci, ci comperava di tanto in tanto qualche piccolo giocattolo e ci faceva fare delle indigestioni di pan di Spagna ogni volta che un’altra vecchia tedesca, che vendeva questo dolce, probabilmente sola e abbandonata anch’essa, passava da casa nostra. Vedevamo di rado nostro padre e i due anni seguenti passarono senza lasciare nella mia memoria nessun ricordo degno di nota.
Nostro padre era molto orgoglioso dell’origine della sua famiglia e mostrava solennemente una pergamena, appesa a una parete del suo studio, fregiata del nostro stemma: lo stemma del Principato di Smolensk, ammantato di ermellino e sormontato dalla corona dei Monomachs, con un’iscrizione firmata dal collegio araldico, nella quale era detto che la nostra famiglia aveva avuto origine da un nipote di Rostislav Mstislavič l’Ardito (nome conosciuto nella storia come quello di un Gran Principe di Kiev) e che i nostri antenati erano stati i Grandi Prìncipi di Smolensk.
“Quella pergamena mi costò trecento rubli”, usava dire nostro padre. Come la maggioranza di quelli della sua generazione era poco versato nella storia russa e considerava la pergamena più per il suo prezzo che per il suo significato storico.
In realtà la nostra famiglia è di origine antichissima; ma come quasi tutti i discendenti di Rurik, che può essere considerato il rappresentante dell’epoca feudale nella storia russa, fu messa in disparte alla fine di quell’epoca, quando i Romanov, incoronati a Mosca, incominciarono a consolidare lo Stato russo.
Negli ultimi tempi nessuno dei Kropotkin ha dimostrato di avere un gusto spiccato per le cariche di Stato. Il nostro bisnonno e il nostro nonno si ritirarono ancor giovani dal servizio militare e si affrettarono a far ritorno alle proprietà paterne. È giusto riconoscere che la principale di queste proprietà, Urusovo, nel governatorato di Rjazan, situata su di un’alta collina ai confini di fertili terre, poteva ben attirare chiunque per la bellezza delle sue foreste ombrose, dei suoi fiumi sinuosi e delle praterie sconfinate. Il nonno aveva solo il grado di tenente quando lasciò l’esercito per ritirarsi a Urusovo e dedicarvisi alla coltivazione dei suoi terreni e alla compera di altri nelle province vicine.
La nostra generazione avrebbe fatto probabilmente altrettanto se nostro nonno non avesse sposato una principessa Gagarin, che apparteneva a una famiglia affatto diversa. Suo fratello era notissimo come fervente ammiratore del teatro. Possedeva un teatro privato e spinse la sua passione fino a sposare, con grande scandalo di tutti i suoi parenti, una serva, la geniale artista Semjonova, una delle creatrici dell’arte drammatica russa e senza dubbio una delle sue figure più simpatiche. E la sposa, scandalo anche maggiore in “tutta Mosca”, aveva continuato a recitare.
Non so se nostra nonna avesse i gusti letterari e artistici del fratello; la ricordo solo quando era già paralizzata e non poteva parlare che sottovoce; ma è certo che nella nuova generazione della nostra famiglia fu spiccatissimo il gusto per la letteratura. Uno dei figli della principessa Gagarin era un poeta di un certo valore e pubblicò un volume di poesie – cosa della quale mio padre si vergognava tanto che evitava sempre di parlarne – e nella mia generazione diversi cugini, mio fratello ed io, chi più chi meno, abbiamo pagato il nostro tributo alla letteratura del nostro tempo.
Nostro padre era un ufficiale tipico dell’epoca di Nicola I. Non che fosse di temperamento guerriero, né che amasse eccessivamente la vita militare: né so se in vita sua abbia passato una sola notte al fuoco del bivacco, o se abbia partecipato a una battaglia. Ma sotto Nicola I ciò aveva scarsa importanza. Il vero militare di quei tempi era l’ufficiale innamorato della divisa, con un disprezzo assoluto per qualsiasi altra tenuta, che addestrava i suoi soldati a esercizi quasi sovrumani con le loro gambe e i loro fucili – spezzare il legno della carabina mentre presentavano le armi era uno di questi famosi esercizi – e che poteva presentare alla rivista una fila di soldati perfettamente allineati e immobili come una fila di soldatini di piombo. “Benissimo”, disse una volta il granduca Michele di un reggimento, dopo averlo tenuto un’ora intiera al presentat’arm, “soltanto respirano!”.
L’ideale di nostro padre senza dubbio era di perpetuare questo concetto del militare.
Prese parte, è vero, alla guerra del 1828 contro la Turchia; ma riuscì a rimanere sempre nello Stato maggiore del comandante in capo; e quando noi ragazzi, approfittando di qualche momento di insolito buon umore, gli chiedevamo di raccontarci degli episodi di guerra, non poteva raccontarci altro che un feroce attacco di centinaia di cani, che lo avevano assalito, una notte, mentre assieme al suo fedele servo Frol passava a cavallo per un villaggio turco abbandonato, portando dei dispacci. Avevano dovuto servirsi delle sciabole per liberarsi dalle bestie affamate. Una masnada di turchi avrebbe certo soddisfatto meglio la nostra immaginazione, ma in mancanza di meglio ci accontentavamo dei cani. Ma quando, incalzato dalle nostre domande, raccontava come si era guadagnata la croce di Sant’Anna “al valore”, e la spada d’oro che portava, devo confessare che restavamo veramente delusi. Il suo racconto era davvero troppo prosaico. Gli ufficiali dello Stato maggiore erano alloggiati in un villaggio turco, quando questo prese fuoco. In un momento le case furono avviluppate dalle fiamme; in una di esse un bambino era stato dimenticato; la madre mandava urla strazianti: Frol allora, che accompagnava sempre il suo padrone, si slanciò fra le fiamme e salvò il bambino. Il comandante in capo, testimone di questo atto, decorò immediatamente mio padre della croce al valore.
“Ma babbo”, – dicevamo noi, – “è stato Frol a salvare il bambino”.
“Cosa importa”, rispondeva con la massima ingenuità, “non era forse un mio servo?”.
Prese anche parte alla campagna del 1831 durante la rivoluzione polacca e a Varsavia conobbe e s’innamorò della figlia minore del comandante di un corpo d’armata, il generale Sulima. Il matrimonio venne celebrato con grande sfarzo nel palazzo Laziencki, il tenente governatore, conte Paskievič, fu testimone dello sposo: “Ma vostra madre” egli soleva dire, “non mi portò dote”.
Questo era vero. Suo padre, Nicolai Semionovič Sulima, non conosceva l’arte di far denaro o carriera. Doveva avere troppo il sangue di quei Cosacchi del Dnepr che sapevano battersi contro i ben armati guerrieri polacchi o contro eserciti di turchi tre volte superiori di numero, ma non sapevano sfuggire alle insidie tese loro dalla sottile diplomazia moscovita; e dopo essersi battuti contro i Polacchi nella terribile insurrezione del 1648, che fu il principio della fine per la Repubblica polacca, persero ogni loro libertà cadendo sotto il dominio degli Zar della Russia. Un Sulima fu preso prigioniero dai Polacchi e torturato a morte a Varsavia, ma gli altri colonnelli della famiglia si batterono ancor più accanitamente, e la Polonia fu la causa della rovina della Piccola Russia. Quanto a nostro nonno, durante l’invasione di Napoleone I, con il suo reggimento di corazzieri seppe farsi strada attraverso un quadrato di fanteria francese irto di baionette, e poté più tardi guarire dopo essere stato abbandonato sul campo di battaglia con una profonda ferita alla testa. Ma non seppe piegarsi a essere il valletto del favorito di Aleksandr I, l’onnipotente Arakcheef, e fu mandato perciò in una specie di onorevole esilio, prima come governatore generale della Siberia occidentale, poi della Siberia orientale. A quei tempi un posto simile era considerato più rimuneratore di una miniera d’oro, ma nostro nonno tornò dalla Siberia povero come vi era andato, e ai suoi tre figli e alle sue tre figlie non lasciò morendo che un modesto patrimonio. Quando andai in Siberia nel 1862 lo sentii spesso ricordare con rispetto. Era stato quasi spinto alla disperazione dalla spudorata disonestà che regnava in quelle province e che egli non aveva modo di reprimere.
Nostra madre era senza dubbio una donna notevole e rara per i suoi tempi. Molti anni dopo la sua morte trovai in un angolo di un solaio della nostra villa un mucchio di carte coperte della sua bella e ferma calligrafia: pagine di diario nelle quali descriveva con entusiasmo il paesaggio tedesco e parlava della sua tristezza e della sua sete di felicità; altre contenevano poesie russe proibite dalla censura, notevoli le belle ballate storiche di [Kondratij] Ryleev, il poeta che Nicola I fece impiccare nel 1826; altri quaderni contenevano musica, drammi francesi, poesie di Lamartine e di Byron, e un gran numero di acquerelli.
Alta, snella, con una folta capigliatura castano scura, occhi grandi e scuri e bocca piccolissima, sembra vivere ancora nel grande ritratto dipinto con amore da un bravo pittore. Sempre vivace e spesso molto allegra, amava il ballo e le contadine del nostro villaggio ricordavano sovente come volentieri ammirasse dal balcone i loro balli in tondo – cadenzati e pieni di grazia – e come spesso finisse per scendere e prendervi parte. Aveva un temperamento artistico. Fu una festa da ballo la causa di un raffreddore che degenerò in una polmonite, le cui conseguenze la portarono al sepolcro.
Tutti quelli che la conoscevano l’amavano e i servi adoravano la sua memoria. Fu in nome suo che Madame Burman ci curò e che la bambinaia russa ci colmò del suo affetto. Mentre ci pettinava o ci faceva il segno della croce, la sera, quando eravamo a letto, Uliana spesso diceva: “E ora la vostra mamma vi guarda dal cielo e piange vedendovi poveri orfanelli”. Tutta la nostra infanzia è stata illuminata dalla sua memoria. Quante volte in qualche andito oscuro la mano di un servo ci ha accarezzati affettuosamente, o una contadina incontrandoci nei campi ci ha detto: “Sarete buoni voi, come la vostra mamma? Lei aveva pietà di noi. L’avrete anche voi, non è vero?”.
Noi, voleva dire i servi. Non so cosa sarebbe stato di noi se non avessimo trovato in casa, fra i servi, quell’atmosfera d’amore indispensabile per i bambini. Eravamo i suoi figlioli, le assomigliavamo, ed essi ci prodigavano le loro cure, qualche volta in una forma patetica, come vedremo più avanti.
L’uomo aspira a vivere ancora dopo la morte, ma come mai non si accorge che la memoria di una persona veramente buona vive sempre? Rimane impressa fortemente nella nuova generazione e viene tramandata ai figli. Non è forse questa un’immortalità degna di ogni sacrificio?
Due anni dopo la morte di nostra madre, nostro padre riprese moglie. Aveva già incominciato a far la corte a una signorina molto graziosa e questa volta anche di una famiglia ricca; ma era destino che andasse diversamente. Una mattina, mentre ancora stava vestendosi, i servi irruppero concitati in camera sua per annunciargli l’arrivo del generale Timofeev, il comandante del sesto corpo d’armata al quale egli apparteneva. Questo favorito di Nicola I era un uomo terribile. Era capace di far frustare quasi a morte un soldato per un errore commesso durante la parata e di degradare un ufficiale e mandarlo in Siberia come soldato semplice se gli capitava di incontrarlo per la strada con l’alto e rigido colletto aperto. La parola del generale Timofeev poteva tutto presso Nicola I.
Il generale, che non aveva mai messo piede in casa nostra, veniva ora a proporre a nostro padre di sposare la nipote di sua moglie, la signorina Elisabetta Karandino, una della molte figlie di un ammiraglio della flotta del Mar Nero, una fanciulla dal profilo classico, ritenuta molto bella. Nostro padre acconsentì e il secondo matrimonio fu celebrato, come il primo, con grande sfarzo.
“Voi giovani non capite niente di queste cose”, soleva dirmi mio padre quando mi raccontava questo avvenimento, con un fine umorismo che non cercherò di riprodurre. “Ma sai tu cosa voleva dire a quei tempi un generale d’armata – e soprattutto uno come quel diavolo guercio, – così lo chiamavano, che veniva in persona a proporre un matrimonio?”. Naturalmente la ragazza non aveva altra dote che una grande cassa piena di stracci e la sua unica serva Marta, bruna come una zingara, seduta sopra.
Non mi rimane nessun ricordo di questo avvenimento. Solo rivedo un grande salone, addobbato riccamente, e in questo una signora giovane e piacente, benché di aspetto meridionale, un po’ troppo duro, che scherzava con noi, dicendo: “Vedrete che mamma allegra sarò io per voi!”. Al che io e Sascia rispondevamo imbronciati: “La nostra mamma è volata in cielo”. Tanta vivacità ci insospettiva.
Venne l’inverno e incominciò per noi una vita nuova.
La nostra casa fu venduta, ne fu comperata un’altra che venne ammobiliata completamente di nuovo. Tutto quello che ricordava nostra madre sparì, i suoi ritratti, i suoi acquerelli, i suoi ricami. Madame Burman implorò inutilmente di rimanere in casa nostra, promettendo di dedicarsi al bambino che aspettava la nostra matrigna come se fosse stato figlio suo: fu licenziata. “Nulla dei Sulima in casa mia”, le fu risposto. Fu rotto ogni rapporto con i nostri zii e con la nonna. Uliana fu sposata a Frol, che diventò maggiordomo, e diventò governante; la nostra educazione fu affidata a un maestro francese, Monsieur Poulain, lautamente pagato, e a uno studente russo, N. P. Smirnov, che ebbe uno stipendio irrisorio.
In molte famiglie della nobiltà moscovita i ragazzi erano allora istruiti da professori francesi, che rappresentavano i brandelli della Grande Armata napoleonica. Monsieur Poulain era uno di questi. Aveva allora terminato l’educazione del figlio minore del romanziere [Michail] Zagoskin, e il suo allievo Sergio godeva una tal fama di ragazzo bene educato nel Vecchio Quartiere degli Scudieri Reali, che nostro padre non esitò ad assumere Monsieur Poulain con l’alto stipendio di 600 rubli all’anno.
Monsieur Poulain portò con sé il suo cane da caccia Trésor, la sua caffettiera stile impero, i suoi libri di testo francesi, e incominciò a regnare su di noi e sul servo Matvej che ci era stato destinato.
Il suo sistema d’istruzione era semplicissimo. Dopo averci svegliati prendeva il suo caffè in camera. Poi, mentre noi preparavamo le lezioni del mattino, si vestiva con cura minuziosa, pettinava i capelli grigi in modo da nascondere la calvizie inoltrata, indossava l’abito nero, si spruzzava e si lavava con l’acqua di Colonia e finalmente ci conduceva da basso per dare il buon giorno ai genitori. Trovavamo nostro padre e la nostra matrigna a colazione, ci avvicinavamo ripetendo cerimoniosamente “Bonjour, mon cher papa” e “Bonjour, ma chère maman”, e baciavamo loro le mani. Monsieur Poulain faceva un saluto complicato ed elegante, dicendo: “Bonjour Monsieur le Prince” e “Bonjour Madame la Princesse”, e immediatamente la processione si ritirava al piano di sopra. Questa cerimonia si ripeteva tutte le mattine.
Allora incominciava il lavoro. Monsieur Poulain cambiava l’abito nero per la veste da camera, metteva in testa un berretto di cuoio, e sprofondandosi in una poltrona, diceva: “Recitate la lezione”.
Si recitava a memoria da un segno fatto con l’unghia sul libro fino a un altro. Monsieur Poulain aveva portato con sé la grammatica di Nöel e Chapsal, memorabile a più di una generazione di ragazzi e ragazze russi, un libro di dialoghi francesi, una storia del mondo in un volume, una geografia universale, pure in un volume. Dovevamo imparare a memoria la grammatica, i dialoghi, la storia e la geografia.
La grammatica con le sue frasi ben note: “Cos’è la grammatica? L’arte di parlare e di scrivere correttamente”, andava bene. Ma il libro di storia disgraziatamente era preceduto da una prefazione nella quale si enumeravano, illustrandoli, i vantaggi che porta lo studio di questa materia. Da principio tutto andava bene. Recitavamo: “Il principe vi trova esempi magnanimi per il governo dei suoi sudditi; il militare vi impara la nobile arte della guerra”. Ma quando si arrivava alla legge, tutto andava a rotoli. “Il giureconsulto vi trova…”: ciò che il cultore di giurisprudenza trova nella storia non lo sapemmo mai. Quella terribile parola, “giureconsulto”, rovinava tutto, e incapaci di continuare, ci fermavamo di botto.
“In ginocchio, gros pouf!” gridava Poulain (questo era per me). “In ginocchio, grand dada!” (questo era per mio fratello); e restavamo inginocchiati piangendo e sforzandoci invano di imparare i vantaggi della storia per il giureconsulto.
Quella prefazione ci fruttò un monte di guai. Imparavamo già la storia romana, buttavamo dei pezzi di legno sulla bilancia quando Uliana pesava il riso, “come Brenno”, saltavamo dalla tavola o da altri simili precipizi per salvare la nostra patria, in ricordo di Curzio; ma di tanto in tanto Monsieur Poulain tornava alla prefazione e di nuovo ci faceva inginocchiare per quel medesimo “giureconsulto”. C’è da meravigliarsi se più tardi io e mio fratello ostentavamo il più gran disprezzo per la giurisprudenza?
Non so che sarebbe avvenuto della geografia, se il libro di Monsieur Poulain avesse avuto una prefazione. Fortunatamente le prime venti pagine del libro erano state strappate (immagino che Sergio Zagoskin ci avesse reso questo grande servizio) e così le nostre lezioni incominciarono a pagina ventuno, che trattava “dei fiumi che irrigano la Francia”.
Bisogna confessare che non sempre la faccenda terminava con una semplice inginocchiatura. C’era una canna nella stanza, e Monsieur Poulain se ne serviva quando non c’era più speranza di progressi nella prefazione o in qualche dialogo sulla virtù e il decoro. Ma un giorno nostra sorella Elena, che, tornata allora dall’Istituto Caterina per le signorine, occupava una camera sotto la nostra, sentendo le nostre grida corse piangendo nello studio del babbo, e lo rimproverò aspramente di averci dato in balia della nostra matrigna che ci aveva abbandonato nelle mani di “un tamburino francese in riposo”. “Naturalmente”, esclamò, “non c’è nessuno per difenderli, ma io non posso vedere i miei fratelli trattati a quel modo da un tamburino”.
Preso così alla sprovvista, nostro padre non seppe difendersi. Cominciò a sgridare Elena, ma finì per approvare il suo amore per i fratelli. E da quel giorno in poi la canna fu adoperata esclusivamente per insegnare le buone maniere a Trésor.
Appena terminati i gravi doveri scolastici, Monsieur Poulain diventava un altro, un compagno allegro invece del professore terribile. Dopo colazione ci portava a passeggio e i suoi racconti erano inesauribili, si cinguettava come uccelli. Benché sotto la sua guida non oltrepassassimo mai le prime pagine della sintassi, in poco tempo imparammo a parlare correttamente, almeno così ci sembrava, in francese; e quando ebbe finito di dettare la metà di un volume di mitologia, correggendo i nostri errori con il libro alla mano, senza mai spiegarci perché una parola doveva essere scritta in un modo piuttosto che in un altro, avevamo imparato a scrivere correttamente.
Dopo pranzo si faceva la lezione con l’insegnante russo, uno studente di legge dell’Università di Mosca. Ci insegnava secondo i programmi delle scuole russe: grammatica, aritmetica, storia, ecc. Ma a quei tempi un metodo serio di insegnamento era sconosciuto. Ci dettava ogni giorno una pagina di storia, e con questo metodo pratico imparammo in poco tempo a scrivere il russo correttamente.
Il più bel giorno per noi era la domenica, quando tutta la famiglia, ad eccezione di noi ragazzi, andava a pranzo dalla signora generalessa Timofeev. Qualche volta accadeva che fosse data vacanza anche a Monsieur Poulain e a Smirnov, e allora venivamo affidati a Uliana. Dopo aver pranzato alla svelta, ci affrettavamo ad andare nel salone grande, dove presto venivano le cameriere più giovani. Allora si facevano tutti i giochi di nostra conoscenza, mosca cieca, l’avvoltoio e i pulcini e così via; poi Tikon, un uomo che faceva un po’ di tutto, veniva con il violino. Si incominciava a ballare: non quei noiosi balli regolati e diretti da un maestro francese, “su gambe di caucciù”, che facevano parte della nostra educazione; ma un ballo libero che non era una lezione, nel quale una ventina di coppie giravano a piacer loro; e questo non era che l’introduzione del ballo cosacco, ancor più animato e un po’ selvaggio. Allora Tikon dava il violino a un servo più vecchio e cominciava a far giochi così meravigliosi con le gambe, che ben presto le porte del salone erano affollate dai cuochi e anche dai cocchieri che accorrevano per vedere il ballo tanto caro al cuore dei Russi.
Verso le nove partiva la grande carrozza per riportare a casa la famiglia. Tikon, con la spazzola in mano, strisciava sul pavimento per rendergli il lustro primitivo, la casa tornava in perfetto ordine e se l’indomani noi due fossimo stati sottoposti al più severo interrogatorio non ci sarebbe sfuggita una sola parola sui divertimenti della sera prima.
Non avremmo mai tradito uno dei servi, ed essi non ci tradirono mai. Una domenica mio fratello ed io, divertendoci da soli nel grande salone, urtammo contro una mensola che reggeva una lampada di valore. La lampada andò in frantumi. Immediatamente i servi tennero consiglio. Nessuno ci sgridò, ma fu deciso che l’indomani, di mattina presto, Tikon a suo rischio e pericolo sarebbe scappato di casa per andare di corsa al Ponte dei Fabbri a comperare un’altra lampada. Costò quindici rubli, una somma enorme per dei servi; ma fu comperata e non sentimmo mai una parola di rimprovero per tutto questo.
Ripensandoci ora che mi tornano alla memoria queste scene, ricordo che non si udivano mai brutte parole in questi giochi, né mai si vedeva quel genere di ballo che oggi si fa vedere ai ragazzi a teatro. Negli appartamenti dei servi, fra di loro, si servivano certamente di espressioni grossolane; ma noi eravamo bambini – i loro bambini – e questo nobile sentimento ci proteggeva da ogni volgarità.
A quei tempi i bambini non possedevano una profusione di giocattoli come oggi. Noi ne avevamo pochissimi e così dovevamo inventarne.
Avevamo acquistato tutti e due molto presto un certo gusto per il teatro. I teatri popolari di carnevale e gli spettacoli di ladri e soldati non ci lasciarono una grande impressione, giocavamo abbastanza da noi ai ladri e ai soldati. Ma la grande diva del ballo, Fanny Elssler, venne a Mosca e andammo a vederla. Quando nostro padre prendeva un palco a teatro ne sceglieva sempre uno dei migliori e lo pagava bene, ma poi insisteva perché tutta la famiglia lo utilizzasse appieno. Benché fossi allora un fanciullo, Fanny Elssler mi fece una tale impressione di grazia, di leggerezza, di armonia, che non ho mai più potuto prendere alcun piacere al nostro modo russo di ballare, che appartiene più alla ginnastica che all’arte.
Il balletto che vedemmo allora, Gitana, la zingara spagnola, fu naturalmente ripetuto da noi a casa: beninteso per quanto riguardava il soggetto, non la parte coreografica. Avevamo un palcoscenico già pronto, perché la nostra camera da letto era separata da una tenda dallo studio. Alcune sedie disposte a semicerchio davanti alla tenda, con una poltrona in mezzo per Monsieur Poulain, sostituivano la sala e il palco imperiale e il pubblico fu trovato facilmente nel maestro russo, Uliana e qualche cameriera.
Bisognava trovar modo di rappresentare due scene del ballo: una dove la piccola Gitana viene portata in un baroccio al campo degli zingari, e quella nella quale Gitana fa la sua prima comparsa sulla scena scendendo una collina e attraversando un ponte sopra un ruscello che ne riflette l’immagine. A questo punto il pubblico applaudiva freneticamente e gli applausi, secondo noi, erano dovuti all’effetto del fiume.
Trovammo la nostra Gitana nella persona di una delle cameriere più giovani; il suo vecchio vestito di cotonina blu non costituiva un ostacolo alla personificazione di Fanny Elssler. Una sedia rovesciata, che spingevamo avanti, faceva le veci del baroccio. Ma il ruscello? Due sedie e la lunga asse da stirare del sarto Andrei facevano da ponte, un pezzo di stoffa di cotonina turchina fingeva l’acqua. Ma l’immagine del ponte riflessa nell’acqua non voleva comparire, malgrado tutti i nostri sforzi fatti con lo specchietto di Monsieur Poulain. Dopo molti tentativi inutili dovemmo rinunciarvi, ma persuademmo Uliana a fare come se vedesse l’immagine e ad applaudire fragorosamente: così alla fine cominciammo a credere che l’effetto scenico non fosse del tutto mancato.
La Fedra di Racine, o perlomeno l’ultimo atto, era un altro dei nostri pezzi forti; Sascia cioè recitava benissimo i versi armoniosi: “A peine nous sortions des portes de Trézène”, mentre io restavo assolutamente fermo e indifferente durante tutto il tragico monologo che mi doveva comunicare la morte di mio figlio, finché si giungeva al punto in cui, secondo il testo, io dovevo declamare: “O dieux!”.
Ma qualunque cosa si rappresentasse, lo spettacolo si chiudeva invariabilmente con l’inferno. Si spegnevano tutte le candele meno una che si metteva dietro un foglio di carta rossa trasparente, per imitare le fiamme, mentre mio fratello ed io, nascosti dagli spettatori, cacciavamo urla spaventose per simulare i dannati. Uliana, alla quale non piaceva che si facesse alcun accenno al diavolo all’ora di andare a letto, se ne mostrava contrariata, ma io mi domando ora se questa allegra rappresentazione dell’inferno con una candela e un pezzo di carta non abbia contribuito a liberarci di buon’ora dalla paura del fuoco eterno. Il concetto che ne avevamo era troppo realistico per resistere allo scetticismo.
Ancora bambino vidi i grandi artisti drammatici moscoviti: Sčepkin, Sadovskij e čumrskij ne Il revisore di Gogol e in qualche altra commedia, e mi ricordo non solo di alcune scene più notevoli delle due commedie, ma anche degli atteggiamenti e delle espressioni di questi grandi attori della scuola realistica, che ha oggi una così mirabile interprete nella Duse. Il mio ricordo è così vivo, che quando a Pietroburgo riudii le stesse commedie rappresentate da artisti che declamavano secondo lo stile della scuola francese, non mi piacquero affatto e trovai inferiore la loro arte a quella di Sčepkin e Sadovski, che decisero del mio gusto in fatto di arte drammatica.
Questo mi fa credere che i genitori che desiderano sviluppare il gusto artistico dei loro figli dovrebbero condurli ogni tanto a vedere delle buone commedie, rappresentate veramente bene, invece di riempir loro la testa con le assurdità delle cosiddette “favole” per ragazzi.
A otto anni la mia carriera ebbe inizio in un modo affatto impreveduto. Non ricordo esattamente in che occasione, ma probabilmente fu per il venticinquesimo anniversario del regno di Nicola I, che si organizzarono grandi feste a Mosca. La famiglia imperiale si recava nella vecchia capitale e la nobiltà moscovita si preparava a celebrare questo avvenimento con un ballo in maschera al quale dovevano partecipare anche i bambini. Fu deciso che tutte le svariate nazionalità di cui l’impero russo si compone fossero rappresentate a questo ballo per portare il loro saluto al monarca. In casa nostra, come in tutte le case del vicinato, si fecero grandi preparativi. Un magnifico costume russo fu fatto per la nostra matrigna. Il babbo, essendo militare, naturalmente doveva indossare l’uniforme, ma quelli dei nostri parenti che non erano nell’esercito erano preoccupati quanto le signore dei loro costumi, russi, greci, caucasici. Quando la nobiltà moscovita dà un ballo alla famiglia imperiale, questo deve essere veramente straordinario.
Quanto a me e a mio fratello Aleksandr, eravamo considerati troppo piccoli per partecipare a una cerimonia così importante. Tuttavia vi presi parte. Nostra madre era stata l’amica intima della signora Nazimov, la moglie del generale che era stato governatore di Vilna quando si cominciò a parlare della liberazione dei servi. La signora Nazimov era una bellissima donna e contava di andare al ballo con il suo bambino di dieci anni indossando un meraviglioso costume persiano, per accompagnare il quale era stato preparato per suo figlio un costume da principe persiano, ricchissimo, con una cintura tempestata di gemme.
Ma il bambino si ammalò qualche giorno prima del ballo e la signora Nazimov pensò che uno dei figli della sua più intima amica avrebbe potuto sostituire bene il proprio figlio. Aleksandr e io fummo portati a casa sua per provare l’abito. Era troppo piccolo per Aleksandr, che era molto più alto di me, ma a me andava a perfezione, e così fu deciso che io avrei rappresentato il principe persiano.
L’immensa sala del Palazzo della nobiltà moscovita era affollata di ospiti. A ognuno dei ragazzi fu dato uno stendardo fregiato dello stemma di una delle sessanta province dell’Impero russo. Io ebbi un’aquila svolazzante sopra un mare azzurro, rappresentante, come seppi più tardi, lo stemma del governatorato di Astrakan, sul Mar Caspio. Fummo poi allineati in fondo alla grande sala e avanzammo lentamente in due file verso il palco sul quale stavano in piedi l’imperatore e la sua famiglia. Quando fummo vicino, sfilammo a destra e a sinistra e ci fermammo così allineati davanti al palco. A un segnale convenuto tutti gli stendardi furono abbassati davanti all’imperatore. L’apoteosi dell’autocrazia fu impressionantissima: Nicola ne fu incantato. Tutte le province dell’Impero adoravano il sovrano. Poi noi ragazzi ci ritirammo lentamente in fondo alla sala.
Ma a questo punto nacque una certa confusione. I ciambellani, nelle loro uniformi ricamate d’oro, correvano qua e là e io fui tolto dai ranghi; mio zio, il principe Gagarin, vestito da tungo (e io non sapevo toglier gli occhi dalla sua bellissima giacca di pelle e dalla sua faretra piena di frecce) mi prese in braccio e mi mise nel palco reale.
Fosse perché ero il più piccolo dei bambini, o perché il mio faccino tondo, circondato di riccioli, faceva un effetto comico sotto l’alto berretto di pelo di Astrakan, io non so, ma Nicola volle avermi con sé nel palco e là rimasi, fra generali e signore che mi osservavano con curiosità. Mi raccontarono più tardi che Nicola I, al quale piacevano sempre gli scherzi da caserma, mi prese per il braccio e conducendomi davanti a Maria Aleksandrovna (moglie del principe ereditario) allora incinta del suo terzo figlio, le disse col suo piglio da militare: “Dovete farmi un ragazzo come questo”. Scherzo che la fece arrossire. Ricordo bene che Nicola mi chiese se volevo dei dolci e io risposi che mi piacevano certi biscottini che venivano serviti con il tè (in fatto di dolciumi non si abbondava in casa nostra): egli chiamò un cameriere e ne vuotò un vassoio pieno nel mio berretto alto: “Li porterò a Sascia” gli dissi.
Ma il fratello di Nicola, il granduca Michele, che godeva fama di uomo di spirito, riuscì a farmi piangere. “Quando sei buono,” mi disse, “ti fanno così”. E passò dall’alto in basso la sua larga mano sulla mia faccia. “Ma quando sei cattivo ti fanno così” e mi passò la mano in senso inverso, fregandomi il naso, che aveva già un’accentuata tendenza a crescere in quella direzione. Le lacrime, che cercavo inutilmente di reprimere, mi riempirono gli occhi, e la buona Maria Aleksandrovna mi prese sotto la sua protezione. Mi fece sedere vicino a sé su di un’alta seggiola di velluto con la spalliera dorata, e mi fu poi detto che poco dopo posai la testa sulle sue ginocchia e mi addormentai. Ella non lasciò la sua sedia durante tutto il ballo.
Ricordo pure che mentre aspettavamo la carrozza i nostri parenti mi accarezzavano e mi baciavano dicendo: “Petia, sei stato fatto paggio”. Ma io rispondevo: “Non sono paggio; voglio andare a casa”; ed ero molto preoccupato del mio berretto pieno di bei biscottini che riportavo a Sascia.
Non so se Sascia abbia avuto molti di quei biscotti, ma ricordo l’abbraccio affettuoso che mi diede quando seppe della mia ansietà a proposito del berretto.
Essere iscritto come candidato per il Corpo dei Paggi era allora un grande onore, che Nicola accordava di rado alla nobiltà moscovita. Mio padre ne fu felice e già sognava una brillante carriera di Corte per suo figlio. La nostra matrigna tutte le volte che raccontava questo episodio non mancava di dire: “E tutto perché gli diedi la benedizione prima di andare al ballo”.
Anche la sorte di mio fratello Aleksandr fu decisa l’anno seguente. Verso quell’epoca si celebrò a Pietroburgo il giubileo del reggimento Ismajlovsk, al quale apparteneva mio padre da giovane. Una notte, mentre tutta la casa dormiva, una vettura a tre cavalli, con i campanellini dei finimenti che tintinnavano, si fermò davanti alla nostra porta. Un uomo ne scese gridando: “Aprite! Un’ordinanza di sua Maestà l’Imperatore!”.
Si può immaginare lo spavento che quella visita notturna sparse in casa nostra. Mio padre scese tremando nel suo studio. “Tribunale militare, retrocessione a semplice soldato”, erano parole che risuonavano allora nelle orecchie di tutti i militari; erano tempi terribili.
Ma Nicola non voleva altro che i nomi dei figli di tutti gli ufficiali che avevano appartenuto al reggimento per mandarli alle scuole militari, se ciò non fosse ancor stato fatto. Un messo speciale era stato spedito da Pietroburgo a Mosca, e ora visitava giorno e notte le case degli ex-ufficiali del reggimento Ismajlovsk.
Con mano malferma mio padre scrisse che il suo figlio maggiore, Nicola, era già nel primo corpo dei Cadetti a Mosca, che il minore, Pietro, era candidato del Corpo dei Paggi, e non gli rimaneva che il secondo, Aleksandr, che non era stato ancora avviato alla carriera militare. Poche settimane dopo giunse una lettera che informava mio padre del favore del monarca. Aleksandr doveva entrare in un corpo a Orel, una cittadina di provincia. Per ottenere che fosse iscritto in un corpo di Cadetti a Mosca, mio padre dovette spendere molti denari e molta fatica. Questo nuovo “favore” fu concesso solo in considerazione del fatto che il nostro fratello maggiore era già in quel corpo.
Così per volontà di Nicola I dovevamo ricevere tutti e due una educazione militare, benché dopo pochi anni odiassimo l’uno e l’altro questa carriera per la sua assurdità. Ma Nicola I vigilava perché nessun figlio di nobile potesse dedicarsi a un’altra professione, a meno che lo esigesse la sua salute: dovemmo così diventare tutti e tre ufficiali, con grande soddisfazione di nostro padre.
La ricchezza allora era stimata secondo il numero di anime che un proprietario di terreni possedeva. Tante anime, voleva dire tanti servi maschi, le donne non contavano. Mio padre, che possedeva quasi mille e duecento anime in tre diverse province e che aveva, oltre le tenute dei contadini, grandi estensioni di terreni, era considerato un uomo ricco. Viveva secondo questa reputazione, la sua casa quindi era aperta a un numero illimitato di ospiti e aveva una servitù numerosissima.
Eravamo in otto in famiglia, qualche volta dieci, e anche dodici; una cinquantina di servi a Mosca e il doppio in campagna erano ritenuti appena sufficienti. Quattro cocchieri per custodire una dozzina di cavalli; tre cuochi per il padrone e due per la servitù, dodici camerieri per servire in tavola (un piatto in mano dietro ogni commensale), e innumerevoli ragazze servivano come domestiche. Come si sarebbe potuto fare con meno?
Poi l’ambizione di ogni proprietario era che tutto quel che serviva alla casa fosse fabbricato nell’ambiente familiare, dai suoi stessi servi.
“Com’è sempre bene accordato il vostro pianoforte! Immagino che Herz Schimmel sarà il vostro accordatore!”, avveniva che osservasse un invitato.
Poter rispondere: “Ho in casa il mio accordatore”, era a quei tempi la risposta ideale.
“Che bel pasticcio!”, esclamavano gli invitati quando si portava in tavola un dolce artisticamente lavorato. “Confessate, principe, che è stato fatto da Tremblé” (il pasticciere alla moda).
“È fatto dal mio pasticciere, un allievo di Tremblé, al quale ho permesso di dar prova delle sue capacità”, ecco una risposta che suscitava l’ammirazione generale.
Avere i ricami, i finimenti per i cavalli, mobili – tutto insomma – fatto dai propri uomini, era l’ideale del proprietario ricco e rispettato. Appena arrivavano ai dieci anni i figli dei servi venivano mandati come apprendisti dai negozianti alla moda, dove passavano cinque o sette anni, occupati soprattutto a scopare, ricevere un numero incredibile di bastonate e fare le commissioni per la città. Bisogna confessare che ben pochi diventavano dei maestri nella loro arte. I sarti e i calzolai non sapevano fare che abiti e scarpe per i servi, e quando si voleva un dolce veramente buono, per qualche pranzo di cerimonia, veniva ordinato da Tremblé, mentre il nostro pasticciere suonava il tamburo nella banda.
Questa, dell’orchestra, era un’altra delle ambizioni di mio padre. Quasi tutti i suoi servi, oltre al loro mestiere, sapevano suonare il violoncello o il clarinetto: Makar, l’accordatore di pianoforte, alias sottocredenziere, suonava il flauto; Andrej, il sarto, suonava il corno francese; il pasticciere fu messo dapprima a suonare la grancassa ma maltrattava il suo strumento in un modo così assordante, che gli fu comperata un’enorme tromba, nella speranza che i suoi polmoni non avrebbero fatto tanto danno quanto le sue mani, quando si dovette abbandonare anche questa ultima speranza fu mandato via come soldato. Quanto a “Tikon il macchiato”, oltre alle sue numerose funzioni nella casa come pulitore di lumi, lustratore di pavimenti e cameriere, si rendeva utile nella banda oggi come trombone, domani come fagotto e a volte come secondo violino.
Solo i due primi violinisti facevano eccezione alla regola: erano violinisti e niente altro. Mio padre li aveva comperati, con le loro famiglie, per una forte somma dalle sue sorelle (non vendeva né comperava mai servi fuori dalla sua famiglia). Le serate che non passava al circolo, o quando c’era pranzo e rimaneva a casa, faceva venire la banda di dodici o quindici musicisti.
Suonavano molto bene ed erano molto ricercati per le feste da ballo del vicinato, e anche più quando eravamo in campagna.
Questo dava una grande soddisfazione a mio padre, al quale si doveva chiedere il permesso per avere il favore della sua orchestra. Realmente non vi era nulla che gli piacesse tanto quanto essere pregato per un aiuto, o in questo o in un altro modo: per esempio ottenere una borsa di studi per un ragazzo, o salvare qualcuno da una punizione inflittagli dal tribunale.
Quantunque si abbandonasse ogni tanto alla collera, la sua natura lo portava indubbiamente all’indulgenza e quando si chiedeva il suo aiuto scriveva dozzine di lettere in favore del suo protetto a ogni specie di alti funzionari. In quei periodi la sua corrispondenza, sempre voluminosa, era ingrossata da una mezza dozzina di lettere speciali, scritte in uno stile originalissimo, fra l’ufficiale e l’umoristico, ognuna sigillata naturalmente con il suo stemma, chiusa in una grande busta quadrata, rumorosa come un sonaglio per la gran quantità di polverino che conteneva, la carta asciugante essendo allora sconosciuta. Più il caso era difficile, più egli vi si metteva d’impegno, finché riusciva a ottenere il favore richiesto dal suo protetto, che in molti casi gli era sconosciuto.
A mio padre piaceva aver molti invitati in casa. Si pranzava alle quattro e alle sette la famiglia si raccoglieva intorno al samovar per prendere il tè. I nostri amici erano tutti i benvenuti a quest’ora, e quando tornò a casa nostra sorella Elena non mancarono ospiti giovani e vecchi ad approfittare di quell’abitudine.
Quando le finestre sulla strada si illuminavano, tutti sapevano che la famiglia era in casa e che gli amici sarebbero stati i benvenuti. Quasi tutte le sere avevamo compagnia. I tavoli verdi erano preparati in sala per i giocatori, mentre le signore e la gioventù rimanevano nel salotto e si raccoglievano attorno al pianoforte di Elena. Dopo la partenza delle signore si continuava a giocare a carte, talvolta fino alle prime ore del mattino, e somme considerevoli cambiavano di padrone. Mio padre perdeva invariabilmente. Il vero pericolo per lui, però, non era a casa ma al circolo inglese, dove le scommesse erano molto più alte che nelle case private, e specialmente quando si lasciava persuadere ad andare con dei signori “molto rispettabili” in una delle case aristocratiche del Vecchio Quartiere degli Scudieri Reali dove si giocava tutta la notte. In queste occasioni era quasi certo che avrebbe perso grandi somme.
Si ballava molto di frequente, senza contare le due feste da ballo d’obbligo tutti gli inverni. In queste occasioni mio padre voleva che tutto fosse fatto molto bene, senza badare a spese. Ma al tempo stesso un’economia così meschina prevaleva nella nostra vita quotidiana, che se lo raccontassi sarei tacciato d’esagerazione. Si dice di una famiglia di pretendenti al trono di Francia, rinomata per le sue partite di caccia veramente regali, che nella vita quotidiana lesinasse persino le candele di sego. La medesima grettezza si usava in casa nostra a ogni proposito, tanto che noi figli, cresciuti, avemmo poi sempre in odio il risparmio e il calcolo. Ma nel Vecchio Quartiere degli Scudieri Reali questo sistema di vita non faceva che accrescere la stima nella quale era tenuto mio padre.
“Il vecchio principe”, si diceva, “sta attaccato al denaro per le spese di casa, ma sa come deve vivere un nobile”.
Nelle nostre strade tranquille e pulite quello era il genere di vita più rispettato. Uno dei nostri vicini, il generale D., viveva con molto lusso, ma nonostante questo tutte le mattine si svolgevano le scene più comiche fra lui e il suo cuoco. Fatta colazione, il vecchio generale, fumando la pipa, dava gli ordini per il suo pranzo.
“Bene, ragazzo mio”, diceva al cuoco che entrava tutto vestito di bianco, “oggi non saremo in molti: soltanto due invitati. Ci farai una minestra in brodo, sai, con qualche primizia primaverile, pisellini, fagiolini freschi o qualche cosa di simile. Sai bene che la signora preferisce a tutto una buona minestra di verdura alla francese”.
“Va bene, signore”.
“Poi farai quel che ti piace come entrée”.
“Va bene, signore”.
“So che gli asparagi non sono ancora di stagione, ma ieri ne ho visti dei mazzi molto belli in negozio”.
“Sissignore: dieci lire il mazzo”.
“Va bene. Noi siamo stanchi dei tuoi arrosti di polli e di tacchini, dovresti darci qualche cosa di nuovo”.
“Della selvaggina, signore?”.
“Sì, sì, tanto per cambiare”.
Quando si erano messi d’accordo sulle sei portate, il vecchio generale chiedeva: “Ora quanto ti devo dare per la spesa? Basteranno otto lire, credo!”.
“Ce ne vorranno venticinque, signore!”
“Sei matto, ragazzo mio! Ecco otto lire, ti assicuro che bastano”.
“Dieci lire di asparagi, cinque di legumi…!!”
“Ma senti un poco, figlio mio benedetto, sii ragionevole. Ti darò dieci lire e cerca di fare economia”. E continuavano a contrattare così per mezz’ora, finché si mettevano d’accordo sulla cifra di lire 18,60, purché il pranzo del giorno dopo non costasse più di quattro lire! Allora il generale, contento di aver fatto un affare tanto buono, saliva in slitta e faceva il giro dei negozi di moda, tornando tutto allegro con una bottiglia di profumo finissimo per sua moglie, che aveva pagato un prezzo pazzesco dal profumiere francese, e dicendo alla figlia che nel pomeriggio le avrebbe portato un nuovo mantello di velluto, “qualche cosa di molto semplice e di molto ricco…”.
Tutti i nostri parenti, numerosi da parte paterna, vivevano precisamente così, e se ogni tanto una nuova tendenza faceva capolino, prendeva quasi sempre la forma di fanatismo religioso. Così un principe Gagarin si fece gesuita, con grande scandalo di “tutta Mosca”. Un altro giovane principe si ritirò in un monastero e parecchie signore attempate diventarono fanaticamente devote.
C’era una sola eccezione a questa regola. Uno dei nostri parenti più prossimi, il principe – chiamiamolo Mirskij – aveva passato la gioventù a Pietroburgo come ufficiale della Guardia. Non gli interessava affatto di avere i propri sarti o ebanisti, poiché la sua casa era riccamente arredata con mobili moderni, e i suoi abiti venivano confezionati nelle prime sartorie di Pietroburgo. Non si appassionava al gioco, faceva la partita solo quando era in compagnia delle signore, ma aveva un debole per la cucina, per la quale spendeva somme incredibili.
La Quaresima e la Pasqua erano le epoche delle sue più grandi stravaganze. Quando arrivava la Quaresima e non era più permesso mangiare carne, panna o burro, ne approfittava per inventare ogni specie di squisitezze in fatto di pesce. Saccheggiava a questo scopo le migliori botteghe delle due capitali, spediva messi speciali nelle sue proprietà alle bocche del Volga perché ne riportassero con i cavalli di posta (non c’erano ancora le ferrovie) uno storione di straordinaria grandezza o qualche rarità in fatto di pesce salato. E quando arrivava la Pasqua non c’era più limite alle sue trovate.
La Pasqua è in Russia la più venerata e anche la più allegra delle feste. È la festa della primavera.
Gli enormi mucchi di neve che hanno ingombrato le strade tutto l’inverno si fondono rapidamente e corrono formando dei ruscelli lungo le vie. Non come un ladro, che avanza furtivamente, ma decisa e a viso aperto viene la primavera, portando ogni giorno un cambiamento nella condizione della neve e un progresso nel germogliare degli alberi; le brinate notturne bastano solo a regolare un poco il disgelo. L’ultima settimana della Quaresima, la settimana santa, veniva celebrata a Mosca, durante la mia infanzia, con una solennità straordinaria: erano giorni di lutto universale e le chiese erano affollate di gente che accorreva per sentire la lettura di quei passi del Vangelo che trattano della passione di Cristo.
Non solo non si mangiava né carne, né uova, né burro, ma neanche pesce; i più severi non toccavano affatto cibo il venerdì santo. Tanto maggiore era quindi il contrasto quando giungeva la Pasqua.
Il sabato andavano tutti alla messa di mezzanotte, che incominciava lugubremente. Poi tutto a un tratto, quando suonava la mezzanotte, si proclamava la Resurrezione. Subito tutte le chiese si illuminavano e un allegro scampanio risuonava da cento e cento campanili. Cominciava un’allegria generale; tutti si abbracciavano e si baciavano tre volte in viso, ripetendo le parole della resurrezione e le chiese, ora sfolgoranti di luce, erano animate dagli abiti primaverili delle donne.
Quasi tutte erano vestite a nuovo e le più povere aspettavano quella notte per far sfoggio dell’unico loro vestito.
Al tempo stesso la Pasqua era, ed è ancora, la scusa per una vera orgia di ghiottoneria. Speciali formaggi pasquali di panna (paska) e pane pasquale (koolich) vengono preparati per quel giorno, e tutti, anche il più miserabile, devono avere una piccola paska e un piccolo koolich con almeno un uovo colorato di rosso da fare benedire in chiesa e poi servirsene per rompere il digiuno. Gran parte dei vecchi russi incominciavano a mangiare durante la notte, dopo una breve messa pasquale, appena riportato il cibo benedetto dalla chiesa, ma nelle case dell’aristocrazia la cerimonia veniva rimandata alla domenica mattina, quando si imbandiva la tavola ricoprendola di ogni genere di carne e formaggi e pasticceria, e tutti i servitori venivano a scambiare tre baci e un uovo rosso con i loro padroni. La settimana seguente nella grande entrata veniva tenuta una tavola coperta di vivande pasquali e tutti gli ospiti dovevano gustarne.
In questa occasione il principe Mirskij superava se stesso. Fosse a Pietroburgo o a Mosca, i corrieri gli portavano a casa dalla sua proprietà un formaggio di panna preparato apposta per la paska, e con questo il suo cuoco riusciva a fare un dolce artistico. Altri corrieri accorrevano dalla provincia di Novgorod con il prosciutto salato che il principe aveva l’abitudine di far servire alla sua tavola pasquale. E mentre la principessa e le sue due figlie visitavano i monasteri più austeri, dove la messa di mezzanotte durava due o tre ore di seguito e passavano tutta la settimana santa il più austeramente possibile, mangiando solo un pezzo di pane duro negli intervalli fra le visite ai vari predicatori, ortodossi, cattolici e protestanti, il marito faceva ogni mattina il giro dei famosi negozi di Mitatin a Pietroburgo, dove ogni genere di ghiottoneria viene portata da ogni parte del mondo. Là sceglieva le cose più costose per la sua tavola pasquale. Centinaia di ospiti visitavano la sua casa e tutti venivano pregati di gustare questa o quella rarità.
Il risultato fu che il principe si mangiò letteralmente una fortuna considerevole. La sua casa riccamente arredata e la sua bella proprietà di campagna furon vendute, e quando il principe e la principessa divennero vecchi, non rimase loro più nulla, neppure la vecchia casa di famiglia, e dovettero andare a vivere in casa dei loro figliuoli.
Non c’è da meravigliarsi se l’emancipazione dei servi rovinò quasi tutte queste famiglie del Vecchio Quartiere degli Scudieri Reali. Ma non anticipiamo gli avvenimenti.
Sarebbe stato disastroso mantenere tanti servitori quanti ne avevamo in casa nostra, se avessimo dovuto comperare le provviste a Mosca; ma a quei tempi la cosa era molto semplice. Quando veniva l’inverno, mio padre si metteva al tavolo e scriveva:
“All’amministratore della mia proprietà di Nikolskoje, nel governatorato di Kaluga, distretto di Mešovsk, sul fiume Sirena, da parte del principe Aleksej Petrovič Kropotkin, colonnello e comandante di diversi ordini.
“Ricevuto questo e non appena stabilite le comunicazioni invernali, ti ordino di spedire a casa mia, nella città di Mosca, venticinque slitte da contadini, tirate ognuna da due cavalli (un cavallo da ogni casa e una slitta e un uomo ogni due case) e di caricarle di tanti sacchi di biada, di tanti di frumento, di tanti di segale e anche di tutto il pollame, oche e anatre, ucciso al principio dell’inverno, ben congelato, ben imballato, il tutto accompagnato da una lista completa e sotto la sorveglianza di un uomo di fiducia”; e continuava così per un paio di pagine, senza mai interrompere il periodo. Poi faceva seguire l’enumerazione delle pene in cui sarebbe incorso l’amministratore nel caso che le provviste non fossero arrivate alla sua casa, situata nella tal strada, al tal numero, il giorno fissato e in buono stato.
Un po’ prima di Natale le venticinque slitte da contadini passavano veramente la nostra cancellata e venivano a riempire il grande cortile.
“Frol!”, gridava mio padre, subito informato del grande avvenimento. “Kiriuška, Yegorka! Dove sono? Ruberanno tutto! Frol, vai a ricevere la biada; Uliana, vai a prendere il pollame; Kiriuška, chiama la principessa!”.
Tutta la casa era sottosopra, i servi correvano di qua e di là, dall’entrata al cortile, dal cortile all’entrata, ma soprattutto alla sala della servitù, per comunicarsi le notizie di Nikolskoje: “Pascia si sposa dopo Natale, la zia Anna ha reso l’anima a Dio”, e così giungevano anche le lettere dalla campagna, e ben presto una delle cameriere veniva di nascosto in camera mia.
“Sei solo? Non c’è il professore?”.
“No, è all’Università”.
“Allora sii buono e leggimi questa lettera della mamma”.
E mi mettevo a leggerle la lettera ingenua che incominciava sempre con le parole: “Padre e madre ti mandano la loro benedizione per secoli senza fine”. Seguivano poi le notizie: “La zia Eufrasia è a letto ammalata, tutte le ossa le dolgono; tua cugina non è ancora sposa, ma spera di sposarsi dopo Pasqua; la mucca della zia Stefania morì il giorno di Ognissanti”. Dopo le notizie venivano i saluti, due pagine intere: “Tuo fratello Paolo ti manda a salutare, così pure le tue sorelle Maria e Doria”, e così di seguito. Ma nonostante la monotonia dell’enumerazione, ogni nome dava luogo a qualche osservazione. “Vuol dire che vive ancora, poverina, se manda i saluti, sono nove anni che giace immobile!”, oppure: “Oh, non mi ha dimenticato; allora, sarà di ritorno per Natale; un così bravo giovane! Mi scriverai una lettera, non è vero? Allora bisognerà che non mi dimentichi di lui”. Naturalmente mantenevo la promessa e più tardi scrivevo la lettera nell’identico stile.
Quando le slitte erano state scaricate, l’entrata si riempiva di contadini. Avevano indossato le loro giacche da festa sopra le pelli di montone e aspettavano che mio padre li chiamasse nel suo studio per parlargli della neve e delle speranze per il nuovo raccolto.
Osavano appena camminare con i loro stivaloni sul pavimento lucido. Pochi si arrischiavano a sedersi sull’orlo di una panca di quercia e rifiutavano energicamente di servirsi delle sedie. Aspettavano così per ore intere, guardando con occhi spaventati chiunque entrasse o uscisse dalla camera del babbo.
Più tardi, quasi sempre il giorno dopo, una delle serve correva cautamente nel mio studio.
“Sei solo?”.
“Sì”.
“Allora corri. I contadini vogliono vederti; hanno notizie della tua balia”.
Appena sceso uno dei contadini mi consegnava un fagottino contenente qualche pane di segale, una mezza dozzina di uova sode e poche mele, avvolte in un fazzoletto dai colori vivaci.
“Prendi, è la tua balia, Vasilissa, che te lo manda. Guarda se le mele sono gelate, spero di no: l’ho tenuto sul petto tutto il tempo del viaggio. Abbiamo avuto delle brinate così forti”. E la larga faccia barbuta, morsa dal gelo, sorrideva scoprendo due file di denti bianchissimi sotto una foresta di peli.
“E questo è per tuo fratello, da parte della sua balia Anna”, diceva un altro contadino, consegnandomi un altro fagottino come il primo.
Arrossivo e non sapevo cosa dire, poi finalmente mormoravo: “Di’ a Vasilissa che la bacio, così ad Anna per mio fratello”, e tutti i volti allora si illuminavano di sorrisi.
“Lo farò, certo”.
Allora Kirila, che stava di guardia alla porta di papà, sussurrava in fretta: “Va su alla svelta, tuo padre può uscire da un momento all’altro. Non dimenticare il fazzoletto, lo devono riportare.
Mentre piegavo accuratamente il vecchio fazzoletto, avrei desiderato mandare qualche cosa a Vasilissa. Ma non avevo nulla, neppure un giocattolo, e non si aveva mai del denaro!
Naturalmente il periodo più bello per noi era quello che passavamo in campagna. Passata la Pasqua e la Pentecoste, ogni nostro pensiero era rivolto a Nikolskoje. Nostro padre aveva ancora molti affari che lo trattenevano in città. Finalmente cinque o sei carri da contadino entravano nel cortile: venivano per trasportare roba di ogni specie nella nostra casa di campagna. La grande carrozza antica e le altre vetture nelle quali si doveva fare il viaggio venivano portate fuori dalla rimessa e ispezionate. Si incominciavano a fare i bauli; le nostre lezioni andavano a rilento, ogni momento si interrompevano i professori per chiedere se dovevano portare questo o quel libro, e molto prima di tutti gli altri noi incominciavamo a imballare le nostre cose, la lavagna e i giocattoli che ci eravamo fabbricati noi stessi.
Tutto era pronto; i carri dei contadini aspettavano, carichi di mobili per la villa, di casse con le masserizie di cucina e innumerevoli bottiglie che riportavamo in autunno piene di conserve. I contadini aspettavano ogni mattina per ore intere nell’entrata: ma l’ordine della partenza non veniva dato. Mio padre continuava a scrivere tutta la mattina in camera sua e verso sera spariva. Finalmente interveniva la nostra matrigna, dopo che la sua cameriera si era fatta coraggio e le aveva detto che i contadini erano ansiosi di ritornare, avvicinandosi l’epoca della falciatura del fieno.
Il giorno dopo nel pomeriggio Frol, il maggiordomo, e Michail Aleiev, il primo violinista, venivano chiamati in camera da nostro padre. Un sacchetto con il denaro per il vitto pochi centesimi al giorno per ognuno dei quaranta o cinquanta uomini che dovevano accompagnare la famiglia a Nikolskoje veniva consegnato a Frol con una lista. In questa lista erano enumerati l’orchestra per intero, poi i cuochi e i sottocuochi, la stiratrice, la sottostiratrice, benedetta da una famiglia di sei bambini! “Polka la strabica”, “Domna la grossa”, “Domna la piccola” e tutti gli altri.
Il primo violino riceveva un “ordine di marcia”, che io conoscevo bene perché mio padre, accorgendosi che non arrivava mai alla fine, mi chiamava per trascriverlo nel libro dove teneva copia di tutte le carte che uscivano.
“Al mio servo, Michail Aleiev, dal principe Aleksej Petrovič Kropotkin, colonnello e comandante.
“Tu devi, il 29 maggio, alle ore 6 della mattina, metterti in marcia con i miei carri dalla città di Mosca per la mia proprietà, situata nel governatorato di Kaluga, distretto di Mešovsk, sul fiume Sirena a una distanza di 160 miglia da questa casa; sorvegliare la condotta degli uomini affidati a te, e se qualcuno di loro si rende colpevole di cattiva condotta, di ubriachezza o di insubordinazione, conduci detto uomo davanti al comandante del distaccamento della guarnigione del corpo, e chiedi che sia punito con una fustigazione (il primo violinista sapeva bene di che si trattava) come esempio per gli altri.
“Ti ordino inoltre di avere speciali riguardi per l’integrità delle cose affidate a te, e di conformarti al seguente ordine di marcia: giorno primo, ti fermerai al villaggio tal dei tali, per far mangiare i cavalli; giorno secondo, passerai la notte nella città di Podolsk”, e così via di seguito, per ognuno dei sette o otto giorni che doveva durare il viaggio.
Il giorno dopo, alle dieci invece che alle sei – la puntualità non è una virtù russa (“Grazie a Dio non siamo Tedeschi”, solevano dire i veri Russi) – i carri si avviavano. I servi dovevano fare il viaggio a piedi, solo i bambini trovavano modo di sedersi dentro qualche cassa o cesta sopra il carro pieno, e qualcuna delle donne riusciva a riposarsi ogni tanto sull’orlo dei carri. Gli altri facevano a piedi tutte le centosessanta miglia.
Finché attraversavano Mosca osservavano una certa disciplina: era severamente proibito portare gli stivaloni e mettere la cinghia attraverso la giacca; ma quando erano sulla strada maestra, dove noi li raggiungevamo dopo due o tre giorni, soprattutto quando sapevano che nostro padre si sarebbe fermato ancora qualche giorno a Mosca, uomini e donne indossavano giacche d’ogni specie la più impensata, si legavano alla cintura fazzoletti di cotone e arsi dal sole o inzuppati dall’acqua, appoggiati a lunghi bastoni tagliati nei boschi, somigliavano più a una banda di zingari che ai domestici di un ricco proprietario. A quei tempi tutte le famiglie facevano di queste peregrinazioni, e quando si vedeva una banda di servi in marcia per una delle strade del nostro quartiere, si sapeva subito che gli Apukintin o i Preganišnikov partivano per la campagna.
I carri se ne erano andati, ma ancora la famiglia non si muoveva. Eravamo tutti stanchi di aspettare; mio padre continuava a scrivere ordini interminabili agli amministratori dei suoi terreni e io li copiavo diligentemente sul libro delle “uscite”. Finalmente ci fu dato l’ordine della partenza. Mio padre ci chiamava tutti e leggeva ad alta voce l’ordine di marcia indirizzato “alla principessa Kropotkin, moglie del principe Aleksej Petrovič Kropotkin, colonnello e comandante”, nel quale erano segnate tutte le fermate del viaggio, che durava cinque giorni. È vero che l’ordine era scritto il 30 maggio e la partenza fissata per le nove di mattina, malgrado il mese di maggio fosse già trascorso e la partenza avvenisse nel pomeriggio, cosa che guastava tutti i calcoli. Ma come si usa negli ordini di marcia militari, questa circostanza era stata prevista e vi si era provveduto con il paragrafo seguente:
“Ma se contrariamente al previsto la partenza di Vostra Altezza non avrà luogo nel detto giorno e alla detta ora, siete pregata di agire secondo il vostro giudizio, per condurre detto viaggio a buon fine”.
A questo punto tutti i presenti, membri della famiglia e servitù, si sedevano un momento, si facevano il segno della croce e salutavano mio padre. “Ti scongiuro, Aleksej, di non andare al circolo”, gli sussurrava la nostra matrigna. La grande carrozza a quattro cavalli con il postiglione era pronta davanti al portone, con la piccola scala per salirvi; anche le altre vetture erano preparate.
I nostri posti erano segnati nell’ordine di marcia, ma la nostra matrigna si trovava a dover “agire secondo il suo giudizio” anche in questa prima parte del nostro viaggio, e partivamo con grande soddisfazione di tutti.
Per noi ragazzi il viaggio era una fonte inesauribile di divertimento. Le tappe erano brevi e ci fermavamo due volte al giorno per dar da mangiare ai cavalli. Poiché le signore strillavano ogni volta che la strada scendeva, si trovò più comodo smontare ogni volta che la strada scendeva o saliva una collina e noi ne approfittavamo per dare qualche occhiata ai boschi che fiancheggiavano la strada o per correre lungo qualche limpido ruscello.
La splendida strada maestra fra Mosca e Varsavia, che seguivamo per qualche tratto, era inoltre ricca di cose interessanti: lunghe file di carri, gruppi di pellegrini e gente di ogni specie. Due volte al giorno ci si fermava in villaggi grandi e animati e, dopo aver a lungo contrattato sul prezzo della biada e del fieno e anche su quello del samovar, si scendeva alla porta di una trattoria. Il cuoco Andrej comperava un pollo e faceva la minestra, mentre noi scappavamo nel bosco o facevamo il giro della fattoria, dei giardini e della trattoria.
Si passava quasi sempre una notte a Malojaroslavec, dove nel 1812 ebbe luogo una battaglia, quando l’esercito russo si sforzò invano di ostacolare la ritirata di Napoleone da Mosca. Monsieur Poulain, che era stato ferito nella guerra spagnola, conosceva o pretendeva di conoscere tutti i particolari della battaglia di Malojaroslavec. Ci conduceva sul luogo della mischia e ci spiegava come i Russi avessero cercato di sbarrare la strada a Napoleone e come la Grande Armata li avesse schiacciati, passando attraverso le linee russe. Spiegava tanto bene gli avvenimenti della giornata, come se anch’egli avesse preso parte ai combattimenti. Qui i Cosacchi tentavano una manovra accerchiante, ma Davout, o qualche altro maresciallo, li aveva sbaragliati e inseguiti oltre quelle colline sulla destra. Là l’ala di Napoleone aveva schiacciato la fanteria russa e qui Napoleone in persona, alla testa della Vecchia Guardia, aveva caricato il centro di Kutusov e si era coperto, insieme alla Guardia, di gloria immortale.
Una volta si prese la vecchia via di Kaluga e ci fermammo a Tarutino; ma Monsieur Poulain fu allora molto meno eloquente. Fu là infatti che Napoleone, volendo ritirarsi a sud, si vide obbligato, dopo una battaglia sanguinosa, a cambiare itinerario e a prendere la via di Smolensk, che il suo esercito aveva già devastato nella sua marcia su Mosca. Ma secondo Monsieur Poulain Napoleone non era stato vinto: era stato solo tradito dai suoi marescialli, altrimenti avrebbe marciato direttamente su Kiev e Odessa, e le sue aquile avrebbero volteggiato sul Mar Nero.
Oltre Kaluga si devono fare cinque chilometri di strada attraverso una bellissima pineta, che ritorna nella mia memoria con i miei più cari ricordi d’infanzia.
In quella foresta la sabbia era alta come in un deserto africano e si faceva tutta la strada a piedi, mentre i cavalli, fermandosi tutti i momenti, trascinavano a stento le vetture attraverso la rena. Quando fui più grande mi piaceva lasciare indietro la famiglia e fare tutta la strada solo. I pini rossi, giganteschi, secolari, si alzavano da ogni parte e non si sentiva altro che il sussurrio del vento tra gli alberi altissimi. In fondo a un piccolo burrone mormorava un limpido ruscello, e un viandante vi aveva lasciato, perché ne usassero i suoi compagni, un ramaiolo a forma di imbuto, fatto di corteccia di betulla con un bastoncino lavorato a mano. Uno scoiattolo correva silenzioso su per una pianta, e il bosco ceduo era pieno di mistero quanto gli alti alberi secolari. In quella foresta nacque il mio amore per la natura e là provai per la prima volta il vago sentimento della sua eterna vita.
Oltre la foresta, passato o traghettato il fiume Ugrà, ci si allontanava dalla strada maestra per entrare negli stretti viottoli campestri, dove le spighe di grano si abbassavano sotto la carrozza e i cavalli riuscivano a strappare qua e là qualche boccata d’erba, mentre correvano uno vicino all’altro, nella strada stretta come una trincea. Finalmente si vedevano i salici, che annunciavano l’avvicinarsi del nostro villaggio, poi a un tratto vedevamo lo snello campanile di un giallo pallido della chiesa di Nikolskoje.
Nikolskoje si adattava mirabilmente alla vita pacifica dei proprietari di quel tempo. Non vi si vedeva quel lusso che caratterizza proprietà più ricche, ma la pianta delle case e dei giardini e l’ordinamento generale rivelavano un senso d’arte. Oltre la villa, costruita di recente da mio padre, vi erano, attorno a un cortile spazioso e ben tenuto, parecchie piccole costruzioni, che consentivano maggiore indipendenza agli inquilini, senza interrompere gli stretti rapporti della vita familiare. Per giungere alla chiesa si doveva attraversare un vasto giardino, coltivato ad alberi da frutta; il versante a mezzogiorno, che conduceva al fiume, era tutto coltivato a fiori, con viali fiancheggiati da cedri, lillà e acacie. Dalla terrazza della villa si godeva una bellissima vista sul fiume, con le rovine di un antico bastione di terra dove i Russi si erano difesi accanitamente all’epoca dell’invasione mongola; al di là si vedeva l’ampia distesa dei campi biondeggianti di spighe mature, chiusa dai boschi all’orizzonte.
Da piccoli abitavamo con Monsieur Poulain in una casa da soli, e dopo che il suo metodo era stato addolcito dall’intervento di nostra sorella Elena, vivevamo con lui nei migliori rapporti. Nostro padre passava sempre l’estate fuori di casa a fare ispezioni militari e la nostra matrigna non badava molto a noi, specialmente dopo la nascita di sua figlia Paolina. Così stavamo sempre con Monsieur Poulain, che godeva molto la villeggiatura e ce la lasciava godere. I boschi, le passeggiate lungo il fiume, le salite su per le colline al vecchio bastione che Monsieur Poulain animava con la pittoresca descrizione della difesa dei Russi e del come cadde in mano dei Tartari; le piccole avventure, una delle quali fece di Poulain il nostro eroe, perché salvò Aleksandr che stava per annegare, uno scontro fortuito con i lupi, erano tante altre impressioni nuove ed emozionanti. Si organizzavano anche grandi gite in comitiva alle quali prendeva parte tutta la famiglia, per raccogliere funghi nel bosco e poi prendere il tè nella foresta, dove abitava un vecchio di cento anni, che teneva le api, solo con il nipote. Altre volte si andava a uno dei villaggi del babbo, dove era stato scavato un grande stagno in cui si prendevano a migliaia le carpe dorate, una parte delle quali era del padrone e le altre venivano distribuite fra i contadini.
La mia balia, Vasilissa, abitava in quel villaggio. La sua famiglia era delle più povere, suo marito non aveva che un ragazzino per aiutarlo e una bambina, la mia sorella di latte, che più tardi diventò una predicatrice e una “Vergine” nella setta di dissidenti religiosi alla quale appartenevano.
Quando andavo da lei, la sua gioia non conosceva confini. Latte, frutta, uova e miele era tutto quello che poteva offrirmi; ma per il modo come li offriva, in piatti di legno risplendenti su una tavola coperta da una tovaglia bianchissima fatta dalle sue mani (fra i dissidenti russi l’assoluta pulizia è un dogma religioso), e per le parole affettuose che mi diceva, trattandomi come un suo figliolo, commoveva profondamente. Lo stesso devo dire per le balie dei miei fratelli Nicola e Aleksandr, che appartenevano a due note famiglie di altre sette di dissidenti di Nikolskoje. Pochi sanno quali tesori di bontà si trovano nel cuore dei contadini russi, anche dopo secoli della più dura oppressione, che avrebbe ben potuto inasprirli!
Quando il tempo era brutto, Monsieur Poulain aveva una quantità di storie da raccontarci, specialmente sulla guerra di Spagna. Gli si faceva ripetere mille volte la storia della ferita che aveva avuto combattendo, e quando arrivava al punto tragico del sangue caldo che gli colava giù nello stivale, noi gli saltavamo al collo baciandolo e chiamandolo con i nomi più affettuosi.
Tutto sembrava prepararci alla carriera militare: i gusti di nostro padre (ricordo che i soli giocattoli che ci regalasse furono una carabina e una vera garitta da sentinella), i racconti di battaglie di Monsieur Poulain, persino la biblioteca a nostra disposizione. Questa biblioteca, una volta proprietà del generale Repninsky nostro nonno materno, uno studioso di cose militari del diciottesimo secolo, si componeva esclusivamente di trattati militari, ornati di belle riproduzioni e riccamente rilegati in cuoio. Il nostro divertimento preferito nei giorni di pioggia era sfogliare questi volumi guardando le illustrazioni, che riproducevano le armi dai tempi degli ebrei in poi e davano la topografia di tutte le battaglie combattute dall’epoca di Alessandro il Macedone. Questi pesanti volumi ci offrivano anche un eccellente materiale per costruire delle fortezze che resistevano per un pezzo agli attacchi di un ariete e ai proiettili lanciati da una catapulta all’Archimede – la quale però mandava ostinatamente le pietre a finire nei vetri, e non tardò a essere proibita. Ma né Aleksandr né io diventammo veri militari. La letteratura degli anni posteriori al 1860 cancellò gli insegnamenti dell’infanzia.
Le opinioni di Monsieur Poulain a proposito delle rivoluzioni erano quelle dell’organo orleanista “L’illustration française” che riceveva dalla Francia e del quale conoscevamo tutte le figure. Per un pezzo non fui capace di immaginare la Rivoluzione altrimenti che come la Morte che cavalca con la bandiera rossa in una mano e la falce nell’altra. È così che era raffigurata nell’“Illustration”. Ma ora credo che questi giudizi di Monsieur Poulain si riferissero esclusivamente alla sommossa del 1848, perché uno dei suoi racconti sulla Rivoluzione del 1789 mi lasciò una impressione ben altrimenti duratura.
In casa nostra si usava il titolo di principe a ogni proposito e anche a sproposito. Questo deve aver urtato Monsieur Poulain, perché una volta si mise a raccontarci quel che sapeva della grande Rivoluzione. Non ricordo bene quel che dicesse, ma di una cosa mi ricordo benissimo, cioè che il conte di Mirabeau e altri nobili rinunciarono un giorno ai loro titoli e che il conte di Mirabeau, per ostentare il suo disprezzo per le pretese aristocratiche, aprì un negozio con l’insegna: “Mirabeau sarto”. (Riferisco la cosa come la ebbi da Monsieur Poulain). Per molto tempo ebbi da fantasticare sul mestiere che avrei scelto, per poter scrivere: “Kropotkin, tal mestiere”.
Più tardi il mio maestro russo e le tendenze repubblicane della letteratura russa esercitarono su di me la stessa influenza, e quando incominciai a scrivere novelle – cioè a dodici anni – adottai la firma P. Kropotkin, che non ho mai più abbandonato, malgrado le osservazioni dei miei superiori militari.
Nell’autunno del 1852 mio fratello Aleksandr fu mandato al corpo dei Cadetti e dopo d’allora ci vedevamo solo durante le vacanze e di rado le feste. Il corpo dei Cadetti era a sei miglia dalla nostra casa e, benché avessimo una dozzina di cavalli, accadeva sempre che quando era l’ora di spedire la slitta al corpo non c’era un cavallo libero da mandare. Mio fratello Nicola tornava a casa molto di rado. La relativa libertà di cui godeva Aleksandr a scuola, e soprattutto l’ascendente di due dei suoi professori di letteratura, svilupparono rapidamente la sua intelligenza, e dirò più tardi della benefica influenza che esercitò sul mio sviluppo. È una grande fortuna avere un fratello maggiore intelligente e affettuoso.
Intanto io restavo in casa. Dovevo aspettare il mio turno per entrare nel Corpo dei Paggi, e non venne prima che io avessi quasi quindici anni. Monsieur Poulain fu licenziato e un maestro tedesco prese il suo posto. Era uno di quegli idealisti molto frequenti fra i Tedeschi e me ne ricordo soprattutto per l’entusiasmo con cui recitava le poesie di Schiller, accompagnandosi con una recitazione ingenua, che mi piaceva moltissimo. Passò un inverno solo in casa nostra.
L’inverno seguente frequentai i corsi di un ginnasio a Mosca e infine rimasi con il nostro maestro russo, Smirnov. Diventammo presto amici, specialmente dopo un viaggio che mio padre ci fece fare insieme nella sua proprietà di Rjazan. Ci divertimmo molto durante questo viaggio inventando ogni genere di buffi scherzi sugli uomini e le cose che vedevamo; e l’impressione che mi fece il paese montuoso che attraversammo aggiunse nuovi delicati accenti al mio amore per la natura.
Sotto l’influenza di Smirnov i miei gusti letterari cominciarono a manifestarsi e durante gli anni fra il 1854 e il 1857 ebbero modo di svilupparsi. Il mio maestro, che aveva allora terminato i suoi studi all’università, ottenne un piccolo posto in un tribunale e vi passava le sue mattinate. Restavo così solo fino all’ora del pranzo e dopo aver preparate le lezioni e fatta una passeggiata mi rimaneva molto tempo libero per leggere e per scrivere. In autunno, quando il maestro ritornò al suo ufficio a Mosca mentre noi eravamo in villeggiatura, rimasi di nuovo solo e, sebbene vivessi con tutta la famiglia e passassi una parte della giornata a giocare con la mia sorellina Paolina, pure potevo disporre a volontà del mio tempo.
La schiavitù volgeva allora alla fine. È storia recente, pare solo ieri, eppure anche in Russia pochi si rendono conto di ciò che era la schiavitù. Si ha generalmente una vaga idea delle pessime condizioni che portava con sé, ma l’effetto morale e intellettuale che essa esercitava sulla persona umana è solo intravisto. È davvero stupefacente osservare la rapidità con cui si dimentica una istituzione sociale e le sue conseguenze quando esse cessano di esistere, e quanto breve tempo sia necessario poi per mutare gli uomini e le cose. Cercherò di evocare le condizioni della schiavitù raccontando ciò che ho visto senza tener conto di quello che ho sentito dire.
Uliana, la governante, sta davanti alla porta di mio padre e si fa il segno della croce: non osa avanzate né retrocedere. Finalmente, recitata una preghiera, si decide a entrare e con un fil di voce dice che la provvista di tè sta per terminare, che non ci sono più di venti chili di zucchero e che le altre provviste saranno presto esaurite.
“Ladri, assassini!”, urla mio padre, “e tu, tu sei in lega con loro tutti”. La sua voce tonante si sente per tutta la casa. La nostra matrigna lascia che Uliana affronti da sola la tempesta. Mio padre grida: “Frol, chiama la principessa! Dov’è?”, e quando arriva le fa i medesimi rimproveri:
“Anche voi siete in lega con questa stirpe di Cam; voi li proteggete”. E così per mezz’ora.
Comincia poi a verificare i conti. Intanto si ricorda del fieno: Frol è mandato a pesare quello che rimane e la nostra matrigna deve essere presente alla pesatura, mentre mio padre calcola quanto ce ne dovrebbe essere nel fienile. Pare ne manchi una quantità considerevole e Uliana non sa rendere conto di parecchi chili di certe provviste. La voce di mio padre diventa sempre più minacciosa, Uliana trema; ma ora entra il cocchiere e la tempesta si scarica su di lui. Mio padre gli salta addosso, lo colpisce, ma egli continua a ripetere: “Vostra Altezza deve essersi sbagliato”.
Mio padre rivede i conti e questa volta pare che il fieno sia troppo.
Le lamentele continuano: adesso rimprovera il cocchiere di non aver dato abbastanza da mangiare ai cavalli, ma il cocchiere chiama tutti i santi a testimoni che egli ha dato alle bestie tutto quello che doveva e Frol invoca la Madonna per confermare le parole del cocchiere. Ma mio padre non si lascia calmare.
Fa chiamare Makar, l’accordatore e sottocredenziere, e gli rimprovera tutti i suoi recenti peccati: era ubriaco la settimana scorsa e dev’essere stato ubriaco ieri, perché ha rotto una mezza dozzina di piatti. In realtà la rottura di quei piatti era la vera ragione di tutta la tempesta; la nostra matrigna l’aveva raccontata quella mattina a mio padre ed era per questo che Uliana era stata sgridata più del solito, per questo che si era dovuto verificare il peso del fieno, ed è sempre per questo che mio padre continua a gridare che questa “stirpe di Cam” merita tutti i castighi immaginabili.
A un tratto la burrasca si calma. Mio padre siede alla scrivania e scrive un biglietto: “Conducete Makar con questo biglietto alla questura e fategli dare cento frustate”.
Il terrore e il più assoluto silenzio regnano in casa. Suonano le quattro e andiamo tutti a tavola, ma nessuno ha appetito e la minestra resta nei piatti. Siamo dieci a tavola e dietro a ognuno sta un trombettiere o un violinista, piatto in mano, ma Makar non si vede.
“Dov’è Makar?”, chiede la nostra matrigna. “Fatelo venire”.
Makar non si fa vedere, bisogna richiamarlo. Finalmente entra, pallido, disfatto, vergognoso, con gli occhi bassi.
Mio padre tiene gli occhi sul piatto e la nostra matrigna, accorgendosi che nessuno mangia, dice per incoraggiarci: “Non vi pare, ragazzi, che questa minestra sia squisita?”. Il pianto mi soffoca e subito dopo pranzo corro dietro a Makar in un andito scuro e cerco di baciargli la mano, ma egli la ritira dicendo, con tono di rimprovero e di dubbio:
“Lasciami stare, anche tu da grande farai altrettanto!”.
“Oh no, mai!”.
Eppure mio padre non era dei peggiori, anzi, la servitù e i contadini lo consideravano uno dei migliori. Ciò che si vedeva in casa nostra si vedeva un po’ dappertutto spesso in una forma più crudele. La fustigazione dei servi faceva parte dei compiti normali della polizia.
Un proprietario osservò un giorno a un altro: “Come si spiega, generale, che nelle vostre proprietà il numero delle anime cresce così lentamente? Probabilmente non vi prendete cura dei matrimoni”. Pochi giorni dopo il generale si fece consegnare una lista di tutti gli abitanti del suo villaggio. Segnò i nomi di tutti i ragazzi di diciott’anni e di tutte le ragazze di sedici, l’età voluta dalla legge per il matrimonio in Russia. Poi scrisse: “Giovanni sposerà Anna, Paolo sposerà Paraška” e così via per cinque coppie.
I cinque matrimoni dovevano aver luogo entro dieci giorni, la seconda domenica del mese. Un grido di disperazione si levò per tutto il villaggio. Donne, giovani e vecchie, piangevano in tutte le case. Anna aveva sperato di sposare Gregorio, i genitori di Paolo avevano già parlato con i Fedotov della loro ragazza, che avrebbe avuto fra poco l’età voluta; e poi era la stagione per arare, non per sposarsi, e come si può preparare tutto il necessario per uno sposalizio, in dieci giorni! Dozzine di contadini vennero per parlare con il proprietario; le contadine si affollavano alla porta del cortile con pezze di tela fine che offrivano alla signora, nella speranza che volesse intervenire in loro favore. Ma tutto fu vano: il padrone aveva detto che i matrimoni dovevano essere celebrati il tal giorno, e così doveva essere.
Il giorno stabilito le processioni nuziali, simili questa volta piuttosto a cortei funebri, si avviarono alla chiesa. Le donne piangevano lamentandosi ad alta voce, come si usa nei funerali.
Fu mandato in chiesa un servitore perché informasse il padrone, appena gli sposalizi fossero stati celebrati; ma poco dopo tornò di corsa, il berretto in mano, pallido, sconvolto.
“Paraška”, dice, “resiste, rifiuta di sposare Paolo. Il padre (cioè il prete) le ha chiesto: ‘Consentite?’, ad alta voce ha risposto: ‘No!’”.
Il proprietario andò su tutte le furie.
“Va’ e di’ a quell’ubriacone dai capelli lunghi (intendeva il prete, il clero russo porta i capelli lunghi) che se non sposa immediatamente Paraška faccio rapporto al vescovo sulle sue sbornie. Come osa, sporco chierico, disobbedirmi? Digli che sarà mandato a marcire in fondo a un monastero e che esilierò la famiglia di Paraška nelle steppe”.
Il domestico fece la commissione. I parenti di Paraška e il prete circondarono la ragazza, scongiurandola di non rovinare la famiglia. La poverina continuava a mormorare “non voglio”, ma la sua voce diventava sempre più debole, e finalmente tacque. Le fu messa in testa una corona nuziale, non fece resistenza, e il domestico corse di carriera ad annunciare: “Sono sposi”.
Mezz’ora dopo i campanelli della processione nuziale risuonavano davanti al cancello. Le cinque coppie scesero dai carri, traversarono il cortile e affollarono l’entrata. Il proprietario le ricevette e offrì del vino, mentre i genitori, in piedi dietro le loro figlie piangenti, comandavano loro di prosternarsi a terra davanti al loro signore.
I matrimoni comandati erano così comuni fra i nostri servi, che tutte le volte che una giovane coppia prevedeva di doversi sposare contro voglia, i minacciati usavano prendere la precauzione di fare insieme da padrino e da madrina al battesimo del bambino di qualche famiglia di contadini. Questo rendeva impossibile il matrimonio secondo la legge canonica russa. Questo stratagemma riusciva quasi sempre bene, ma una volta ebbe una fine tragica.
Andrej, il sarto, si innamorò di una ragazza appartenente ad un nostro vicino. Sperava che mio padre lo avrebbe lasciato andare libero, come sarto, in compenso di un certo pagamento annuo e che, a forza di lavorare, sarebbe riuscito a mettere da parte la somma necessaria per comperare la libertà della ragazza. Altrimenti, sposando uno dei servi di mio padre, sarebbe diventata serva del padrone di suo marito. Andrej però prevedeva che gli si sarebbe ordinato di sposare una delle nostre cameriere, e i due si misero d’accordo per essere padrini di battesimo di un bambino. I loro timori si avverarono: un giorno furono chiamati dal padrone e fu loro ordinato quello che temevano.
“Siamo sempre ossequienti alla vostra volontà”, risposero, “ma poche settimane fa fummo padrino e madrina a un battesimo”. – Poi Andrej spiegò quali erano le sue speranze e come pensava di realizzarle. Per punizione fu mandato via come soldato.
Ai tempi di Nicola I non vi era il servizio militare obbligatorio per tutti, come ora. I nobili e i mercanti ne erano dispensati e quando veniva ordinata una nuova leva, i proprietari dovevano fornire un certo numero dei loro servi. Di solito i contadini stessi, nelle loro comunità di villaggio, tenevano una lista degli uomini disponibili, ma la servitù era assolutamente alla mercé del signore, il quale, se era scontento di un servo, lo mandava soldato, ricevendo per ogni coscritto una quietanza per un valore considerevole, perché si poteva vendere a qualcun altro al quale toccava fare il servizio militare.
Il servizio militare a quei tempi era terribile; si doveva rimanere sotto le armi venticinque anni e la vita del soldato era durissima. Diventare militare voleva dire separarsi per sempre dal villaggio natio e dalla propria famiglia, per essere alla mercé di ufficiali come quel Timofeev al quale ho già accennato. Tutti i giorni erano ceffoni, vergate e frustate per la minima mancanza. La crudeltà che infieriva sorpassa il credibile. Anche nel corpo dei cadetti, dove si istruivano i figli dei nobili, si davano a volte mille vergate per una sigaretta trovata; il medico stava vicino al condannato e faceva sospendere la pena quando si accorgeva che il polso stava per fermarsi. La vittima sanguinante veniva trasportata all’ospedale priva di conoscenza. Il granduca Michele avrebbe certo fatto trasferire il comandante di un corpo dove non si fosse ripetuta una scena simile almeno due volte l’anno. “Nessuna disciplina!”, avrebbe detto.
Con un soldato semplice le cose andavano ben peggio. Quando uno di essi veniva portato davanti a un tribunale militare, la sentenza era che mille soldati venissero allineati in due ranghi uno in faccia all’altro, ogni soldato munito di una verga della grossezza del dito mignolo (queste verghe erano conosciute con un nome tedesco, Spitzruthen) e che il condannato venisse trascinato in mezzo, in modo da ricevere una vergata da ogni soldato. I sergenti seguivano per controllare che fosse adoperata tutta la forza possibile. Dopo aver ricevuto una o duemila vergate, la vittima, sputando sangue, veniva portata all’ospedale per essere medicata, e appena un po’ rimessa dalle ferite subiva il resto della condanna. Se moriva sotto i colpi, si finiva di eseguire la condanna sul cadavere. Nicola I e suo fratello Michele erano spietati: non c’era speranza di fare condonare la pena. “Ti manderò fra i ranghi, ti farò pelare dalle verghe”, erano espressioni che si usavano correntemente.
Quando si sapeva che uno dei servi era destinato al servizio militare, si spargeva per la casa un lugubre terrore. Il poveretto veniva incatenato e messo sotto sorveglianza per impedire che si suicidasse. Poi veniva alla porta un carro da contadini e il condannato usciva fra due guardie. Tutti i servi lo circondavano. Egli si inchinava profondamente davanti ad ognuno, chiedendo perdono delle offese che involontariamente avesse potuto far loro. Se i suoi genitori abitavano nel nostro villaggio, venivano per vederlo partire. Egli si prostrava a terra davanti a loro e sua madre e le altre donne della sua famiglia intonavano ad alta voce le loro benedizioni, fra il canto e il recitativo; “Perché ci abbandoni? Chi avrà cura di te in terra straniera? Chi ti proteggerà dagli uomini spietati?”, proprio come usano cantare le loro lamentazioni a un funerale, servendosi persino delle stesse parole.
Così Andrej dovette subire per venticinque anni il terribile destino del soldato: tutti i suoi sogni di felicità naufragarono tragicamente.
La sorte di una delle nostre cameriere, Paolina o Polya, come si chiamava, fu ancora più triste. Era stata messa a imparare il ricamo ed era diventata un’artista perfetta. A Nikolskoje il suo telaio stava nella camera di mia sorella Elena e Polya spesso partecipava alla conversazione con la sorella della nostra matrigna, che stava con Elena. Insomma, le sue maniere e la sua conversazione erano piuttosto quelle di una signorina che di una domestica.
Le capitò una disgrazia: si accorse di essere madre. Confessò tutto alla nostra matrigna, che la coprì di ingiurie. “Non voglio più quella donna perduta in casa mia! Non ammetto simili vergogne sotto il mio tetto! Svergognata!”, e così di seguito.
Le lacrime di Elena non servirono a nulla: le fece tagliare i capelli e la relegò nella cascina, ma stava ricamando una meravigliosa sottana e dovette finirla là, in una sudicia capanna davanti a una finestrella piccolissima. La terminò e fece altri ricami finissimi, nella speranza di essere perdonata: ma inutilmente.
Il padre di suo figlio, il servo di un nostro vicino, supplicò il permesso di sposarla, ma siccome non aveva denaro da offrire, la sua preghiera fu respinta. Le maniere troppo “signorili” di Polya dispiacevano, e le fu riservata una sorte tristissima. C’era nella nostra casa un uomo impiegato come postiglione a causa della sua piccola statura, soprannominato “Filka gambestorte”. Da ragazzo aveva ricevuto un terribile calcio da un cavallo e da allora non era più cresciuto. Aveva le gambe storte, i piedi voltati in dentro, il naso rotto e voltato da una parte e la mascella sformata. Fu deciso di dare questo mostro per marito a Polya e fu sposata per forza. Furono poi mandati come contadini nella proprietà di mio padre a Rjazan.
Non si ammetteva, non si sospettava neppure che i servi avessero sentimenti umani, e quando Turgenev pubblicò il suo racconto Mumú, e [Dmitry] Grigorovič i suoi romanzi commoventi, che facevano piangere sulle sventure dei servi, fu per molta gente una vera rivelazione. “Come, anch’essi amano come amiamo noi? È possibile?”, esclamavano le signore sentimentali, incapaci di leggere un romanzo francese senza spargere lacrime sulle disgrazie dei loro nobili eroi e eroine. L’istruzione che talvolta i padroni davano ai loro servi non era per essi che fonte di nuove sventure. Una volta mio padre osservò un ragazzo intelligente in una casa di contadini e lo fece istruire come assistente medico. Il ragazzo era molto volenteroso e dopo pochi anni divenne un assistente veramente notevole. Quando tornò a casa mio padre comperò tutto l’occorrente per una farmacia, che fece sistemare molto bene in una delle piccole costruzioni di Nikolskoje. Durante l’estate il dottore Sascha – in casa mia era conosciuto con questo nome – raccoglieva e preparava ogni specie di erbe medicinali, e in breve acquistò una vera popolarità nella zona di Nikolskoje. I contadini ammalati accorrevano dai paesi circostanti e mio padre era molto orgoglioso della sua bella farmacia. Ma le cose non durarono a lungo così. Un inverno mio padre si recò a Nikolskoje, si fermò pochi giorni e venne via. Quella notte stessa il dottor Sascha si tirò una rivolverata, per disgrazia, si disse: si trattava invece di una storia d’amore. Era innamorato di una ragazza che non poteva sposare perché di proprietà di un altro signore.
Un altro giovane, Gherasim Kruglov, che mio padre aveva fatto istruire all’Istituto d’agricoltura di Mosca, era sempre molto triste. Aveva passato molto brillantemente i suoi esami, ottenendo la medaglia d’oro, e il direttore dell’istituto aveva fatto il possibile per convincere mio padre a liberarlo e a lasciarlo andare all’Università – i servi non vi erano ammessi.
“Diventerà senza dubbio un uomo famoso”, diceva il direttore, forse una delle glorie della Russia e sarà un gran vanto per voi l’aver riconosciuto le sue capacità e aver dato un uomo simile alla scienza russa.
“Ne ho bisogno nelle mie proprietà”, rispondeva mio padre! In verità, dati i sistemi primitivi di coltura che prevalevano allora, e dai quali mio padre non si sarebbe mai voluto allontanare, Gherasim Kruglov era assolutamente inutile. Fece un’ispezione nelle nostre proprietà, ma poi gli fu imposto di servire in tavola, piatto in mano.
Naturalmente Gherasim si sentiva offeso; sognava l’Università e il lavoro scientifico, e la nostra matrigna sembrava provare un gusto speciale ad umiliarlo continuamente. Un giorno d’autunno un colpo di vento spalancò il portone: essa lo chiamò.
“Guaska! Va’ a chiudere il portone”.
Fu la goccia che fece traboccare il vaso. Rispose: “Avete un portiere”, e se ne andò.
La mia matrigna corse nella camera di papà, gridando: “I vostri servi mi insultano in casa vostra!”. Gherasim venne immediatamente arrestato, incatenato e mandato militare. Gli addii fra lui e i vecchi genitori furono una delle scene più strazianti che abbia mai visto.
Ma questa volta era destino che dovesse prendersi una rivincita. Nicola I morì e il servizio militare diventò meno crudele. Gherasim si fece presto notare per la sua straordinaria intelligenza e in pochi anni divenne uno dei capi ufficio e la vera forza motrice di una delle sezioni del ministero della guerra. Accadde che mio padre, che era assolutamente onesto e che in quell’epoca, quando tutti accettavano regali e facevano fortuna, rifiutava di lasciarsi corrompere, si allontanasse per una volta dalle rigide regole del servizio e consentisse qualche piccola irregolarità per gentilezza verso il comandante del reggimento. Mancò poco che questo gli costasse la promozione a generale: l’ambito premio di trentacinque anni di servizio militare sembrava perduto.
La mia matrigna andò a Pietroburgo per appianare le difficoltà e un giorno, dopo molti inutili tentativi, le fu detto che l’unico mezzo per ottenere il favore richiesto era di indirizzarsi a un certo impiegato del ministero. Benché fosse solo un impiegato, era lui che dirigeva tutto e tutto poteva.
Il nome di questo impiegato era Gherasim Ivanovič Kruglov!
“Immaginate, il nostro Guaska!”, mi raccontava in seguito. “Sapevo che era un uomo di grande valore. Andai a trovarlo e gli parlai di questa faccenda, ed egli mi disse: ‘Non ho niente contro il principe e farò tutto il possibile per lui’”. Gherasim tenne parola, fece un rapporto favorevole e mio padre ottenne la promozione. Poté finalmente portare i pantaloni rossi, che aveva tanto desiderato, indossare il cappotto foderato di rosso e portare il pennacchio sull’elmo.
Queste cose le vidi io stesso nella mia infanzia. Se però volessi raccontare ciò che sentii dire in quegli anni, sarebbe un racconto ben più straziante. Direi di uomini e donne strappati alle loro famiglie, ai loro villaggi e venduti o perduti al gioco, o scambiati per un paio di cani da caccia e poi trasportati in qualche provincia lontana, per fondarvi una proprietà; di bambini strappati ai loro genitori e venduti a padroni crudeli e dissoluti; di “fustigazioni nelle stalle” che succedevano tutti i giorni con ferocia inaudita; di una ragazza che non trova altra via di scampo che affogarsi; di un vecchio incanutito al servizio di un padrone, che finisce per impiccarsi sotto le finestre del suo signore, e di ribellioni di servi che venivano soffocate dai generali di Nicola I flagellando a morte uno su ogni dieci o cinque uomini, o devastando il villaggio, i cui abitanti, dopo un’esecuzione militare, andavano a mendicare il pane nelle province vicine, come se fossero stati vittime di un incendio… Quanto alla miseria che ho visto in certi villaggi, specialmente in quelli appartenenti alla famiglia imperiale, mancano le parole per darne un’idea al lettore!
Ottenere la libertà era il sogno di ogni servo, sogno non facile a realizzarsi, perché ci voleva una grossa somma per indurre un proprietario a liberare un servo.
“Sai”, mi disse una volta mio padre, “che tua madre mi comparve davanti dopo morta? Voi giovani non credete a queste cose, ma è veramente accaduto. Una notte che avevo fatto molto tardi, ero seduto su questa sedia davanti ad una scrivania e sonnecchiavo, quando la vidi entrare dal fondo della stanza, vestita di bianco, pallidissima, con gli occhi scintillanti. – Mi aveva pregato, in punto di morte, di liberare la sua donna Mascia, e io l’avevo promesso; ma fra una cosa e l’altra passò quasi un anno, e non avevo adempiuto la promessa. Allora mi apparve e mi disse con voce commossa: ‘Aleksej, hai promesso di liberare Mascia, te ne sei dimenticato?’. Spaventato, balzai dalla seggiola, ma era sparita. Chiamai i servi, ma non avevano visto niente. L’indomani mattina visitai la sua tomba, feci recitare una litania e detti immediatamente la libertà a Mascia”.
Quando morì mio padre Mascia venne ai funerali e io le parlai. Era sposa e viveva felice. Mio fratello Aleksandr, con il suo solito buon umore, le raccontò quello che mi aveva detto mio padre e le chiese se ne sapeva qualche cosa.
“Sono cose successe tanto tempo fa”, rispose, “e posso dirvi la verità. Mi ero accorta che vostro padre aveva completamente dimenticato la sua promessa, così mi vestii di bianco e gli parlai come fossi stata vostra madre. Gli ricordai la promessa fatta e… non me ne portate rancore, è vero?”.
“Certamente no!”.
Dieci o dodici anni dopo le scene descritte in questo capitolo, stavo in camera di mio padre e si parlava del passato. La schiavitù era stata abolita ed egli si lamentava delle nuove condizioni, benché senza acrimonia: le aveva accettate senza troppo brontolare.
“Devi confessarlo, babbo”, gli dissi, “spesso punivi crudelmente i tuoi servi e senza ragione”.
“Con quella gente”, rispose, “era impossibile fare altrimenti”. E sdraiandosi nella poltrona rimase assorto nei suoi pensieri. “Ma quello che facevo io era nulla”, disse dopo una lunga pausa. “Quel Sableev, per esempio: sembra tanto sdolcinato, ha una voce tanto mite, ma era veramente terribile con i suoi servi. Quante volte congiurarono per ammazzarlo! Io almeno non ho mai approfittato delle mie donne, ma quel vecchio diavolo di Tomkov si comportava in un modo così scandaloso, che le sue contadine avevano deciso di infliggergli una terribile punizione… Addio, bonne nuit!”.
Mi ricordo benissimo della guerra di Crimea. A Mosca se ne sentivano poco le conseguenze. Naturalmente in tutte le case ci si riuniva la sera a preparare filacce e fasce per i feriti: ma poche arrivarono all’esercito russo, quantità enormi furono rubate e vendute al nemico. Mia sorella Elena e altre signorine cantavano canzoni patriottiche, ma nel complesso si sentì poco il riflesso della grande lotta che si combatteva. In campagna invece la guerra aveva portato una grande tristezza.
Nuove leve si succedevano rapidamente e si sentivano di continuo le contadine intonare le loro canzoni funebri. Il popolo russo considera la guerra come una calamità inflittagli dalla Provvidenza, e accettò questa guerra con una solennità che contrastava stranamente con la leggerezza manifestata in altre circostanze. Giovane com’ero, mi rendevo ben conto della profonda rassegnazione che regnava nei nostri villaggi.
Mio fratello Nicola, come tanti altri, fu preso dalla febbre della guerra, e prima di aver terminato il suo corso alla scuola militare partì per il Caucaso. Non lo rividi mai più.
Nel 1854 la nostra famiglia si accrebbe per l’arrivo di due sorelle della nostra matrigna. Possedevano una casa e dei vigneti a Sebastopoli, ma erano rimaste senza tetto e vennero a stare con noi. Quando gli alleati sbarcarono in Crimea, dissero agli abitanti di Sebastopoli di non spaventarsi e di rimanere; ma dopo la disfatta di Alma, ebbero l’ordine di sgomberare immediatamente perché entro pochi giorni la città sarebbe stata assediata. Vi erano pochi mezzi di trasporto e non era possibile percorrere le strade a mezzogiorno, dove marciavano le truppe; era quasi impossibile trovare un carretto da noleggiare e le signore, dopo aver abbandonato lungo la via tutte le cose loro, dovettero sopportare fatiche e privazioni per poter arrivare a Mosca.
Facemmo presto amicizia con la minore delle sorelle, una signora di una trentina d’anni, che fumava una sigaretta dopo l’altra, e mi raccontava tutte le peripezie del loro viaggio. Parlava con le lacrime agli occhi delle belle corazzate colate a picco nel porto di Sebastopoli e non riusciva a persuadersi che i Russi potessero difendere Sebastopoli da terra: non vi erano mura di cui valesse la pena di parlare.
Avevo tredici anni quando morì Nicola I. A tarda ora, nel pomeriggio del 18 febbraio [2 marzo] i poliziotti distribuirono in tutte le case di Mosca un bollettino con l’annuncio della malattia dello Zar e l’invito a tutti gli inquilini di recarsi in chiesa a pregare per la sua guarigione. A quell’ora era già morto, e le autorità lo sapevano, perché c’era il telegrafo tra Mosca e Pietroburgo: ma poiché non era stato detto nulla della sua malattia, credevano necessario preparare il popolo alla notizia della sua morte. Andammo tutti in chiesa e pregammo con molta compunzione.
Il giorno seguente, sabato, si ripeté la stessa cosa, e anche la domenica mattina vennero distribuiti bollettini sulla salute dello zar. La notizia della morte di Nicola I non ci giunse che a mezzogiorno, portata da alcuni servi che tornavano dal mercato.
Un vero terrore invase la nostra casa e quella dei nostri parenti quando si sparse la notizia. Si diceva che al mercato la gente si comportava in uno strano modo, che non si mostravano addolorati, ma che si permettevano strani discorsi. I grandi parlavano sottovoce e la nostra matrigna ci ripeteva: “Non parlate davanti ai domestici”, mentre i servi sussurravano fra di loro, probabilmente facendo supposizioni sulla vicina “libertà”. I nobili si aspettavano da un momento all’altro una rivolta di servi, una nuova sommossa alla Pugačëv.
A Pietroburgo intanto gli uomini delle classi colte si abbracciavano per le strade comunicandosi la notizia. Tutti sentivano prossima la fine della guerra e delle terribili condizioni in cui si viveva sotto il “despota di ferro”. Si parlava di avvelenamento; tanto più che il cadavere dello Zar si corrompeva rapidamente, ma la vera ragione della morte si conobbe solo più tardi: aveva preso una dose troppo forte di una medicina energica.
Durante l’estate del 1855 in campagna seguimmo con ansioso interesse la lotta eroica che si combatteva a Sebastopoli per ogni palmo di terreno e davanti a ogni metro di mura smantellate. Un messaggero partiva tutte le mattine da casa nostra per la città più vicina a prendervi i giornali e quando ritornava i giornali gli venivano strappati di mano prima che avesse avuto il tempo di smontare da cavallo. Elena e io li leggevamo ad alta voce a tutta la famiglia e le notizie venivano subito comunicate all’appartamento della servitù e qui ripetute in cucina, nelle rimesse, in casa del prete e nelle capanne dei contadini. Le notizie degli ultimi giorni di Sebastopoli, del terribile bombardamento e infine dell’evacuazione della città da parte delle nostre truppe, furono accolte fra le lacrime. In tutte le ville dei dintorni si pianse la perdita di Sebastopoli, come si sarebbe pianta la morte di un prossimo parente, quantunque tutti fossero ormai certi che la fine della terribile guerra era vicina.
Nell’agosto del 1857 – avevo quindici anni – venne il mio turno per entrare nel Corpo dei Paggi e fui condotto a Pietroburgo. Lasciai la casa ancora bambino, ma il carattere di solito si forma a un’età inferiore a quanto si crede generalmente, e sono certo che sotto il mio aspetto infantile io ero pressappoco quello che fui più tardi. I miei gusti, le mie preferenze erano già formati.
Il primo impulso al mio sviluppo intellettuale mi venne, come ho già detto, dal mio maestro russo. Esiste un uso nelle famiglie russe, un uso che ora disgraziatamente si va perdendo, di tenere in casa uno studente che aiuta i ragazzi e le ragazze nei loro studi, anche quando sono già al ginnasio. Il suo aiuto è inestimabile per far loro assimilare quanto studiano a scuola e allargare poi le loro idee sulle cose che vanno imparando. Inoltre si introduce nella famiglia un elemento intellettuale, che diventa per i ragazzi come un fratello maggiore, spesso qualche cosa di più di un fratello maggiore, perché questo studente sente una certa responsabilità nella formazione della coscienza dei propri allievi: e poiché i sistemi di educazione cambiano rapidamente da una generazione all’altra, può educarli meglio di quanto potrebbero fare anche gli stessi genitori, per quanto colti.
Nicola Pavlovič Smirnov aveva del gusto per la letteratura. A quei tempi, sotto la stupida censura di Nicola I, molti libri innocui dei nostri migliori scrittori erano proibiti, altri erano così mutilati da privare di un senso qualsiasi molti periodi. Nella commedia di [Aleksandr] Griboedov Che disgrazia l’ingegno, che può essere paragonata alle migliori commedie di Molière, bisogna chiamare il colonnello Skalozub semplicemente Skalozub, a scapito del senso, e anche dei versi, perché rappresentare un colonnello sotto un aspetto comico era ritenuto un insulto all’esercito. Non fu permesso stampare la seconda parte di un libro innocente come Le anime morte di Gogol, e non si poteva ristampare neppure la prima parte, quantunque l’edizione fosse esaurita da molto tempo. Molti versi di Puškin, di Lermontov, di A. K. Tolstoj, di Ryleev e di altri, non poterono essere pubblicati; senza dire di quei versi che contenevano una opinione politica e una critica alle condizioni sociali del tempo. Tutti questi versi circolavano manoscritti, e il mio maestro copiava interi libri di Puškin e di Gogol per sé e per i propri amici, lavoro in cui spesso lo aiutavo. Da vero moscovita nutriva una profonda ammirazione per quelli fra i nostri scrittori che abitavano a Mosca, alcuni dei quali stavano nel Vecchio Quartiere degli Scudieri. Mi mostrava con rispetto la casa della contessa Salias (Eugénie Tour), nostra vicina; mentre la casa del noto proscritto, il conte Aleksandr Herzen, ci ispirava un misterioso sentimento di rispetto e di terrore.
La casa di Gogol era oggetto di profonda devozione e quantunque non avessi che nove anni al momento della sua morte, nel 1851, e non avessi letto nessuno dei suoi libri, ricordo bene il lutto di tutta Mosca per la sua morte. Turgenev dipinse molto bene quel sentimento di tristezza in alcune sue memorie, per aver scritto le quali Nicola I lo fece arrestare ed esiliare nella sua lontana proprietà.
Il grande poema di Puškin, Eugenio Onegin, non mi impressionò molto e ancor oggi ammiro più in quell’opera la meravigliosa semplicità e bellezza dello stile che la sua sostanza. Ma le opere di Gogol, le lessi a dieci o dodici anni, mi fecero una profonda impressione e i miei primi saggi letterari erano scritti in quel suo stile umoristico. Un romanzo storico di [Michail] Zagoskin, Jurij Miloslavskij, che descrive l’epoca della grande ribellione del 1612, La figlia del capitano di Puškin e La regina Margot di Dumas svegliarono in me un interesse per la storia, che doveva poi durare. Quanto agli altri romanzi francesi, ho incominciato a leggerli solo dopo la rivelazione di Daudet e Zola. Le poesie di [Nikolaj] Nekrasov erano fra quelle che prediligevo da ragazzo, tanto che ne sapevo molti versi a memoria.
Nicola Pavlovič Smirnov mi fece scrivere molto presto, e con il suo aiuto composi una lunga Storia di una moneta da dieci soldi per la quale immaginai una serie di personaggi che successivamente venivano in possesso della fantastica moneta.
Mio fratello Aleksandr aveva allora una vena poetica ben più ricca della mia; scriveva dei racconti romantici e incominciò prestissimo a comporre versi con meravigliosa semplicità e con uno stile facile e armonioso. Se più tardi non si fosse dedicato agli studi di filosofia e di storia naturale, sarebbe certo diventato un poeta di valore. In quegli anni aveva l’abitudine, per trovare ispirazioni, di coricarsi su di un letto leggermente inclinato posto sotto la nostra finestra, ciò che mi dava la maliziosa tentazione di dargli noia. “Ecco il poeta che cerca l’ispirazione sotto il comignolo”, dicevo, e lo stuzzicavo tanto, che si finiva per litigare, con gran disperazione di mia sorella Elena. Ma Aleksandr era così poco vendicativo, che la pace era presto ristabilita, e ci amavamo profondamente. Fra ragazzi le dispute e l’affetto sembra vadano di pari passo.
Fin d’allora mi attraeva il giornalismo. A dodici anni incominciai a redigere il mio quotidiano. In casa nostra non si poteva aver carta a volontà e il mio giornale fu di proporzioni microscopiche. Poiché la guerra in Crimea non era ancora scoppiata, e mio padre non riceveva altro giornale che la “Gazzetta della Polizia di Mosca”, non avevo molta scelta di modelli. La mia Gazzetta quindi si componeva di brevi paragrafi, con la cronaca della giornata; per esempio: “Si andò nei boschi; N. P. Smirnov uccise due tordi”, e così via.
Mi accontentai di questo giornale solo per poco tempo e nel 1855 fondai una rivista mensile che conteneva i versi di Aleksandr, i miei romanzetti e infine anche una rubrica di “varietà”. Economicamente la vita di questa rivista era alimentata dal numero degli abbonati: il redattore stesso, cioè, Smirnov, che pagava regolarmente la sua quota in fogli di carta, anche dopo lasciata la nostra casa. In compenso io scrivevo accuratamente una seconda copia per il mio fedele abbonato.
Quando Smirnov ci lasciò, sostituito da uno studente in medicina, N. M. Pavlov, quest’ultimo mi aiutò anche nei miei compiti di editore. Ottenne per la rivista una poesia di un suo amico e – quello che più importava – l’introduzione alla geografia fisica di uno dei professori di Mosca. Naturalmente questa era inedita: una rivista così seria non avrebbe mai stampato una riproduzione!
Aleksandr, si capisce, si interessava molto della rivista, la cui fama arrivò ben presto al Corpo dei Cadetti. Alcuni giovani autori in cerca di gloria intrapresero la pubblicazione di una rivista rivale. La cosa era grave: in fatto di poesie e romanzi si poteva stare tranquilli, ma essi avevano un “critico”, e un “critico” che scrive accennando ai personaggi di tutti i romanzi nuovi, parlando delle condizioni politico-sociali e toccando mille questioni che non si possono trattare altrove, è l’anima di una rivista russa. Essi avevano un critico, e noi no! Per fortuna l’articolo che egli scrisse per il primo numero fu visto da Aleksandr; era piuttosto debole e pretenzioso e Aleksandr scrisse subito una replica, mettendolo in ridicolo e demolendo l’avversario con molto fuoco.
Grande fu lo sgomento nel campo nemico quando si seppe che questa replica sarebbe apparsa nel nostro prossimo numero. Sospesero la pubblicazione della loro rivista e i loro migliori scrittori vennero da noi. Si annunciò trionfalmente l’esclusiva collaborazione, per l’avvenire, di tutti questi distinti letterati.
Nell’agosto del 1857 la rivista dovette sospendere la pubblicazione dopo quasi due anni di vita. Un nuovo ambiente, una nuova vita mi aspettavano.
Partii da casa a malincuore perché tutta la distanza fra Mosca e Pietroburgo mi separava da Aleksandr e perché consideravo già come una disgrazia di dover entrare in una scuola militare.
Parte seconda
Il Corpo dei Paggi
Si realizzava così l’ambito sogno di mio padre. Vi era un posto vacante nel Corpo dei Paggi e io l’ottenni prima di aver superato l’età fissata per l’ammissione; fui condotto, a Pietroburgo ed entrai nella scuola. Solo centocinquanta ragazzi – quasi tutti figli di nobili appartenenti alla Corte – erano educati in questo corpo privilegiato, che univa il tipo di scuola militare dotata di diritti speciali a quello di un istituto di Corte dipendente dalla famiglia imperiale. Dopo quattro o cinque anni trascorsi nel Corpo dei Paggi, quelli che passavano l’esame finale diventavano ufficiali in qualunque reggimento della Guardia o dell’esercito scegliessero, senza tener conto del numero dei posti vacanti in quel reggimento; e ogni anno i primi sedici allievi della classe superiore erano nominati pages de chambre: erano cioè addetti personalmente ai membri della famiglia imperiale, all’imperatore, all’imperatrice, alle granduchesse e ai granduchi. Naturalmente era considerato un grande onore; i giovani che si distinguevano in questo modo si facevano conoscere alla Corte e avevano ogni probabilità di venir poi nominati aiutanti di campo dell’imperatore o di uno dei granduchi e avevano quindi mille facilitazioni per una carriera brillante al servizio dello Stato. I padri e le madri prendevano perciò tutte le misure possibili perché i loro ragazzi potessero entrare nel Corpo dei Paggi, anche se la loro ammissione doveva essere a scapito di quella di altri candidati, per i quali non si presentava mai un posto vacante. Ora finalmente ero entrato a far parte di un corpo tanto ambito, mio padre poteva concedere libero corso ai suoi sogni più ambiziosi.
Il corpo comprendeva cinque classi, delle quali la prima era la più alta, la quinta l’ultima: era stato deciso che io sarei passato nella quarta. Ma agli esami si trovò che non avevo sufficiente familiarità con le frazioni decimali, e siccome quell’anno vi erano più di quaranta allievi nella quarta, e soltanto venti nella quinta, entrai in quest’ultima.
La decisione mi dispiacque molto. Entravo malvolentieri in una scuola militare, e ora ci dovevo restare cinque anni invece di quattro! Cosa potevo fare in quinta, quando sapevo già tutto quello che vi si insegnava? Con le lacrime agli occhi ne parlai all’ispettore – il direttore per la parte culturale – ma egli mi rispose scherzando: “Sapete”, mi disse, “le parole di Cesare; meglio essere il primo in un villaggio che il secondo a Roma”. Io risposi con calore che avrei preferito essere l’ultimo di tutti pur di lasciare la scuola militare il più presto possibile. “Forse fra non molto vi affezionerete alla scuola”, osservò; e da allora in poi fu sempre gentile con me.
Al professore di matematica che cercava anch’egli di consolarmi, diedi la parola d’onore di non aprire mai il libro di testo, avvertendolo che avrebbe dovuto darmi ugualmente il massimo dei voti. Mantenni la parola, ma riflettendo ora a questa scena penso di non essere stato uno scolaro troppo docile.
Ripensando a quel lontano passato, non posso che sentirmi grato di essere stato messo in quella classe. Dovendo soltanto ripetere durante il primo anno quello che sapevo già, mi abituai a imparare ascoltando le parole del professore durante le lezioni, e finite queste avevo tutto il tempo di leggere e scrivere quanto volevo. Non studiavo mai per gli esami e passavo il tempo che ci veniva concesso a quello scopo a leggere ad alta voce a un piccolo gruppo di amici i drammi di Shakespeare o di [Aleksandr] Ostrovskij. Quando entrai nella classe superiore “speciale” ero anche preparato meglio per capire tutte le materie che dovevamo studiare. Inoltre passai più della metà del primo inverno all’ospedale. Come tutti i ragazzi nati fuori di Pietroburgo, dovetti pagare un forte tributo alla “capitale sulle paludi della Finlandia” sotto forma di qualche attacco di colera e anche di tifo.
Quando entrai nel Corpo dei Paggi, la vita all’interno di questo istituto stava subendo una profonda modificazione. L’intera Russia si svegliava allora dal sonno pesante e dall’incubo tremendo del regno di Nicola I. La nostra scuola sentì gli effetti di questo risveglio. Non so davvero che sarebbe stato di me se vi fossi entrato qualche anno prima. O la mia volontà sarebbe stata del tutto spezzata, o sarei stato espulso dalla scuola, chi sa con quali conseguenze. Fortunatamente il periodo di transizione era già inoltrato nel 1857.
Il direttore del corpo era un ottimo vecchio, il generale Jeltuchin, ma non era che il capo nominale. Il vero padrone della scuola era “il colonnello”, colonnello Girardot, un francese al servizio della Russia. Si diceva che fosse un gesuita, e io lo credo. In ogni modo era certamente imbevuto delle teorie di Loyola e il suo sistema educativo era quello in voga nei collegi dei gesuiti in Francia. Immaginatevi un uomo piccolo e magrissimo, dagli occhi neri penetranti, con i baffi tagliati corti che gli davano un’espressione felina, molto calmo e deciso; di un’intelligenza media, ma straordinariamente furbo; un despota in fondo, capace di odiare di un odio intenso il ragazzo che non subiva il suo ascendente e di far sentire quell’odio non per mezzo di persecuzioni stupide, ma incessantemente, in ogni suo atto – per mezzo di una parola detta a caso, di un gesto, di un sorriso, di un’esclamazione. Non camminava, strisciava, e il contrasto dell’immobilità del suo capo con il suo sguardo mobilissimo e indagatore completava quell’impressione. Un’espressione di fredda indifferenza era stampata sulle sue labbra anche quando voleva aver l’aria benevola, e questa espressione diventava ancor più crudele quando la sua bocca si contraeva in un sorriso di disprezzo o di disapprovazione. Con tutto questo non aveva l’aria dittatoriale, faceva piuttosto pensare a prima vista a un padre benevolo che discorre con i suoi ragazzi come se fossero già grandi.
Ma ben presto si sentiva che tutto e tutti dovevano piegarsi alla sua volontà. Guai a quel ragazzo che non si mostrava felice o infelice a seconda dell’umore del colonnello a suo riguardo.
Le parole “il colonnello” erano sulle labbra di tutti continuamente. Gli altri ufficiali erano conosciuti con i loro soprannomi, ma a Girardot nessuno osava dare un soprannome. Era avvolto da una aureola di mistero, come se fosse onnisciente e onnipresente. Passava tutto il giorno e parte della notte nella scuola; anche quando eravamo in classe gironzolava qua e là, aprendo le nostre cassette con la sua chiave. Passava gran parte della notte a segnare su certi quadernetti di cui aveva una vera biblioteca, su colonne speciali e a diversi colori, i difetti e le qualità di ogni ragazzo.
I giochi, gli scherzi, le conversazioni cessavano immediatamente quando lo si vedeva avanzare lentamente nelle nostre grandi sale, accompagnato da uno dei suoi favoriti, dondolandosi sui fianchi, sorridendo a un ragazzo, scrutandone un altro con occhio indagatore, dando a un terzo un’occhiata indifferente, torcendo la bocca alla vista di un quarto; e da questi sguardi tutti capivano che il primo ragazzo gli piaceva, che il secondo gli era indifferente; che ignorava di proposito il terzo e che il quarto gli era antipatico. Questa antipatia era sufficiente a spaventare la maggior parte delle sue vittime – tanto più se non se ne capiva il motivo. Ragazzi sensibili erano stati ridotti alla disperazione da quella muta, incessante ostilità e da quegli sguardi sospettosi; in altri aveva avuto per effetto di spezzarne del tutto la volontà, come uno dei Tolstoj – Teodoro, anch’egli scolaro di Girardot – ha mostrato in un suo romanzo autobiografico, Le malattie della volontà.
La vita all’interno del corpo era infelicissima sotto il governo dispotico del colonnello. In tutti i convitti gli ultimi venuti sono sottoposti a umilianti persecuzioni. I novellini vengono così messi alla prova. Cosa valgono? Faranno la spia? Ai “vecchi” poi piace ostentare con i nuovi venuti la superiorità che deriva loro dalla lunga familiarità con l’ambiente: avviene in tutte le scuole e in tutte le prigioni. Ma sotto Girardot queste persecuzioni assumevano un carattere più aspro e venivano inflitte non dai compagni, ma dagli allievi della prima classe, dai Paggi che erano già sottufficiali e ai quali Girardot aveva creato una posizione tutta particolare e privilegiata. Il suo sistema era di concedere loro assoluta libertà, di fingere di ignorare gli orrori che si permettevano e di mantenere per mezzo loro una disciplina severissima. Rispondere a un ceffone dato da un paggio della prima classe, avrebbe voluto dire, ai tempi di Nicola I, essere spedito a un battaglione “per i figli dei semplici soldati” se la cosa diventava pubblica; ribellarsi in qualsiasi modo ai capricci di uno di questi Paggi aveva sùbito questa conseguenza: che i venti giovanotti della prima classe, armati delle loro pesanti righe di quercia, si radunavano in una sala e, con la tacita approvazione di Girardot, picchiavano a morte il ragazzo colpevole di un tale spirito di insubordinazione.
Così la prima classe faceva quello che voleva e non più tardi dell’inverno precedente al mio arrivo uno dei loro divertimenti prediletti era stato di condurre i “novellini” in una stanza, vestiti delle sole camicie da notte, e di farli correre in giro come cavalli al circo, mentre essi, armati di grosse fruste di caucciù, stando gli uni in mezzo, gli altri intorno alla sala, frustavano i ragazzi spietatamente. Di solito questo “circo” finiva all’orientale, in una scena abominevole. La morale che allora predominava e i discorsi osceni che si facevano nella scuola su ciò che succedeva dopo uno di questi “circhi” erano tali che è meglio non parlarne.
Il colonnello era al corrente di tutto ciò. Aveva organizzato un sistema di spionaggio completo e nulla gli sfuggiva. Tutto andava bene finché non si scopriva che egli sapeva. Il suo sistema di disciplina era fondato sull’ignorare ciò che faceva la prima classe.
Ma uno spirito nuovo aleggiava sulla scuola e solo pochi mesi prima del mio arrivo era avvenuta una rivoluzione. Quell’anno la terza classe era diversa da quello che era stata fino allora. Vi erano molti giovani che avevano studiato e letto parecchio: alcuni di essi diventarono poi uomini notevoli. Feci conoscenza con uno di loro – lo chiamerò von Schauff – che leggeva allora La critica della ragion pura di Kant. Vi erano poi fra di essi alcuni dei giovani più robusti della scuola. Il ragazzo più alto del corpo era in quella classe e anche un giovane fortissimo, Koštov, grande amico di von Schauff.
Gli allievi di questa terza classe non subirono il giogo dei pages de chambre della prima con la docilità dei loro predecessori; erano disgustati di quello che succedeva e, in seguito a un incidente che preferisco non raccontare, ebbe luogo una battaglia fra la terza e la prima classe e ne risultò una solenne bastonatura inflitta ai Paggi anziani dai loro sottoposti. Girardot soffocò la faccenda, ma l’ascendente della prima classe era svanito. Le fruste di caucciù rimasero, ma non furono più adoperate. I circhi e altre cose simili appartennero al passato.
Fu tanto di guadagnato; ma l’ultima classe, la quinta, composta quasi tutta di ragazzi entrati da poco nella scuola, doveva ancora obbedienza ai Paggi della prima. Avevamo un bellissimo giardino, pieno di alberi secolari, ma i ragazzi della quinta lo godevano ben poco; erano obbligati a correre qua e là mentre i giovani della prima stavano seduti a chiacchierare, o dovevano riportare le palle quando questi signori giocavano. Due giorni dopo il mio arrivo alla scuola, visto come stavano le cose in giardino, non vi andai, ma rimasi in casa. Stavo leggendo, quando un “anziano” dai capelli rossi e la faccia macchiata di lentiggini mi venne incontro e mi ordinò di scendere immediatamente in giardino per partecipare al gioco.
“Non vengo; non vedete che sto leggendo?”, gli risposi.
Il suo viso antipatico si sfigurò per l’ira. Stava per scagliarsi contro di me: mi misi sulla difensiva. Si provò a colpirmi in faccia con il berretto, io mi schermii, allora buttò il berretto in terra.
“Raccattalo”.
“Se lo raccatti lei”.
Una simile mancanza di obbedienza era sconosciuta nella scuola. Non so perché non mi bastonò spietatamente lì per lì. Era molto più grande e più robusto di me.
L’indomani e i giorni seguenti ricevetti altri ordini simili, ma rimasi ostinatamente appartato. Cominciarono allora una serie di meschine e seccantissime persecuzioni, sufficienti a far disperare qualunque ragazzo. Fortunatamente sono sempre stato di un temperamento gioviale e rispondevo scherzando o fingevo di non accorgermene.
Ma anche questo presto finì. Incominciò a piovere, e passavamo quasi tutto il giorno in casa. In giardino quelli della prima classe fumavano liberamente, ma, quando si stava dentro, la sala da fumare era “la torre”. Questa era tenuta pulitissima e vi era sempre il fuoco acceso. Gli “anziani” punivano severamente il ragazzo che trovavano per caso a fumare, ma essi stavano continuamente seduti intorno alla stufa a chiacchierare e a godersi le sigarette. L’ora preferita era per loro dopo le dieci di sera, quando avrebbero dovuto essere già a letto; prolungavano la serata fino alle undici e mezzo e per proteggersi da una sorpresa da parte di Girardot ci costringevano a montare la guardia. I ragazzi della quinta dovevano alzarsi a turno dal letto, due alla volta, e restare sulle scale fino alle undici e mezza per dare l’allarme se si avvicinava il colonnello.
Ci si mise d’accordo per mettere fine a queste veglie notturne. Le discussioni furono lunghe e ci si consigliò con le classi superiori sul da farsi. Finalmente si arrivò a questa decisione: “Rifiutatevi concordemente di montare la guardia e quando cominceranno a battervi, come è certo che faranno, andate per quanto possibile tutti insieme e chiamate Girardot. Egli sa già tutto, ma allora sarà obbligato a intervenire”. Gli esperti in questioni d’onore decisero che questo non poteva essere qualificato spionaggio: gli “anziani” non si comportavano verso gli altri come dei compagni. Quella sera doveva montare la guardia il principe Šahovskoj, un vecchio allievo, e Selanov, un nuovo venuto, ragazzo timidissimo dalla voce femminile. Šahovskoj fu comandato per il primo, ma rifiutò di andare e fu lasciato in pace. Allora due pages de chambre andarono dal timido nuovo venuto che era a letto; e siccome si rifiutò di obbedire, cominciarono a fustigarlo brutalmente con le pesanti cinghie di cuoio. Šahovskoj svegliò diversi compagni che gli si trovavano vicini e tutti insieme corsero da Girardot.
Anch’io ero a letto quando due mi si avvicinarono e mi ordinarono di montare la guardia. Mi rifiutai. Subito afferrarono due paia di bretelle – invariabilmente si posavano gli abiti in perfetto ordine su di una panca accanto al letto, le bretelle sopra e la cravatta attraverso – e cominciarono a fustigarmi. Seduto sul letto, mi coprivo con le mani e avevo già ricevuto diversi colpi, quando si udì l’ordine: “La prima classe dal colonnello!”. I feroci combattenti si ammansirono improvvisamente e frettolosamente rimisero a posto i miei abiti.
“Non una parola!”, mi sussurrarono.
“Mettete la cravatta al suo posto!”, gridai loro, mentre le spalle e le braccia mi bruciavano per i colpi ricevuti.
Quel che dicesse Girardot alla prima classe non si seppe mai; ma il giorno dopo, mentre stavamo allineati, pronti per avviarci al refettorio, il colonnello ci parlò con aria compunta, dicendo quanto era triste pensare che un paggio della prima classe avesse colpito un ragazzo che si rifiutava a ragione di ubbidirgli. E quale ragazzo? Un nuovo venuto, un ragazzo timido come Selanov! La scuola intera fu nauseata di questo discorso da gesuita.
Fu senza dubbio un colpo per l’autorità di Girardot, ed egli se ne ebbe molto a male. Aveva per la nostra classe e per me in particolare molta avversione (gli era stato raccontato del mio rifiuto a partecipare al gioco in giardino) e non perdeva l’occasione di manifestarci i suoi sentimenti.
Durante il primo inverno passai molto tempo in infermeria. Dopo un attacco di tifo, durante il quale il direttore e il dottore ebbero per me cure veramente paterne, soffrii di attacchi di gastrite gravi e prolungati. Girardot, facendo il suo giro quotidiano nell’infermeria e vedendomi spesso, incominciò a dire tutte le mattine ironicamente, in francese: “Ecco un giovanotto sano come il Ponte Nuovo e che non vuol lasciare l’ospedale”. Risposi un paio di volte per le rime, ma infine, accorgendomi della sua malignità, persi la pazienza e mi adirai davvero. “Come osate parlarmi così?”, esclamai, e aggiunsi: “Pregherò il dottore di proibirvi l’ingresso di questa camera!”.
Girardot indietreggiò di un passo e i suoi occhi scuri scintillarono, le sue labbra sottili si strinsero più del solito. Finalmente disse: “Dunque vi ho offeso? Ebbene, abbiamo nell’atrio due pezzi d’artiglieria: volete battervi in duello?”.
“Io non scherzo, e vi dico che non tollero le vostre insinuazioni”, continuai. Non ripeté più il suo sciocco ritornello, ma mi prese in odio più che mai. Fortunatamente per me non davo occasioni per castigarmi. Non fumavo, i miei abiti erano sempre in buono stato e abbottonati e messi bene in ordine la notte. Mi divertivo a qualsiasi gioco, ma ero tanto occupato nella lettura e nella corrispondenza con mio fratello che trovavo appena il tempo per fare una partita a lapta nel giardino, e avevo sempre premura di ritornare ai miei libri. Quando ero colto in fallo, però, non ero io quello che Girardot puniva, ma l’anziano dal quale dipendevo. Una volta, per esempio, feci a pranzo nientemeno che una scoperta di fisica! Osservai che il suono fatto da un bicchiere dipende dalla quantità di acqua che contiene e cercai subito di ottenere un accordo con quattro bicchieri. Ma dietro di me stava Girardot, e senza una parola mise agli arresti il mio “anziano”. Fortuna volle che fosse un ottimo ragazzo, un mio terzo cugino, che non volle sentire le mie scuse, dicendo: “Va bene, so che non ti può vedere”. Però i suoi compagni incominciarono a farsi sentire: “Stai attento briccone! Non intendiamo farci castigare per colpa tua!”. E se la lettura non fosse stata la mia costante occupazione mi avrebbero probabilmente fatto pagar caro il mio esperimento di fisica. Tutti notavano l’antipatia che mi dimostrava Girardot, ma io non vi badavo, e probabilmente l’aumentavo con la mia indifferenza. Durante diciotto mesi non volle darmi le spalline, che si concedono di solito ai nuovi venuti dopo il primo o secondo mese di permanenza nella scuola; ma io ero perfettamente felice anche senza quella decorazione militare. Finalmente un ufficiale, il migliore istruttore della scuola, un uomo innamorato dell’esercizio, si offrì per istruirmi, e quando vide che facevo tutti gli esercizi in modo perfettamente soddisfacente, domandò egli stesso che mi fossero concesse le spalline. Il colonnello rifiutò di nuovo due volte di seguito, così che l’ufficiale se la prese come un’offesa personale; e quando il direttore del corpo gli chiese una volta come si spiegasse che io non avevo ancora le spalline, egli rispose bruscamente: “Il ragazzo non ne ha colpa, è il colonnello che non vuole”. Dopo di che, probabilmente dietro osservazione del direttore, Girardot chiese per me un nuovo esame e mi dette le spalline il giorno stesso.
Ma l’influenza del colonnello declinava rapidamente. Il carattere della scuola subiva un cambiamento radicale. Durante vent’anni Girardot aveva realizzato il suo ideale che consisteva nell’avere i ragazzi ben pettinati, arricciati e di aspetto effeminato, e nel mandare alla Corte dei Paggi compìti come i cortigiani di Luigi XIV. Che si istruissero o no, poco gli importava: prediligeva quelli meglio forniti di spazzolini da unghie di ogni specie, di boccette di profumo, che avevano il vestito borghese (che si poteva indossare nei giorni di libera uscita) del taglio migliore e che sapevano fare il più elegante salut oblique. Prima, quando Girardot faceva fare la prova di qualche cerimonia di Corte, drappeggiando un paggio in una coperta di cotonina a strisce rosse presa da uno dei nostri letti perché fungesse da imperatrice a un baisemain, i ragazzi si avvicinavano quasi devotamente all’imperatrice immaginaria, compivano seriamente la cerimonia di baciarle la mano e si ritiravano con un inchino elegantissimo; ma ora, anche se a Corte erano elegantissimi, alle prove facevano degli inchini così goffi che tutti si sbellicavano dal ridere, mentre Girardot impazziva dalla bile. Prima i ragazzi più giovani, quando erano condotti a un ricevimento di Corte, appositamente pettinati, si tenevano i riccioli tanto quanto duravano; ora, di ritorno dal palazzo, si affrettavano a mettere la testa sotto la fontana per farli sparire. Un contegno effeminato veniva deriso da tutti. Ormai si considerava più come una seccatura che come un favore essere mandati ai ricevimenti per fare da comparse ornamentali. E quando i ragazzi più piccoli, che venivano condotti ogni tanto a palazzo per giocare con i piccoli granduchi, accortisi che uno di questi, in un certo gioco, si faceva una frusta del fazzoletto e se ne serviva largamente, vollero fare altrettanto e picchiarono tanto un granduca da farlo piangere, Girardot ne fu spaventatissimo, ma il vecchio ammiraglio di Sebastopoli, che era il precettore del granduca, non ebbe che lodi per i nostri compagni.
Nel Corpo dei Paggi, come in tutte le altre scuole, andava prevalendo un nuovo spirito, di serietà e di studio. Un tempo i Paggi, certi di ottenere, con un mezzo o con l’altro, i punti necessari per essere nominati ufficiali nel reggimento della Guardia, passavano i primi anni alla scuola senza imparare quasi niente, e incominciavano a studiare un poco solo nelle ultime due classi; ora anche nelle classi inferiori si studiava con serietà. Anche moralmente il tono era ben diverso da quello di qualche anno prima. I divertimenti orientali erano ritenuti disgustosi e un paio di tentativi per ritornare al vecchio sistema dettero luogo a scandali la cui eco giunse fin nei saloni di Pietroburgo. Girardot fu licenziato. Ebbe solo il permesso di conservare il suo appartamento da scapolo nell’edificio della scuola, e lo vedevamo spesso, avvolto nel lungo mantello militare, passeggiare su e giù, immerso nei suoi pensieri – tristi, suppongo – perché non poteva che disapprovare il nuovo spirito che rapidamente si affermava nel Corpo dei Paggi.
In tutta la Russia non si parlava che di educazione. Appena firmata la pace a Parigi, la severità della censura diminuì e la questione dell’educazione diventò argomento di discussioni animate. L’ignoranza delle masse popolari, gli ostacoli posti fino a quel giorno sulla via di chi volesse istruirsi, la mancanza di scuole nelle campagne, i sistemi di insegnamento antiquati e i rimedi per questi mali divennero l’argomento prediletto delle discussioni nei circoli, nella stampa e, persino, nei saloni dell’aristocrazia. Le prime scuole superiori femminili si inaugurarono nel 1857 con un ottimo corpo di insegnanti e un eccellente sistema d’insegnamento. Come per incanto un gran numero di uomini e di donne si fecero avanti e non soltanto si dedicarono all’insegnamento, ma dimostrarono di essere nel loro lavoro degli ottimi studiosi di pedagogia: i loro scritti avrebbero un posto d’onore nella letteratura di ogni paese civile, se fossero conosciuti all’estero.
Il Corpo dei Paggi sentì gli effetti di questo risveglio. Salvo poche eccezioni, la tendenza generale nelle tre classi inferiori era di studiare. L’ispettore Vinkler che dirigeva la sezione culturale, un colonnello d’artiglieria molto colto, un bravo matematico e un uomo di idee progressiste, trovò un sistema eccellente per incoraggiare questo spirito. Sostituì i professori poco capaci che prima insegnavano nelle classi inferiori con altri migliori. Non si era mai abbastanza bravi per insegnare i primi elementi di una materia a dei ragazzi, e così per insegnare i primi princìpi dell’algebra alla quarta classe invitò un matematico di prim’ordine, con la vocazione dell’insegnante, il capitano Suchonin, e la classe si appassionò immediatamente alle matematiche. A proposito, il caso volle che questo capitano fosse il precettore dell’erede al trono (Nicola Aleksandrovič, che morì a ventidue anni) il quale veniva una volta la settimana al Corpo dei Paggi per sentire la lezione di algebra del capitano Suchonin. L’imperatrice, Maria Aleksandrovna, donna colta, sperava che la compagnia di ragazzi studiosi avrebbe incoraggiato suo figlio nell’amore per lo studio. Sedeva con noi e doveva rispondere alle domande come gli altri. Ma per lo più, mentre il professore parlava, faceva dei disegni molto graziosi e sussurrava scherzi di ogni genere ai suoi vicini. Era di buon cuore e molto gentile, ma molto superficiale negli studi, e ancor più negli affetti.
Per la quinta classe l’ispettore procurò degli insegnanti di valore. Venne un giorno da noi tutto contento a dirci che avevamo avuto una rara fortuna. Il professor Klasovskij, famoso classicista e specialista in letteratura russa, accettava di insegnarci grammatica russa per tutte e cinque le classi.
Un altro professore di università, Herr Becker, bibliotecario della libreria imperiale nazionale, avrebbe fatto altrettanto per il tedesco. Aggiunse che il professor Klasovskij quell’inverno era un poco sofferente, ma che non dubitava che ci saremmo comportati con lui da ragazzi bene educati. Non dovevamo perdere l’occasione di avere un simile insegnante.
Non si era sbagliato. Eravamo molto orgogliosi di avere per insegnanti dei professori d’università, e quantunque dalla Kamčatka (in Russia gli ultimi banchi di ogni classe portano il nome di quella lontana e selvaggia penisola) venisse la voce che “il fabbricante di salsicce”, cioè il tedesco, doveva essere tenuto a ogni costo alla larga, l’opinione pubblica della nostra classe era francamente favorevole al professore.
Il “fabbricante di salsicce” conquistò subito il nostro rispetto. Un uomo alto di statura, dalla fronte spaziosa, con gli occhi dolci e intelligenti, leggermente velati dagli occhiali, si presentò alla nostra classe e ci disse in un russo eccellente che intendeva dividere la nostra classe in tre sezioni. La prima sarebbe stata composta dai Tedeschi, che già conoscevano la lingua e dai quali si aspettava un lavoro più serio; alla seconda sezione insegnerebbe la grammatica e, più tardi, la letteratura tedesca secondo i programmi stabiliti; e la terza sezione, concluse con un simpatico sorriso, sarebbe la Kamčatka. “Da voi”, disse, pretenderò solo che a ogni lezione copiate quattro righe che vi sceglierò in un libro. Fatto questo, sarete liberi di fare quello che vi piace, purché non disturbiate gli altri. E vi prometto che in cinque anni avrete acquistato una certa conoscenza del tedesco e della letteratura tedesca. E ora, chi sarà nel gruppo dei Tedeschi? Voi, Stackelberg? Voi, Lansdorf? Qualcuno dei Russi, forse? E chi vuol essere della Kamčatka?”. Cinque o sei ragazzi che non sapevano una sillaba di tedesco andarono a occupare gli ultimi banchi. Copiavano scrupolosamente le loro quattro righe – dodici o venti nelle classi superiori – e Becker scelse questo esercizio con tanto giudizio, e si occupava con tanta cura di questi ragazzi, che alla fine dei cinque anni essi sapevano veramente qualche cosa della lingua tedesca e della sua letteratura.
Io appartenni al gruppo dei Tedeschi. Mio fratello Aleksandr insisteva tanto nelle sue lettere sulla necessità per me di imparare il tedesco, che ha una letteratura tanto ricca e che possiede la traduzione di ogni nuovo libro importante, che mi misi a studiarlo assiduamente. Tradussi e studiai a fondo una descrizione poetica di una tempesta, una pagina molto difficile; imparai a memoria, per consiglio del professore, le congiunzioni, gli avverbi e le preposizioni e incominciai a leggere. È un eccellente sistema per imparare le lingue. Becker inoltre mi consigliò di abbonarmi a un giornale settimanale illustrato di poco prezzo, e le illustrazioni e i brevi racconti mi incoraggiavano continuamente a leggere qualche linea o una colonna. Ben presto fui padrone della lingua.
Verso la fine dell’inverno pregai Herr Becker di prestarmi un esemplare del Faust di Goethe. L’avevo letto in una traduzione russa, e conoscevo il bellissimo romanzo di Turgenev intitolato Faust; ora desideravo ardentemente leggere il lavoro nell’originale. “Non capirete nulla, è troppo filosofico”, mi disse Becker con il suo sorriso dolce; ma ciò nonostante mi portò un piccolo libro quadrato dalle pagine ingiallite dagli anni, che conteneva il dramma immortale. Certo non immaginava la profonda gioia che mi diede con quel piccolo, desiderato volume. Mi immedesimavo nel senso e nella musica di ogni verso, a cominciare proprio dai primi della dedica, e presto seppi a memoria pagine intere. Il monologo di Faust nella foresta, e soprattutto quei versi nei quali esprime il suo modo di capire la natura:
Tu…
mi concedi una conoscenza non soltanto fredda e stupita,
ma permetti che io fissi i misteri
nel suo cuore, come si studia il cuore di un amico,
mi estasiavano e oggi ancora esercitano lo stesso fascino su di me. Ogni verso diventava per me un caro amico. C’è forse un godimento estetico più elevato di quello dato dalla lettura della poesia in una lingua che non si capisce perfettamente? Tutto è velato da una nebbia leggera che si adatta mirabilmente alla poesia. Parole che con il loro senso banale per chi conosce a fondo la lingua nuocciono a volte all’immagine poetica che debbono evocare, conservano solo il loro senso più elevato e profondo, mentre la misura del verso si imprime anche più profondamente nell’orecchio.
La prima lezione del professor Klasovskij fu per noi una vera rivelazione. Era un uomo di statura bassa, di una cinquantina d’anni, dalle movenze rapidissime, dagli occhi intelligenti e scintillanti, con una fronte alta da poeta. Quando entrò per la prima lezione, ci disse con voce debole che soffriva per una lunga malattia e che non poteva parlare a voce alta: ci pregava dunque di sedere più vicini a lui. Avvicinò la sua sedia alla prima fila dei nostri banchi e noi lo circondammo come uno sciame di api.
Doveva insegnarci la grammatica russa, ma invece di una noiosa lezione di grammatica sentimmo una cosa affatto diversa da quanto ci aspettavamo. Si trattava sempre di grammatica, ma ora faceva un paragone fra un’espressione di qualche poeta epico russo e un verso di Omero o del Mahābhārata, traducendo la bellezza del verso sanscrito con parole russe; ora introduceva un verso di Schiller, seguito da un’osservazione sarcastica a proposito di qualche pregiudizio della società moderna; poi di nuovo la grammatica propriamente detta, e poi qualche vasta generalizzazione poetica o filosofica.
Naturalmente molto di quello che diceva noi non lo capivamo, o ce ne sfuggiva il senso più profondo. Ma forse che il fascino di ogni studio non consiste nell’aprirci nuovi e insospettati orizzonti, non ancora del tutto compresi? Che cosa incoraggia a indagare sempre più, se non quello che a prima vista si rivela solo come un insieme confuso? Alcuni con le mani appoggiate alle spalle dei compagni, altri sporgendosi sui tavoli della prima fila, altri ancora in piedi intorno a Klasovskij, tutti pendevamo dalle sue labbra. Quando verso la fine dell’ora la sua voce si affievoliva, ascoltavamo trattenendo il respiro. Il direttore socchiuse la porta dell’aula per vedere come ci comportavamo con il nuovo insegnante, ma vedendo quello sciame immobile si ritirò in punta di piedi. Persino Darauv, uno spirito irrequieto, fissava Klasovskij come per dire: “Siete dunque un uomo di nuovo genere?” – Persino von Kleinau, uno stolido circasso dal nome tedesco, stava immobile. Nel cuore di noi tutti nasceva qualche cosa di nobile e di buono, come se ci fosse rivelata la visione di un nuovo mondo. Klasovskij ebbe su di me una grande influenza, che aumentò con gli anni. La profezia di Winkler si realizzava: la scuola incominciava a piacermi.
Nell’Europa occidentale, e probabilmente in America, questo tipo di insegnante è poco conosciuto; ma in Russia non vi è uomo o donna di rilievo nella letteratura o nella politica che non debba il primo impulso a un maggior sviluppo intellettuale all’insegnante di letteratura. Tutte le scuole dovrebbero avere questo professore. Ogni insegnante nella scuola ha la propria materia e non vi è un legame fra le varie discipline. Solo il professore di letteratura, tenuto alle linee generali del suo programma, ma libero di trattarlo come vuole, può dare unità alle diverse discipline storiche e letterarie grazie a una larga visione filosofica e umanistica, e risvegliare nel cuore dei giovani ideali e aspirazioni più nobili. In Russia quest’opera così importante spetta naturalmente al professore di letteratura russa. Mentre parla dello sviluppo della lingua, della primitiva poesia epica, dei canti e della musica popolare e più tardi del romanzo moderno, della letteratura scientifica, politica e filosofica del proprio paese, deve necessariamente dare agli allievi un’idea generale dell’evoluzione dello spirito umano, che esorbita da ognuna delle singole discipline che si insegnano loro.
Si dovrebbe fare altrettanto per le scienze naturali. Non basta insegnare la fisica, la chimica, l’astronomia, la meteorologia, la zoologia e la botanica. La filosofia delle scienze naturali, una visione generale della natura come entità, un po’ sul genere del primo volume del Cosmos di Humboldt, sono necessarie per gli scolari e gli studenti, qualsiasi possa essere l’importanza data nella scuola allo studio delle scienze naturali. La filosofia è la poesia della natura, i metodi seguiti dalle diverse scienze esatte dovrebbero far parte dell’educazione. Potrebbe assumersi questo incarico il professore di geografia, ma con altri insegnanti e professori universitari più competenti. Quello che si insegna oggi sotto questo nome sarà tutto quello che si vuole, ma non geografia.
Un altro professore conquistò la nostra classe, ma in modo un po’ diverso. Era questi il professore di calligrafia, il meno quotato degli insegnanti. Se i pagani – gli insegnanti di francese e di tedesco – erano poco rispettati, il professore di calligrafia, un ebreo tedesco di nome Ebert, era un vero martire. Mostrarsi insolente con lui era considerato molto elegante fra i paggi.
Solo la sua povertà estrema doveva essere la ragione per cui continuava a insegnare nel nostro corpo. I vecchi scolari, che ripetevano da due o tre anni la quinta, lo trattavano molto male, ma non so come, era venuto a patti con loro: “Uno scherzo a ogni lezione, ma non di più” un patto che temo non fosse sempre scrupolosamente osservato da parte nostra.
Un giorno uno degli abitanti della “lontana penisola” inzuppò la spugna della lavagna nell’inchiostro e la gettò contro il martire della calligrafia. “Prendilo, Ebert”, gridò con uno stupido sorriso. La spugna toccò la spalla di Ebert e l’inchiostro gli schizzò sul viso e gli macchiò la camicia bianca. Pensavamo che senz’altro questa volta Ebert avrebbe fatto rapporto al direttore. Invece si accontentò di dire, mentre levava il fazzoletto per pulirsi la faccia: “Signori, uno scherzo, basta per oggi!”. E aggiunse sottovoce: “La camicia è rovinata”, poi continuò a correggere il quaderno che aveva davanti.
Restammo meravigliati e vergognosi. Come mai, invece di fare rapporto si era calmato! La classe intera prese le sue parti. “Quello che hai fatto è idiota”, dicevamo rimproverando il nostro compagno. “È povero e gli hai rovinato la camicia! Vergognati!”, esclamò uno di noi. Il colpevole andò subito a scusarsi. “Bisogna imparare, signore”, fu l’unica risposta che gli diede Ebert con voce triste. Restammo tutti in silenzio e la lezione dopo, come se ci fossimo messi d’accordo, scrivemmo quasi tutti con la nostra più bella calligrafia e portammo i nostri quaderni a Ebert pregandolo di correggerli. Era raggiante e per un giorno si sentiva felice!
Questo episodio mi fece una profonda impressione e non l’ho più dimenticato. Sono grato oggi ancora a quell’uomo per la lezione che ci diede.
Non riuscimmo mai a stabilire buoni rapporti con il professore di disegno, un certo Ganz. Faceva continuamente dei rapporti contro quelli che giocavano nella sua classe. Secondo noi non aveva il diritto di farlo, prima di tutto perché era solo l’insegnante di disegno, ma soprattutto perché non era un uomo onesto. Durante la lezione si occupava ben poco della maggior parte di noi e occupava il suo tempo a correggere i disegni di quelli che prendevano lezioni private da lui, o che lo pagavano per poter portare agli esami un bel disegno e ottenere delle buone votazioni. Non ce la prendevamo con i compagni che facevano così. Al contrario, ci sembrava naturale che quelli che non riuscivano in matematica, o non avevano memoria per la geografia, aumentassero il totale dei voti facendosi fare da un disegnatore una carta topografica per avere delle medie migliori alla fine dell’anno. Solo ai due primi allievi della classe non avremmo certo riconosciuto il diritto di fare questo, ma gli altri lo potevano fare senza scrupoli. Il professore però non doveva fare questi disegni; e se voleva comportarsi così doveva poi rassegnarsi al baccano e agli scherzi dei suoi scolari. Questa era la nostra morale.
Non passava invece lezione senza che egli facesse rapporto, e ogni volta si faceva più arrogante.
Appena fummo nella quarta classe, e sentimmo di avere ormai diritto di cittadinanza nel corpo, decidemmo di ridurlo a più miti consigli. “La colpa è vostra”, ci dicevano i compagni più anziani, “se con voi si dà tante arie; noi lo abbiamo sempre tenuto a posto”. Decidemmo dunque di dargli una lezione.
Un giorno due dei migliori allievi della nostra classe si avvicinarono a Ganz con la sigaretta in bocca, pregandolo di accenderla. Non era naturalmente che uno scherzo – nessuno pensava mai di fumare nelle aule, secondo il nostro codice di quel che non si doveva fare. Ganz avrebbe dovuto semplicemente mandar via i ragazzi: invece scrisse i loro nomi nel registro e furono severamente puniti.
Fu la goccia che fece traboccare il vaso. Si decise di dargli una “serata d’onore”. Ciò significava che un giorno la classe intera, provvista di regoli prestati dalle classi superiori, avrebbe incominciato a fare un tal baccano, battendoli contro i banchi, da cacciare il professore dall’aula.
Questo piano presentava però molte difficoltà. Vi erano nella nostra classe parecchi ragazzi “modello”, che avrebbero accettato di partecipare alla dimostrazione, ma che all’ultimo momento si sarebbero spaventati e ritirati, e allora il professore avrebbe dato il nome degli altri. L’unanimità è indispensabile in imprese di questo genere, perché il castigo, qualunque sia, è sempre meno grave se colpisce la classe intera.
Le difficoltà furono superate con un’abilità degna di Machiavelli. A un segnale convenuto tutti dovevano voltare le spalle a Ganz e allora, con i regoli già preparati sulla fila vicina, si sarebbe fatto il rumore che volevamo. In questo modo i ragazzi modello non si sarebbero lasciati spaventare dagli sguardi di Ganz. Ma quale doveva essere il segnale? Non si poteva ricorrere, come nei racconti di banditi, a fischiare, gridare e neppure a starnutire. Ganz sarebbe stato capace di denunciare chiunque avesse fischiato o starnutito. Doveva essere un segnale silenzioso. Uno di noi, che disegnava benino, avrebbe portato il suo lavoro da vedere a Ganz, e il momento in cui fosse tornato a sedere – quello sarebbe stato il momento fatale!
Tutto andò bene. Nesadov portò il suo disegno e Ganz lo corresse in pochi minuti, che a noi sembrarono una eternità. Finalmente tornò al suo posto: si fermò un momento, ci guardò e sedette… Immediatamente tutta la classe si voltò sulle panche e i regoli batterono allegramente sulle tavole, mentre parecchi di noi gridavano in mezzo al baccano: “Fuori Ganz, abbasso Ganz!”. Il baccano era assordante; in tutte le classi si seppe che Ganz aveva avuto il fatto suo. Rimase là a mormorare qualche cosa e finalmente uscì. Arrivò di corsa un ufficiale – il rumore continuava, poi accorse il vice direttore. Il rumore cessò. Incominciarono le sgridate.
“Il capoclasse agli arresti”, comandò l’ispettore; e io che ero il primo della classe quindi il capoclasse, fui condotto nella cella di punizione. Mi fu risparmiato così di assistere a quello che seguì. Venne il direttore: Ganz fu pregato di nominare i capi dell’insurrezione, ma non fu in grado di farlo. “Mi voltarono tutti le spalle e incominciò il baccano”, disse. Allora fu condotta fuori tutta la classe e, benché l’uso del bastone nella nostra scuola fosse stato completamente abbandonato, questa volta i due che erano stati messi a rapporto per aver chiesto del fuoco per fumare furono fustigati con la canna, con il pretesto che la dimostrazione voleva essere una vendetta per il castigo che avevano dovuto subire.
Seppi questo, dieci giorni dopo, quando ebbi il permesso di tornare in classe. Il mio nome, che era stato messo sul quadro d’onore, era stato cancellato. Me ne importava poco; ma devo confessare che dieci giorni passati in cella, senza libri, mi erano parsi molto lunghi, anche se avevo composto, in versi più che barbari, una poesia in onore delle gesta della mia classe.
Per un pezzo, naturalmente, fummo gli eroi della nostra scuola. Per più di un mese dovemmo raccontare e tornare a raccontare i particolari della vicenda alle altre classi, e riceverne le lodi per aver saputo organizzare la cosa con tanta unanimità da escludere ogni punizione personale. Poi vennero le domeniche – tutte le domeniche fino a Natale – in cui dovevamo rimanere nella scuola, senza il permesso di andare a casa. Siccome stavamo tutti insieme, riuscivamo a passare la giornata allegramente. Le mamme dei “ragazzi modello” portarono una quantità di dolci; quelli che avevano del denaro lo spendevano a comperare dei pasticci – piuttosto solidi prima del pranzo e dolci dopo – mentre di sera gli amici delle altre classi riuscivano a fare entrare di contrabbando gran quantità di frutta per i loro coraggiosi compagni.
Ganz non fece più rapporti; ma noi eravamo del tutto disgustati del disegno. Nessuno voleva lavorare con quell’uomo venale.
Nel frattempo mio fratello Aleksandr viveva a Mosca in un reggimento di cadetti, e ci scambiavamo un’assidua corrispondenza. In casa nostra questo non era possibile, perché nostro padre considerava suo diritto leggere tutte le lettere che arrivavano e avrebbe messo fine a ogni corrispondenza che non fosse stata del tutto banale. Ora invece eravamo liberi di discutere nelle nostre lettere tutto quello che volevamo. La sola difficoltà era quella di ottenere il denaro per i francobolli; ma non tardammo a imparare a scrivere in una calligrafia così minuta, che ci riusciva possibile dire una incredibile quantità di cose in ogni lettera. Aleksandr, che aveva una bellissima calligrafia, sapeva mettere quattro pagine di stampa in un solo foglio di carta da lettere, e i suoi caratteri miscroscopici erano leggibili quanto i migliori caratteri a stampa. È un peccato che queste lettere, che egli conservava come preziose memorie, siano sparite. La polizia di Stato, durante una delle tante perquisizioni, gli rubò anche queste!
Le nostre prime lettere parlavano soprattutto dei particolari del mio nuovo ambiente, ma la nostra corrispondenza non tardò a prendere un tono più serio. Mio fratello non poteva scrivere a proposito di sciocchezze. Anche in società si animava solo quando la discussione prendeva un carattere di serietà, e si lamentava di “un sordo dolore al cervello” – un dolore fisico, diceva – quando si trovava in compagnia di persone che non conoscessero che la conversazione frivola. Per lo sviluppo intellettuale era molto più maturo di me, e mi spingeva avanti, sollevando nuovi problemi scientifici e filosofici uno dopo l’altro e consigliandomi nelle mie letture e nei miei studi. Che fortuna fu per me un fratello simile! Un fratello poi che mi amava con vera passione. A lui devo la miglior parte della mia formazione.
Talvolta mi consigliava di leggere delle poesie e mi mandava nelle sue lettere versi e interi componimenti poetici che scriveva a memoria. “Leggi i poeti”, mi diceva, “la poesia rende gli uomini migliori!”. Egli stesso era poeta e scriveva con meravigliosa facilità versi pieni di armonia; penso anzi che fu un vero peccato che egli abbandonasse la letteratura. Ma la reazione contro l’arte, che sorse in mezzo alla gioventù russa verso il sessanta, e che Turgenev ha descritto nel Bazarov di Padri e figli, lo portò a disprezzare i versi e a darsi esclusivamente alle scienze naturali. Devo dire però che il mio poeta prediletto non era di quelli che egli prediligeva per il suo dono poetico, il suo orecchio musicale e il suo spirito filosofico. Il poeta russo che più gli piaceva era [Dmitrij] Venevitinov, mentre il mio era Nekrasov, che scriveva versi spesso non armoniosi, ma che mi commoveva per il suo amore per gli oppressi e i reietti.
“Bisogna sapersi prefiggere uno scopo nella vita”, mi scrisse una volta; “senza scopo, senza meta, una vita non è vita”. E mi consigliò di volgere la mia mente a uno scopo che le desse un valore. Ero allora troppo giovane per farlo; ma qualche cosa di impreciso, di vago, di profondamente buono sorse in me a quell’appello, quantunque non sapessi dire allora che cosa sarebbe stato.
Nostro padre ci dava pochissimo denaro da spendere e non ne avevo mai da comperarmi anche un solo libro; ma se Aleksandr riceveva qualche rublo da una delle zie, non ne spendeva mai un soldo in divertimenti, comperava invece un libro e me lo spediva. Però non ammetteva la lettura disordinata. “Bisogna sempre rivolgere una domanda al libro che si sta per leggere”, mi scriveva. Ma non apprezzavo allora questa sua osservazione e ora non posso pensare senza meraviglia al numero di libri, spesso di un carattere specializzato, che lessi allora, trattanti di ogni cosa un po’, e soprattutto di storia. Non perdevo il mio tempo con i romanzi francesi, da quando Aleksandr, molti anni prima, li aveva qualificati con una frase brutale: “Sono stupidi e pieni di parolacce”.
I grandi problemi della natura dell’universo formavano naturalmente il principale argomento della nostra corrispondenza.
Da bambini non eravamo mai stati religiosi. Ci si conduceva in chiesa, ma in una chiesa russa; in una piccola parrocchia di villaggio il contegno solenne dei fedeli è molto più impressionante della messa stessa. Di tutto quello che avevo visto in chiesa, due sole cose mi avevano fatto impressione: i dodici versetti del Vangelo sulla passione di Cristo, che si leggono in Russia durante la funzione notturna, la vigilia del venerdì santo, e la breve preghiera che condanna lo spirito di predominio, che si recita durante la Grande Quaresima e che è veramente bella per le sue parole semplici e senza pretesa e per il sentimento che esprime. Puškin l’ha messa in versi russi.
Più tardi, a Pietroburgo, frequentai parecchie volte una chiesa cattolica romana, ma la funzione teatrale e la mancanza di un sentimento sincero mi ripugnavano, tanto più quando notavo la semplice fede con la quale qualche vecchio veterano polacco o qualche contadina pregavano in un angolo appartato. Andai anche in una chiesa protestante; ma all’uscita mi sorpresi a mormorare le parole di Goethe:
Ma non potrai mai unire i cuori
se l’unità non nasce nel tuo stesso cuore.
A quel tempo Aleksandr, con il suo solito fervore, aveva abbracciato la fede luterana. Aveva letto il libro di Michelet su Serveto e si era formato una religione secondo le indicazioni di quel grande lottatore. Studiò con entusiasmo la dichiarazione di Augusta, che copiò e mi mandò, e le nostre lettere di quel periodo erano piene di discussioni teologiche a proposito della grazia e di versetti degli apostoli Paolo e Giacomo. Seguivo mio fratello, ma le discussioni teologiche non mi appassionavano. Guarito dal tifo, le mie letture presero una direzione affatto diversa.
Nostra sorella Elena si era sposata e abitava a Pietroburgo, e tutti i sabato sera andavo da lei. Suo marito possedeva una buona biblioteca nella quale i filosofi francesi del XVIII secolo e gli storici francesi moderni erano ben rappresentati. Questi libri erano proibiti in Russia, e naturalmente non si potevano portare a scuola; passavo dunque quasi tutta la notte del sabato a leggere i lavori degli enciclopedisti, il Dizionario filosofico di Voltaire, gli scritti degli storici, soprattutto di Marco Aurelio, e così via. L’immensità infinita dell’universo, la grandiosità della natura, la sua poesia, la sua vita sempre palpitante, mi impressionavano sempre più; quella vita che mai cessa e le sue armonie mi davano quell’ammirazione estatica, quei trasporti dei quali la giovane anima è assetata, mentre i miei poeti prediletti esprimevano per me quel nascente amore per l’umanità e quella fede nel suo progresso che costituiscono il meglio della gioventù e che lasciano la loro impronta nell’uomo per tutta la vita.
Nel frattempo Aleksandr si era convertito all’agnosticismo di Kant e la “Relatività delle percezioni”, “Le percezioni nel tempo e nello spazio e nel tempo soltanto”, ecc., riempivano pagine intere delle nostre lettere, la cui calligrafia diventava sempre più microscopica man mano che la discussione si faceva più seria. Ma né allora né più tardi, quando potemmo passare ore ed ore a discutere la filosofia di Kant, mio fratello poté convertirmi alle teorie del filosofo di Königsberg.
Le scienze esatte, – cioè la matematica, la fisica e l’astronomia – formavano i miei studi principali. Nel 1858, prima che Darwin avesse pubblicato il suo libro immortale, Roulier, professore di zoologia all’università di Mosca, stampò tre sue conferenze sul trasformismo e mio fratello si interessò immediatamente alle sue idee a proposito della variabilità delle specie. Egli non si accontentava però delle sole prove approssimative e incominciò a studiare una quantità di libri speciali sull’eredità e sui problemi del genere, e mi comunicava nelle sue lettere i fatti principali, assieme alle sue idee e ai suoi dubbi. La pubblicazione della Origine delle specie non lo persuase in parecchi punti; non fece che sollevare nuovi problemi, spingendolo a studi ulteriori.
Più tardi discutemmo – e fu una discussione che durò parecchi anni – varie questioni aventi rapporto con la origine delle variazioni, la possibilità di trasmetterle e di accentuarle; insomma gli stessi problemi che sono stati posti ultimamente dalla controversia Weissmann-Spencer, dalle ricerche di Galton e dalle opere dei moderni neolamarckiani. Grazie al suo spirito filosofico e critico, Aleksandr aveva subito afferrato l’importanza fondamentale di queste discussioni pro e contro la teoria della variabilità delle specie, quantunque non fosse allora rilevata dalla maggior parte dei naturalisti.
Devo ricordare anche una breve incursione nel regno dell’economia politica. Negli anni fra il 1858 e il 1859 tutti in Russia si occupavano di economia politica; le conferenze sul libero scambio e sulle tariffe protezionistiche richiamavano un pubblico numeroso, e mio fratello, non ancora preoccupato della variabilità delle specie, prese un vivo interesse anche se di breve durata, agli studi di economia e mi mandò l’Economia politica di G. B. Say. Ne lessi solo pochi capitoli: le tariffe e le operazioni bancarie non mi interessavano affatto; ma Aleksandr ci si appassionò tanto che scrisse persino delle lettere alla nostra matrigna, cercando di interessarla ai diritti di dogana. Più tardi, in Siberia, nel rileggere alcune lettere di quell’epoca ridemmo di gusto ritrovandone una in cui egli si lamentava dell’incapacità che dimostrava la nostra matrigna di interessarsi a problemi così ardenti, e in cui inveiva contro un ortolano incontrato per strada, il quale “lo puoi credere”, scriveva con segni esclamativi, quantunque fosse un commerciante ostentava un’ostinata indifferenza alle questioni di tariffa!
Ogni estate una metà circa dei Paggi andava al campo a Peterhof. Le classi inferiori, però, erano esonerate da quel servizio, e io passai le prime due estati a Nikolskoje. Lasciare la scuola, prendere il treno per Mosca e incontrarvi Aleksandr, era una prospettiva così cara che contavo i giorni che dovevano ancora passare prima di quell’istante tanto desiderato. Ma una volta dovetti subire una crudele delusione a Mosca. Aleksandr non passò l’esame e dovette ripetere la classe. Era veramente troppo giovane ancora per le classi tecniche, ma nostro padre ne fu adiratissimo e non ci permise di vederci. Mi sentivo molto infelice. Non eravamo più bambini e avevamo tante cose da dirci!
Cercai di ottenere il permesso di andare da una nostra zia, Sulima, dove avrei potuto incontrare Aleksandr, ma ebbi un rifiuto reciso. Dopo il secondo matrimonio di nostro padre non ci fu mai permesso di visitare i parenti da parte di nostra madre.
La nostra casa a Mosca fu piena di invitati quella primavera. Ogni sera i saloni risplendevano di luce, si faceva della musica, il pasticciere aveva un gran da fare a preparare dolci e gelati e nella sala grande si giocava a carte fino a tarda ora. Io gironzolavo senza scopo per le sale illuminate a giorno e mi sentivo infelice.
Una sera, dopo le dieci, un servo mi fece cenno, dicendomi di raggiungerlo in anticamera. Andai. “Venite in casa del cocchiere”, mi sussurrò il vecchio maggiordomo Frol, “Aleksandr Alekseevič vi aspetta”.
Mi precipitai attraverso il cortile e su per le scale che conducevano alla casa del cocchiere. In una grande stanza mezzo buia, seduto all’immenso tavolo da pranzo dei servitori, vidi Aleksandr.
“Sascia, caro, come sei venuto?”, e ci abbracciammo forte, incapaci di parlare per l’emozione.
“Zitti, zitti, potrebbero sentirvi”, disse Praskovia, la cuoca dei servi, asciugandosi gli occhi con il grembiale.
“Poveri orfani! Se vivesse vostra madre!”.
Il vecchio Frol stava con la testa bassa, i lucciconi agli occhi.
“Bada Petia, non una parola a nessuno, a nessuno”, diceva, mentre Praskovia metteva in tavola una pentola piena di minestra per Aleksandr.
Egli, raggiante di salute nella sua divisa da cadetto, cominciò a parlare un po’ di tutto senza smettere di mangiare. Riuscivo a stento a fargli raccontare come si trovasse là a un’ora così tarda. Abitavamo allora sul viale Smolensk, a un passo dalla casa dove era morta nostra madre, e il Corpo dei Cadetti stanziava nei sobborghi di Mosca, nella direzione opposta, ben cinque miglia lontano.
Aveva fatto un fantoccio con i suoi abiti e lo aveva messo a letto sotto le coperte; poi era andato alla torre, era sceso da una finestra, uscito inosservato e aveva fatto tutta la strada a piedi.
“E non hai avuto paura nei campi deserti vicino alla vostra caserma?”, gli chiesi.
“Di che dovevo aver paura? Solo i cani mi hanno inseguito: li avevo disturbati. Domani porterò la spada”.
Il cocchiere e i servi entravano e uscivano: sospiravano vedendoci e si sedevano in disparte, lungo il muro, scambiando poche parole sottovoce per non disturbarci; mentre noi due, stretti vicino, rimanemmo seduti fino a mezzanotte, discorrendo di nebulose e dell’ipotesi di Laplace, della formazione della materia, delle lotte fra l’impero e il papato sotto Bonifacio VIII, e così via.
Ogni tanto uno dei servi accorreva frettoloso per dirmi: “Petinka, vai a farti vedere nel salone, potrebbero chiedere di te”.
Supplicai Sascia di non tornare la notte dopo; ma venne ugualmente, non senza aver avuto a che fare con i cani, contro i quali si era armato di spada. Accorsi con ansietà febbrile quando, più presto della sera prima, fui chiamato di nuovo in casa del cocchiere. Aleksandr aveva fatto un pezzo del tragitto in carrozza. La sera prima uno dei servi gli aveva portato parte delle mance regalategli dai giocatori, pregandolo di servirsene. Egli aveva accettato pochi spiccioli per pagare la vettura, e così era arrivato prima della sera precedente.
Voleva tornare il giorno dopo, ma sarebbe stato troppo pericoloso per i servi e decidemmo di lasciarci fino all’autunno. Un bigliettino convenzionale mi informò il giorno dopo che le sue scappate notturne non erano state scoperte. Quanto sarebbe stato grave il castigo altrimenti! Fa orrore pensarvi! Sarebbe stato fustigato davanti a tutto il corpo finché, privo di sensi, sarebbe stato portato via su di un lenzuolo, per poi essere degradato e mandato in un battaglione di semplici soldati – tutto era possibile a quei tempi!
Quello che avrebbe sofferto la servitù per averci nascosto, se nostro padre avesse avuto sentore della faccenda, sarebbe stato altrettanto terribile, ma sapevano tenere un segreto e non tradirsi. Tutti sapevano delle visite di Aleksandr, ma nessuno ne sussurrò parola a chicchessia.
Loro ed io fummo i soli in casa a conoscere il segreto.
Quello stesso anno feci il mio primo esperimento come studioso della vita popolare; questo tentativo mi avvicinò di un passo ai nostri contadini, facendomeli vedere sotto una luce nuova, e più tardi mi fu di grande aiuto in Siberia.
Tutti gli anni in luglio, per la festa della Madonna di Kazan, che era la patrona della nostra chiesa, si teneva una fiera molto importante a Nikolskoje. I negozianti accorrevano dalle città vicine e i contadini da trenta miglia intorno venivano a migliaia al nostro villaggio, che per due giorni prendeva un aspetto animatissimo. Lo slavofilo [Sergej] Aksakov quell’anno aveva pubblicato uno studio importante sulle fiere nei villaggi della Russia meridionale e mio fratello, allora al colmo del suo entusiasmo per l’economia politica, mi consigliò di fare uno studio statistico sulla nostra fiera e di calcolare il valore delle compere e delle vendite. Seguii il suo consiglio e, con mia grande sorpresa, riuscii nel mio intento; il mio calcolo delle entrate, per quanto posso giudicare, non era molto più inesatto di molti calcoli del genere dei libri di statistica.
La fiera durava poco più di ventiquattro ore. La vigilia della festa la grande piazza dove si svolgeva offriva una scena animatissima. Lunghe file di baracche dove si vendevano cotonine, nastri, e ogni genere di oggetti di vestiario per le contadine, venivano frettolosamente costruite. La trattoria, una solida costruzione in pietra, veniva rifornita di tavoli, sedie e panche, e sul pavimento si spargeva sabbia gialla. In tre punti diversi venivano aperti tre spacci di vino, e le frasche nuove, alzate su lunghi pali, si levavano nell’aria per richiamare da lontano i contadini. Numerose file di baracche di legno per la vendita di terraglie, scarpe, stoviglie, pan di Spagna e ogni specie di oggetti minuti, sorgevano come per incanto, mentre in un angolo apposito si scavavano in terra delle buche per mettervi le enormi caldaie nelle quali venivano lessate staia di miglio, di granoturco, e pecore intere, per fornire alle migliaia di intervenuti lo sci e la kascia calda (brodo e polenta). Nel pomeriggio le quattro strade di accesso alla fiera erano stipate di centinaia di contadini con i carri e il bestiame, il grano, i barili pieni di catrame; e montagne di terraglia venivano esposte lungo le vie.
La messa notturna, alla vigilia della festa, si celebrava nella nostra chiesa con grande solennità. Una mezza dozzina di preti e diaconi dei villaggi vicini vi partecipavano e i loro cantori, con il rinforzo di giovani bottegai, cantavano nel coro, con ritornelli quali non si potevano sentire che dal vescovo di Kaluga. La chiesa era affollata. Tutti pregavano con fervore. I negozianti facevano a gara nella grossezza e nel numero dei ceri che accendevano davanti alle icone come offerte ai santi locali per la buona riuscita dei loro affari; e poiché la folla era tanto grande da non permettere agli ultimi arrivati di avvicinare gli altari, i ceri di ogni grandezza – grossi e sottili, bianchi e gialli, secondo i mezzi del donatore – venivano fatti passare dal fondo della chiesa, sussurrando le indicazioni: “per la Santa Maria Vergine di Kazan, nostra protettrice”, “a Nicolò il Prediletto”, “a Frol e Laur” (i santi protettori dei cavalli; da quelli che avevano cavalli da vendere) o semplicemente “ai Santi”, senza altre indicazioni.
Appena terminata la messa notturna incominciavano i preliminari della fiera e io dovetti mettermi immediatamente al lavoro, interrogando centinaia di persone sul valore delle mercanzie che avevano portato. Con mia grande sorpresa il lavoro procedeva magnificamente. Naturalmente fui interrogato a mia volta: “Perché chiedi questo? Il vecchio principe non vorrà per caso aumentare i diritti di mercato?”. Ma tutti i dubbi furono messi in fuga dalla mia affermazione che “il vecchio principe” non ne sapeva e non ne avrebbe mai saputo niente (egli avrebbe considerato la mia un’occupazione vergognosa). Presto acquistai una certa pratica nel fare le domande, e dopo aver bevuto una mezza dozzina di tazze di tè alla trattoria con alcuni negozianti (orrore e spavento se l’avesse saputo mio padre!) tutto procedette benissimo. Vassili Ivanov, il responsabile di Nikolskoje, un bellissimo giovane contadino dalla faccia colorita e intelligente e dalla barba fine e bionda, si interessò al mio lavoro. “Va bene, se ti occorre per i tuoi studi fallo pure; ci dirai più tardi quello che hai imparato”, fu la sua conclusione; e disse agli altri: “È una buona cosa”. Egli era conosciuto da tutti, per parecchie miglia intorno, e l’assicurazione che non ne sarebbe venuto nessun danno ai contadini se mi fornivano le informazioni, fece il giro della festa.
Le importazioni, insomma, furono calcolate con sufficiente precisione.
Ma il giorno dopo il “calcolo delle vendite” fu molto più difficile, soprattutto per i merciai, che non sapevano ancora neppure loro per quanto avevano venduto. Il giorno della festa le allegre contadine prendevano d’assalto le botteghe; ognuna aveva venduto la tela fatta in casa e ora si comperava la cotonina per farsi un vestito e uno scialletto dai colori vivaci, un fazzoletto di colore per il marito, forse qualche pizzo e qualche nastro e una quantità di regali per la nonna, il nonno, e i bambini rimasti a casa. Quanto ai contadini che vendevano terraglia o pan di Spagna, o bestiame e canapa, calcolavano subito le loro vendite, soprattutto le vecchie. “Hai fatto buoni affari, nonnina?”, chiedevo, “Non posso lamentarmi, figliolo. Perché dovrei irritare il buon Dio? Ho venduto quasi tutto”. E sommando le loro piccole entrate, le decine di migliaia di rubli crescevano nel mio quaderno. Un punto solo rimaneva incerto. Un largo spiazzo era riservato a parecchie centinaia di contadine che stavano sotto il sole cocente, ognuna con la sua pezza di tela di lino tessuta a mano, spesso di una finezza squisita, che aveva portato da vendere; e un gran numero di compratori dalle facce da zingaro e dallo sguardo rapace si aggiravano in mezzo a loro. Evidentemente non si poteva fare che un calcolo approssimativo di queste vendite.
Non trassi allora nessuna conclusione da questo mio nuovo esperimento. Ero soddisfatto di constatare che non era stato un insuccesso. Ma il buon senso e la solidità di giudizio dei contadini russi di cui ebbi la prova in quei due giorni mi fecero un’impressione duratura. Più tardi, quando facevamo propaganda socialista in mezzo ai lavoratori, non potevo non meravigliarmi di alcuni dei miei compagni, che apparentemente avevano ricevuto un’educazione più democratica della mia, e che non erano capaci di discorrere con i contadini o con gli operai venuti dalla campagna. Cercavano di imitare il loro modo di parlare con gran numero di cosiddette “espressioni popolari”, che non facevano che renderli ancor più incomprensibili.
Non vi è affatto bisogno di queste frasi, né parlando né scrivendo per i contadini. Il contadino della Grande Russia è perfettamente in grado di capire i discorsi di un uomo colto, purché questi non si serva continuamente di parole straniere. Quello che il lavoratore non capisce sono le idee astratte quando non siano illustrate da esempi pratici. Ma quando si parla a un contadino russo con chiarezza, partendo da fatti concreti, allora capisce perfettamente, e questo è vero anche per i contadini di qualsiasi nazionalità; la mia esperienza mi insegna che non esiste generalizzazione scientifica, che non sia possibile far capire a un uomo di intelligenza media se chi parla la spiega in modo concreto. Mi pare che la principale differenza fra l’uomo istruito e l’ignorante consiste nel fatto che quest’ultimo non è in grado di seguire una catena di deduzioni logiche. Ne afferra la prima, forse la seconda, ma alla terza si stanca e non capisce dove si voglia arrivare. Ma questa è una difficoltà che si incontra spessissimo anche con le persone colte.
Questo mio lavoro da ragazzo mi diede un’altra impressione: un’impressione che formulai soltanto più tardi e che sorprenderà certo molti lettori. Rimasi colpito dal senso dell’eguaglianza così fortemente sviluppato nel contadino russo e dappertutto fra la popolazione rurale. Il contadino russo potrà mostrarsi di una docilità servile verso il padrone o l’ufficiale di polizia, si sottometterà umilmente alla loro volontà, ma non li considera degli esseri superiori, e se il momento dopo quello stesso proprietario o ufficiale di polizia parla a quel contadino di fieno o di anatre, quest’ultimo discorrerà con loro da pari a pari. Non ho mai trovato in un contadino russo quella servilità, diventata una seconda natura, con la quale un piccolo funzionario parla a una persona altolocata, o un cameriere al suo padrone. Il contadino si sottomette con troppa facilità alla forza, ma senza adorarla.
Ritornai quell’estate da Nikolskoje tutto rinnovato. Allora non esisteva la ferrovia fra Kaluga e Mosca e un certo Buck aveva alcune diligenze che facevano servizio fra le due città. La nostra famiglia non aveva mai pensato di servirsene; aveva le sue carrozze e i suoi cavalli; ma quando mio padre, per risparmiare alla mia matrigna un doppio viaggio, mi propose, quasi per scherzo, di fare il viaggio da solo con quel mezzo, accettai la proposta con entusiasmo.
Unici viaggiatori erano la moglie di un negoziante, una vecchia grassissima, e io, poi un negoziante o artigiano seduto a cassetta davanti. Trovai il viaggio piacevolissimo – prima di tutto perché viaggiavo da solo (non avevo ancora sedici anni) e poi perché la vecchia signora, che aveva con sé un’enorme cesta piena di viveri per i tre giorni del viaggio, mi colmò di ogni specie di ghiottonerie fatte in casa. Tutti i particolari di quel viaggio mi divertirono. Una sera arrivammo in una grossa borgata e ci fermammo alla trattoria principale; la vecchia signora si fece portare il samovar e io me ne andai in giro per il paese. Una piccola “trattoria bianca”, di quelle dove si serve da mangiare ma non si danno bibite fermentate, attirò la mia attenzione, e vi entrai. Un gran numero di contadini stavano seduti a dei tavolini rotondi con le tovaglie bianche a godersi il tè. Feci altrettanto.
Era un ambiente completamente nuovo per me. Si trattava di un villaggio di “contadini della Corona”, contadini non servi, cioè, che godevano di un relativo benessere, dovuto probabilmente alla tessitura della tela che praticavano come industria casalinga. Conversazioni serie e tranquille, interrotte ogni tanto dal riso, si svolgevano attorno a quelle tavole, e dopo le solite domande introduttive mi trovai a chiacchierare con una dozzina di contadini sul raccolto nelle nostre terre, e a rispondere a un’infinità di domande. Chiedevano notizie di Pietroburgo e si interessavano soprattutto delle voci che correvano sulla liberazione dei servi. Un senso di semplicità, di sincera cordialità e un trattare con naturalezza da pari a pari, che ho poi sempre trovato in mezzo ai contadini, mi conquistò in quella trattoria. Non accadde nulla di particolare quella sera, tanto che mi chiedo se è un episodio degno di nota; eppure quella scura notte nel villaggio, quella piccola trattoria, quella conversazione con i contadini e la loro curiosità per mille cose nuove per il loro ambiente, mi lasciarono un’impressione tale, che una povera “trattoria bianca” mi ha poi sempre attirato, più del più bel ristorante del mondo.
Vennero giorni tempestosi per il nostro Corpo dei Paggi. Quando Girardot fu licenziato, fu sostituito da uno dei nostri ufficiali, il capitano B. Era un uomo piuttosto bonario, ma si era messo in testa che non lo si rispettasse abbastanza, per l’alta posizione che ormai occupava; cercò quindi di terrorizzarci e di obbligarci a un maggior riguardo per la sua persona. Incominciò col litigare per una quantità di sciocchezze con la classe superiore, poi, quel che era peggio, cercò di calpestare le nostre “libertà”, la cui origine si perdeva nella notte dei tempi e che, insignificanti per se stesse, forse appunto per questo ci erano carissime.
Il risultato fu che la scuola per parecchi giorni visse in uno stato di aperta ribellione, ribellione che terminò con un castigo generale e l’espulsione dal corpo di due dei nostri più cari compagni.
Poi il capitano incominciò a introdursi nelle sale di studio, dove la mattina avevamo l’abitudine di passare un’ora a preparare le nostre lezioni prima dell’inizio della scuola. Là ci consideravamo sotto la sorveglianza dei nostri insegnanti e ci sentivamo felici, liberi dai nostri superiori militari. Questa intrusione del capitano fu vista molto male da noi, e un giorno espressi ad alta voce il vivo malcontento di noi tutti, dicendogli che quello era il posto dell’ispettore delle classi, non il suo. Pagai la mia franchezza con settimane di arresti e forse sarei stato espulso dalla scuola, se non fosse stato per l’intervento dell’ispettore delle classi, del suo aiuto e persino del nostro vecchio direttore, i quali giudicarono che io non avevo fatto che esprimere ad alta voce quello che tutti andavano dicendo.
Erano appena stati sedati questi tumulti, quando a interrompere il nuovo corso dei nostri studi venne la morte dell’imperatrice madre, la vedova di Nicola I. I funerali dei sovrani sono sempre organizzati in modo da impressionare profondamente la folla, e devo ammettere che questo scopo fu raggiunto. La salma dell’imperatrice fu trasportata da Zarskoje Selo, dove era morta, a Pietroburgo; e seguita dalla famiglia imperiale, da tutti gli alti dignitari di Stato, da migliaia di funzionari e di corporazioni, preceduta da centinaia di ecclesiastici e cantori, fu trasportata dalla stazione, attraversando le vie principali, alla fortezza, dove rimase esposta durante alcune settimane.
Lungo le strade erano allineati centomila uomini della Guardia e migliaia di persone, vestite delle più ricche divise, precedevano, accompagnavano e seguivano la bara in una solenne processione. Nei punti principali del percorso si cantavano le litanie e allora il rintocco delle campane dalle chiese, i canti degli immensi cori e le musiche militari si univano in un insieme dei più impressionanti per far credere che la folla immensa piangesse veramente la morte dell’imperatrice.
Finché la salma rimase esposta nella chiesa della fortezza, i Paggi dovettero montarvi la guardia con gli altri, giorno e notte.
Tre Paggi del seguito e tre damigelle d’onore stavano ininterrottamente vicino alla bara, alzata, su un alto piedistallo, mentre una ventina di Paggi stava sulla piattaforma, dove due volte al giorno si cantavano le litanie in presenza dell’imperatore e della sua famiglia. Tutte le settimane, quindi, una metà del corpo veniva condotta a turno in fortezza, dove veniva alloggiata.
Ci si dava il cambio quasi ogni due ore, e di giorno il servizio non era pesante; ma quando ci si doveva alzare di notte, indossare la divisa di Corte e poi attraversare gli oscuri e lugubri cortili della fortezza per raggiungere la chiesa, mi coglieva un fremito al pensiero dei prigionieri sepolti vivi in qualche parte di quella Bastiglia russa. “Chi sa” – mi dicevo, – “se non mi toccherà raggiungerli un giorno o l’altro?”.
Prima che i funerali terminassero avvenne un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze gravi. Sotto la cupola, al di sopra della bara, era stato alzato un enorme baldacchino. Su di esso si alzava una grande corona dorata e da questa pendeva un amplissimo manto di porpora, foderato di ermellino, che si stendeva fino alle quattro colonne massicce che reggono la cupola. L’effetto era imponente, ma noi ragazzi ci accorgemmo presto che la corona era fatta di cartone dorato e di legno, che soltanto le falde del manto erano di velluto, mentre la parte superiore era di cotonina rossa, e che l’ermellino non era che fustagno, al quale erano state cucite code nere di scoiattolo, mentre gli stemmi abbrunati di crespo che rappresentavano le armi della Russia erano di cartone.
La folla che aveva il permesso di passare davanti alla bara durante certe ore della notte e di baciare frettolosamente il broccato d’oro che la copriva, non aveva certo il tempo di esaminare l’ermellino di flanella o gli stemmi di cartone, e l’effetto teatrale che si era voluto ottenere era raggiunto anche con questi mezzi meschini.
In Russia quando si canta una litania tutti i presenti reggono ceri accesi che devono essere spenti dopo la lettura di certe preghiere. Anche la famiglia imperiale aveva di queste candele, e un giorno il figlioletto del granduca Costantino, vedendo che gli altri le spegnevano rovesciandole, fece altrettanto. Il velo nero che pendeva da uno scudo alle sue spalle si accese e in un istante lo scudo e la cotonina furono in fiamme. Un’enorme lingua di fuoco corse lungo le pieghe pesanti del finto manto di ermellino.
La funzione fu sospesa. Tutti gli sguardi inorriditi erano fissi alla fiamma che si alzava sempre verso la corona di cartone e l’impalcatura di legno che reggeva tutta la costruzione. Incominciavano a cadere lembi di stoffa accesa, che minacciavano di dar fuoco ai veli neri delle signore.
Alessandro II perse per due secondi la sua presenza di spirito, ma si riprese subito e disse con voce calma: “Bisogna portar via la bara!”. Immediatamente i Paggi la coprirono con il grande broccato d’oro e ci facemmo tutti avanti per sollevare la bara pesante; ma intanto la grande lingua di fiamma si era suddivisa in molte più piccole, che divoravano lentamente la superficie lanosa della cotonina e, trovando poco alimento nella parte alta della costruzione, si spensero a poco a poco nelle pieghe.
Non saprei dire che cosa guardassi di più, se il fuoco che strisciava o il maestoso atteggiamento delle tre signore che stavano vicino alla bara, le lunghe code delle loro vesti nere stese sulla scalinata che metteva alla piattaforma e i veli di pizzo nero che ricadevano sulle loro spalle. Non una fece il minimo movimento, stavano immobili come tre belle statue. Solo negli occhi scuri di una di esse, la signorina Gamaleja, le lacrime brillavano come perle. Veniva dalla Russia meridionale ed era la sola veramente bella delle dame d’onore alla Corte.
Durante questo periodo tutto era sottosopra al nostro corpo. Le lezioni erano interrotte, quelli che tornavano dalla fortezza venivano alloggiati in appartamenti provvisori; e non avendo niente da fare passavano le giornate a pensare mille birichinate. Fra l’altro riuscimmo ad aprire un armadio della nostra sala che conteneva una splendida collezione di modelli di animali di ogni specie, per l’insegnamento della storia naturale. Questa sarebbe stata la loro destinazione ufficiale: ma non ce li avevano mai neppur fatti vedere e ora che ce ne eravamo impadroniti ce ne servimmo a modo nostro. Con il teschio umano che faceva parte della collezione si fece una figura macabra, con la quale spaventare di notte i nostri compagni e gli ufficiali. Quanto alle bestie furono raggruppate e messe nelle posizioni più assurde. Le scimmie cavalcavano i leoni, le pecore giocavano con i leopardi, la giraffa ballava con l’elefante, eccetera. Il peggio fu che alcuni giorni dopo uno dei principi prussiani venuti per assistere ai funerali (credo fosse quello che più tardi diventò l’imperatore Federico), visitò là nostra scuola, e gli fu mostrato tutto quello che riguardava il nostro insegnamento.
Il direttore non tralasciò di vantare l’eccellente materiale didattico che possedeva e lo condusse a quel disgraziato armadio…
Quando il principe tedesco vide la nostra classificazione zoologica, fece un viso lungo e voltò gli occhi da un’altra parte. Il nostro vecchio direttore rimase inorridito; aveva perso la parola e si limitava ad accennare ad alcune stelle marine appese in alcuni quadri appesi al muro vicino all’armadio. Il seguito del principe cercò di darsi l’aria di non aver visto niente, lanciando solo occhiate furtive alla causa di tanto sgomento, mentre noi ragazzi, veri diavoli, facevamo mille smorfie per non scoppiare in una risata.
Gli anni di scuola di un giovane russo sono così diversi da quelli della gioventù dell’Europa occidentale, che devo dilungarmi ancora sulla mia vita di scuola. La gioventù russa, per lo più, mentre ancora frequenta i licei o le scuole militari, si interessa già ai più diversi problemi sociali, politici e filosofici. È vero che il Corpo dei Paggi era la meno adatta di tutte le scuole alla vita intellettuale, ma in quegli anni di risveglio generale le idee più larghe penetravano anche fra di noi e ci appassionavano senza impedirci di prendere una parte attivissima alle “serate d’onore” e divertimenti del genere.
L’anno in cui frequentavo la quarta mi interessavo alla storia e, con l’aiuto di appunti presi durante le lezioni, – sapevo che gli studenti universitari facevano così – e aiutandomi con le letture, scrissi un vero corso di storia del primo medioevo per uso mio.
L’anno seguente attirò particolarmente la mia attenzione la lotta fra Bonifacio VIII e l’Impero, e avrei voluto ottenere di frequentare la Biblioteca imperiale per poter studiare a fondo quell’importante periodo storico. Questo non era concesso dal regolamento della Biblioteca, che non ammetteva gli studenti delle scuole medie, però il nostro buon Herr Becker accomodò la faccenda, e un giorno ebbi il permesso di entrare nel santuario e di sedere a uno dei tavolini per i lettori, adagiato su uno dei divani di velluto rosso che ammobiliavano allora la sala di lettura.
Non tardai a scoprire le fonti di vari libri di testo e di alcuni volumi della nostra biblioteca scolastica. Ignoravo il latino, ma trovai un ricco materiale dell’epoca in vecchio teutonico e vecchio francese, e provai un grandissimo godimento intellettuale nell’ingenuità della costruzione e nella semplicità di espressione di queste vecchie cronache. Tutta una nuova vita sociale e un mondo di rapporti intricati mi si apriva dinanzi: e da allora imparai ad apprezzare ben di più le fonti originali della storia che non i lavori nei quali la storia è una generalizzazione d’accordo con le idee moderne e la vera vita dell’epoca è sostituita dai pregiudizi della politica attuale. Non vi è nulla che dia tanto impulso allo sviluppo intellettuale, quanto le ricerche personali, e questi miei studi mi furono più tardi estremamente utili.
Disgraziatamente dovetti trascurarli quando arrivai alla seconda classe (la penultima). Durante gli ultimi due anni i Paggi dovevano studiare quasi tutte le materie che nelle altre scuole militari venivano insegnate in tre classi “speciali”, ed eravamo sovraccarichi di lavoro per la scuola. Le scienze naturali, la matematica e le scienze militari misero necessariamente in ombra la storia.
In seconda incominciammo a studiare seriamente la fisica. Avevamo un insegnante bravissimo, un uomo di grande intelligenza, di spirito, sarcastico, che odiava lo studio mnemonico e che riusciva a farci pensare e non semplicemente a farci imparare dei fatti. Era un bravo matematico e insegnava la fisica a base di matematica, spiegando nello stesso tempo in modo ammirevole le idee principali che regolano la ricerca e il lavoro in fisica. Alcune sue domande erano così originali e le sue spiegazioni così argute, che non le ho mai più dimenticate.
Il nostro libro di testo per la fisica era fatto bene, – quasi tutti i libri per le scuole militari erano compilati dagli uomini più eminenti del tempo – ma era un po’ vecchio, e il nostro professore, che seguiva un proprio metodo di insegnamento, incominciò a preparare un breve sommario delle sue lezioni, una specie di vademecum ad uso della nostra classe. Dopo poche settimane però io fui incaricato di scrivere questo riassunto e il nostro insegnante, con ottimo criterio pedagogico, lo affidò interamente a me, rileggendone soltanto le bozze. Quando si arrivò ai capitoli che trattavano del calore, dell’elettricità e del magnetismo, dovemmo rifarli completamente e io lo feci, preparando così un testo di fisica quasi completo, che fu poi stampato a uso della scuola.
In seconda incominciammo anche lo studio della chimica, e anche qui avemmo un professore di prim’ordine, appassionato alla sua materia, che aveva fatto importanti ricerche originali. Gli anni 1859-1861 videro un grande risveglio nel culto delle scienze esatte. Grove, Clausius, Joule e Séguin dimostrarono che il calore e tutti i fenomeni fisici non sono che forme diverse del moto; verso quell’epoca Helmholtz iniziò i suoi studi sul suono che fecero epoca, e Tyndall, con le sue conferenze popolari, ci fece toccare, per così dire, gli atomi stessi e le molecole. Gerhardt e Avogadro introdussero la teoria delle sostituzioni e Mendeleev, Lothar Meyer e Newlands scoprirono la legge periodica degli elementi; Darwin con la sua L’origine delle specie rivoluzionò le scienze biologiche, mentre Karl Vogt e Moleschott, sulle orme di Claude Bernard, gettarono le basi della vera psicologia nella fisiologia. Fu un grande momento di rinnovamento scientifico, e la tendenza del pensiero verso le scienze naturali era irresistibile. Venivano tradotti e pubblicati un gran numero di libri eccellenti e mi resi conto ben presto che, qualunque corso di studi avessi voluto seguire poi, uno studio approfondito delle scienze naturali e la familiarità con il loro metodo ne dovevano essere la base.
Ci associammo in cinque o sei per fare una specie di laboratorio. Con l’apparecchio elementare che Stockhardt consiglia ai principianti nel suo eccellente libro di testo, creammo il laboratorio nella camera di due nostri compagni, i fratelli Zasetskij. Il padre, un ammiraglio in ritiro, fu contentissimo di vedere che i suoi figli si dedicavano a un lavoro così utile e non gli dispiaceva che ci radunassimo la domenica e durante le vacanze in quella camera, vicina al suo studio. Facemmo sistematicamente tutti gli esperimenti seguendo il libro di Stockhardt. È vero che una volta poco mancò si desse fuoco alla casa, e che più volte avvelenammo le stanze con il cloro e altre sostanze puzzolenti. Ma quando all’ora di pranzo raccontammo quello che ci era successo, il vecchio ammiraglio prese tutto mel migliore dei modi e ci raccontò come lui e i suoi compagni avessero quasi dato fuoco alla casa con lo scopo, molto meno utile, di fare il punch, e la padrona di casa si limitava a dire, fra un accesso di tosse e l’altro: “Naturalmente, se è necessario per i vostri studi maneggiare delle cose così puzzolenti, fate pure!”. Dopo pranzo lei si metteva di solito al pianoforte e fino a tarda ora si stava a cantare duetti, trii e cori delle opere. O si prendeva lo spartito di qualche opera italiana o russa e si provava tutto, compresi i recitativi; la madre e la figlia sostenevano la parte delle prime donne, mentre noi interpretavamo, più o meno bene, le altre. Così chimica e musica procedevano insieme.
Lo studio della matematica superiore mi teneva occupatissimo. Eravamo in quattro o cinque già decisi a non entrare in un reggimento della Guardia, dove tutto il nostro tempo sarebbe stato occupato dagli esercizi e dalle parate militari, e pensavamo invece di entrare, dopo la promozione, in una delle accademie militari – quella di artiglieria o del genio.
Era necessaria quindi una buona preparazione di geometria, di calcolo differenziale, dei princìpi di quello integrale, e prendevamo per questo delle lezioni private. Al tempo stesso, poiché ci insegnavano i princìpi dell’astronomia, sotto il nome di geografia matematica, mi appassionai alla lettura di opere di astronomia, specialmente l’ultimo anno di scuola. La vita incessante dell’universo, che io concepivo come vita ed evoluzione, divenne per me fonte inesauribile di alati pensieri poetici e a poco a poco il senso dell’unità dell’uomo con la natura, animata o inanimata – la poesia della natura – diventò la filosofia della mia vita.
Se l’insegnamento scolastico si fosse limitato alle materie di cui ho parlato, le nostre giornate sarebbero già state abbastanza occupate; ma dovevamo studiare anche la storia, diritto (cioè gli articoli principali del codice russo) e i princìpi essenziali dell’economia politica, compreso un corso di statistica comparata; e oltretutto digerirci formidabili corsi di scienza militare: tattica, storia militare (le campagne del 1812 e 1815 in tutti i loro particolari), balistica e arte delle fortificazioni.
Ripensando a questo sistema di studi, credo che, a eccezione delle materie riguardanti la scienza della guerra che avrebbero potuto essere sostituite vantaggiosamente da uno studio più particolareggiato delle scienze esatte, la varietà degli studi non fosse superiore alla capacità di un giovane di intelligenza media. Grazie a una prima conoscenza molto esatta della matematica e della fisica che acquistavamo nelle classi elementari, riuscivamo quasi tutti ad assimilare queste materie. Ve ne erano alcune che quasi tutti trascuravano, soprattutto il diritto e anche la storia moderna, che disgraziatamente ci era insegnata da un rudere di professore, tenuto al suo posto solo perché potesse godere della pensione. Ci si lasciava poi una certa libertà nella scelta delle materie che ci interessavano di più, e mentre per queste gli esami erano severi, per il resto vi era una certa indulgenza.
Ma il discreto successo della scuola va attribuito soprattutto al fatto che si cercava di rendere l’insegnamento il più concreto possibile. Appena imparata la geometria elementare sui libri, la si tornava a studiare sui campi con speciali strumenti, con l’astrolabio, la bussola e le tavole da agrimensore. Dopo questo insegnamento pratico l’astronomia elementare non offriva più difficoltà, mentre studiavamo l’agrimensura stessa con grandissimo piacere.
Lo stesso sistema di insegnamento pratico prevaleva per l’arte delle fortificazioni. Durante l’inverno si risolvevano problemi come questo: “Disponendo di mille uomini e di quindici giorni di tempo, costruite la fortificazione più solida per proteggere questo ponte per un esercito in ritirata”; e discutevamo con calore i nostri progetti, quando l’insegnante li criticava. Durante l’estate mettevamo in pratica la nostra scienza al campo. Attribuisco interamente a questo sistema di studi, pratici e concreti, la facilità con cui assimilavamo tante diverse cognizioni scientifiche, nonostante fossimo così giovani. Con tutto questo ci rimaneva ancora tempo per i divertimenti. La vacanza preferita era quando, terminati gli esami, ci restavano tre o quattro settimane di libertà prima di andare al campo, o quando, al ritorno dal campo, ci venivano concesse altre tre settimane di libertà prima di incominciare le lezioni. I pochi che restavano nella scuola durante le vacanze erano liberi di uscire quando volevano e trovavano sempre alloggio e vitto alla scuola. Lavoravo allora in biblioteca o visitavo le gallerie dell’Hermitage, studiando uno per uno tutti i quadri più notevoli delle diverse scuole; o giravo per le fabbriche regie aperte al pubblico, quelle di carte da gioco, i cotonifici, le ferriere, le fabbriche di ceramica, le vetrerie, o andavo con i miei amici a remare sulla Neva, passando tutta la notte sul fiume, spingendoci a volte nel Golfo di Finlandia con i pescatori; melanconiche notti Nordiche, quando l’alba si sposa al chiarore del tramonto e si può leggere un libro all’aria aperta a mezzanotte!
Quelle visite alle fabbriche mi diedero il gusto delle macchine potenti e perfette. Lo spettacolo di un artiglio gigantesco, che di sotto una tettoia afferra un ceppo galleggiante sulla Neva, lo tira dentro e lo mette sotto le seghe che lo ridurranno in assi, o di un’enorme massa di ferro incandescente trasformata in binari dopo essere passata attraverso dei cilindri, mi fece capire la poesia delle macchine. Oggi il lavoro della macchina nelle fabbriche è micidiale per l’operaio, che diventa per tutta la vita lo schiavo di un dato meccanismo e nulla più. Ma questo è colpa di una cattiva organizzazione, e non ha nulla a che vedere con la macchina stessa. Il lavoro eccessivo, la monotonia incessante, sono altrettanto dannosi quanto il lavoro che si fa a mano, con arnesi primitivi o a macchina. Ma a parte ciò, capisco benissimo la soddisfazione che può venire all’uomo dalla coscienza della potenza della macchina, dal carattere intelligente del suo lavoro, dalla garanzia dei suoi movimenti, dalla perfezione del lavoro che esegue, e credo che l’odio che William Morris aveva per le macchine non fosse che la prova dell’incapacità del suo grande genio poetico di afferrare il concetto della potenza e della grazia della macchina.
Anche la musica ebbe una parte importante nella mia formazione. Essa mi dava un godimento e un’esaltazione anche maggiori di quelli che mi dava la poesia. L’opera russa non esisteva quasi a quei tempi; ma l’opera italiana, che contava fra gli artisti parecchi virtuosi, era il ritrovo più popolare di Pietroburgo. Quando si ammalò [Angelina] Bosio, la celebre prima donna, migliaia di persone, specialmente di giovani, rimanevano fino a notte tarda alla porta del suo albergo per sentire le sue notizie. Non era bella, ma lo diventava tanto quando cantava, che si contavano a centinaia i suoi innamorati e quando morì ebbe un funerale come nessuno aveva mai avuto a Pietroburgo. “Tutta Pietroburgo” si divideva allora in due campi: quello degli ammiratori dell’opera italiana e quello degli entusiasti del teatro francese, che mostrava già i germi della decadente tendenza offenbachiana, che poco più tardi inondò l’Europa intera. Anche la nostra classe era divisa in due da queste preferenze e io tenevo per la prima. Non ci era permesso andare in platea o in galleria e tutti i palchi dell’opera italiana erano sempre accaparrati mesi prima e in certe famiglie venivano persino trasmessi come proprietà private.
Ma il sabato sera trovavamo il modo di entrare nei corridoi della galleria, dove si stava in piedi, in un’atmosfera da bagno turco, e per nascondere le nostre divise vistose tenevamo addosso, nonostante quel calore, i nostri cappotti neri foderati di ovatta, con il collo di pelliccia abbottonato; c’è da meravigliarsi che nessuno di noi abbia preso una polmonite, specialmente se si pensa che uscivamo accaldati per le ovazioni ai nostri favoriti e che indugiavamo poi davanti alla porta del palcoscenico per dare un’altra occhiata agli artisti e applaudirli. Durante quegli anni vi fu uno strano ma intimo rapporto fra l’opera italiana e il movimento radicale; e i recitativi rivoluzionari del Guglielmo Tell e dei Puritani erano sempre salutati da applausi calorosi e da grida che colpivano al cuore Aleksandr II; intanto nelle gallerie del sesto ordine, nel ridotto dell’opera e all’ingresso del palcoscenico la parte migliore della gioventù di Pietroburgo si dava convegno, accomunata dal culto ideale di una nobile arte.
Tutto questo può sembrare puerile; ma questa adorazione dei nostri artisti prediletti ci ispirava alti ideali e nobili speranze.
Ogni estate andavamo al campo a Peterhof, con il resto delle truppe del distretto di Pietroburgo. In complesso vi si faceva una vita molto piacevole e certo molto salubre: si dormiva sotto grandi tende, si facevano i bagni di mare e si passavano tutte e sei le settimane in esercizi all’aria aperta.
Lo scopo principale della vita al campo per una scuola militare erano evidentemente gli esercizi, che noi tutti non potevamo vedere; ma la noia veniva interrotta di tanto in tanto dalle manovre, alle quali prendevamo parte anche noi.
Una notte, mentre stavamo coricandoci, Aleksandr II svegliò il campo, facendo suonare l’allarme. In pochi minuti tutto il campo fu in movimento, mentre parecchie migliaia di giovani si radunavano attorno alle bandiere e i cannoni della scuola di artiglieria tuonavano nel silenzio della notte.
Tutti i soldati di Peterhof galoppavano verso il campo, ma per qualche equivoco l’imperatore restò a piedi. Furono spedite ordinanze da ogni parte per trovargli un cavallo, ma non se ne trovavano, e non essendo un buon cavallerizzo, egli non volle montare un cavallo che non conosceva. Aleksandr II ne fu adiratissimo e dette libero sfogo alla sua collera. “Imbecille (durak)! Ho forse un cavallo solo?”, lo sentii gridare a un’ordinanza che gli diceva che il suo cavallo era in un altro campo.
L’oscurità crescente, il tuonare dei pezzi di artiglieria, il calpestio della cavalleria, tutto concorreva a eccitare noi giovani, e quando Aleksandr II dette l’ordine di caricare, la nostra colonna si slanciò diritto su di lui. I ranghi serrati, le baionette abbassate, dovevamo avere un aspetto ben minaccioso, perché vidi Aleksandr II, che era ancora a piedi, fare tre formidabili balzi per lasciare libera la strada alla colonna. Capii in quel momento cosa sia una colonna che marcia a ranghi serrati, eccitata dalla musica e dal suo stesso movimento. Là davanti a noi era l’imperatore – il nostro comandante – per cui avevamo tutti una grande venerazione; ma sentivo che in tutta quella massa in moto non vi era un solo paggio o un cadetto che si sarebbe scostato di un centimetro o che si sarebbe fermato un istante per fargli posto.
Eravamo la colonna in marcia – egli non era che un ostacolo – e la colonna avrebbe marciato sopra di lui. “Perché si è messo sulla nostra strada?”, si sarebbero chiesti più tardi i paggi. In casi simili i giovani con la carabina in pugno sono ancora più terribili dei vecchi soldati.
L’anno dopo, quando il nostro corpo prese parte alle grandi manovre della guarnigione di Pietroburgo, ebbi modo di fare alcune osservazioni sulla guerra.
Per due giorni di seguito non si fece che marciare su e giù per uno spazio di una ventina di miglia senza avere la minima idea di quello che succedeva intorno a noi, né del perché della marcia. I cannoni tuonavano, ora vicini, ora lontani da noi; si sentiva da qualche parte nei boschi una nutrita scarica di moschetti; i portaordini galoppavano avanti e indietro, ora dicendoci di procedere, ora di ritirarci – e noi marciavamo, marciavamo, marciavamo, senza capire la ragione di tutti questi spostamenti. La strada era già stata percorsa da plotoni di cavalleria che l’avevano ridotta a una massa di sabbia in cui si affondava; e dovemmo avanzare e ritirarci parecchie volte lungo la stessa strada finché la nostra colonna abbandonò ogni disciplina e assomigliò più a una folla sbandata di pellegrini che a un corpo militare. Solo la bandiera restava in mezzo alla strada; gli altri camminavano lentamente lungo il margine del bosco. I comandi e le preghiere degli ufficiali non erano valsi a nulla.
Improvvisamente si alzò un grido: “Viene l’imperatore! L’imperatore!”. Gli ufficiali correvano di qua e di là, supplicandoci di tornare nei ranghi, ma nessuno li ascoltava.
Venne l’imperatore e ancora una volta ordinò che ci ritirassimo.
“Dietro front!”, fu gridato. “L’imperatore è alle nostre spalle, per favore, dietro front”, – sussurravano gli ufficiali; ma il battaglione si preoccupò ben poco del comando e affatto della presenza dell’imperatore. Per fortuna Aleksandr II non era un militare fanatico, e dopo averci rivolto qualche parola di incoraggiamento, promettendoci il riposo, si allontanò al galoppo.
Compresi allora tutta l’importanza che ha in tempo di guerra il morale delle truppe. A che serve la disciplina quando le truppe sfinite devono fare un supremo sforzo per essere sul campo di battaglia a una data ora? Non può far nulla. Solo l’entusiasmo e la fede possono in momenti simili indurre i soldati a compiere “l’impossibile” per assicurare il successo. Quante volte ricordai più tardi quella lezione, quando in Siberia anche noi dovevamo fare l’impossibile durante le nostre spedizioni scientifiche!
Il tempo però dedicato agli esercizi militari e alle manovre durante il nostro soggiorno al campo era relativamente poco. Buona parte veniva dedicata agli esercizi pratici di agrimensura e di fortificazione. Dopo pochi esercizi preliminari, ci si dava un livellatore e ci si diceva: “Andate a fare una carta di questo lago, o di queste strade, o di quel parco, misurando gli angoli con il livellatore e le distanze con i passi”. E di buon mattino, dopo una colazione affrettata, il giovane si riempiva la borsa di fette di pane nero e se ne andava per quattro o cinque ore al giorno nei parchi, facendo miglia e miglia lungo le belle strade erbose, i ruscelli e i laghi. Più tardi il suo lavoro veniva controllato su carte precise e si assegnavano premi in strumenti scientifici a scelta del premiato. Queste spedizioni erano per me ricche di ore deliziose. Il lavoro indipendente, la solitudine sotto gli alberi secolari, la vita nella foresta, che godevo indisturbato e nello stesso tempo l’interesse che prendevo al lavoro, tutto questo lasciò nel mio spirito tracce profonde; e se più tardi diventai esploratore in Siberia e se diversi miei compagni si fecero esploratori nell’Asia centrale, la preparazione necessaria ci fu data da queste prime esperienze di agrimensura.
Nell’ultima classe, infine, gruppetti di quattro giovani venivano condotti ogni due giorni in qualche paese lontano dal campo e là dovevano tracciare una carta particolareggiata di diversi chilometri quadrati con l’aiuto delle tabelle da agrimensore e con la regola telescopica. Ogni tanto gli ufficiali dello Stato maggiore venivano a controllare il lavoro e a dare un aiuto ai ragazzi con i loro consigli. Questa vita in mezzo ai contadini esercitava un’ottima influenza sullo sviluppo intellettuale e morale di molti di noi.
Nello stesso tempo ci si esercitava alla costruzione di sezioni di fortificazioni di grandezza naturale. Un ufficiale ci conduceva in un campo aperto e là dovevamo costruire le sezioni laterali di un bastione o di una testa di ponte, inchiodando pali e assicelle proprio come fa un ingegnere tracciando una linea ferroviaria. Quando si arrivava alle feritoie e alle barbette si dovevano fare lunghi calcoli per ottenere la corretta inclinazione dei diversi piani, e dopo questi esercizi pratici ci riusciva facile capire anche le parti più difficili della geometria teorica.
Prendevamo un gusto grandissimo a questo lavoro, tanto che anche in città, trovato nel giardino un mucchio di sabbia e di ghiaia, incominciammo subito a costruire una vera fortificazione a scala ridotta, con le feritoie e le barbette diritte e oblique ben calcolate… Facemmo tutto con grande precisione e la nostra grande aspirazione era di poter avere delle tavole per fare le piattaforme per i pezzi di artiglieria e di mettervi su i modellini di cannoni che avevamo nelle nostre aule.
Ma ahimè, i nostri calzoni erano in uno stato deplorevole. “Che cosa state facendo”, esclamò il nostro capitano. “Guardatevi! Sembrate dei muratori!”, (era proprio quello che ci faceva andare superbi). “Che cosa succederà se viene il granduca e vi trova in uno stato simile?”.
“Gli faremo vedere la nostra fortificazione e lo pregheremo di farci avere gli arnesi e le assi per costruire le piattaforme”.
Ma tutte le nostre proteste furono inutili! Il giorno dopo una dozzina di operai furono mandati a portar via il nostro splendido lavoro, come se non fosse stato altro che un mucchio di fango!
Racconto questo per dimostrare quanto i ragazzi e i giovani desiderino l’applicazione pratica di quello che imparano a scuola teoricamente, e come sia stupido da parte degli insegnanti il non capire quale grandissimo aiuto troverebbero nelle applicazioni pratiche per far capire ai loro allievi il vero significato delle cose che imparano. Nella nostra scuola tutto era indirizzato a prepararci ai nostri doveri militari. Ma avremmo lavorato con lo stesso entusiasmo anche per costruire una casa di legno o per coltivare un giardino o un campo. Questo appassionato desiderio dei ragazzi e dei giovani per un lavoro “reale”, non viene utilizzato perché il nostro concetto della scuola è ancora quello della scolastica antica, del monastero medioevale.
Gli anni tra il 1857 e il 1861 furono fecondi per lo sviluppo intellettuale in Russia. Tutto ciò che era stato sussurrato sottovoce nell’intimità delle riunioni amichevoli della generazione rappresentata nella letteratura russa da Turgenev, Tolstoj, [Aleksandr] Herzen, Bakunin, [Nikolaj] Ogarëv, [Konstantin] Kavelin, Dostoevskij, Grigorovič, [Aleksandr] Ostrovskij e Nekrasov incominciò allora a penetrare nella stampa. La censura era ancora molto severa; ma quello che non si poteva dire apertamente negli articoli politici, si faceva passare di contrabbando sotto forma di romanzi, bozzetti umoristici, o di commenti velati sull’Europa Occidentale, e ognuno leggeva tra le righe e capiva. Fuori della scuola e di un ristretto circolo di parenti non avevo conoscenze a Pietroburgo, e così mi trovai fuori del movimento di quegli anni, ne ero anzi lontano mille miglia. Eppure la caratteristica più notevole del movimento fu, forse, che sapeva penetrare in una scuola “benpensante” come la nostra e trovare un’eco in una società come quella dei miei parenti di Mosca.
Passavo allora le domeniche e le feste in casa di mia zia, della quale ho già parlato sotto il nome di principessa Mirskij. Il principe Mirskij non si preoccupava che di colazioni e di pranzi straordinari, mentre la moglie e la giovane figlia facevano la vita allegra. Mia cugina era una bellissima ragazza di diciannove anni, di un carattere piacevolissimo e quasi tutti i suoi cugini ne erano pazzamente innamorati. A sua volta si innamorò di uno di essi e voleva sposarlo. Ma la chiesa russa considera un grave peccato il matrimonio fra cugini; e la vecchia principessa cercò invano di ottenere una dispensa dagli alti dignitari ecclesiastici. Allora condusse la figlia a Pietroburgo, nella speranza che scegliesse un marito fra i molti ammiratori. Debbo dire che fu tempo perso; ma il loro appartamento era il ritrovo preferito degli eleganti giovanotti della Guardia e del servizio diplomatico.
Che in un ambiente simile potessero diffondersi idee rivoluzionarie, sembra inverosimile; eppure fu là che per la prima volta conobbi la letteratura rivoluzionaria di quei tempi. Il famoso esule Herzen aveva iniziato a Londra la pubblicazione della sua rivista “La Stella Polare”, che fece sensazione in Russia persino nei circoli di Corte ed ebbe una grande diffusione clandestina a Pietroburgo. Mia cugina, non so come, era riuscita ad averla e la leggevamo insieme.
Il suo cuore si ribellava agli ostacoli che si opponevano alla sua felicità e il suo spirito era quindi tanto più pronto ad accogliere la critica profonda che il grande scrittore faceva all’autocrazia russa e a tutto il decrepito sistema del suo cattivo governo. Era con un sentimento non privo di adorazione che guardavo il medaglione stampato sulla copertina della “Stella Polare”, che rappresentava le nobili teste dei cinque decabristi, fatti impiccare da Nicola I dopo la ribellione del 14 dicembre 1825: [Aleksandr] Bestužev, [Pëtr] Kachovskij, [Pavel] Pestel, Ryleev e [Sergej] Muravëv-Apostol.
La bellezza dello stile di Herzen – del quale Turgenev disse giustamente che scriveva con le lacrime e con il sangue e che nessun altro russo aveva mai scritto come lui – la sua larghezza di vedute, il suo amore profondo per la Russia si impadronirono di me e leggevo e rileggevo quelle pagine, certo più ricche di sentimento che di pensiero.
Nel 1859 o nei primi mesi del 1860 incominciai a redigere il mio primo giornale rivoluzionario. Che cosa potevo essere a quell’età, se non un costituzionalista? – e il mio giornale predicava la necessità di una costituzione per la Russia. Scrissi delle spese pazze della Corte, del denaro profuso a Nizza per tenervi un distaccamento della marina agli ordini dell’imperatrice madre, che morì nel 1860; parlavo delle malefatte della burocrazia, di cui sentivo spesso parlare, e insistevo sulla necessità di un governo costituzionale. Introdussi il mio giornale nelle scrivanie di tre dei miei compagni delle classi superiori, che pensavo si dovessero interessare di politica; pregavo i miei lettori di mettere le loro osservazioni dietro l’orologio a cassa della nostra biblioteca.
Con il cuore palpitante di emozione la mattina dopo andai a vedere se vi fosse qualche cosa. Trovai due biglietti. Due compagni scrivevano che simpatizzavano completamente con le idee del mio giornale, e si limitavano a consigliarmi di non espormi a rischi troppo grandi. Scrissi il secondo numero, insistendo ancor più sulla necessità di unire tutti i nostri sforzi in nome della libertà. Ma questa volta non trovai niente dietro l’orologio. I due compagni invece vennero da me.
“Siamo certi”, dissero, che sei tu l’editore del giornale e vogliamo parlartene. Pensiamo come te, ed eccoci per dirti: siamo amici. Il giornale ha raggiunto il suo scopo – ci ha uniti; ma non è necessario continuarlo. In tutta la scuola non ci sarebbero che altri due che potrebbero interessarsi a simili idee, e d’altra parte se si sapesse che esiste un giornale come questo le conseguenze sarebbero terribili per noi tutti. Formiamo un circolo e discutiamo su tutte queste questioni; forse potremo mettere qualche idea in testa agli altri”.
Questa proposta era tanto ragionevole che non potevo non acconsentirvi, e confermammo il nostro patto con una cordiale stretta di mano. Da quel giorno noi tre fummo sinceri amici e leggevamo molto insieme, discutendo un po’ di tutto.
L’abolizione della servitù era la questione che assorbiva allora l’attenzione di tutte le persone serie. La rivoluzione del 1848 aveva avuto un’eco notevole nel cuore dei contadini russi, e a partire dal 1850 le insurrezioni di servi ribelli assunsero un carattere grave. Quando fu dichiarata la guerra di Crimea e vi furono arruolamenti in tutta la Russia, queste ribellioni si estesero con inaudita violenza. Parecchi padroni furono ammazzati dai servi e le rivolte di contadini si fecero tanto minacciose che interi reggimenti appoggiati dall’artiglieria furono mandati per sedarle, mentre per il passato piccoli distaccamenti di soldati erano stati più che sufficienti per terrorizzare i contadini.
Queste ribellioni da un lato e la profonda avversione per la schiavitù che caratterizzava la generazione che si affacciava alla vita all’avvento di Aleksandr II al trono, rendevano più che mai imperiosa l’emancipazione dei contadini.
L’imperatore, avverso egli stesso alla schiavitù e appoggiato, o piuttosto influenzato nella cerchia familiare dalla moglie, dal fratello Costantino e dalla granduchessa Elena Paulovna, fu il primo a fare un passo in quella direzione. Il suo progetto era che l’iniziativa della riforma fosse presa dalla nobiltà, dai padroni dei servi stessi. Ma non ci fu una sola provincia in Russia nella quale fosse possibile indurre la nobiltà a mandare allo Zar una petizione in questo senso. Nel marzo del 1856 egli stesso parlò alla nobiltà moscovita della necessità di questa iniziativa, ma come risposta non ebbe che un silenzio ostinato, tanto che Aleksandr II si adirò e terminò il suo discorso con queste memorabili parole di Herzen: “Signori, sarebbe meglio che venisse dall’alto, piuttosto che aspettare che venga dal basso”.
Ma neppure queste parole ottennero qualche cosa, e si dovette ricorrere alle province della vecchia Polonia – Grodno, Wilna e Kovno – nelle quali Napoleone I aveva abolito (di diritto, non di fatto) nel 1812 la schiavitù. Il governatore generale di quelle province, Nazimov, riuscì a ottenere dalla nobiltà polacca la petizione desiderata.
Nel novembre 1859 fu pubblicato il famoso rescritto al governatore generale delle province della Lituania, nel quale l’imperatore dichiarava la sua intenzione di abolire la schiavitù: e leggemmo con le lacrime agli occhi il bellissimo articolo di Herzen, “Hai vinto Galileo”, nel quale i rifugiati di Londra dichiaravano che non avrebbero più trattato Aleksandr II da nemico, ma che lo avrebbero aiutato nel suo grande lavoro di emancipazione.
L’atteggiamento dei contadini fu significativo: appena si sparse la notizia che la liberazione tanto sospirata era stata accordata, le insurrezioni cessarono quasi completamente. Ormai i contadini aspettavano e quando Aleksandr fece un viaggio nella Russia centrale, gli si affollavano attorno pregandolo di accordare loro la libertà; – preghiera che però Aleksandr accolse con evidente ripugnanza. Da nota-
re, e questo prova la forza della tradizione, la leggenda diffusa fra i contadini che Napoleone III nel trattato di pace volesse esigere dallo Zar la liberazione dei servi. Lo udii ripetere più di una volta, e anche alla vigilia dell’emancipazione sembravano dubitare che potesse attuarsi senza pressioni dall’estero. “Non si farà niente se non viene Garibaldi”, fu la risposta data a Pietroburgo da un contadino a un mio compagno che gli parlava della vicina libertà.
I primi momenti di esultanza generale furono seguiti da anni d’incertezza e di inquietudini. Comitati nominati apposta nelle province e a Pietroburgo discutevano della progettata emancipazione, ma i propositi di Aleksandr non sembravano fermi. La stampa fu continuamente imbavagliata per impedirle di discutere i particolari. A Pietroburgo circolavano voci sinistre, che arrivarono al nostro Corpo.
Non mancavano in mezzo alla nobiltà giovani che lavorassero sinceramente a favore dell’abolizione definitiva dell’antica schiavitù; ma il partito favorevole alla schiavitù si stringeva sempre più attorno all’imperatore e acquistava ascendente su di lui. Gli sussurravano all’orecchio che il giorno in cui la schiavitù fosse abolita i contadini comincerebbero un massacro generale dei proprietari, e che la Russia vedrebbe una nuova insurrezione alla Pugačëv, ben più terribile di quella del 1773. Aleksandr, debole di carattere, dava ascolto anche troppo a quelle profezie. Ma la enorme macchina per la formulazione della legge sull’emancipazione era ormai stata messa in moto. I comitati tenevano le loro sedute; centinaia di progetti di emancipazione indirizzati all’imperatore circolavano manoscritti o venivano stampati a Londra. Herzen aiutato da Turgenev che lo teneva al corrente di tutto quello che succedeva nei circoli governativi, discuteva nella sua “Kolokol” (Campana) e nella “Poljarnaja Zvezda” (Stella Polare) i particolari dei vari progetti, e altrettanto faceva černyševskij nel “Sovremennik” (Il Contemporaneo). Gli slavofili, specialmente Aksakov e Beljaev, avevano approfittato dei primi momenti di relativa libertà concessa alla stampa, per dare larga pubblicità alla questione in Russia e per discutere i vari aspetti del problema rivelando una profonda conoscenza della parte tecnica della questione. Tutta Pietroburgo intellettuale patteggiava per Herzen e soprattutto černyševskij, e ricordo che gli ufficiali della Guardia a cavallo che vedevo la domenica dopo l’uscita dalla chiesa in casa di mio cugino (Dmitrij Nicolaevič Kropotkin, aiutante di campo del reggimento e aiutante dell’imperatore) parteggiavano per černyševskij, il capo del partito progressista nella lotta per l’emancipazione. L’atteggiamento di Pietroburgo, nei salotti e nelle strade, era tale da rendere impossibile qualsiasi reazione.
Bisognava mettere in atto la liberazione dei servi; e un altro punto fu vinto: i contadini avrebbero ricevuto le loro case e la porzione di terra che fino allora avevano coltivato per uso proprio.
Il partito della vecchia nobiltà, però, non si diede per vinto. Cercava con ogni mezzo di ritardare l’applicazione della riforma, di diminuire la superficie delle terre donate e di gravare i servi emancipati di una tale imposta per la redenzione della terra, da rendere illusoria la loro libertà economica: cosa in cui riuscì perfettamente.
Alessandro II congedò l’anima del movimento, Nikolaj Miljutin (fratello del ministro della guerra) dicendogli: “Mi dispiace tanto dovermi separare da voi, ma la nobiltà vi considera un rivoluzionario!”. I primi comitati che avevano elaborato i progetti di emancipazione furono anche essi sciolti e i nuovi comitati corressero il lavoro che era stato fatto nell’interesse della proprietà personale dei servi; la stampa fu di nuovo imbavagliata.
La situazione si faceva oscura; ci si chiedeva ora se l’emancipazione si sarebbe fatta o no. Io seguivo febbrilmente questa lotta e tutte le domeniche, quando i miei compagni tornavano presso le loro famiglie, chiedevo loro cosa avessero detto i loro genitori. Sul finire del 1860 le notizie si facevano sempre più fosche. “Il partito Valnev sta prevalendo”. “Stanno per modificare tutto il progetto”. “I parenti della principessa X (una amica dello zar) lo incalzano”. “L’emancipazione sarà rimandata, temono una rivoluzione”.
Nel gennaio del 1861 incominciarono a circolare voci più ottimistiche: si credeva generalmente che si sarebbe saputo qualche cosa di preciso a proposito dell’emancipazione in occasione dell’anniversario dell’incoronazione dello zar, il 19 febbraio.
Venne il 19, ma non portò nessuna novità. Quel giorno ero al Palazzo. Non fu un ricevimento ufficiale, ma privato, e i Paggi della seconda classe assistevano a questi ricevimenti per abituarsi agli usi della Corte. Quel giorno ero di turno e quando riaccompagnai alla carrozza una delle granduchesse venute per assistere alla messa, e suo marito non si fece avanti, io andai a cercarlo.
Fu chiamato fuori dallo studio dell’imperatore e io gli raccontai scherzando l’imbarazzo di sua moglie, senza minimamente sospettare le gravi questioni delle quali forse aveva parlato pochi minuti prima. Salvo i pochi iniziati, nessuno a Palazzo sospettava che il manifesto fosse stato firmato il 19 febbraio; fu trattenuto una quindicina di giorni per la sola ragione che la domenica successiva, il 26 febbraio, era il primo giorno della settimana di carnevale e si temeva, data l’ubriachezza abituale nei villaggi durante il carnevale, che scoppiassero delle insurrezioni di contadini. Anche la fiera che si teneva di solito in occasione del carnevale a Pietroburgo, sul piazzale vicino al teatro d’inverno, fu tenuta quell’anno in un’altra piazza per paura di un sollevamento popolare nella capitale.
L’esercito aveva ricevuto ordini severissimi nel caso di rivolte di contadini.
Una quindicina di giorni dopo, l’ultima domenica di carnevale (il 5 marzo o piuttosto il 17, nuovo stile) mi trovavo al corpo e dovevo partecipare a una parata militare nel maneggio. Ero ancora a letto quando il mio attendente Ivanov irruppe nella camera con il tè, esclamando: “Principe, la liberazione! Il manifesto è affisso al Gostinoi Dvor (negozio di fronte al nostro palazzo).
“L’hai visto tu?”.
“Sì. La gente sta intorno, uno legge, gli altri ascoltano. È la libertà!”.
In meno di due minuti mi vestii e sulla porta incontrai un compagno:
“Kropotkin, la libertà!”, gridò. “Ecco il proclama. Mio zio ha saputo ieri sera che sarebbe stato letto alla prima messa nella cattedrale Isacco; e ci siamo andati. Dopo la messa il proclama è stato letto e distribuito. Ne hanno capito perfettamente il senso; mentre uscivo dalla chiesa due contadini mi hanno detto, in un modo comicissimo: ‘Ebbene, signore? Avete perduto tutto!’”, e imitò la mossa con la quale gli avevano mostrato la porta. Lunghi anni di attesa erano in quel semplice gesto di mettere il padrone alla porta.
Lessi e rilessi il manifesto. Era scritto in uno stile elevato dal vecchio metropolita di Mosca, Filarete, ma con un inutile miscuglio di russo e di antico slavo, che ne rendeva difficile il senso.
Era la libertà, ma non la libertà immediata. I contadini sarebbero restati servi ancora per due anni, fino al 19 febbraio 1863. Ma con tutto ciò una cosa appariva evidente: la schiavitù era abolita e i servi emancipati avrebbero avuto la loro casa e la loro terra. La dovevano pagare, ma la vergogna della schiavitù spariva. Non sarebbero più schiavi; la reazione non aveva vinto!
Andammo alla parata, e quando le manovre militari furono finite Aleksandr II, sempre a cavallo, gridò a voce alta: “A me gli ufficiali!”. Si radunarono intorno a lui ed egli incominciò con voce sonora un discorso sul grande avvenimento della giornata.
“Gli ufficiali… i rappresentanti della nobiltà, dell’esercito…”, questi brani giungevano al nostro orecchio. “È finita un’ingiustizia secolare… Mi aspetto sacrifici da parte della nobiltà… La nobiltà si stringerà fedele attorno al trono…”, e altre frasi del genere. Alla fine tutti gli ufficiali riuniti lanciarono entusiastici evviva.
La marcia di ritorno dal campo fu piuttosto una corsa, ci affrettavamo tutti per arrivare in tempo all’opera italiana che quella sera dava l’ultima recita della stagione; senza dubbio vi sarebbe stata qualche dimostrazione. Ci spogliammo in gran fretta degli abiti militari e ci lanciammo di corsa alla galleria del sesto piano. Il teatro era affollato.
Durante il primo intervallo il ridotto del teatro si riempì di giovani che parlavano tutti assieme, si conoscessero o no. Si decise subito di tornare in teatro e di cantare con il pubblico, in un coro formidabile, l’inno Dio salvi lo Zar. Ma alle nostre orecchie giunsero degli accordi: accorremmo in sala. L’orchestra intonava già l’inno, immediatamente soffocato dagli evviva frenetici che si alzavano dalla galleria, dalla platea, dai palchi.
Vidi il maestro Baveri alzare la bacchetta, ma non si sentiva una nota di quell’orchestra potente. Allora Baveri si fermò, ma gli evviva continuarono. Di nuovo vidi la bacchetta agitarsi, vidi gli archi dei violini muoversi e i musicisti che soffiavano nelle trombe, ma le voci soffocavano ancora la musica. Baveri ricominciò di nuovo a battere il tempo e fu solo verso la fine di questa terza replica che suoni isolati degli strumenti a fiato incominciarono a penetrare il frastuono delle voci umane.
Lo stesso entusiasmo regnava nella strada.
Folle di contadini e di signori erano fermi davanti al palazzo ad acclamare, e lo Zar non poteva farsi vedere senza essere seguito dalla folla che correva plaudente dietro la sua carrozza.
Due anni più tardi, quando lo stesso Zar Aleksandr soffocava nel sangue l’insurrezione polacca, e Muravëv il boia la strangolava sul patibolo, Herzen scrisse giustamente: “Aleksandr Nikolaevič, perché non sei morto dopo la liberazione dei servi? Il tuo nome sarebbe passato alla storia come quello di un eroe”.
E le insurrezioni previste dai campioni della schiavitù? Sarebbe stato impossibile immaginare condizioni più incerte di quelle create dalla legge sull’emancipazione. Se qualcosa poteva provocare delle sommosse, era proprio la tormentosa incertezza di condizioni creata dalla nuova legge. Eppure, se si tolgono due località dove vi furono delle insurrezioni e pochissimi altri luoghi dove vi furono piccoli incidenti, dovuti solo a dei malintesi e immediatamente sedati, prevalse ovunque la tranquillità, una tranquillità maggiore del solito. Con l’abituale buon senso i contadini avevano capito che la servitù era abolita, “che l’ora della libertà era scoccata”, e subivano le condizioni imposte loro, benché fossero gravissime.
Nell’agosto del 1861 e di nuovo nell’estate del 1862 fui a Nikolskoje e mi colpì la serenità e l’intelligenza con cui i contadini avevano accettato le nuove condizioni. Sapevano perfettamente quanto sarebbe stato difficile per loro pagare l’imposta per la redenzione della terra, imposta che in realtà era un’indennità data ai nobili per la perdita dei loro diritti sui servi. Ma apprezzavano talmente la loro emancipazione personale, che accettarono le spese rovinose – non senza lamentarsi, ma come una dura necessità – appena la libertà personale fu raggiunta.
Durante i primi mesi osservavano due feste la settimana, dicendo che era peccato lavorare il venerdì, ma quando venne l’estate si rimisero al lavoro con maggiore energia di prima.
Quando rividi i nostri contadini di Nikolskoje quindici mesi dopo l’emancipazione, non potei non ammirarli. Conservavano la loro innata bonarietà e gentilezza, ma ogni traccia di servilismo era scomparsa. Parlavano con i loro padroni da eguale a eguale, come se non vi fossero mai stati differenti rapporti fra di loro. Non mancarono neppure uomini capaci di lottare per i loro diritti. La legge sull’emancipazione formava un volume grosso e difficile e mi ci volle parecchio tempo per capirlo, ma quando Vasilij Ivanov, il responsabile di Nikolskoje, venne da me un giorno pregandomi di spiegargli qualche passo oscuro, mi accorsi che, pur non sapendo neppure leggere correntemente, aveva saputo orientarsi mirabilmente nell’intricata matassa dei capitoli e dei paragrafi della legge.
La “gente addetta alla casa” – cioè i servitori – furono i più sfortunati. Non ebbero terra e non avrebbero saputo cosa farsene se l’avessero avuta. Ottennero la libertà, niente altro. Nel nostro quartiere si licenziarono quasi tutti dai padroni; neppure uno, per esempio, rimase in casa di mio padre. Si cercarono un altro lavoro e molti trovarono subito da occuparsi presso famiglie di mercanti, ai quali piaceva vantarsi di avere il cocchiere del principe Taldeitali, o il cuoco del generale Taldeitali. Quelli che avevano un mestiere trovarono lavoro nelle città: per esempio la banda di mio padre rimase banda e si guadagnava bene la vita a Kaluga, mantenendo rapporti amichevoli con noi. Quelli che non avevano un mestiere dovevano invece lottare duramente; ciò nonostante la maggioranza preferì qualsiasi cosa piuttosto di rimanere con gli antichi padroni.
Quanto ai proprietari, mentre i più potenti fecero ogni sforzo a Pietroburgo per restaurare il vecchio stato di cose in un modo o nell’altro (e fino a un certo punto riuscirono nel loro intento sotto Aleksandr III) la grande maggioranza si rassegnò all’abolizione della servitù come a una disgrazia inevitabile. La giovane generazione dotò la Russia di quella notevole schiera di “mediatori di pace” e giudici conciliatori che contribuirono tanto all’esito pacifico dell’emancipazione.
Gran parte della vecchia generazione aveva già esaurito le forti somme incassate in pagamento della terra concessa ai servi liberati, terra che era stata stimata molto al di sopra del suo vero valore; questo denaro fu sciupato nei grandi ritrovi della capitale o giocato al tappeto verde. E quasi tutti lo dissiparono appena lo ebbero.
Per molti proprietari la liberazione dei servi fu un ottimo affare. Per esempio i terreni che mio padre, prevedendo l’emancipazione, vendeva a lotti al prezzo di undici rubli all’acro russo, furono stimati a quaranta rubli per le assegnazioni ai contadini – cioè tre volte al di sopra del loro valore sul mercato – e questa fu la regola in tutta la nostra zona; mentre nella proprietà di mio padre a Tambov, nelle steppe, il mir – la comunità del villaggio – affittò tutti i suoi terreni per dodici anni a un prezzo che rappresentava il doppio dell’utile che egli ne ritraeva facendolo coltivare dai servi.
Undici anni dopo quell’epoca memorabile visitai la proprietà di Tambov che avevo ereditato da mio padre. Vi rimasi alcune settimane e la sera della mia partenza il parroco, un uomo intelligente, di idee indipendenti come se ne trovano ogni tanto nelle nostre province meridionali, fece un giro per il villaggio.
Il tramonto era splendido; dalle steppe soffiava una brezza profumata. Trovò un contadino di mezza età – Anton Savelič – seduto su un monticello fuori del villaggio, che sembrava immerso nella lettura di un libro di salmi. Questo contadino sapeva compitare nel vecchio slavo e spesso fingeva di leggere un libro incominciando dall’ultima pagina e sfogliandolo indietro; quello che più gli piaceva era l’atto del leggere, poi ogni tanto una parola lo colpiva, e gli piaceva allora ripeterla più volte.
Aveva sotto gli occhi un salmo nel quale ogni verso incominciava con la parola: “Gioite”.
“Che cosa leggi?” – gli chiese.
“Ebbene, padre, vi dirò”, rispose. “Quattordici anni fa il vecchio principe venne qui. Era d’inverno. Ero tornato allora a casa tutto intirizzito. Infuriava una tempesta di neve. Avevo già incominciato a spogliarmi quando si sentì bussare alla finestra: era il responsabile che gridava: ‘Vai dal principe, ti vuole!’. Noi tutti, mia moglie e i nostri figli, rimanemmo come fulminati. ‘Cosa può volere da te?’, chiedeva mia moglie spaventata.
“Mi feci il segno della croce e mi avviai, la neve quasi mi accecava quando attraversai il ponte. Ma tutto finì bene. Il vecchio principe faceva il suo sonno del dopopranzo e quando si svegliò mi chiese se sapevo dare l’intonaco, e mi disse solo: ‘Vieni domani ad accomodare la intonacatura di quella stanza’. Così tornai a casa tutto contento e quando arrivai al ponte vi trovai mia moglie.
“Era rimasta per tutto quel tempo nella neve, con la creatura in braccio, ad aspettarmi. ‘Cos’è successo, Savelič?’ mi gridò. ‘Oh’, dissi, ‘niente di male; mi ha detto soltanto di fare alcune riparazioni’. Questo era sotto il vecchio principe, padre. E ora, l’altro giorno viene qui il giovane principe. Andai a vederlo e lo trovai nel giardino seduto a prendere il tè, all’ombra della casa; voi, padre, eravate con lui, e il responsabile del distretto, con la sua catena di sindaco sul petto. ‘Vuoi prendere il tè, Savelič?’, mi chiese. ‘Accomodati. Pëtr Grigorovič – questo lo disse al vecchio – portaci un’altra sedia’. E Pëtr Grigorovič (sapete quanto era temuto da noi quando era intendente del vecchio principe) portò una sedia, e ci mettemmo tutti attorno alla tavola da tè chiacchierando, ed egli ci versò il tè a tutti quanti. E ora, padre, la serata è così bella, l’aria profumata viene dalle praterie, e io mi riposo e leggo: ‘Gioite! Gioite!’”.
Nel giugno del 1861 fui proposto sergente del Corpo dei Paggi. Devo confessare che la cosa non piacque molto a certi nostri ufficiali, che pretendevano che io non fossi adatto a mantenere la disciplina, ma non vi era rimedio. Vi era l’abitudine di nominare sergente il primo allievo della prima classe, e io ero stato il primo della classe per alcuni anni di seguito.
Era una posizione molto ambita, non solo perché il sergente occupava un posto privilegiato nella scuola ed era trattato come un ufficiale, ma soprattutto perché fin che durava in carica egli era il paggio dell’imperatore; e si pensava naturalmente che essere conosciuto personalmente dall’imperatore dovesse offrire l’occasione di ulteriori vantaggi. Per me la cosa più importante era che mi trovavo libero da tutte le seccature annesse al servizio interno della scuola, che toccavano ai Paggi della prima classe, e che avrei avuto una camera mia dove studiare isolandomi dal rumore della camerata. Vi era, è vero, un serio inconveniente: avevo sempre trovato noioso percorrere al passo, su e giù parecchie volte al giorno in tutta la loro lunghezza le nostre sale, e avevo preso l’abitudine di attraversarle a passo di corsa, cosa severamente proibita; ora invece dovevo passeggiare adagio adagio, con il libro dei rapporti sotto il braccio, invece di correre! Alcuni miei amici tennero addirittura una riunione per discutere questa grave questione, e fu deciso che di tanto in tanto avrei potuto ancora concedermi una delle mie corse preferite; quanto ai miei rapporti con gli altri, stava a me il metterli su una nuova base di amicizia, e lo feci.
I Paggi della prima classe dovevano andare molto sovente a Palazzo per assistere ai ricevimenti ufficiali e non ufficiali ai balli, ai pranzi e così via.
Nelle settimane di Natale, di Capodanno e di Pasqua fummo chiamati a Palazzo quasi tutti i giorni, spesso due volte al giorno. Inoltre, nella mia qualità di sergente, la domenica alla parata nel maneggio dovevo fare il rapporto all’imperatore che “tutto andava bene nella compagnia del Corpo dei Paggi”, anche quando un terzo della compagnia era malato di malattia contagiosa! “Non dovrei fare oggi il rapporto che tutto non va bene?”, chiesi al colonnello in questa occasione. “Per carità”, mi rispose, “una cosa simile non la devi dire che in casi di insurrezione!”.
La vita di Corte ha certo il suo lato pittoresco. L’elegante raffinatezza di maniere – anche se superficiale – l’etichetta rigida, l’ambiente brillante, sono indubbiamente calcolati per fare impressione.
Una grande levée offre un bello spettacolo, e anche il semplice ricevimento di poche signore, fatto dall’imperatrice, assume un carattere tutto diverso da quello di una semplice visita, quando avviene in un fastoso salone del palazzo; gli invitati introdotti da ciambellani dalle uniformi ricamate d’oro; l’imperatrice seguita dai Paggi nelle loro ricche divise e da un seguito di dame, e ogni particolare che si svolge con impressionante solennità.
Partecipare alle cerimonie di Corte, prestando servizio presso i personaggi principali, accontentava qualche cosa di più di una semplice curiosità per un ragazzo della mia età. Allora poi Aleksandr II era per me una specie di eroe; un uomo che non dava importanza alle cerimonie di Corte, ma che, a quell’epoca del suo regno, cominciava la sua giornata di lavoro alle sei del mattino ed era in lotta contro un potente partito reazionario per realizzare una serie di riforme, delle quali l’abolizione della schiavitù non era che la prima.
Ma poco per volta, man mano che conoscevo meglio il lato spettacolare della vita di Corte e intravedevo quello che succedeva dietro le quinte, capii non soltanto la vanità di questi spettacoli e delle cose che avrebbero dovuto celare, ma capii anche che queste ubbie occupavano talmente la Corte da impedire che si studiassero cose ben più importanti. Spesso la realtà si perdeva di vista per le apparenze. E poi lentamente svaniva l’aureola di cui la mia immaginazione aveva circondato Aleksandr II, così che alla fine dell’anno era svanita ogni illusione che io avessi potuto farmi da principio sulla possibilità di una attività utile nelle sfere di Corte.
Per ogni festa importante, per i compleanni e gli onomastici dell’imperatore e dell’imperatrice, per l’anniversario dell’incoronazione e altri ricevimenti simili, si teneva a palazzo un grande ricevimento. Migliaia di generali e ufficiali di ogni grado, a cominciare dai capitani, e gli alti funzionari dei servizi pubblici erano allineati lungo i vasti saloni del palazzo per inchinarsi al passaggio dell’imperatore e della sua famiglia, quando si recava solennemente in chiesa. In quei giorni tutti i membri della famiglia imperiale venivano a Palazzo e si riunivano in un salotto, dove chiacchieravano allegramente fino al momento di assumere la maschera della solennità.
Si formava allora il corteo. L’imperatore dava il braccio all’imperatrice e apriva la marcia. Era seguito dal suo paggio, seguito a sua volta dal generale aiutante di campo, dall’aiutante di campo di servizio quel giorno e dal ministro della casa imperiale; mentre l’imperatrice, o piuttosto l’immensa coda del suo vestito, era accompagnata da due Paggi che dovevano reggere lo strascico alle voltate e dispiegarlo in tutta la sua bellezza.
Il principe ereditario, un giovane di diciotto anni, e tutti i granduchi e le granduchesse seguivano nell’ordine del loro diritto al trono, ognuna delle granduchesse con il suo paggio; veniva poi una lunga processione di dame di Corte vecchie e giovani, tutte indossanti il cosiddetto costume russo, un abito cioè da società, nel costume delle donne della Vecchia Russia.
Mentre passava la processione vedevo come ognuno dei funzionari più alti, militari e civili, cercasse prima di fare l’inchino di richiamare su di sé l’attenzione dell’imperatore, e se l’inchino veniva contraccambiato dallo Zar con un sorriso o un impercettibile cenno del capo, o magari con qualche parola, il fortunato guardava con orgoglio i suoi vicini, aspettandosi le loro felicitazioni.
Il corteo tornava dalla chiesa nello stesso ordine, poi ognuno si affrettava ad andarsene per i fatti suoi. Salvo pochi devoti e qualche signorina, non c’era uno su dieci dei presenti che non considerasse queste levée un dovere noioso.
Due o tre volte durante l’inverno si davano a palazzo delle grandi feste da ballo, alle quali erano invitate migliaia di persone. Quando l’imperatrice aveva aperto il ballo con una polonaise, ognuno era libero di divertirsi a modo suo. Vi era abbondanza di spazio nelle grandi sale illuminate a giorno, dove le ragazze si sottraevano facilmente agli occhi vigili dei genitori e delle zie, e molte si godevano di cuore le danze e la cena, durante la quale la gioventù riusciva a gustare una completa libertà.
I miei doveri a questi balli erano piuttosto difficili. Aleksandr II non ballava né stava seduto, ma si aggirava continuamente in mezzo ai suoi invitati e io, come paggio al suo servizio, lo dovevo seguire a distanza, non troppo lontano, per poter essere chiamato con facilità, ma non vicino in modo indiscreto. Non era facile raggiungere questa combinazione di presenza e di assenza, come desiderava l’imperatore: il quale veramente avrebbe preferito esser lasciato solo, ma doveva sottomettersi a quello che voleva la tradizione. Il più difficile era quando entrava nella fitta folla di signore che facevano circolo attorno allo spazio dove ballavano i granduchi, e passava lentamente in mezzo a loro. Non era affatto facile aprirsi la strada in mezzo a questo giardino di fiori animati, che si apriva per lasciar passare l’imperatore, ma si richiudeva immediatamente dietro di lui. Invece di ballare per conto loro, le signore e le signorine stavano là a centinaia assiepate, ognuna con la speranza che uno dei granduchi la notasse e la invitasse a ballare un valzer o una polka.
L’influenza della Corte sulla società di Pietroburgo era tale, che se uno dei granduchi posava lo sguardo su una ragazza, i genitori di questa facevano di tutto perché la figlia si innamorasse alla follia dell’augusto personaggio, benché sapessero bene che un matrimonio era impossibile, non essendo permesso ai granduchi sposarsi con i “sudditi” dello Zar. I discorsi che sentii fare una volta in una famiglia “rispettabile”, in relazione con la Corte, dopo che il principe ereditario ebbe ballato due o tre volte con una ragazza di diciassette anni e le speranze espresse dai suoi genitori, sorpassarono tutto quello che avrei creduto possibile!
Tutte le volte che si andava a Palazzo vi si faceva colazione o pranzo; i camerieri ci sussurravano le ultime novità degli scandali di Corte, si volesse sentire o no. Sapevano tutto quello che succedeva nei diversi palazzi, era il loro regno. Devo dire, in verità, che durante l’anno del mio servizio quella cronaca non fu così ricca di avvenimenti come lo divenne dopo il settanta. I fratelli dello Zar erano ammogliati da poco, i suoi figli erano tutti molto giovani. Ma i servi parlavano ancor più liberamente della società di Pietroburgo, dei rapporti che correvano fra l’imperatore e la principessa X, quella che Turgenev ha descritto così bene nel suo romanzo Fumo, sotto il nome di Irene.
Un giorno però, mentre entravamo nel nostro spogliatoio, ci dissero: “La X oggi ha avuto il suo congedo, definitivo questa volta”. Mezz’ora più tardi vedemmo la signora stessa arrivare in chiesa con gli occhi gonfi di pianto e scorgemmo le sue lacrime, mentre le altre signore si tenevano ben lontane da lei per metterla meglio in evidenza.
I servitori sapevano già la notizia e la commentavano a modo loro. Erano veramente ributtanti i discorsi di questi uomini, che il giorno prima si sarebbero inchinati fino a terra davanti a quella donna!
Il sistema di spionaggio che domina a Corte, soprattutto intorno alla persona dell’imperatrice, è tale da sembrare incredibile ai profani. Ecco un incidente che ne darà un’idea. Pochi anni fa dopo questi avvenimenti uno dei granduchi ricevette una severa lezione da un signore di Pietroburgo. Questi aveva chiuso la sua casa al granduca; un giorno, tornando improvvisamente, lo trovò nel suo salotto e gli si scagliò addosso con il bastone in mano. Il giovane si precipitò giù per le scale e già saliva in carrozza, quando il suo assalitore lo raggiunse e lo colpì con il bastone. Il poliziotto che stava alla porta di casa vide la scena e corse a farne rapporto al capo della polizia, il generale Trepov, che a sua volta saltò in vettura e corse dall’imperatore per essere il primo a fare rapporto dell’“infausto evento”.
Alessandro II fece chiamare il granduca e gli parlò. Due giorni più tardi un vecchio funzionario che apparteneva alla terza sezione della cancelleria dell’imperatore – cioè alla polizia di Stato – e che era intimo di casa di uno dei miei compagni, raccontava tutta la conversazione. “L’imperatore”, ci disse, “andò in collera e finì col dire al granduca: dovreste sapere sbrigare meglio i vostri piccoli intrighi”. Naturalmente gli chiesero come potesse essere al corrente di una conversazione privata, e la risposta fu caratteristica! “Il nostro dicastero ha il dovere di conoscere le parole e le opinioni dell’imperatore. Altrimenti come sarebbe possibile amministrare un’istituzione così delicata come la polizia di Stato? Potete essere certi che l’imperatore è la persona più sorvegliata di Pietroburgo”.
E non si trattava di una semplice vanteria.
Ogni ministro, ogni governatore generale, prima di presentarsi con i suoi rapporti nello studio dell’imperatore parlava con il suo cameriere per sapere da lui di che umore fosse quel giorno il suo padrone, e secondo le informazioni avute gli esponeva qualche affare difficile o lasciava dormire il rapporto in fondo al portafoglio, aspettando un momento più favorevole. Quando il governatore generale della Siberia orientale veniva a Pietroburgo, mandava sempre il suo aiutante di campo particolare con qualche regalo generoso al cameriere dell’imperatore.
“Vi sono giorni”, diceva, “nei quali l’imperatore andrebbe in collera e ordinerebbe una inchiesta severa su tutti, me compreso, se gli esponessi certi rapporti, mentre altre volte tutto passa tranquillamente; quel cameriere è un uomo prezioso”. Gran parte dell’arte di conservare una carica importante era nel conoscere tutti i giorni lo stato d’animo dell’imperatore – un’arte che più tardi conobbero alla perfezione il conte Šuvalov e il generale Trepov, così come il conte Ignat’ev, anche senza l’aiuto del cameriere.
Nei primi tempi del mio servizio avevo una grande ammirazione per Aleksandr II, il liberatore dei servi. L’immaginazione trasporta spesso un ragazzo al di là della realtà e le mie idee allora erano tali, che se in presenza mia qualcuno avesse attentato alla vita dell’imperatore, lo avrei difeso con il mio corpo. Un giorno, sul principio di gennaio del 1862, lo vidi lasciare il corteo e solo incamminarsi rapidamente verso le sale dove alcuni distaccamenti di tutti i reggimenti della guarnigione di Pietroburgo erano allineati per essere passati in rivista. Questa rivista di solito si faceva all’aperto, ma quell’anno, a causa del gelo, si fece in caserma e Aleksandr II, che di solito galoppava a tutta carriera davanti alle truppe nelle riviste, dovette questa volta camminare davanti ai reggimenti. Sapevo che i miei doveri di Corte terminavano appena l’imperatore si mostrava nella sua qualità di comandante militare, e che dovevo seguirlo fin là, non oltre. Tuttavia mi guardai attorno e vidi che era tutto solo. I due aiutanti di campo erano spariti e non c’era un solo uomo del suo seguito. “Non lo lascerò solo!”, mi dissi, e lo seguii.
Non saprei dire se Aleksandr II avesse molta fretta quel giorno o se avesse qualche altra ragione per desiderare che la rivista terminasse il più presto possibile, ma in ogni modo si slanciò davanti alle truppe marciando con tanta velocità e facendo passi così lunghi e così rapidi – era molto alto – che io lo seguivo a fatica camminando il più in fretta possibile e in certi momenti dovevo quasi correre per rimanere vicino a lui. Andava sempre più in fretta, come se fuggisse davanti a qualche pericolo. Il suo eccitamento si comunicava a me, e mi sentivo pronto a slanciarmi davanti a lui a ogni istante e mi rammaricavo solo di aver con me la mia spada di ordinanza e non l’altra dalla lama di Toledo, un’arma perfetta. Dopo essere passato davanti all’ultimo battaglione rallentò il passo, e entrando in un’altra sala volse lo sguardo e incontrò i miei occhi, lucenti dall’emozione per quella corsa pazza. Il più giovane degli aiutanti correva disperatamente ed era rimasto due sale più indietro. Io mi aspettavo una solenne sgridata, ma invece Aleksandr II, forse rivelando un pensiero segreto, mi disse: “Voi qui? Coraggioso ragazzo!”, e allontanandosi lentamente fissò nel vuoto quello sguardo distratto e assente che da un po’ di tempo osservavo spesso in lui.
Tale era allora la disposizione del mio spirito. Vari episodi però, oltre il carattere reazionario della politica che Aleksandr II incominciava a seguire, mi facevano sempre più dubitare di lui. Tutti gli anni il 6 di gennaio si celebra in Russia una cerimonia mezzo cristiana e mezzo pagana per santificare le acque, e la si celebra anche a Palazzo. Si costruisce un padiglione sulla Neva, di fronte al palazzo, e la famiglia imperiale, preceduta dal clero, avanza attraverso il bellissimo viale lungo la Neva verso il padiglione, dove si canta il Te Deum e si immerge la croce nelle acque del fiume. Migliaia di persone si affollano sul viale e sul ghiaccio del fiume per assistere da lontano allo spettacolo. Durante la funzione tutti devono stare a capo scoperto. Quell’anno, essendo il freddo molto intenso, un vecchio generale si era messo una parrucca e nella furia di mettersi il cappotto la parrucca si era spostata e ora gli stava di traverso sulla testa, senza che egli se ne fosse accorto. Il granduca Costantino se ne accorse e rise durante tutto il Te Deum insieme ai più giovani granduchi, guardando continuamente il disgraziato generale, che sorrideva stupidamente senza capire il motivo di tanta ilarità. Finalmente Costantino lo sussurrò all’imperatore, e anch’egli guardò il generale e si mise a ridere.
Pochi minuti dopo, mentre il corteo attraversava di nuovo il viale lungo la Neva facendo ritorno al Palazzo, un vecchio contadino a capo scoperto si spinse oltre la doppia fila dei soldati allineati lungo il percorso del corteo e cadde in ginocchio ai piedi dello Zar, gridando con le lacrime agli occhi: “Padre! Difendeteci!”. La secolare oppressione dei contadini russi trovava voce in quelle parole; ma Aleksandr II, che pochi minuti prima, durante una funzione ecclesiastica, aveva riso per una parrucca mal messa, ora passò davanti al povero contadino senza prestargli la minima attenzione. Io gli stavo proprio dietro e non vidi che un tremito di paura all’improvvisa apparizione del supplicante, poi egli proseguì la sua strada senza neppure degnare di uno sguardo la figura umana prosternata ai suoi piedi.
Mi guardai intorno. Non c’erano gli aiutanti di campo: il granduca Costantino che seguiva non badò al contadino più di quanto facesse suo fratello, non il clero, nessuno neppure per prendere la petizione: la presi quindi io, benché sapessi che facendo così mi esponevo a ricevere un rimprovero. Non stava a me ricevere petizioni, ma pensai quanto doveva essere costato al contadino giungere alla capitale, e poi spingersi oltre le linee della polizia e dei soldati che circondavano il corteo. Sapeva anche che, come tutti i contadini che presentavano petizioni allo zar, sarebbe stato trattenuto in arresto per chissà quanto tempo.
Il giorno dell’emancipazione dei servi Aleksandr II era stato acclamato con adorazione, a Pietroburgo; ma è molto notevole che, salvo quel momento di entusiasmo, non era riuscito a guadagnarsi l’affetto della città. Suo fratello Nicola, chissà perché, era almeno molto popolare tra i commercianti e i vetturini; ma né Aleksandr II né suo fratello Costantino, il capo del partito riformista, né il suo terzo fratello Michele avevano saputo conquistarsi l’affetto di alcuna categoria di persone a Pietroburgo.
Alessandro II aveva ereditato troppo il carattere dispotico del padre, che ogni tanto traspariva attraverso le sue maniere gentili. Si inquietava facilmente e spesso trattava i suoi cortigiani con il massimo disprezzo. Non si poteva dire un uomo sicuro di sé, né in fatto di politica né nelle simpatie personali, ed era vendicativo. Non credo che fosse capace di affetto sincero.
Parecchi dei suoi familiari erano canaglie della peggior specie, il conte Adlerberg, per esempio, che più di una volta gli fece pagare i suoi debiti enormi, e altri conosciuti per furti colossali. Dal principio del 1862 incominciò a manifestarsi la sua tendenza a un ritorno ai pessimi sistemi di governo di suo padre. Si andava dicendo che egli volesse realizzare una serie di importanti riforme nell’organizzazione giudiziaria e nell’esercito, che le terribili pene corporali sarebbero state abolite e che sarebbe stata concessa una forma di governo autonomo e forse una specie di costituzione. Ma intanto la minima sommossa veniva soppressa per ordine suo con estrema severità; ogni movimento lo considerava un’offesa personale, così che ci si potevano aspettare da parte sua, da un momento all’altro, le misure più reazionarie.
I disordini che scoppiarono all’università di Pietroburgo, Mosca e Kazan nell’ottobre del 1861 furono soffocati con una severità inconsueta. L’università di Pietroburgo fu chiusa, e quando la maggior parte dei professori inaugurarono dei corsi liberi al palazzo municipale, anche questi furono soppressi e i professori migliori lasciarono l’università.
Immediatamente dopo l’abolizione della servitù fu iniziato un grande movimento per l’apertura di scuole domenicali; ne furono inaugurate dappertutto, da privati e da corporazioni – tutti gli insegnanti erano volontari – e i contadini e gli operai, vecchi e giovani, vi si affollavano. Ufficiali, studenti, persino alcuni Paggi si fecero insegnanti; e si elaborarono dei metodi di insegnamento così buoni, che data l’ortografia fonetica russa si riusciva a insegnare a leggere a un contadino con nove o dieci lezioni. Ma improvvisamente tutte le scuole domenicali per mezzo delle quali la massa dei contadini avrebbe imparato a leggere in pochi anni senza spese da parte dello Stato, furono chiuse. In Polonia, dove era stata iniziata una serie di manifestazioni patriottiche, furono mandati i Cosacchi perché disperdessero la folla con le loro fruste e perché arrestassero con la consueta brutalità centinaia di persone nelle chiese. Diverse persone furono fucilate per le vie di Varsavia alla fine del 1861, e per punire le poche rivolte di contadini che si ebbero in quell’epoca, si ricorse all’orribile castigo prediletto da Nicola I, la fustigazione attraverso una doppia fila di soldati. Nel 1861 si presentiva il despota che Aleksandr II doveva diventare nel periodo dal 1870 al 1881.
Di tutta la famiglia imperiale senza dubbio la più simpatica era Maria Aleksandrovna. Era sincera e quando le si diceva una cosa gradita, se ne mostrava lieta. La maniera con cui mi ringraziò una volta per una piccola cortesia (era dopo il ricevimento offerto da lei all’ambasciatore degli Stati Uniti, giunto allora a Pietroburgo) mi fece una profonda impressione: non era la maniera di una signora viziata dall’ambiente, come si suppone debba essere una imperatrice. Certo non era felice nella sua vita domestica, e non era ben veduta neppure dalle dame di Corte, che la trovavano troppo austera e che non riuscivano a capire perché prendesse tanto a cuore le étourderie di suo marito. Si sa ora che ebbe non poca parte nell’emancipazione dei servi. Ma allora si sospettava poco l’influenza esercitata da lei in favore di questa riforma e si consideravano il granduca Costantino e la granduchessa Elena Pavlovna, che era il sostegno principale di Nikolaj Miljutin alla Corte, come i due capi del partito delle riforme al palazzo.
L’imperatrice era più conosciuta per la parte decisiva che aveva avuto nella fondazione dei ginnasi femminili, che ebbero fin dall’inizio un’organizzazione superiore e un carattere nettamente democratico. I suoi rapporti di amicizia con [Konstantin] Ušinskij, un grande pedagogista, risparmiarono a questo il destino di tutti gli uomini famosi di questa epoca: l’esilio.
Essendo molto colta, Maria Aleksandrovna fece del suo meglio per dare una buona educazione al figlio maggiore. Gli uomini più notevoli nelle varie discipline furono scelti come insegnanti e a questo scopo invitò persino Kavelin, benché non ignorasse le sue relazioni di amicizia con Herzen. Quando egli le parlò di questa amicizia, gli rispose che non portava rancore a Herzen, salvo che per il suo linguaggio violento contro l’imperatrice madre.
Il principe ereditario era bellissimo, di una bellezza forse troppo femminea. Non era superbo e durante i ricevimenti chiacchierava da buon compagno con i paggi. Ricordo persino che a un ricevimento per Capodanno, dato al Corpo diplomatico, mi sforzai di fargli apprezzare la semplicità della uniforme dell’ambasciatore degli Stati Uniti, paragonata alle uniformi ridicolmente pompose degli altri ambasciatori. Quelli che lo conoscevano bene, però, lo dicevano profondamente egoista, assolutamente incapace di provare un affetto sincero per chiunque. Questo era ancora più tipico in lui che in suo padre. Quanto alla sua educazione, tutti gli sforzi della madre furono vani. Nell’agosto del 1861 fece i suoi esami davanti a suo padre e fece un fiasco completo; ricordo che durante una rivista comandata dal principe ereditario, questi fece qualche sbaglio e l’imperatore gli gridò ad alta voce: così che tutti lo sentirono: “Non hai saputo imparare neppure questo!”. Morì, come si sa, a ventidue anni, di una malattia al midollo spinale.
Suo fratello Alessandro, che diventò principe ereditario nel 1865 e che fu più tardi Aleksandr III, faceva un contrasto notevolissimo con Nicola Aleksandrovič. Mi ricordava tanto Paolo I, nella faccia, nella persona e nell’ammirazione per la propria grandezza, che usavo dire: “Se arriverà a regnare sarà un altro Paolo I nel palazzo di Gatčina, e farà la stessa fine del suo avo nelle mani dei cortigiani”. Si rifiutava ostinatamente di studiare. Correva voce che Aleksandr II, avendo avuto molte contrarietà con suo fratello Costantino, più istruito di lui, avesse seguito la tattica di concentrare ogni cura sull’erede al trono, trascurando l’istruzione degli altri suoi figli; dubito però che fosse così. Aleksandr Aleksandrovič deve essere stato ribelle all’istruzione fin dall’infanzia; la sua ortografia che ho potuto vedere nei dispacci che spedì alla sua sposa in Danimarca, era pessima in modo incredibile. Non posso rendere qui la sua ortografia russa, ma in francese scrisse: “Ecri a oncle à propos parade… les nouvelles sont mauvaisent”, e così via.
Si dice che abbia migliorato negli ultimi anni, ma fino al 1870 e anche più tardi fu un vero discendente di Paolo I. Conoscevo a Pietroburgo un ufficiale di origine svedese, mandato negli Stati Uniti per ordinarvi delle carabine per l’esercito russo. Al suo ritorno dovette fare il rapporto della sua missione ad Aleksandr Aleksandrovič, nominato sovrintendente per il rifornimento d’armi all’esercito. Durante questo colloquio lo zarevic, in uno sfogo di collera, cominciò a sgridare l’ufficiale, che probabilmente rispose con dignità, e allora il principe si abbandonò a un impeto e insultò l’ufficiale rivolgendogli male parole. L’ufficiale, che era uno di quegli uomini leali e fieri come si incontrano spesso nella nobiltà svedese residente in Russia, se ne andò immediatamente e scrisse una lettera nella quale chiedeva al principe ereditario delle scuse entro le ventiquattro ore, aggiungendo che se le scuse non fossero giunte, si sarebbe fatto saltare le cervella. Era una specie di duello giapponese. Aleksandr Aleksandrovič non rispose e l’ufficiale mantenne la parola. Lo vidi in casa di un mio caro amico, intimo suo, mentre aspettava di momento in momento la lettera che aveva chiesto! Il giorno dopo era morto. Lo Zar si adirò con suo figlio e gli ordinò di seguire al sepolcro la bara dell’ufficiale. Ma neppure questa terribile lezione frenò l’orgoglio dei Romanov e l’impetuosità del giovane principe.
Parte terza
La Siberia
Alla metà di maggio del 1862, poche settimane prima della nostra promozione, ebbi dal capitano l’ordine di fare l’elenco definitivo dei reggimenti nei quali ognuno di noi desiderava servire. Ci era concessa la scelta di tutti i reggimenti della Guardia, nei quali si poteva entrare con il primo grado di ufficiale, e dell’esercito con il terzo grado di tenente.
Scrissi la lista per la nostra classe, facendo il giro dei compagni. Tutti sapevano già il reggimento nel quale desideravano appartenere, e molti portavano già, in giardino, il berretto da ufficiale.
“Corazzieri di Sua Maestà”, “Guardia del Corpo Preobrazenskij”, “Guardia a cavallo”: erano le risposte scritte sul mio taccuino. “E tu, Kropotkin? L’artiglieria? I Cosacchi?”, mi si chiedeva da tutte le parti. Non potevo rispondere a queste domande e infine pregai un compagno di completare la lista e me ne andai in camera a riflettere di nuovo sul mio avvenire.
Già da un pezzo avevo deciso di non entrare in un reggimento della Guardia, dove sarei stato occupato in riviste e in balli di Corte. Il mio sogno era di entrare all’università, di fare la vita dello studente. Questo naturalmente avrebbe portato alla rottura definitiva con mio padre, che aveva per me tutt’altre ambizioni, e mi obbligava a contare per mantenermi su ciò che avrei potuto guadagnare dando lezioni. Migliaia di studenti russi vivevano così e una vita del genere non aveva per me nulla di spiacevole. Ma come superare i primi passi di quella vita? Fra poche settimane dovevo lasciare la scuola, rivestire i miei panni, trovare un alloggio e non vedevo la possibilità di trovare il poco denaro necessario anche per l’inizio più modesto. In mancanza dell’università avevo anche pensato più d’una volta di entrare all’Accademia di artiglieria; per due anni sarei stato libero dalla seccatura del servizio militare e con le scienze militari avrei potuto studiare la matematica e la fisica. Ma soffiava il vento della reazione, e gli ufficiali delle accademie erano stati trattati durante l’inverno precedente come tanti scolaretti; in due accademie si erano ribellati e da una di esse si erano dimessi tutti insieme.
I miei pensieri si volgevano sempre più verso la Siberia. La regione dell’Amur era stata da poco annessa alla Russia; io avevo letto molto a proposito di quel Mississippi dell’Oriente, delle montagne attraverso cui si scava la strada, della vegetazione subtropicale del suo affluente, l’Ussuri; e i miei pensieri viaggiavano anche più in là, alle regioni tropicali descritte da [Alexander von] Humboldt e da [Carl] Ritter, di cui mi deliziavo di leggere le grandiose costruzioni. Mi dicevo inoltre che la Siberia offriva un vasto teatro per l’applicazione delle grandi riforme fatte e da fare; i lavoratori là erano pochi e io vi avrei trovato un campo d’azione di mio gusto.
Mi era dolorosissimo separarmi da mio fratello Aleksandr; ma era stato obbligato a lasciare l’università di Mosca in seguito agli ultimi disordini e avevo il presentimento – e non mi sbagliavo – che tra un anno o due, in un modo o nell’altro, ci saremmo rivisti. Non mi restava che scegliere il reggimento nel distretto dell’Amur.
L’Ussuri mi attirava molto, ma disgraziatamente non vi era sull’Ussuri che un solo reggimento di Cosacchi di fanteria. Un cosacco a piedi era troppo sconfortante per un ragazzo della mia età e decisi in favore dei “Cosacchi a cavallo dell’Amur”.
Scrissi questo sull’elenco, con grande sgomento dei miei compagni. “È così lontano”, mi dicevano, mentre il mio amico Daurov afferrando la guida degli ufficiali leggeva, sollevando l’orrore di tutti i presenti: “Uniforme nera, con semplice bavero rosso, senza galloni; berretto di pelo di cane, pantaloni grigi”.
“Pensa soltanto a quell’uniforme!”, esclamò. “Passi per il berretto: potrai portarlo di pelle di lupo o di orso; ma pensa anche solo a quei pantaloni! Grigi, come quelli della milizia ferroviaria!”.
Sorrisi scherzosamente e portai la lista al capitano.
“Kropotkin ne deve sempre fare una delle sue!”, esclamò. “Ma se vi ho detto che l’elenco deve essere consegnato oggi stesso al granduca?”.
Lo convinsi a fatica che vi avevo espresso seriamente le mie intenzioni. Il giorno dopo però tornavo quasi sulle mie decisioni, quando vidi come Klasovskij accolse la notizia. Egli aveva sperato di vedermi all’università e mi aveva dato a questo scopo delle lezioni di latino e di greco; non osavo confessargli il vero motivo che mi impediva di entrare all’università: sapevo che se gli avessi detto la verità avrebbe voluto dividere con me il poco che aveva.
Poi mio padre telegrafò al direttore proibendo la mia partenza per la Siberia, e la questione fu rimessa al granduca, che era a capo delle scuole militari. Fui chiamato davanti al suo aiutante e parlai della vegetazione dell’Amur e di altre cose simili, perché avevo delle buone ragioni per credere che se avessi detto che desideravo andare all’università, ma che non potevo farlo per ragioni finanziarie, una borsa mi sarebbe stata offerta da qualche membro della famiglia imperiale, cosa che volevo evitare a ogni costo.
Non so come sarebbe finita la cosa se un avvenimento di grande importanza, un terribile incendio a Pietroburgo, non fosse venuto a dare una spinta decisiva ai miei progetti.
Il lunedì dopo la festa della Santissima Trinità – il giorno dello Spirito Santo, che quell’anno fu il 26 maggio (secondo il calendario giuliano) – scoppiò un terribile incendio nel così detto Apraksin Dvor. L’Apraksin Dvor era una grande piazza di quasi mezzo chilometro quadrato, completamente ingombra di piccole botteghe di legno – semplici baracche – dove si vendevano oggetti di ogni specie. Vecchi mobili, materassi usati, abiti e libri d’occasione affluivano da tutti i quartieri della città e venivano immagazzinati nelle baracche, nei vicoletti che le separavano e persino sui tetti.
Questo cumulo di materiale facilmente infiammabile era addossato al Ministero dell’Interno e ai suoi archivi, nei quali si conservavano tutti i documenti riguardanti la liberazione dei servi; sul davanti della piazza, che era fronteggiata da una fila di negozi costruiti in pietra, vi era la Banca Nazionale. Uno stretto vicolo, fiancheggiato anch’esso da negozi costruiti in pietra, separava l’Apraksin Dvor da un’ala del palazzo del Corpo dei Paggi, occupato al pianterreno da negozi di drogheria e di olio e al piano superiore dagli appartamenti degli ufficiali. Quasi di fronte al Ministero dell’Interno, sull’altra riva del canale, vi erano dei grandi depositi di legname. Questo labirinto di piccole baracche e i depositi di legname in faccia si incendiarono quasi simultaneamente alle quattro del pomeriggio.
Se fosse stata una giornata di vento metà della città sarebbe stata ridotta in cenere, compresa la Banca, diversi Ministeri, il Gostiny Dvor (un’altra grande piazza a negozi sulla Prospettiva Nevskij) il Corpo dei Paggi e la Biblioteca Nazionale.
Quel giorno ero al corpo e pranzavo con uno degli ufficiali. Accorremmo sul posto appena si vide da una delle finestre il fumo denso che si alzava non lontano da noi. Era uno spettacolo terribile.
Come un enorme serpente, l’incendio si stendeva fischiando e crepitando in tutte le direzioni, a destra e a sinistra; avviluppò le baracche e improvvisamente si alzò in una enorme colonna, dardeggiante lingue che sibilando divoravano altre baracche con quanto contenevano. Si formavano dei turbini di fiamme e di fumo, e quando i fiocchi di penne in fiamme incominciarono a volare per la piazza, fu impossibile rimanere ancora dentro il mercato incendiato. Si dovette abbandonarlo del tutto.
Le autorità avevano perduto completamente la testa. Non si trovava una pompa a vapore a Pietroburgo, e furono gli operai che proposero di portarne una delle ferriere di Kolpino, a una ventina di miglia dalla capitale. Quando la pompa giunse alla stazione fu il popolo che la trascinò sul luogo dell’incendio. Dei quattro getti, uno era stato danneggiato da mano sconosciuta, gli altri tre furono diretti sul Ministero dell’Interno.
I granduchi vennero sul luogo e poi se ne allontanarono. A sera inoltrata, quando la Banca era stata salvata, l’imperatore apparve e disse ciò che tutti sapevano, che il Corpo dei Paggi era ormai la chiave della situazione e che bisognava difenderlo a ogni costo. Era evidente che se il palazzo del Corpo si fosse incendiato la Biblioteca Nazionale e metà della Prospettiva Nevskij sarebbero state distrutte dalle fiamme.
Fu la folla, il popolo, che fece di tutto per impedire l’ulteriore dilagare dell’incendio. Per un momento la Banca fu seriamente minacciata. Le mercanzie asportate dai negozi di fronte furono buttate nella via Sadovaya, appoggiate in grossi mucchi contro il muro dell’ala sinistra della Banca. La roba che ingombrava la strada stessa si incendiava tutti i momenti, ma la folla, mezzo arrostita, in un caldo insopportabile, impediva che le fiamme si comunicassero ai mucchi di merce dall’altro lato della via. Si imprecava contro le autorità per la mancanza di pompe. “Che cosa fanno al Ministero dell’Interno, mentre la Banca e l’Istituto dei Trovatelli stanno per bruciare? Hanno perduto la testa! Che cosa fa il capo della polizia, che non manda i pompieri per salvare la Banca?”, si diceva. Conoscevo personalmente il capo, il generale Annenkov, per averlo incontrato un paio di volte in casa del nostro vice-ispettore, dove veniva insieme al fratello, il noto critico letterario, e mi offrii di andarlo a cercare. Lo trovai infatti che passeggiava senza scopo su e giù per la via, e quando gli raccontai come stavano le cose egli, incredibile ma vero, dette a me giovanissimo l’ordine di muovere una delle brigate di pompieri dal ministero alla Banca. Gli dissi naturalmente che gli uomini non mi avrebbero dato retta e lo pregai di darmi un ordine scritto; ma il generale Annenkov non aveva con sé un foglio di carta, così dovetti pregare uno dei nostri ufficiali, L. L. Gosse, di accompagnarmi per trasmettere l’ordine. Finalmente riuscimmo a persuadere il capitano di una brigata di pompieri – che invocò maledizioni sul mondo intero e sui suoi capi – a dislocare i suoi uomini e le pompe alla Banca.
Il Ministero non aveva preso fuoco; erano gli archivi che bruciavano, e molti giovani, per lo più Cadetti e Paggi, insieme a molti impiegati, asportavano dall’edificio in fiamme pacchi di carte che caricavano sulle vetture. Spesso un pacco cadeva e il vento ne sparpagliava i fogli per la piazza. Attraverso il fumo si vedeva infuriare un sinistro incendio nei depositi di legname dall’altro lato del canale.
Lo stretto vicolo che separava il Corpo dei Paggi dalla Apraksin Dvor era in uno stato deplorevole. Le botteghe che lo fiancheggiavano erano piene di zolfo, di olio, di acqua ragia e materie simili, e immense lingue di fuoco di diverso colore, lanciate fuori dalle esplosioni, lambivano i tetti dell’ala del nostro palazzo. Le finestre e i pilastri sotto il tetto incominciavano già a bruciare e i Paggi, con l’aiuto di alcuni cadetti, dopo avere sgombrato le stanze pompavano acqua da una piccola macchina, che riceveva a lunghi intervalli un magro approvvigionamento da antichi barili, che si dovevano riempire con una bigoncia. Due pompieri che stavano sul tetto infuocato gridavano continuamente: “Acqua! Acqua!”, con accento disperato. Non potevo più sopportare quelle grida e mi precipitai nella via Sadovaya, dove con la forza obbligai il conduttore di uno dei barili appartenenti ai pompieri della polizia a entrare nel nostro cortile e a rifornire d’acqua la nostra pompa. Ma un secondo conduttore mi oppose un reciso rifiuto. “Se vi obbedissi sarei mandato davanti a un tribunale militare”. Da tutte le parti i compagni mi incoraggiavano: “Va’ a trovare il capo della polizia, il granduca, non importa chi e di’ che ci manca l’acqua, che dovremo abbandonare il palazzo al fuoco”.
“Non sarebbe il caso di far rapporto al nostro direttore?”, chiese qualcuno.
“Al diavolo tutti quanti! Non si troverebbero a cercarli con la lanterna! Va’ e fallo da te”.
Tornai un’altra volta a cercare il generale Annenkov e finalmente mi dissero che era nel cortile della Banca. Vi erano là infatti diversi ufficiali superiori attorno ad un generale, in cui riconobbi il governatore generale di Pietroburgo, principe Suvorov. Il cancello però era chiuso a chiave e un impiegato della Banca che vi stava davanti, si rifiutò di lasciarmi passare.
Io insistetti, minacciai, e finalmente passai. Andai diritto al principe Suvorov che scriveva un biglietto sulla spalla del suo aiutante di campo. Quando gli ebbi esposto il pericolo e la necessità di provvedere, la sua prima domanda fu: “Chi vi ha mandato?”. “Nessuno, i compagni”, risposi.
“Così, dite che presto il palazzo brucerà?”.
“Sì”, risposi.
Si mise subito in strada e, afferrando per via una cappelliera vuota, se ne coprì la testa per proteggersi dal calore ardente che proveniva dalle botteghe infuocate dell’Apraksin Dvor, e si precipitò di corsa verso il vicolo.
Questo era ingombro di barili vuoti, di paglia, di casse e cose del genere; da un lato si innalzavano le fiamme delle botteghe, dall’altro si trovava il nostro palazzo con le finestre e i pilastri che ardevano.
Il principe Suvorov agì energicamente. “C’è una compagnia di soldati nel vostro giardino”, mi disse. “Prendete un distaccamento e fate sgomberare quel vicolo, immediatamente. Un condotto della pompa sarà portato qui subito. Fatelo funzionare senza interruzione. L’affido a voi”.
Non era cosa facile muovere i soldati dal nostro giardino. Avevano vuotato le casse e i barili e con le tasche piene di caffè e le zollette di zucchero nascoste nei berretti si godevano la serata calda sotto gli alberi, schiacciando noci! Nessuno volle muoversi, finché non intervenne l’ufficiale. Il vicolo fu sgomberato e la pompa incominciò a funzionare. I compagni furono contentissimi e ogni venti minuti si dava il cambio agli uomini che dirigevano il getto d’acqua stando sotto un calore quasi insopportabile.
Verso le tre o le quattro del mattino l’incendio era stato circoscritto: il pericolo che si estendesse al palazzo del corpo era sventato, e quando ebbi placato la mia sete con una mezza dozzina di bicchieri di tè, bevuti in una piccola “trattoria bianca” trovata aperta, mi buttai mezzo morto di stanchezza sul primo letto che trovai libero nell’infermeria del Corpo.
L’indomani mi svegliai presto e andai a visitare i luoghi dell’incendio; al ritorno incontrai il granduca Michele che accompagnai com’era mio dovere nel suo giro di ispezione. I Paggi, con il viso annerito dal fumo, con gli occhi gonfi e le palpebre infiammate, alcuni con i capelli bruciacchiati, alzavano le teste dal guanciale. Era difficile riconoscerli, ma erano orgogliosi perché non erano stati semplicemente “mani bianche” e avevano lavorato come chiunque altro.
La visita del granduca mise termine alla mia perplessità. Egli mi chiese come fosse nato il mio desiderio di andare nella regione dell’Amur – se avevo degli amici laggiù, se il governatore generale mi conosceva – e quando seppe che non avevo parenti nella Siberia e che non vi conoscevo nessuno, esclamò: “Ma allora perché volete andare laggiù? Potrebbero mandarvi in qualche sperduto villaggio cosacco, a farvi che cosa? Bisognerà che scriva di voi al governatore generale per raccomandarvi a lui”. Ero certo che dopo una simile offerta mio padre non avrebbe avuto più difficoltà, e così fu. Ero libero di andare in Siberia!
Questo grande incendio segnò l’inizio della reazione non soltanto nella politica di Aleksandr II, ma anche nella storia della Russia di questo periodo. Era evidente che non lo si poteva attribuire al caso. Le feste della Trinità e dello Spirito Santo sono osservate con molta solennità in Russia, e tranne pochi guardiani, sul mercato non c’era nessuno. Inoltre il mercato dell’Apraksin Dvor e i depositi di legname si incendiarono contemporaneamente e l’incendio di Pietroburgo fu seguito da altri in parecchie città di provincia. Il fuoco era stato appiccato da qualcuno, ma da chi? Ecco una domanda rimasta finora senza risposta.
Katkov, l’ex liberale che nutriva un odio personale per Herzen e soprattutto per Bakunin, con il quale si era battuto in duello, l’indomani stesso dell’incendio accusò i Polacchi e i rivoluzionari russi di esserne gli autori, e quella opinione era la più diffusa a Pietroburgo e a Mosca.
La Polonia si preparava allora alla rivoluzione che scoppiò il gennaio seguente, e il governo clandestino rivoluzionario aveva stretto un’alleanza con i rifugiati di Londra e aveva i suoi agenti al centro stesso dell’amministrazione a Pietroburgo. Non molto tempo dopo l’incendio il governatore militare della Polonia, il conte Lüders, fu ucciso da un ufficiale russo e quando fu sostituito con il granduca Costantino (con il proposito, a quanto si diceva, di fare della Polonia un regno separato per Costantino) subito vi fu un attentato anche contro di lui, il 26 giugno. Attentati simili si ebbero nell’agosto contro il marchese [Aleksander] Wielopolski, il capo polacco del partito russofilo. Napoleone III lasciava sperare ai Polacchi un intervento armato in favore della loro indipendenza. Date queste condizioni, dal punto di vista militare si poteva considerare una buona tattica di guerra distruggere la Banca di Russia e diversi Ministeri e spargere il panico nella capitale; ma non si ebbe mai la minima prova in favore di questa ipotesi.
D’altra parte i partiti progressisti in Russia vedevano che non si poteva continuare a sperare nell’iniziativa riformatrice di Alessandro, che si abbandonava sempre più apertamente al partito della reazione. Era facile prevedere che la liberazione dei servi, date le condizioni di riscatto che erano state poste, avrebbe significato la loro certa rovina, e manifesti rivoluzionari usciti nel maggio a Pietroburgo chiamarono il popolo e l’esercito alla rivoluzione, mentre incitavano le classi più elevate a insistere sulla necessità di una Convenzione Nazionale. Date queste circostanze, l’idea di disorganizzare l’ingranaggio governativo avrebbe potuto entrare nei piani di alcuni rivoluzionari.
Infine l’incertezza che caratterizzava le leggi sull’emancipazione produsse molto fermento fra i contadini, che costituiscono una parte considerevole della popolazione nelle città russe; e nella storia della Russia, in ogni tempo simili fermenti hanno prodotto minacce anonime predicanti la distruzione, e infine scoppi di incendi. È possibile che l’idea di appiccare il fuoco al mercato di Apraksin sia stata suggerita da individui isolati nel campo rivoluzionario, ma né le inchieste più minuziose né gli arresti in massa che si ebbero in Russia e in Polonia subito dopo l’incendio rivelarono il minimo indizio che potesse avvalorare questa supposizione. Se qualche prova del genere si fosse avuta, il partito reazionario se ne sarebbe fatto forte. Sono state pubblicate molte memorie e molti volumi di corrispondenze di quei tempi, ma non contengono nessun indizio favorevole a questi sospetti.
Al contrario, quando fatti simili accaddero in diverse città sul Volga, e specialmente a Saratov, e quando Zdanov, un membro del senato, fu mandato per ordine dello Zar a fare un’inchiesta, egli tornò con la ferma convinzione che l’incendio di Saratov fosse opera del partito reazionario. In quel partito era generale l’opinione che fosse possibile indurre Aleksandr II a posporre l’abolizione definitiva della servitù, che doveva aver luogo il 19 febbraio 1863. Si conosceva la debolezza del suo carattere e immediatamente dopo il grande incendio di Pietroburgo i reazionari aprirono una violenta campagna perché fosse rimandata e riesaminata la legge sull’emancipazione e le sue applicazioni pratiche. Nei circoli legali bene informati si diceva che il senatore Zdanov fosse realmente ritornato con delle prove positive della colpevolezza dei reazionari a Saratov; ma egli morì al suo ritorno e le sue carte scomparvero e non furono più ritrovate!
Comunque stiano le cose, l’incendio di Apraksin ebbe le più deplorevoli conseguenze. Dopo questo avvenimento Aleksandr II passò dalla parte dei reazionari e – quel che è peggio – quella parte della società di Pietroburgo e specialmente di Mosca che più influiva sul governo gettò a un tratto la sua maschera e da liberale si mutò non solo in nemica della frazione avanzata del partito delle riforme, ma anche delle sue frazioni più moderate. Pochi giorni dopo l’incendio andai una domenica a vedere mio cugino, l’aiutante di campo dell’imperatore, nel cui appartamento un tempo avevo sentito gli ufficiali della Guardia a cavallo esprimersi con simpatia a proposito di černyševski; lo stesso mio cugino era stato fino allora un assiduo lettore de “Il Contemporaneo” (l’organo della frazione d’avanguardia del partito delle riforme). Questa volta egli prese alcuni numeri de “Il Contemporaneo” e mettendoli sul tavolo al quale io ero seduto, mi disse: “Bene, ora, dopo quello che è successo non ne voglio più di questa roba incendiaria; ne ho abbastanza di tutto questo”, e queste parole esprimevano l’opinione di tutta Pietroburgo. Né io potevo, naturalmente, parlare di riforme. Tutta l’atmosfera era carica di spirito reazionario. “Il Contemporaneo” e altre riviste del genere furono soppresse, le scuole domenicali furono proibite sotto qualsiasi forma; furono eseguiti arresti in massa, la capitale fu posta in stato d’assedio.
Due settimane dopo, il 13 (25) giugno, giunse il giorno che i Paggi e i Cadetti aspettavano da tanto tempo. L’imperatore presiedeva una specie di esame militare di tutte le nostre evoluzioni, durante il quale egli comandava le compagnie – ed io presi parte alla parata cavalcando davanti al battaglione – quindi fummo promossi ufficiali.
Quando la parata fu finita, Aleksandr II gridò: “Gli ufficiali promossi da me!”, – e noi ci raccogliemmo intorno a lui. Egli rimase a cavallo. Lo vidi allora sotto una nuova luce. L’uomo che l’anno prima aveva avuto la parte di domatore vendicativo e assetato di sangue dell’insurrezione polacca, mi si levò ora intero davanti agli occhi, nel discorso che egli ci rivolse.
“Mi congratulo con voi”, disse con voce calma, “siete ufficiali”. Parlò poi degli obblighi militari e della fedeltà, come si usa parlare in queste occasioni. “Ma se qualcuno di voi”, soggiunse scolpendo distintamente ogni parola, con il viso a un tratto sconvolto da un moto d’ira, “ma se qualcuno di voi – Dio ve ne guardi – per qualsiasi circostanza si mostrerà sleale verso lo Zar, il trono, la patria – ricordate bene quello che vi dico – egli sarà trattato con la maggiore se-ve-ri-tà della legge, senza nessuna com-mi-se-ra-zio-ne!”.
La voce gli mancò; la faccia gli era diventata dura, piena di quell’espressione di cieca rabbia che avevo potuto vedere nella mia infanzia sui visi dei signori quando minacciavano i loro servi “di scorticarli sotto le verghe”. Spinse violentemente il suo cavallo fuori dal nostro gruppo; la mattina dopo, il 14 giugno, per ordine suo venivano fucilati tre ufficiali a Modlin, in Polonia, e un soldato di nome Szur veniva ucciso sotto le verghe!
“Ecco il trionfo della reazione!”, dissi fra di me, mentre ce ne tornavamo al Corpo.
Vidi un’altra volta Aleksandr II poco prima di lasciare Pietroburgo. Alcuni giorni dopo la nostra promozione tutti i nuovi ufficiali andarono a Palazzo per esservi presentati. La mia uniforme più che modesta, con i suoi caratteristici pantaloni grigi richiamò l’attenzione di tutti e dovevo continuamente soddisfare la curiosità degli ufficiali di tutti i ranghi che venivano a chiedermi qual fosse l’uniforme che vestivo. Quello dei Cosacchi dell’Amur era fra i più giovani reggimenti dell’esercito russo e io ero fra gli ultimi dei cento ufficiali che erano presenti. Aleksandr II mi si avvicinò e mi chiese: “Così voi andate in Siberia? Ma vostro padre ha finalmente acconsentito?”. Risposi affermativamente. “Non avete timore di andare tanto lontano?”. “No”, replicai con calore, “voglio lavorare; in Siberia si può fare molto per applicare le grandi riforme che si preparano”. Egli mi guardò fisso, diventò pensieroso e finalmente disse: “Bene, andate; si può essere utili dovunque”, e così dicendo il suo viso assunse un’espressione di profonda stanchezza, come il segno di un completo abbandono, tanto che io pensai: “È un uomo finito”.
Pietroburgo aveva assunto un aspetto tetro. Per le vie marciavano i soldati. Le pattuglie di Cosacchi perlustravano intorno al Palazzo, la fortezza era piena di prigionieri. Dovunque andassi scorgevo la medesima cosa: la reazione più manifesta. Lasciai Pietroburgo senza rimpianto.
Andavo ogni giorno all’ufficio dell’amministrazione cosacca per sollecitare il rilascio dei miei documenti e appena furono pronti mi affrettai ad andare a Mosca per raggiungervi mio fratello Aleksandr.
I cinque anni trascorsi in Siberia furono per me di una grande utilità per la conoscenza della vita e degli uomini. Mi trovai a contatto con individui di tutte le classi, le migliori e le peggiori; quelle che stanno al sommo della società e quelle che vegetano al basso: – i vagabondi e i cosiddetti criminali incorreggibili. Ebbi ogni opportunità di osservare gli usi e le abitudini dei contadini nella loro vita quotidiana e una possibilità anche maggiore di apprezzare quanto poco possa essere loro utile l’amministrazione dello Stato, fosse anche animata dalle migliori intenzioni. I miei lunghi viaggi, poi, durante i quali attraversai cinquantamila miglia su carri, su piroscafi, in barca, ma soprattutto a cavallo, ebbero un effetto meraviglioso nel rafforzare la mia salute. Essi mi insegnarono anche come pochi siano i reali bisogni dell’uomo, non appena egli sia uscito dal cerchio magico della civiltà convenzionale. Con qualche pagnotta di pane e pochi grammi di tè in un sacchetto di cuoio, un pentolino, e un’accetta attaccata alla sella e, dietro la sella, una coperta da stendere al bivacco, sopra un letto di frasche tagliate di fresco, un uomo può sentirsi perfettamente indipendente anche in mezzo a montagne sconosciute, rivestite di fitte foreste o coperte di neve. Potrei scrivere un libro intero su questa parte della mia vita, ma è necessario procedere rapidamente, perché dovrò dire molto degli anni che seguirono.
La Siberia non è solo la terra gelata e sepolta sotto la neve e popolata di esiliati, come la si immagina, anche da parte di molti Russi. Nella sua parte meridionale è tanto ricca di prodotti naturali quanto il mezzogiorno del Canada, al quale assomiglia molto nel suo aspetto fisico; e accanto a un mezzo milione di indigeni vi è una popolazione di più di quattro milioni di Russi. Il mezzogiorno della Siberia Sud-occidentale è altrettanto russo quanto le province a Nord di Mosca.
Nel 1862 l’amministrazione della Siberia fu dovunque molto più illuminata e migliore che in ogni altra provincia della Russia propriamente detta. Per diversi anni il posto di governatore generale della Siberia orientale fu occupato da un individuo notevole, il conte N. N. Muravëv, al quale la Russia deve l’annessione della regione dell’Amur. Era intelligentissimo, molto attivo, straordinariamente amabile e desideroso di lavorare per il bene del paese. Come tutti gli uomini d’azione della scuola governativa, in fondo al cuore era un despota, ma aveva idee avanzate e una repubblica democratica non gli sarebbe del tutto dispiaciuta. Era riuscito a liberarsi in misura considerevole del vecchio tipo degli impiegati civili, che consideravano la Siberia un campo da saccheggiare, e si era raccolto intorno un certo numero di giovani impiegati molto onesti, alcuni dei quali animati dalle sue stesse ottime intenzioni. Nel suo studio i giovani ufficiali, con l’esiliato Bakunin fra di loro (fuggì dalla Siberia nell’autunno del 1861), discutevano la possibilità di creare gli Stati Uniti della Siberia, federati attraverso il Pacifico agli Stati Uniti d’America. Quando arrivai a Irkutsk, la capitale della Siberia orientale, l’ondata di reazione che avevo visto salire a Pietroburgo non aveva ancor raggiunto questi lontani domini. Fui ricevuto molto bene dal giovane governatore generale Korzakov, che era proprio allora succeduto a Muravëv, e che mi disse di essere ben contento di aver con sé un uomo di opinioni liberali. Quanto al comandante dello Stato maggiore, Kukel, un giovane generale di non più di trentacinque anni del quale diventai l’aiutante di campo personale, mi condusse in una stanza in casa sua dove trovai, insieme alle migliori riviste russe, una collezione completa delle opere di Herzen edite dal comitato rivoluzionario di Londra. Diventammo subito buoni amici.
Il generale Kukel occupava allora, provvisoriamente, il posto di governatore della Transbaikalia e alcune settimane dopo attraversammo lo splendido lago Bajkal e andammo all’estremità orientale della provincia, alla capitale, la piccola città di čita. Mi diedi qui anima e corpo, senza perder tempo, alle grandi riforme che erano allora in discussione. I ministri da Pietroburgo avevano fatto appello alle autorità, chiedendo loro di presentare uno schema di riforma completa dell’amministrazione della provincia, l’organizzazione della polizia, dei tribunali, delle prigioni, del sistema d’esilio, del governo autonomo delle comunità cittadine, tutto fondato sui princìpi liberali espressi dall’imperatore nel suo manifesto.
Kukel, aiutato da un uomo intelligente ed esperto, il colonnello Pedašenko, e da due ufficiali civili pieni di buona volontà, lavorava tutto il giorno e spesso anche una parte della notte. Diventai segretario di due comitati per la riforma delle prigioni e di tutto il sistema dell’esilio e per preparare uno schema di governo municipale autonomo, e mi accinsi al lavoro con tutto l’entusiasmo di un giovane di diciannove anni. Lessi molto sulla storia di queste istituzioni in Russia e sulle loro condizioni odierne all’estero; eccellenti libri sull’argomento erano stati pubblicati dai ministri dell’Interno e della Giustizia; ma la nostra opera in Transbaikalia non si limitò alla teoria. Discussi dapprima le linee generali e in seguito punto per punto ogni particolare con uomini sperimentati, bene al corrente dei reali bisogni e delle possibilità locali; e mi intrattenni a questo scopo con un numero considerevole di persone, tanto in città che nella provincia. A questo punto le conclusioni alle quali eravamo arrivati vennero di nuovo discusse con Kukel e Pedašenko; e quando ebbi esposti i risultati in forma preliminare, ogni punto fu di nuovo vagliato nei comitati. Uno di questi, che doveva preparare lo schema dell’amministrazione municipale, fu composto di cittadini di čita, eletti da tutta la popolazione, tanto liberamente quanto avrebbero potuto esserlo negli Stati Uniti. Insomma, fu un lavoro veramente serio e anche ora, ripensandoci dopo tanti anni, posso dire con assoluta sicurezza che se il governo municipale autonomo fosse stato concesso nella modesta forma in cui lo progettammo allora, le città della Siberia sarebbero molto diverse da quello che sono. Ma, come vedremo, tutto ciò rimase senza risultati pratici.
Non ci mancavano altri lavori particolari. Si doveva trovare il denaro necessario per sostenere le istituzioni di carità; si redasse una descrizione economica delle province in occasione di un’esposizione locale di agricoltura e si fecero alcune serie inchieste. “Viviamo in una grande epoca. Lavorate, caro amico; ricordatevi che voi siete il segretario di tutti i comitati presenti e futuri”, mi diceva Kukel qualche volta: e io lavoravo con raddoppiata energia. Con quale risultato, lo dirà qualche esempio.
Nella nostra provincia funzionava un “capo-distretto”, ufficiale di polizia investito di larghi e imprecisati poteri – che era semplicemente un flagello. Derubava i contadini e li bastonava a torto e a traverso, non escluse le donne, cosa contraria alla legge; e quando un processo penale finiva nelle sue mani, lo protraeva per mesi e mesi, mentre gli imputati restavano in prigione finché non gli avessero sborsato qualche regalia. Kukel avrebbe voluto sbarazzarsi di quest’uomo già da molto tempo, ma il governatore generale non osava accettare, perché l’ufficiale aveva a Pietroburgo dei protettori potenti. Dopo molte esitazioni, finalmente fu deciso che io sarei andato a fare un’inchiesta sul posto e avrei raccolto le testimonianze a suo carico. Non era un lavoro facile, perché i contadini terrorizzati da lui e ben conoscendo il vecchio proverbio russo: “Dio è lontano, il nostro padrone sta vicino a casa nostra”, non osavano fare le deposizioni. Anche le donne che erano state frustate in principio si spaventavano all’idea di una dichiarazione scritta. Fu soltanto dopo un soggiorno di una quindicina di giorni fra i contadini che, guadagnatami la loro fiducia, potei mettere in luce i misfatti del loro capo. Raccolsi le testimonianze accusatrici ed egli dovette dimettersi. Ci felicitammo di essere riusciti a liberarci da quella peste; quale fu però la nostra sorpresa, quando alcuni mesi dopo venimmo a sapere che lo stesso individuo era stato promosso a una carica superiore nella Kamčatka! Qui avrebbe potuto derubare gli indigeni senza timore di controllo, ciò che difatti egli fece. Alcuni anni dopo ritornò ricco a Pietroburgo. Gli articoli che mandava talvolta alla stampa reazionaria erano, come ci si può immaginare, pieni di spirito patriottico.
L’onda della reazione, come ho detto, non aveva ancora raggiunto la Siberia e gli esiliati politici continuavano a essere trattati con dolcezza come al tempo di Muravëv. Quando nel 1861 il poeta [Nikolaj] Michailov, condannato ai lavori forzati per un suo proclama rivoluzionario, venne mandato in Siberia, il governatore della prima città siberiana che incontrò, Tobolsk, diede un pranzo in suo onore al quale presero parte tutti gli ufficiali. Nella Transbaikalia non fu messo ai lavori forzati, ma gli fu permesso di restare nell’ospedale di un piccolo villaggio di minatori. Poiché era molto debole di salute – era tisico e morì alcuni mesi dopo – il generale Kukel gli permise di vivere in casa di un suo fratello, un ingegnere che aveva in appalto per suo conto una miniera d’oro della Corona. Tutto questo lo si sapeva nella Siberia orientale. Ma un giorno venimmo a sapere che da Irkutsk, in seguito a una denuncia segreta, un generale della polizia di Stato era in viaggio per čita, per fare un’inchiesta rigorosa sulla faccenda.
Un aiutante di campo del governatore generale ci comunicò la notizia. Fui mandato in gran fretta ad avvisare Michailov e a dirgli che doveva ritornare all’ospedale della prigione, mentre il generale veniva trattenuto a čita. E poiché a questo signore accadde una notte di vincere una considerevole somma di denaro al gioco in casa di Kukel, egli decise di non lasciare il suo piacevole passatempo per un lungo viaggio alle miniere, con una temperatura di una dozzina di gradi sotto zero, e tornò poi a Irkutsk molto soddisfatto di una missione tanto lucrativa.
Con tutto ciò, la tempesta si avvicinava sempre più, e spazzò via ogni cosa poco dopo lo scoppio dell’insurrezione in Polonia.
Nel gennaio del 1863 la Polonia insorse contro l’oppressione della Russia. Si formarono delle bande di insorti e incominciò una guerra che durò diciotto mesi interi. I rifugiati a Londra avevano implorato il comitato rivoluzionario polacco di rimandare il movimento. Essi prevedevano che sarebbe stato schiacciato e avrebbe messo fine all’epoca delle riforme in Russia. Ma non lo si era potuto impedire. La repressione delle manifestazioni nazionaliste a Varsavia, nel 1861, e le crudeli ingiustificate esecuzioni che seguirono, esasperarono i Polacchi. Il dado era gettato.
Mai prima di allora la causa della Polonia aveva avuto tante simpatie in Russia come in quel momento. Non parlo dei rivoluzionari, ma anche in mezzo agli elementi più moderati della società russa si pensava, e si diceva apertamente, che era più utile per la Russia avere un vicino amico che un suddito ostile. La Polonia non perderà mai il suo carattere nazionale, esso è troppo forte; ha e avrà sempre una propria letteratura, la sua arte e la sua industria. La Russia può tenerla assoggettata solo con la forza e l’oppressione – una condizione di cose che finora ha favorito e favorirà necessariamente l’oppressione all’interno della Russia stessa. Anche i pacifici slavofili erano di quest’opinione; quando io ero ancora uno scolaro la società di Pietroburgo applaudiva Il Sogno che lo slavofilo Ivan Aksakov aveva il coraggio di stampare sul suo giornale, “Il Giorno”. Il suo sogno era che le truppe russe avevano sgomberato il territorio polacco, e discuteva gli eccellenti risultati che ne seguivano.
Quando scoppiò la rivoluzione nel 1863 molti ufficiali russi rifiutarono di marciare contro i Polacchi, mentre altri si schierarono apertamente con loro, e morirono gli uni e gli altri sul patibolo o sul campo di battaglia. I fondi per mantenere l’insurrezione furono raccolti in tutta la Russia – in Siberia quasi apertamente – e nelle università russe gli studenti equipaggiavano quelli dei loro colleghi che andavano a partecipare alla lotta.
Intanto, in mezzo a questa effervescenza, si divulgò in Russia la notizia che nella notte del primo gennaio alcune bande di insorti si erano gettate sui soldati, accantonati in un villaggio, e li avevano assassinati nei loro letti, benché fino alla vigilia le relazioni fra Polacchi e truppa sembrassero amichevoli. C’era in questo rapporto una certa esagerazione, ma disgraziatamente c’era anche una parte di vero e l’impressione che produsse in Russia fu disastrosa. Le vecchie antipatie fra le due nazioni, tanto consanguinee nella loro origine, ma tanto diverse nelle loro caratteristiche nazionali, si ridestarono.
Questa pessima impressione svanì gradatamente, ma non del tutto. L’eroica lotta dei figli della Polonia sempre così valorosi e l’indomabile energia con la quale essi resistevano a un esercito formidabile, conquistò ancora una volta la simpatia per questa eroica nazione. Ma si venne a sapere che il comitato rivoluzionario polacco, nelle sue richieste perché fossero ridate alla Polonia le sue antiche frontiere, vi aveva incluso la Piccola Russia, o Ucraina, la cui popolazione greco-ortodossa odiava i suoi governatori polacchi e più di una volta negli ultimi tre secoli li aveva assassinati. Oltre tutto Napoleone III incominciò a minacciare la Russia di una nuova guerra; una vana minaccia che fece più male alla Polonia di tutte le altre circostanze messe assieme. E finalmente gli elementi radicali in Russia videro con dolore che in Polonia il nazionalismo aveva preso il sopravvento, che il governo rivoluzionario non si preoccupava affatto di dare la terra ai servi – un errore del quale il governo russo non mancò di approfittare per assumere l’atteggiamento di difensore dei contadini contro i loro signori polacchi.
Quando era scoppiata la rivoluzione in Polonia, generalmente in Russia si credeva che essa avrebbe avuto un carattere democratico e repubblicano, e che la liberazione dei servi e una larga democrazia sarebbero state la prima cosa che avrebbe proclamato un governo rivoluzionario, che combatteva per l’indipendenza del paese.
La legge sull’emancipazione, quale era stata proclamata a Pietroburgo nel 1861, offriva largamente la possibilità di un’azione del genere. Gli obblighi personali dei servi verso i loro proprietari vennero a scadenza soltanto il 19 febbraio 1863. Ebbe inizio allora un processo molto lento per stabilire una specie di intesa fra i proprietari e i servi a proposito dell’estensione e dell’ubicazione degli appezzamenti che dovevano essere dati ai servi liberati. Il pagamento annuo per questi appezzamenti (sproporzionatamente alto) fu fissato dalla legge a un tanto per ettaro; ma i contadini dovevano pagare una somma in più per le loro case, e di questa somma il decreto aveva fissato solo il massimo – perché si sperava che i proprietari avrebbero trascurato questo pagamento addizionale o si sarebbero almeno accontentali di una parte sola. Così per la pretesa “redenzione” della terra. In questo caso il governo si impegnava a pagare al proprietario il primo valore in obbligazioni di Stato e i contadini che ricevevano la terra dovevano pagare in compenso per quarantanove anni il sei per cento su questa somma come interesse e rendita: non solo i pagamenti erano stravaganti e rovinosi per i contadini, ma poiché non era stata stabilita nessuna epoca per la redenzione, questa era lasciata alla buona volontà dei proprietari, e in un grandissimo numero di casi gli accordi per la redenzione non furono iniziati che dopo quasi venti anni dall’emancipazione.
Date queste condizioni un governo rivoluzionario aveva ogni opportunità di migliorare la legge russa. Era suo dovere compiere un atto di giustizia verso i contadini – le cui condizioni in Polonia erano altrettanto cattive e alcune volte peggiori che nella stessa Russia – concedendo loro l’emancipazione a condizioni migliori e meno equivoche. Ma nulla di tutto questo fu fatto. Il partito nazionalista e aristocratico prese il sopravvento nel movimento rivoluzionario e questo problema gravissimo fu dimenticato. Fu facile al governo russo guadagnarsi i contadini. Il vantaggio che si poteva trarre da questo errore risultò chiaramente quando Nikolaj Miljutin fu mandato in Polonia da Aleksandr II con la missione di liberare i contadini, così come egli intendeva fare in Russia. “Andate in Polonia, e applicate là il vostro programma russo contro i proprietari polacchi”, gli disse Aleksandr II, e Miljutin, con l’aiuto del principe čerkasskij e di vari altri, fece veramente del suo meglio per prendere la terra dalle mani dei proprietari e darne larghissimi appezzamenti ai contadini.
Conobbi una volta uno dei funzionari russi che erano stati in Polonia con Miljutin e con il principe čerkasskij. “Avevamo piena libertà di aiutare i contadini”, mi disse. “Il mio metodo di solito era di andare in un villaggio e di convocarvi l’Assemblea dei contadini. ‘Ditemi prima di tutto’, chiedevo, ‘quanta terra possedete in questo momento?’. Essi mi mostravano i campi tutto intorno. ‘È questa tutta la terra che avete sempre posseduto?’, chiedevo ancora. ‘Certo’, mi rispondevano in coro, ‘molto tempo fa queste praterie erano nostre, questo bosco pure era nostro, e quei campi appartenevano a noi’. Io lasciavo che parlassero e poi chiedevo: ‘ora, chi di voi può attestare con giuramento che questa terra e quella è stata sempre posseduta da voi?’. Naturalmente nessuno si faceva avanti, erano cose di troppo tempo prima! Finalmente qualche vecchio usciva dalla folla e gli altri dicevano: ‘Lui sa tutto di queste cose e può giurarlo’. Il vecchio cominciava allora una lunga storia di quello che ricordava di quando era giovane e di quanto aveva sentito raccontare da suo padre; ma io volevo tagliar corto… ‘Dichiarate con giuramento che cosa potete affermare essere stato proprietà della gmina (la comunità del villaggio) e la terra è vostra’. E appena aveva giurato – e si poteva avere completamente fiducia in questo giuramento – io firmavo le carte e dichiaravo all’assemblea: ‘Ora questa terra è vostra. Non avete più nessun obbligo verso i vostri antichi padroni: siete semplicemente dei loro vicini. Ciò che voi tutti dovete fare è di pagare la tassa di redenzione, un tanto all’anno, al governo. Le vostre case sono comprese nella terra: le ricevete senza altri pagamenti’”.
È facile immaginare l’effetto di una simile politica sui contadini. Un mio cugino, Pëtr Nikolaevič, fratello dell’aiutante di campo del quale ho parlato, fu in Polonia e in Lituania con il suo reggimento di ulani della Guardia. La rivoluzione era tanto grave che da Pietroburgo avevano mobilitato persino i reggimenti della Guardia; e si è poi saputo che quando Michail Muravëv ebbe ordine di andare in Lituania e andò a salutare l’imperatrice Maria, essa gli disse: “Conservate alla Russia almeno la Lituania”. La Polonia era considerata perduta.
“Le bande armate dei rivoluzionari tenevano il paese”, mi diceva mio cugino, “e noi eravamo impotenti non solo a vincerle ma anche a scovarle. Piccole bande attaccavano continuamente i nostri distaccamenti e, poiché sapevano battersi a meraviglia, conoscevano bene il paese e avevano l’appoggio delle popolazioni, sovente avevano il sopravvento nelle scaramucce. Eravamo obbligati a marciare sempre in forti colonne. Potevamo attraversare una regione, marciare attraverso un bosco senza trovare traccia di una banda; ma al nostro ritorno venivamo a sapere che le bande erano comparse dietro di noi, che avevano riscosso il tributo per il movimento patriottico nel paese, e se in un modo o nell’altro qualche contadino si era reso utile alle nostre truppe, noi li trovavamo impiccati agli alberi dalle bande rivoluzionarie. Queste condizioni durarono parecchi mesi, senza che vi fosse speranza di un miglioramento della situazione, finché venne Miljutin e liberò i contadini dando loro la terra. Allora tutto fu finito. I contadini passarono dalla nostra parte, ci aiutarono a metter le mani sulle bande e l’insurrezione ebbe fine”.
Parlai più tardi di questo argomento con dei polacchi esiliati in Siberia e alcuni di loro capivano l’errore commesso. Una rivoluzione, fin dal principio, deve essere un atto di giustizia a favore degli “umiliati e oppressi” non una promessa di fare più tardi certe riforme – altrimenti è sicura di essere schiacciata. Sfortunatamente accade spesso che i capi sono tanto preoccupati di semplici questioni di tattica militare, da dimenticare le cose principali. Essere rivoluzionari e non dare alle masse la prova che una nuova era è veramente venuta per loro, significa condurre il movimento a certa rovina.
Le conseguenze di questa insurrezione, disastrose per la Polonia, sono ben note: appartengono alla storia. Quante migliaia di uomini morirono in battaglia, quante centinaia furono impiccati, e quante ventine di migliaia furono trasportati nelle varie province della Russia e della Siberia, ancora non è stato accertato. Persino le cifre ufficiali che furono pubblicate in Russia alcuni anni dopo ammettono che nelle sole province lituane – per non parlare della Polonia propriamente detta – quell’uomo terribile che fu Michail Muravëv, al quale il governo russo ha eretto un monumento a Wilna, fece impiccare personalmente 128 polacchi e deportare in Russia e in Siberia 9433 persone fra uomini e donne. Le liste ufficiali, pure pubblicate in Russia, danno 18672 uomini e donne esiliati in Siberia dalla Polonia, e di questi 10407 furono mandati nella Siberia orientale. Ricordo che il governatore generale della Siberia orientale mi citava la stessa cifra, circa 11000 persone, condannate ai lavori forzati e esiliate nei suoi domini. Io li vidi laggiù e fui testimone delle loro sofferenze. Tutto sommato, quasi 60000 o 70000 polacchi, se non di più, furono deportati dalla Polonia e trasportati nelle varie province della Russia, negli Urali, nel Caucaso, in Siberia.
Per la Russia le conseguenze furono altrettanto disastrose. L’insurrezione polacca chiuse definitivamente il periodo delle riforme. È vero che la legge sulle autonomie provinciali (zemstva) e quella sulla riforma dei tribunali furono promulgate nel 1864 e nel 1866; ma furono redatte entrambe nel 1862 e per di più all’ultimo momento Aleksandr II diede la preferenza allo schema di governo autonomo che era stato preparato dal partito reazionario di Valuev, invece che a quello presentato da Nikolaj Miljutin, e immediatamente dopo la promulgazione delle due riforme la loro efficacia fu attenuata e, in alcuni casi, annullata dai decreti e dai regolamenti.
Peggio di tutto questo fu il passo indietro compiuto dall’opinione pubblica. L’eroe del momento era Kaktov, il capo del partito sostenitore della servitù, che apparve ora come un “patriota” e trascinò con sé una gran parte delle società di Mosca e di Pietroburgo. Da quel momento tutti quelli che osavano parlare di riforme venivano subito classificati da Kaktov come “traditori della Russia”.
Ben presto la furia della reazione raggiunse anche le nostre lontane province. Un giorno di marzo venne portata una lettera da Irkutsk da un messaggero speciale. Era l’intimazione al generale Kukel di abbandonare il posto di governatore della Transbaikalia e di andare a Irkutsk per aspettarvi gli ordini che sarebbero seguiti, senza riprendere il posto di comandante dello Stato maggiore.
Perché? Cosa significava tutto questo? Non vi era una parola di spiegazione. Neppure il governatore generale, un amico personale di Kukel, aveva osato aggiungere una sola parola a quell’ordine misterioso. Voleva forse dire che Kukel stava per essere condotto, fra due gendarmi, a Pietroburgo per esservi murato in quell’enorme tomba di pietra, la fortezza di San Pietro e Paolo? Tutto era possibile. Più tardi sapemmo che questa era veramente l’intenzione; e questa sarebbe stata la sua sorte se il conte Nicolaj Muravëv, “il vincitore dell’Amur”, non fosse energicamente intervenuto implorando personalmente lo Zar di risparmiare a Kukel questo destino.
La separazione da Kukel e dalla sua simpatica famiglia fu ben triste! Non solo in lui io perdevo un amico, ma sentivo anche che quella partenza segnava la fine di tutta un’epoca, piena di speranze lungamente accarezzate, “piena di illusioni”, come si soleva dire.
Fu così. Arrivò un nuovo governatore – un buon uomo che voleva essere lasciato tranquillo a tutti i costi. Con rinnovata energia, vedendo che non vi era tempo da perdere, completai il nostro piano di riforme del sistema di esilio e di governo municipale autonomo. Il governatore mosse qualche obiezione qui e là, per la forma, ma finalmente il progetto fu firmato e mandato al quartier maggiore. Ma a Pietroburgo le riforme non si volevano più. Là i nostri progetti giacquero in pace, in compagnia di cento altri giunti da tutte le parti della Russia. Nella capitale furono costruite alcune prigioni “migliorate”, anche più terribili di quelle vecchie, per essere mostrate agli stranieri di riguardo durante il Congresso delle discipline carcerarie, ma il resto, come l’antico sistema di esilio, fu trovato da George Kennan nel 1886 nello stesso stato in cui le lasciai nel 1862. Ora soltanto, dopo trentasei anni, le autorità hanno accettato la riforma dei tribunali e una parodia di governo autonomo in Siberia e alcune commissioni sono state nominate per compiere un’inchiesta sul sistema del confino.
Quando [George] Kennan tornò a Londra dal suo viaggio in Siberia, egli cercò di mettersi subito in rapporto con Stepniak, čajkovskij e altri rifugiati russi. Ci incontrammo una sera nella stanza di Kennan, in un piccolo albergo vicino a Charing Cross. Lo vedevamo per la prima volta, e non avendo eccessiva fiducia negli inglesi in cerca di avventure, che prima di lui si erano incaricati di sapere tutto sulle prigioni siberiane, senza sapere una parola di russo, incominciammo a interrogare Kennan. Con nostra grande sorpresa, non solo egli parlava benissimo il russo, ma conosceva tutto il conoscibile sulla Siberia. Conoscevamo, fra tutti, molti esiliati e assediammo Kennan di domande. Dov’è il tale? È ammogliato? È felice nel suo nuovo stato? È sempre su di morale? Ci persuademmo ben presto che Kennan sapeva tutto di ognuno di loro.
Quando la nostra conversazione fu finita e mentre ci preparavamo a partire, io domandai: “Signor Kennan, non sapete se sia stata finalmente costruita la torre per i pompieri a čita?”. Stepniak mi guardò, come per rimproverarmi di abusare della bontà di Kennan; ma questi si mise a ridere, e io pure, e ridendo ci scambiavamo domande e risposte. “Allora sapete questa storia?”. “E anche voi?”. “È costruita?”. “Sì, dopo una stima doppia del valore” – e così via, finché Stepniak intervenne e con tono burberamente bonario ci disse: “Spiegatevi dunque, cosa c’è di così divertente in questa faccenda?”. E Kennan raccontò allora la storia della torre, che i suoi lettori ricorderanno. Nel 1859 la città di čita chiese di costruire una stazione di pompieri e raccolse il denaro necessario; ma il preventivo della spesa doveva essere mandato al ministro degli Interni. Fu dunque mandato a Pietroburgo; ma quando due anni dopo ritornò debitamente approvato, tutti i prezzi del legno e della mano d’opera erano cresciuti con l’aumentare dell’importanza della giovane città. Questo accadeva nel 1862, quando io ero a čita. Nuove perizie furono mandate a Pietroburgo e la storia si ripeté per venticinque anni di seguito, finché alla fine la popolazione di čita, persa la pazienza, deliberò di raddoppiare i prezzi della stima. Questo conto fantastico fu preso solennemente in considerazione a Pietroburgo, e approvato. Fu così che čita poté avere una stazione di pompieri.
È stato detto che Aleksandr II commise un grave errore e preparò la propria rovina suscitando tante speranze che poi non soddisfece. Si può vedere da quello che ho raccontato – e la storia della piccola čita è la storia di tutta la Russia – dove fece ancora peggio. Egli non suscitò soltanto speranze, cedendo per un momento alla corrente dell’opinione pubblica intorno a lui, ma incitò uomini da tutte le parti della Russia a lavorare per uscire dal dominio delle speranze e dei sogni, a toccar con mano quanto le riforme fossero necessarie. Egli li mise in condizione di sapere quello che si poteva fare immediatamente e quanto fosse facile farlo; li indusse a sacrificare quella parte dei loro ideali che non poteva essere realizzata immediatamente e a chiedere ciò che era praticamente possibile in quel momento; dopo che essi ebbero dato ordine alle loro idee e le ebbero tradotte in leggi che richiedevano solo la sua firma per diventare realtà, egli rifiutò questa firma. Nessun reazionario avrebbe potuto farsi avanti per affermare che le istituzioni esistenti – i tribunali non riformati, la mancanza di un governo municipale o il sistema del confino – fossero buone e meritassero di essere mantenute: nessuno ha osato dire questo. Eppure, per la paura di fare qualche cosa tutto è stato lasciato com’era; durante trentacinque anni quelli che osavano parlare della necessità di un cambiamento sono stati trattati come “sospetti” e istituzioni unanimamente riconosciute cattive possono continuare a esistere soltanto perché non si vuole sentire la aborrita parola di “riforma”.
Vedendo che a čita non era possibile far nulla in favore delle riforme, accettai ben volentieri l’offerta di visitare l’Amur nella stessa estate del 1863.
L’immenso dominio sulla riva sinistra, settentrionale, dell’Amur e lungo le coste del Pacifico, che giunge a Sud fino alla baia di Pietro il Grande (Vladivostock), era stato annesso alla Russia per opera del conte Muravëv, quasi contro la volontà delle autorità di Pietroburgo e certo senza molto aiuto da parte di loro. Quando egli concepì il piano audace di prendere possesso del grande fiume il cui territorio fertile e esposto a mezzogiorno aveva attirato le popolazioni della Siberia durante gli ultimi duecento anni, e quando, agli albori dell’apertura del Giappone all’Europa, egli decise di impadronirsi per la Russia di una forte posizione sulle coste del Pacifico e di congiungersi così agli Stati Uniti, egli ebbe quasi tutti contro a Pietroburgo: il ministro della guerra, che non aveva uomini disponibili a questo scopo; il ministro delle finanze, che non aveva denaro per nuove annessioni; e soprattutto il ministro degli esteri, unicamente ispirato dalle sue preoccupazioni di evitare “complicazioni diplomatiche”. Muravëv dovette dunque agire sotto la propria responsabilità, servendosi unicamente dei pochi mezzi che la Siberia orientale, scarsamente popolata, offriva per questa impresa. Per di più tutto dovette essere fatto rapidamente, per opporre il “fatto compiuto” alle proteste dei diplomatici dell’Europa occidentale, che non sarebbero certo mancate.
Un’occupazione nominale non sarebbe servita a nulla e si pensò di fondare per l’intera lunghezza del fiume e del suo tributario meridionale, l’Ussuri, cioè per duemilacinquecento miglia, una catena di colonie libere, e di stabilire quindi delle comunicazioni regolari fra la Siberia e le coste del Pacifico. Furono richiesti degli uomini per queste colonie, e poiché la scarsa popolazione della Siberia orientale non poteva provvederli, Muravëv non indietreggiò neppure di fronte ai sistemi più irregolari. Galeotti liberati, che dopo aver espiato la loro pena erano diventati servi delle miniere orientali, furono liberati e organizzati come Cosacchi transbaikaliani, una parte dei quali fu sistemata lungo l’Amur e l’Ussuri, formando così due nuove comunità cosacche. Muravëv ottenne poi il rilascio di un migliaio di condannati ai lavori forzati (per lo più ladri e assassini) che furono mandati come uomini liberi sul basso Amur. Egli stesso andò ad assistere alla loro partenza e quando stavano per andarsene, parlò loro dalla riva: “Andate, figlioli miei, siete liberi, coltivate la terra, rendete russo questo suolo, fate che sorga qui una nuova vita”, e così via.
Le contadine russe seguono quasi sempre – di loro spontanea volontà – i loro uomini quando questi vengono mandati in Siberia ai lavori forzati, e parecchi di questi aspiranti coloni avevano con sé le proprie famiglie; ma quelli che non ne avevano, fecero osservare a Muravëv: “Che cos’è un contadino senza la moglie? Noi vogliamo essere ammogliati”. Subito Muravëv ordinò la liberazione delle donne che erano sul posto, condannate ai lavori forzati, circa un centinaio, e offrì loro di scegliersi l’uomo che volevano per marito e di seguirlo. Vi era però poco tempo da perdere; il fiume scendeva rapidamente, le zattere dovevano mettersi in cammino e Muravëv, comandando a tutti di disporsi a coppie sulla riva, li benedì dicendo: “Io vi sposo, figlioli, vogliatevi bene; voi uomini non maltrattate le vostre mogli e siate felici”.
Vidi queste colonie circa sei anni dopo che si era svolta questa scena. I loro villaggi erano poveri, la terra su cui si erano stabiliti aveva dovuto essere liberata dalla foresta vergine; ma, tutto compreso, quella colonizzazione non era stata un errore e “i matrimoni alla Muravëv” non erano meno felici di tanti altri. Quell’uomo intelligente che era Innocenzo, vescovo dell’Amur, più tardi riconobbe come legali questi matrimoni, e appena i bambini furono nati li iscrisse nei registri della chiesa.
Muravëv fu meno fortunato nella creazione di un’altra colonia, che aggiunse alla popolazione della Siberia orientale. Non potendo procurarsi uomini altrimenti, aveva accettato circa duemila soldati delle compagnie di disciplina. Questi furono incorporati come “figli adottivi” nelle famiglie cosacche, oppure furono sistemati in casamenti annessi ai villaggi. Ma dieci o venti anni di vita di caserma sotto l’orribile disciplina di Nicola I non erano certo la preparazione migliore alla vita dell’agricoltore. I “figli” abbandonarono i loro padri adottivi e costituirono la popolazione fluttuante delle città, vivendo di carità o lavorando saltuariamente, spendendo al gioco tutto il loro guadagno e vivendo a caso, come gli uccelli del cielo, in attesa di un altro lavoro.
La folla variopinta di Cosacchi transbaikaliani, di ex galeotti e di “figli” che erano stati stabiliti affrettatamente, a casaccio, lungo le rive dell’Amur, non era certo in grado di raggiungere la prosperità, soprattutto nella parte inferiore del fiume e sull’Ussuri, dove ogni metro quadrato doveva spesso essere strappato a una foresta vergine tropicale, dove le piogge torrenziali portate dai monsoni di luglio, le inondazioni disastrose, i milioni di uccelli migratori e altri malanni del genere distruggevano continuamente le messi, piombando popolazioni intere nella disperazione e nell’apatia.
Ogni anno è necessario mandare considerevoli provviste di sale, farina, carne conservata e altri generi, sia per aiutare le truppe regolari quanto le colonie del basso Amur e si erano costruiti a questo scopo circa centocinquanta bacini, ancorati a čita, per scendere poi con l’inondazione primaverile l’Ingoda, il Šilka e l’Amur. Tutta la flottiglia era divisa in distaccamenti di venti o trenta barconi, agli ordini di un certo numero di Cosacchi e di ufficiali civili. Io fui nominato aiutante del capo di tutta questa flottiglia, un certo maggiore Marovskij.
La mia prima esperienza nella mia nuova qualità di navigatore fu tutt’altro che fortunata. Dovevo affrettarmi ad andare con le mie barche fino a un certo punto dell’Amur, dove dovevo consegnarle a un altro, e ingaggiai a questo scopo degli uomini adatti, scelti fra quei “figli” dei quali ho parlato. Nessuno di loro era pratico di navigazione fluviale e io nemmeno. La mattina della partenza la mia ciurma fu racimolata qua e là per la città, e la maggior parte era tanto ubriaca a quell’ora mattutina, che bisognava tuffarli nel fiume perché tornassero in sé.
Quando fummo imbarcati dovetti insegnar loro tutto quello che dovevano fare. Le cose tuttavia andarono abbastanza bene durante la giornata; i barconi scendevano il fiume trascinati dalla corrente veloce e la mia ciurma, per poco disposta che fosse, non aveva nessun interesse a spingerli a riva – cosa che avrebbe richiesto un certo sforzo. Ma quando venne la sera e il nostro enorme carico, del peso di cinquanta tonnellate, fu portato a riva e assicurato per la notte, uno dei barconi che era più avanti di quello su cui mi trovavo si fermò bordeggiando, proprio sopra una roccia, ai piedi di una terribile rupe. Là rimase immobile, mentre il livello del fiume, temporaneamente ingrossato dalle piogge, diminuiva rapidamente. Evidentemente i miei dieci uomini non lo potevano muovere. Remai quindi fino al villaggio vicino per chieder aiuto ai Cosacchi e contemporaneamente mandai un messaggero a un mio amico – un ufficiale cosacco che stava a circa venti miglia di distanza e che era pratico di cose di questo genere.
Venne la mattina e un centinaio di Cosacchi – uomini e donne – erano arrivati per aiutarmi, ma non vi era nessun mezzo di rimettere a galla la barca e riportarla a riva, tanto l’acqua era profonda sotto la rupe. E quando provammo a spingerla fuori dalle rocce il fondo si aprì e l’acqua vi entrò liberamente, inzuppando la farina e il sale del carico. Pieno d’orrore vedevo entrare dalla falla dei pesciolini che guizzavano tranquillamente nel barcone, mentre io me ne stavo completamente disperato, non sapendo più che cosa fare. Vi è un rimedio molto semplice e molto efficace, in simili casi. Un sacco di farina bianca ficcato attraverso la fessura ne prende immediatamente tutto lo spazio e l’ottura, mentre la crosta di pasta che si forma all’interno impedisce all’acqua di entrare; ma nessuno di noi lo conosceva. Un poco più tardi finalmente fu segnalata una barca che scendeva il fiume verso di noi. L’apparizione del cigno che porta Lohengrin non fu salutata da Elsa disperata con ardore maggiore di quello con cui salutammo noi quell’umile imbarcazione! Le dense nebbie che coprono il bellissimo Šilka a quella ora del mattino davano un fascino anche maggiore alla poetica visione. Era il mio amico, l’ufficiale cosacco, che aveva capito dalla mia descrizione che nessuna forza umana avrebbe potuto disincagliare il mio barcone – il quale quindi era perduto – e preso un altro barcone vuoto, che aveva per fortuna a disposizione, veniva con quello per mettervi il carico del mio, ormai condannato. La falla fu riparata, l’acqua pompata e il carico trasportato sul nuovo battello, che era stato posto vicino al mio: e il giorno dopo potei continuare il mio viaggio. Imparai molto da questa piccola disavventura e senza altri incidenti notevoli potei raggiungere la mia destinazione sull’Amur. Trovavamo ogni sera un tratto di spiaggia ripida ma molto bassa, dove potevamo fermare la barca per passare la notte e accendevamo i nostri fuochi sulla riva del fiume rapido e limpido, in mezzo a uno dei più grandiosi scenari di montagne.
Durante il giorno sarebbe difficile immaginare delle ore più piacevoli di quelle passate a bordo di un battello che naviga pigramente, senza nessuno degli inconvenienti del vapore. Si ebbero solo un paio di volte degli urti causati dalla grande poppa, per mantenerlo in mezzo alla corrente. Per chi ama la natura, la parte bassa del Šilka e la parte superiore dell’Amur, dove si vede uno dei fiumi più belli, larghi e rapidi, che corre fra montagne scoscese coperte di boschi, alte circa duemila piedi sul livello del fiume, offrono uno dei più piacevoli spettacoli del mondo. Ma per queste stesse ragioni le comunicazioni lungo la spiaggia a cavallo, su di un sentiero, sono estremamente difficili. Ne feci l’esperienza a mie spese l’autunno stesso. Nella Siberia orientale le ultime sette stazioni lungo il Šilka (circa 120 miglia) sono conosciute come i sette peccati capitali. Questo tratto della ferrovia transiberiana – se sarà mai costruito – costerà un’incredibile somma di denaro, molto più di quel tratto della ferrovia Canada-Pacifico che attraversa le Montagne Rocciose nel canyon del fiume Fraser.
Dopo aver consegnato i miei battelli discesi l’Amur per quasi mille miglia su una delle navi postali che fanno servizio su quel fiume. Sulla poppa della nave vi è una baracca e a prua una cassa di terra sulla quale si trova il fuoco per far la cucina. La mia ciurma era composta di tre uomini. Bisognava affrettarsi e avevamo quindi l’abitudine di remare a turno tutto il giorno, mentre la notte si lasciava che la nave seguisse la corrente e io vigilavo per tre o quattro ore per tenerla in mezzo al fiume e impedire che fosse portata verso qualche tributario. Queste veglie – con la luna piena splendente nel cielo e le montagne scure che si specchiavano nel fiume – erano straordinariamente belle.
I miei rematori erano scelti fra quei “figli” dei quali ho parlato. Erano tre vagabondi e si diceva fossero ladri e briganti incorreggibili – e io avevo con me un grosso sacco pieno di biglietti di banca, e soldi di argento e di rame. Nell’Europa occidentale un viaggio simile su un fiume solitario sarebbe stato pericoloso, ma non lo era nella Siberia orientale: io lo feci senza avere neppure una vecchia pistola, e i miei tre vagabondi furono un’ottima compagnia. Soltanto quando ci avvicinammo a Blagoveščensk si mostrarono inquieti.
“La Chanšina (l’acquavite cinese) costa poco laggiù”, dicevano sospirando. “Ci troveremo certo nei pasticci. Costa poco e va subito alla testa quando non se ne beve da un po’ di tempo!”. Proposi che lasciassero il denaro che dovevano ricevere nelle mani di un amico, che li avrebbe fatti imbarcare con il primo vapore. “Non servirebbe a salvarci”, rispondevano melanconicamente, “qualcuno ci offrirà da bere… costa poco e un bicchiere basta per diventar brilli”, continuavano a dire. Erano turbati davvero e quando alcuni mesi dopo ripassai di là mi fu detto che uno dei “miei figli” – come li chiamavano in città – si era davvero trovato in un imbroglio. Dopo aver venduto le sue ultime scarpe per comperare quel liquido pernicioso, aveva commesso un furto e si era fatto mettere in carcere. Finalmente il mio amico riuscì a farlo liberare e lo rispedì indietro.
Solo quelli che hanno visto l’Amur o che conoscono il Mississippi o lo Yang Tze Kiang possono farsi un’idea della immensità dell’Amur dopo che si è congiunto con il Sungari e possono immaginare le enormi ondate che si infrangono sulle rive quando è in tempesta. Quando viene la stagione delle piogge in luglio, dopo i monsoni, il Sungari, l’Ussuri e l’Amur sono gonfi di incredibili quantità di acqua; migliaia di isolotti, coperti di solito di giunchi e di salici sono sommersi e portati via e il fiume in certi punti raggiunge una larghezza di due, tre e anche cinque miglia. L’acqua irrompe in centinaia di torrenti e di laghi che si stendono nelle basse pianure lungo il corso principale, e quando dall’Est soffia un vento un po’ forte contro corrente, enormi ondate, più alte di quelle che si vedono all’imboccatura del San Lorenzo, risalgono il braccio principale e anche i tributari. Peggio ancora quando soffia un tifone dal Mar Cinese sul territorio dell’Amur.
Ci trovammo appunto in uno di questi tifoni. Ero allora a bordo di una nave dal ponte coperto, assieme al maggiore Marovskij che avevo incontrato a Blagoveščensk. Egli aveva fatto mettere le vele alla nave, così si poteva navigare con il vento e quando si scatenò la tempesta riuscimmo a condurre la nostra imbarcazione verso la sponda più riparata del fiume e ci rifugiammo in un piccolo affluente. Là ci fermammo per due giorni, mentre la tempesta infuriava a un punto tale che quando volli avventurarmi per qualche centinaio di metri nella foresta vicina, dovetti ritornare a causa degli alberi enormi che il vento abbatteva tutto intorno a me. Incominciammo a preoccuparci per i nostri barconi. Era certo che se si trovavano sul fiume quella mattina non avrebbero mai potuto raggiungere il lato riparato, anzi sarebbero stati spinti dalla tempesta sulla riva più esposta alla furia del vento e là senza dubbio si sarebbero sfasciati. Un disastro era quasi inevitabile.
Appena la furia della tempesta si fu un poco calmata, ci mettemmo a vogare. Sapevamo di dover incontrare presto delle flottiglie di barche, ma navigammo uno, due giorni senza incontrarne traccia. Il mio amico Marovskij perdette il sonno e l’appetito a un punto tale che pareva uscito allora da una grave malattia. Stava ore e ore seduto immobile sul ponte, mormorando: “Tutto è perduto, tutto è perduto!”. Su quel tratto dell’Amur i villaggi sono pochi, distanti l’uno dall’altro e nessuno ci poteva dare notizie. Sopravvenne una nuova tempesta e quando finalmente si arrivò a un villaggio, ci dissero che di là non era passata nessuna imbarcazione, e che il giorno prima si era vista una quantità di relitti scendere il fiume alla deriva. Non vi era più dubbio che almeno quaranta barconi, con un carico di circa 2000 tonnellate, erano andati perduti. La primavera seguente non sarebbe stato possibile evitare la carestia lungo il basso Amur se non si arrivava in tempo a portare delle provviste. La stagione era già avanzata, la navigazione sarebbe presto diventata impossibile e lungo il fiume non esisteva ancora il telegrafo.
Si tenne consiglio e fu deciso che Marovskij sarebbe sceso il più presto possibile sino alla foce dell’Amur. Io dovevo intanto risalire il più velocemente possibile il fiume, stabilire quale fosse l’entità del disastro e affrettarmi quindi a fare le duemila miglia dell’Amur e del Shilka, in barca, a cavallo o su un vaporetto, se avessi avuto la fortuna di incontrarne uno. Più presto fossi riuscito ad avvisare le autorità di čita e a spedire tutte le provviste possibili, meglio sarebbe stato. Forse una parte avrebbe potuto arrivare quell’autunno stesso sull’Amur superiore, e di là sarebbe stato più facile in primavera imbarcarle per la pianura. Il vantaggio anche solo di pochi giorni avrebbe significato molto in caso di carestia.
Incominciai le mie 2000 miglia di viaggio in una barca a remi, cambiando rematori ogni venti miglia circa, a ogni villaggio. Si procedeva molto lentamente, ma potevamo anche non incontrare un vaporetto prima di una quindicina di giorni e io potevo intanto arrivare dove i barconi erano naufragati e vedere se si era riusciti a salvare qualche cosa delle provviste. Poi forse alla foce dell’Ussuri (Khabarovsk) avrei trovato un vaporetto. Nei villaggi trovai delle pessime barche e il tempo continuava a essere burrascoso. Ci tenevamo sempre vicini alla riva, ma bisognava attraversare certe ramificazioni dell’Amur, grandissime, e le ondate, spinte dal vento impetuoso minacciavano di sommergere la mia barchetta. Un giorno si dovette attraversare un braccio dell’Amur largo quasi mezzo miglio. Le onde furiose si alzavano come montagne. I miei rematori, due contadini, furono presi dal panico; i loro visi erano bianchi come panni lavati, le loro labbra livide tremavano, mormoravano preghiere. Solo un ragazzo di quindici anni che stava al timone si mantenne calmo, scrutando le acque. Egli strisciava fra le onde quando si abbassavano un momento intorno a noi, e quando le vedeva alzarsi davanti alla barca minacciose, sterzava leggermente, conducendola in mezzo alle onde. Ogni ondata inondava la barca e io buttavo fuori l’acqua con una vecchia ciotola, osservando come si accumulasse più presto di quanto io ne potessi versare via. A un certo punto la barca era così piena di acqua, che a un segnale fattomi da uno dei rematori esterrefatti gettai via il pesante sacco pieno di monete di argento e di rame che portavo sempre con me. Per vari giorni di seguito dovetti affrontare traversate del genere. Non forzavo mai gli uomini a fare la traversata, fin quando loro stessi, sapendo quanta fretta avessi, non si decidevano a tentarla. “Non ci sono sette morti in una vita”, dicevano, “e a una non si può scappare”. E facendosi il segno della croce si mettevano a remare con tutte le loro forze.
Dopo non molto giunsi sul luogo del disastro. Quarantadue barconi erano stati rovinati dalla tempesta. Era stato impossibile scaricarli e del carico ben poco era stato salvato. Duemila tonnellate di farina erano perdute nell’acqua.
Proseguii il mio viaggio con questa triste notizia. Alcuni giorni dopo un vaporetto che risaliva il fiume a passo d’uomo mi raggiunse e quando mi imbarcai come passeggero, mi dissero che il capitano aveva tanto bevuto che in un eccesso di delirio si era buttato nel fiume. L’avevano però ripescato, e ora era nella sua cabina, a letto ammalato. Mi pregarono di prendere il comando del vaporetto e dovetti accettare; ma ben presto con mia grande sorpresa mi accorsi che tutto procedeva per proprio conto con tale regolarità, che benché passassi tutto il giorno sul ponte non avevo quasi niente da fare. Tranne alcuni momenti di vera responsabilità, quando si doveva approdare per caricare la legna, e salvo alcune parole che dicevo ogni tanto per incoraggiare i fuochisti a mettersi al lavoro appena l’alba ci permetteva di scorgere i contorni delle rive, tutto procedeva da sé, e richiedeva ben poco da parte mia. Un pilota che avesse saputo capire la carta topografica se la sarebbe sbrigata altrettanto bene.
Arrivai finalmente in Transbaikalia, dopo aver viaggiato un po’ con il vaporetto e un bel po’ a cavallo. Ero sempre oppresso dall’idea che una carestia potesse infierire la primavera seguente sul basso Amur. Trovai che il piccolo vapore sul quale mi ero imbarcato non risaliva abbastanza rapidamente il veloce Šilka e per guadagnare una ventina di ore o anche meno lo lasciai, e percorsi a cavallo insieme a un cosacco circa duecento miglia lungo l’Argun, una delle vie più aspre delle montagne siberiane, fermandomi per accendere il fuoco del bivacco solo quando la mezzanotte mi sorprendeva nella foresta. Eppure le dieci o venti ore che potevo così guadagnare non erano da disprezzare, perché ogni giorno si avvicinava l’epoca in cui la navigazione sarebbe stata impossibile: già di notte si formava il ghiaccio sul fiume. Incontrai finalmente il governatore della Transbaikalia e un amico mio, il colonnello Pedašenko, sul Šilka, allo stabilimento penale di Kara, e questo ultimo si incaricò di far subito imbarcare le provviste di cui poteva disporre. Io ripartii immediatamente per fare il rapporto a Irkutsk di quanto era avvenuto.
A Irkutsk la gente si meravigliava che avessi potuto fare un viaggio tanto lungo così in fretta, ma ero proprio sfinito. La gioventù però sa rimettersi ben presto, e io mi ristabilii dormendo, per un certo tempo, tante ore al giorno, che mi vergognerei di confessarlo.
“Vi siete riposato?”, mi chiese il governatore generale una settimana dopo il mio arrivo. “Potreste ripartire domani per Pietroburgo, come corriere, per fare personalmente il rapporto sulla perdita delle barche?”.
Questo voleva dire fare in venti giorni – non uno di più – altre tremila duecento miglia da Irkutsk a Nijni Novgorod, dove avrei potuto prendere il treno fino a Pietroburgo, galoppando giorno e notte con cavalli di posta che bisognava cambiare a ogni stazione, perché nessuna vettura avrebbe potuto resistere a un viaggio simile, fatto a tutta velocità lungo le vie gelate dell’autunno. Ma l’idea di vedere mio fratello Aleksandr mi tentava troppo perché rifiutassi, e partii l’indomani sera. Quando arrivai alle pianure della Siberia occidentale e agli Urali il viaggio diventò un vero supplizio. Vi erano giorni in cui le ruote della carrozza si spezzavano a ogni stazione sui solchi della strada. I fiumi gelavano e dovetti attraversare l’Ob’ in una barca in mezzo al ghiaccio galleggiante che minacciava tutti i momenti di schiacciare la nostra fragile imbarcazione. Quando arrivai al fiume Tom’, dove il ghiaccio si era consolidato solo la notte precedente, da principio i contadini si rifiutarono di fare la traversata, pregandomi di dare loro una “ricevuta”.
“Ma che ricevuta volete?”.
“Scrivete sopra un foglio: ‘Io sottoscritto dichiaro che fui affogato per volontà di Dio e non per colpa dei contadini’, e poi ci date questo foglio”.
“Con piacere, ma quando saremo sull’altra riva”.
Finalmente si decisero ad accompagnarmi. Un ragazzo – un giovane coraggioso e intelligente che avevo scelto in mezzo alla folla – si mise in testa alla spedizione provando con un’asta la resistenza del ghiaccio. Io lo seguivo, portando sulle spalle la borsa dei miei documenti, e noi due eravamo legati a due lunghe redini che cinque contadini reggevano, seguendoci a distanza e portando ognuno un fascio di paglia da gettare sul ghiaccio quando non sembrava abbastanza resistente.
Finalmente arrivai a Mosca, dove mio fratello mi venne incontro alla stazione, e con lui proseguii subito per Pietroburgo.
Che bella cosa la gioventù! Dopo un viaggio simile, durato ventiquattro giorni e ventiquattro notti, quando di buon mattino arrivai a Pietroburgo andai subito a consegnare i miei dispacci e non mancai neppure di far visita a una zia – o piuttosto a una cugina – che abitava a Pietroburgo. Era raggiante. “Abbiamo un ballo questa sera. Volete venire?”, mi disse. Certo che volevo! E non soltanto andai, ma ballai fino al mattino tardi.
Quando arrivai a Pietroburgo e vidi le autorità capii perché mi avessero mandato a fare il rapporto. Nessuno voleva credere alla possibilità della distruzione di tanti barconi.
“Siete stato sul posto? Avete visto il disastro con i vostri occhi? Siete proprio certo che ‘loro’ non hanno semplicemente rubato le provviste e che non vi hanno poi fatto vedere un naufragio qualsiasi?”, queste le domande a cui dovevo rispondere.
Gli altri impiegati preposti agli affari della Siberia a Pietroburgo erano semplicemente meravigliosi nella loro ingenua ignoranza di tutto quanto riguardava la Siberia.
“Mais mon cher”, mi disse uno – parlava sempre in francese – “come è possibile che quaranta barconi vengano distrutti sulla Neva senza che qualcuno si sia slanciato a salvarli?”. “La Neva?”, esclamai. “Mettete tre, quattro Neva una accanto all’altra e avrete il basso Amur!”.
“Ma davvero è così grande?” e due minuti più tardi chiacchierava in eccellente francese del più e del meno.
“Quando avete visto Schwartz, il pittore? Non è vero che il suo Ivan il Terribile è un quadro meraviglioso! Sapete perché volevano arrestare Kukel? Sapevate che černyševskij è stato arrestato? Ora è in fortezza”.
“Perché? Che cosa ha fatto?”, domandai.
“Nulla, nulla di speciale! Ma, mon cher, ragioni di Stato! Un uomo così intelligente, tanto intelligente! E ha tanta influenza sulla gioventù! Capirete, un governo non può tollerarlo, è impossibile! Intolérable, mon cher, dans un état bien ordonné!”
Il conte Ignat’ev non fece domande simili; conosceva bene l’Amur e conosceva anche Pietroburgo. Fra scherzi e battute di ogni genere e osservazioni argute sulla Siberia, fatte con una vivacità sorprendente, mi disse: “È una fortuna che vi siate trovato sul posto e abbiate assistito al naufragio. E ‘loro’ hanno avuto il buon senso di mandarvi a fare rapporto! Molto ben fatto! Sulle prime nessuno voleva credere alla storia del naufragio. Si pensava a un nuovo imbroglio. Ma mi si dice ora che voi eravate ben noto come paggio e che siete in Siberia solo da pochi mesi, e non vi incarichereste quindi di salvare dei disonesti. Si fidano di voi”.
Il ministro della guerra, Dimitrij Miljutin, fu il solo delle autorità di Pietroburgo a considerare la cosa seriamente. Mi fece molte domande e tutte sensate. Si rese subito conto del problema che si doveva risolvere e tutta la nostra conversazione fu fatta di brevi frasi, senza fretta ma anche senza parole inutili. “Le colonie lungo la costa devono essere approvvigionate dal mare, dite? Solo le altre da čita? Va bene. Ma se l’anno venturo viene un’altra tempesta, vi sarà ancora una simile distruzione?”. “No se si provvedesse a due piccoli rimorchiatori per le barche”. “Così andrebbe bene? Basterebbe?”. “Sì, anche con un solo rimorchiatore la perdita non sarebbe stata tanto grave”. “È molto probabile. Scrivetemi, vi prego; esponete tutto quello che mi avete detto, con chiarezza, senza formalità”.
Non mi fermai a lungo a Pietroburgo e tornai a Irkutsk l’inverno stesso. Mio fratello mi doveva raggiungere dopo pochi mesi: era stato nominato ufficiale dei Cosacchi dell’Irkutsk.
Si pensa di solito che un viaggio d’inverno attraverso la Siberia sia un terribile supplizio; ma tutto sommato lo si fa più comodamente in questa stagione che in qualunque altra dell’anno. Le strade coperte di neve sono eccellenti e benché il freddo sia spaventoso, lo si sopporta benissimo. Disteso in tutta la lunghezza della slitta – come si usa in Siberia – avvolto in coperte di pelliccia, pelliccia di fuori e pelliccia di dentro, non si soffre molto il freddo neppure quando la temperatura raggiunge i 30 o 40 gradi sotto zero. Viaggiando come corrieri postali, cambiando cioè rapidamente i cavalli a ogni stazione e fermandomi solo una volta al giorno per un pasto, arrivai a Irkutsk diciannove giorni dopo la mia partenza da Pietroburgo. In questi casi la media della velocità è di duecento miglia al giorno, e ricordo che feci le ultime seicento sessanta miglia che mi separavano da Irkutsk in settanta ore. Il freddo non era intenso, le strade in buonissimo stato, i cocchieri erano sempre di buon umore grazie a una generosa distribuzione di monete d’argento, e il traino di tre piccoli cavalli leggeri sembrava rallegrarsi di trottare veloce attraverso colline e valli, attraverso fiumi gelati, duri come l’acciaio, in mezzo a foreste risplendenti sotto i raggi del sole nella loro veste d’argento.
Ero ormai nominato addetto al governatore generale della Siberia orientale e dovevo stabilirmi a Irkutsk, ma c’era poco da fare. La parola d’ordine da Pietroburgo era che tutto procedesse senza mutamenti, senza che si accennasse a riforme. Accettai quindi con entusiasmo la proposta di fare un viaggio di esplorazione geografica nella Manciuria.
Uno sguardo alla carta dell’Asia mostra la frontiera russa che segue press’a poco il cinquantesimo meridiano per piegare improvvisamente a Nord della Transbaikalia. Per trecento miglia segue il fiume Argun’, poi, raggiunto l’Amur, volge a Sud-est; la città di Blagoveščensk, che fu la capitale del territorio dell’Amur, si trova quasi alla stessa latitudine di cinquanta gradi. La distanza dall’angolo Sud-est della Transbaikalia (Nuova Tsurukaitu) e Blagoveščensk sull’Amur è di sole cinquecento miglia, ma seguendo l’Argun’ e l’Amur è di più di mille miglia, senza contare che le comunicazioni lungo l’Argun’, che non è navigabile, sono difficilissime. Verso la foce non vi è altro che una strada di montagna in rovina e quasi impraticabile.
La Transbaikalia è ricchissima di bestiame e i Cosacchi che ne abitano la zona a Sud-est, ricchi allevatori, volevano stabilire delle comunicazioni dirette con l’Amur centrale, dove pensavano di trovare un buon mercato per il loro bestiame. Commerciavano con i Mongoli e da loro avevano sentito dire che non sarebbe stato difficile raggiungere l’Amur viaggiando verso Oriente, attraverso il Grande Khingan. Avevano saputo che andando diritto verso Oriente si doveva trovare una vecchia strada cinese che attraversa il Khingan, e conduce alla città manciuriana di Merghen (sul fiume Non ni [Nen Chiang], affluente del Sungari) dalla quale una ottima strada conduce all’Amur centrale.
Mi fu offerto il comando di una carovana mercantile che i Cosacchi organizzavano per trovare quella strada, e io accettai con entusiasmo. Nessun europeo aveva mai visitato quella regione e un topografo russo che pochi anni prima si era spinto in quella zona, era stato ucciso. Soltanto due gesuiti, all’epoca dell’imperatore Kan-si, erano penetrati dal Sud fino a Merghen e ne avevano calcolata la latitudine. Tutta l’immensa regione a Nord di quella città, larga cinquecento miglia e profonda altrettanto, era completamente, assolutamente sconosciuta. Consultai tutti i più competenti su quella regione. Nessuno, neppure i geografi cinesi ne sapevano qualche cosa. Inoltre anche il solo fatto di poter mettere in comunicazione l’Amur centrale con la Transbaikalia aveva una certa importanza: Tsurukaitu sarà fra non molto il capolinea della ferrovia transmanciuriana. Eravamo dunque i pionieri di quella grande impresa.
Vi era però una difficoltà. Il trattato con la Cina concedeva libertà di commercio ai Russi con “l’Impero della Cina e la Mongolia”. La Manciuria non era nominata e poteva considerarsi sia inclusa che esclusa dal trattato. Le autorità della frontiera cinese lo interpretavano in un senso, quelle russe in un altro. Inoltre, poiché non si parlava che di commercio, non sarebbe stato permesso a un ufficiale entrare in Manciuria. Dovetti dunque andare come un mercante, e comperai perciò a Irkutsk diversa mercanzia e mi travestii da mercante. Il governatore generale mi diede un passaporto per “il mercante della seconda gilda di Irkutsk, Pëtr Alekseev e i suoi compagni”, e mi avvisò che se le autorità cinesi mi avessero arrestato e portato a Pechino, e di là attraverso il Gobi alla frontiera russa – in una gabbia sul dorso di un cammello, come usavano trasportare i prigionieri attraverso la Mongolia – non avrei dovuto tradirlo rivelando il mio nome. Accettai naturalmente tutte le condizioni; il desiderio di visitare un paese che nessun europeo aveva mai visto era troppo grande perché un esploratore resistesse alla tentazione.
Non era facile nascondere la mia identità nella Transbaikalia. I Cosacchi sono un popolo terribilmente curioso – veri Mongoli – e appena uno straniero arriva in uno dei loro villaggi lo trattano con la più grande ospitalità, ma il padrone di casa gli fa subire un interrogatorio interminabile.
“Un viaggio noioso no?”, incomincia. “È una strada lunga da čita, non è vero? E poi forse più lungo ancora, per uno che viene da più lontano di čita. Forse da Irkutsk? Se non mi sbaglio commerciante laggiù? Molti mercanti passano di qui. Andrete anche a Nerčinsk? Spesso si è già ammogliati alla vostra età; e anche voi avete lasciato a casa una famiglia? Molti figli? Tutti maschi?”, e così via per almeno una mezz’ora.
Il comandante dei Cosacchi del posto, il capitano Buxhövden, conosceva la sua gente e avevamo quindi preso le nostre precauzioni. A čita e a Irkutsk recitavamo spesso in un teatro di filodrammatici, scegliendo di preferenza i drammi di Ostrovskij, nei quali l’azione si svolge quasi sempre nell’ambiente dei mercanti. Io avevo partecipato a parecchie recite; mi divertivo tanto che una volta avevo persino scritto una lettera entusiasta a mio fratello confessandogli il mio appassionato desiderio di abbandonare la carriera militare per dedicarmi al teatro. Recitavo di solito la parte di giovane mercante; avevo imparato perfettamente il loro modo di parlare, di gesticolare e di bere il tè nel piattino – conoscevo questi modi fin dalle mie esperienze di Nikolskoje – e ora mi si offriva l’occasione di ripetere la commedia nella vita reale per uno scopo utile.
“Accomodatevi, Pëtr Alekseevič”, mi diceva il capitano Buxhövden quando si portava in tavola il samovar bollente, dal quale si alzavano nuvole di vapore.
“Grazie, possiamo stare qui”, rispondevo, sedendomi sull’orlo della sedia a una certa distanza e incominciando a sorseggiare il mio tè alla maniera di un mercante di Mosca. Buxhövden intanto scoppiava quasi dalle risa, mentre io soffiavo sul piattino, con gli occhi spalancati, e rosicchiavo in un certo modo particolare minuscole particelle da una zolletta di zucchero che doveva durarmi per una mezza dozzina di tazze.
Sapevamo che i Cosacchi non avrebbero messo molto tempo a scoprire la verità sul mio conto, ma l’importante era di guadagnare qualche giorno e attraversare la frontiera prima che la mia identità fosse stata scoperta. Devo aver recitato bene la mia parte, perché i Cosacchi mi trattavano come un piccolo mercante. In un villaggio una vecchia mi chiamò e mi disse: “Ci sono altre persone che fanno la strada dietro di voi, mio caro?”. “Nessuno, nonna, per quanto ne sappiamo noi”. “Dicevano che un principe, Rapotskij, doveva venire. Verrà?”. “Oh, capisco, avete ragione, nonna. Sua altezza aveva intenzione di partire anche lui da Irkutsk. Ma come potrebbe farlo? Un viaggio simile! Non è adatto per persone come lui. Così è rimasto indietro”. “Naturalmente, come potrebbe farlo?”.
Insomma, attraversammo la frontiera senza essere disturbati. Eravamo undici Cosacchi, un tungo e io, tutti a cavallo. Avevamo con noi circa quaranta cavalli da vendere e due carri uno dei quali, a due ruote, mi apparteneva e conteneva panno, velluto, galloni d’oro, e così via, che portavo con me nella mia qualità di mercante. Di quello e dei miei cavalli mi occupavo esclusivamente io, e scegliemmo uno dei Cosacchi per essere “l’anziano” della carovana. Era incaricato di tutte le conversazioni diplomatiche con le autorità cinesi. Tutti i Cosacchi parlavano la lingua mongola e il tungo capiva il manciuriano. I Cosacchi della nostra carovana naturalmente sapevano chi ero – uno di loro mi aveva conosciuto a Irkutsk – ma non mi tradirono mai; capivano che da questo dipendeva la buona riuscita della spedizione. Io indossavo un lungo abito di cotonina azzurra come gli altri e i Cinesi non badarono a me, così che, senza attirare la loro attenzione potei prendere misure esatte della strada. Solo il primo giorno, quando soldati cinesi di ogni specie indugiarono con noi nella speranza di ottenere un bicchiere di whisky, dovetti spesso rinunciare agli strumenti di misurazione e accontentarmi di calcolare le distanze senza togliermi il foglio di tasca. Non avevamo con noi armi di nessun genere. Solo il tungo, che si doveva sposare, aveva con sé il suo fucile e l’adoperava per dar la caccia ai cervi; ci portava la carne per la cena e si faceva una raccolta di pellicce con le quali contava di pagare la sua futura moglie.
Quando videro che non vi era più speranza di avere whisky, i soldati cinesi ci lasciarono in pace. Continuammo diritti verso Oriente, aprendoci come meglio potevamo una strada attraverso valli e colline, e dopo una marcia di quattro o cinque giorni riprendemmo la strada cinese che ci doveva condurre attraverso il Khingan a Merghen.
Con nostra grande sorpresa ci accorgemmo che la traversata della grande catena di monti che pareva così incerta e difficile sulla carta, era invece facilissima. Raggiungemmo per strada un vecchio miserabile impiegato cinese che percorreva la stessa via su di un carrettino a due ruote. Gli ultimi due giorni la strada fu in salita e il paesaggio ne rivelava la grande altitudine. Il terreno era paludoso e la strada fangosa; l’erba era stentata, gli alberi radi e scarni, spesso rattrappiti e ricoperti di lichene. A destra e a sinistra si levavano montagne rocciose e spoglie e già pensavamo alle difficoltà che avremmo dovuto affrontare per attraversare la catena, quando vedemmo il vecchio impiegato cinese scendere dal suo carrettino davanti a un obo – cioè davanti ad un mucchio di sassi e di rami ai quali erano stati attaccati dei fagottini di crine di cavallo e di straccetti. Egli levò dalla criniera del suo cavallo diversi peli e li attaccò ai rami.
“Che cosa è quello?”, chiedemmo.
“L’obo: le acque davanti a noi corrono all’Amur”.
“È questo tutto il Khingan?”.
“Sì. Ora non vi sono più montagne da attraversare fino all’Amur, soltanto colline!”.
Per la nostra carovana fu una vera emozione. “I fiumi corrono all’Amur, all’Amur!”, si gridavano i Cosacchi. Fin dall’infanzia avevano sentito parlare dai vecchi Cosacchi della vallata del grande fiume, dove la vite cresce selvaggia, dove le praterie si stendono per centinaia di miglia, pronte a dare ricchezza a migliaia di uomini; poi, dopo che l’Amur fu annesso alla Russia, sentirono parlare del lungo viaggio per arrivarci, delle difficoltà dei primi coloni e del benessere dei loro parenti che si erano stabiliti sull’Amur superiore. E ora avevano scoperto una strada così breve per arrivarvi! Davanti a noi si stendeva un declivio ripido lungo il quale la strada scendeva tortuosa, fino a un torrente che si spingeva in mezzo a un mare di montagne fino all’Amur. Ormai non vi erano ostacoli fra noi e il grande fiume. Un viaggiatore potrà immaginare la mia gioia nel fare questa inattesa scoperta geografica. Quanto ai Cosacchi, si affrettarono a scendere da cavallo e ad attaccare a loro volta fagotti di crine di cavallo ai rami buttati sull’obo. Tutti i Siberiani hanno una specie di paurosa venerazione per le divinità pagane. Non ne hanno un gran rispetto, ma dicono che questi dèi sono esseri malefici, desiderosi di fare il male, e non è mai bene trovarsi in cattivi rapporti con loro. Molto meglio guadagnarseli con piccole prove di rispetto.
“Guarda, ecco un albero straniero; deve essere una quercia”, esclamavano scendendo il ripido declivio. Non se ne trovavano prima di aver raggiunto il versante orientale dell’altipiano. “Guarda un noce!”, esclamavano poi. “Che albero sarà quello?”, dicevano vedendo un tiglio o qualche altro albero che non cresce neppure in Russia, ma che sapevo appartenere alla flora manciuriana. Questi uomini del nord, che da secoli sognavano una terra più aprica e che finalmente la vedevano, ne erano incantati. Si buttavano in terra, in mezzo all’erba folta, la carezzavano con gli occhi, l’avrebbero baciata. Ora ardevano dal desiderio di raggiungere l’Amur al più presto. Quando, quindici giorni dopo, ci fermammo per l’ultima volta al fuoco del bivacco a una ventina di miglia dal fiume, erano impazienti come ragazzi. Sellarono i cavalli poco dopo la mezzanotte e si affrettarono a partire molto prima dell’alba: e quando finalmente da un’altura scorgemmo il fiume possente, gli occhi di questi impassibili Siberiani, di solito incapaci di sentimento poetico, scintillavano di gioia guardando le acque turchine del maestoso Amur. Era evidente che presto o tardi, con o senza l’aiuto, o anche contro i desideri del governo russo, le rive di questo fiume, ora deserte ma ricche di promesse, così come le enormi distese spopolate della Manciuria settentrionale, sarebbero state invase da coloni russi, come le rive del Mississippi furono colonizzate dai voyageurs canadesi.
Nel frattempo il vecchio impiegato cinese mezzo cieco, con il quale avevamo fatto la traversata del Khingan, dopo aver indossata una giacca blu e un cappello da ufficiale sormontato da un bottone di cristallo, ci dichiarò l’indomani mattina che non poteva permetterci di andare più avanti. Il nostro “anziano” lo aveva ricevuto nella nostra tenda insieme al suo segretario, e il vecchio, ripetendo le difficoltà che gli suggeriva quest’ultimo, sollevava mille difficoltà per non lasciarci procedere. Avrebbe voluto che ci accampassimo là, aspettando che egli spedisse il nostro passaporto a Pechino e ne ricevesse istruzioni, ma noi rifiutammo recisamente. Allora trovò a ridire sul nostro passaporto.
“Che passaporto è mai questo?”, diceva, guardandolo con disprezzo. Erano poche righe su di un comune foglio di carta protocollo, in lingua russa e mongola, e portava un semplice sigillo di ceralacca. “Avreste potuto scriverlo voi stessi e sigillarlo con una moneta”, osservava. “Guardate il mio: questo, ha valore”, e ci spiegò davanti un foglio di carta lungo mezzo metro, coperto di caratteri cinesi.
Me ne stavo in silenzio in disparte durante questo colloquio, imballando qualche cosa nella mia cassa, quando mi venne sotto mano un foglio della “Gazzetta di Mosca”. La “Gazzetta”, essendo proprietà dell’università di Mosca, portava un’aquila nell’intestazione. “Fategli vedere questo”, dissi al nostro “anziano”. Egli spiegò il voluminoso foglio stampato e mostrò l’aquila. “Quel passaporto lì era da far vedere a voi”, disse l’anziano, “ma ecco quello che abbiamo per noi”.
“Come, è tutto scritto per voi?”, chiese il vecchio con terrore.
“Tutto per noi”, rispose l’“anziano” con sicurezza.
Il vecchio, un vero impiegato di Stato, era tutto confuso nel vedere uno scritto tanto voluminoso. Ci scrutò tutti, annuendo con il capo. Ma il segretario insisteva nel sussurrare al suo capo, il quale finì con il dichiarare che non poteva permetterci di proseguire.
“Basta con le chiacchiere”, dissi all’“anziano”. Detti ordine di sellare i cavalli. I Cosacchi erano dello stesso parere e in un batter d’occhio la nostra carovana si mise in cammino, dopo aver salutato il vecchio impiegato e avergli promesso di dichiarare che – salvo il ricorrere alla forza, cosa che non poteva fare – egli aveva fatto di tutto per impedire la nostra entrata nella Manciuria, e che era colpa nostra se, malgrado tutto, avevamo proseguito per la nostra strada.
Pochi giorni dopo eravamo a Merghen, dove si commerciò un poco, e presto arrivammo alla città cinese di Argun, sulla riva destra dell’Amur, mentre la città russa di Blagoveščensk è sulla riva sinistra. Avevamo scoperto la strada diretta e molte altre cose interessanti: il tipo di catena di frontiera del Gran Khingan, la facilità con la quale si può attraversarlo, i vulcani terziari della regione del Uyun Koldontsi, che da un pezzo costituivano un enigma per la letteratura geografica, e altro ancora. Non posso dire di aver dato prova di abilità come mercante, perché a Merghen insistei, nel mio cinese scorretto, a chiedere trentacinque rubli per un orologio, quando il compratore cinese me ne aveva già offerto quarantacinque, ma i Cosacchi fecero buoni affari. Vendettero bene tutti i loro cavalli e quando anche i miei, le mie mercanzie e tutto quanto furono venduti dai Cosacchi, risultò che, tutto compreso, la spedizione era costata al governo la modesta somma di ventidue rubli, poco più di due sterline.
Tutta quell’estate viaggiai sull’Amur. Scesi fino alla foce – Nicolaevsk – dove raggiunsi il governatore generale che accompagnai in piroscafo sull’Ussuri e più tardi, in autunno, feci un viaggio anche più interessante, risalendo il Sungari, arrivando al centro della Manciuria a Chi Lin (o Kirin secondo la pronuncia mancese).
Molti fiumi dell’Asia sono formati dalla congiunzione di due affluenti di uguale importanza, così che riesce difficile al geografo dire quale dei due è il fiume e quale il confluente. L’Ingoda e l’Onon si congiungono per formare il Šilka; il Šilka e l’Argun’ si congiungono per formare l’Amur, e l’Amur si congiunge al Sungari per formare quel fiume imponente che corre verso sud-est e si butta nel Pacifico alla latitudine inospitale dello stretto di Tartaria.
Fino al 1864 il grande fiume della Manciuria era quasi sconosciuto. Le informazioni che se ne avevano risalivano all’epoca dei primi missionari gesuiti ed erano molto scarse. Ora che si riprendeva l’esplorazione della Mongolia e della Manciuria e che la paura della Cina, che fino allora aveva prevalso in Russia, pareva esagerata, tutti noi giovani insistevamo presso il governatore generale sulla necessità di esplorare il Sungari. Ci irritava l’avere vicino all’Amur una vasta regione che ci era ignota, quasi quanto un deserto africano. Improvvisamente quell’autunno il generale Kusohov si decise a spedire un piroscafo per risalire il Sungari con il pretesto di portare una dichiarazione di amicizia al governatore generale della provincia di Chi lin. Il console russo di Urga doveva portare il messaggio. Un medico, un astronomo, due topografi ed io, tutti agli ordini del colonnello černaev, dovevamo partecipare alla spedizione, imbarcati sul vaporetto Ussuri che rimorchiava una barca carica di carbone. Venticinque soldati, le cui carabine erano nascoste in mezzo al carbone, ci accompagnavano stando sulla barca.
Tutto fu organizzato in fretta e il vaporetto non era adatto a ospitare tante persone; ma eravamo pieni di entusiasmo e ci sistemammo alla meglio nelle piccole cabine. Uno di noi dormiva su una tavola e ci accorgemmo dopo la partenza che non avevamo neppure coltelli e forchette a sufficienza, senza parlare di altre cose necessarie. Qualcuno si serviva del temperino a pranzo e il mio coltello cinese con due stecche di avorio fu un contributo non spregevole al nostro equipaggiamento.
Non era un compito facile risalire il Sungari. Il grande fiume, nel suo corso inferiore, quando scorre attraverso le stesse pianure attraversate dall’Amur, è poco profondo e benché il nostro vaporetto non pescasse più di un metro di acqua, spesso ci capitava di non poter trovare il punto dove tentare il passaggio. In certi giorni non si arrivava a percorrere più di una quarantina di miglia e spesso la chiglia toccava il letto sabbioso del fiume. Spessissimo dovevamo mandare avanti una barca a remi per cercare dove vi fosse la profondità necessaria. Ma il nostro giovane capitano si era proposto di arrivare a Chi lin quell’autunno e ogni giorno si andava avanti. A misura che ci inoltravamo, trovavamo il fiume sempre più bello e la navigazione più facile, e quando furono superate le distese di sabbia dove esso si congiunge con il Non ni, la navigazione diventò facile e piacevole. In poche settimane arrivammo alla capitale di quella provincia della Manciuria. I topografi tracciarono una buonissima carta del fiume.
Disgraziatamente non vi era tempo da perdere e sbarcammo ben di rado in qualche villaggio o città. Lungo il fiume i villaggi sono rari e nella sua parte inferiore non trovammo altro che pianure, che ogni anno vengono inondate. Più su navigammo per un centinaio di miglia in mezzo a rupi sabbiose. Solo quando arrivammo al Sungari superiore e ci avvicinammo a Chi lin trovammo una popolazione numerosa.
Se il nostro scopo fosse stato quello di stabilire dei rapporti amichevoli con la Manciuria – invece di essere quello di esplorare il Sungari – avremmo dovuto considerare fallita la nostra spedizione. Le autorità della Manciuria ricordavano ancora che otto anni prima la “visita” fatta da Muravëv era finita con l’annessione dell’Amur e dello Ussuri, e non potevano far a meno di dubitare di questi nuovi e inaspettati visitatori. Le venticinque carabine nascoste nel carbone, delle quali le autorità cinesi erano state debitamente avvertite prima della nostra partenza, raddoppiavano i loro sospetti; e quando la nostra imbarcazione gettò l’ancora davanti alla popolosa città di Chi lin, trovammo tutti i suoi mercanti armati di spade rugginose dissotterrate in qualche vecchio cascinale. Non ci fu impedito di girare per le strade, ma tutti i negozi si chiusero quando sbarcammo e non fu permesso ai mercanti di venderci nulla. Furono mandate in dono al vapore delle provviste, ma non accettarono denaro in compenso.
L’autunno si avvicinava alla fine, incominciava già a far freddo e dovemmo affrettarci a ritornare, essendo impossibile passare l’inverno sul Sungari. Insomma, visitammo Chi lin ma non parlammo ad anima viva, salvo ai due interpreti che ogni mattina venivano a bordo del nostro vaporetto. Il nostro scopo però era stato raggiunto.
Avevamo provato che il fiume era navigabile e ne avevamo tracciato una carta precisa dalla foce fino a Chi lin, con l’aiuto della quale ci fu possibile al ritorno navigare a tutta velocità senza incidenti. Solo una volta il nostro vaporetto si incagliò. Ma le autorità di Chi lin, desiderose soprattutto di evitare che noi dovessimo passare l’inverno sul fiume, ci mandarono duecento cinesi che ci aiutarono a liberare il battello. Ricordo di essere sceso anch’io nell’acqua, di aver aiutato a spingerlo con i cinesi e di aver intonata la canzone dei nostri barcaioli Dubinuška, che aiuta con il suo ritmo a dare tutti insieme la spinta necessaria nello stesso momento. I cinesi si divertirono molto e dopo parecchie di queste spinte il vaporetto non tardò ad essere rimesso a galla. Dopo questo piccolo incidente rapporti più amichevoli prevalsero fra noi e i cinesi, intendendo cinesi del popolo, che sembravano detestare gli arroganti funzionari manciuriani.
Ci fermammo in parecchi villaggi abitati da esiliati del Celeste Impero e fummo accolti con la più schietta cordialità. Di una sera soprattutto mi resta il ricordo. Una densa folla di un centinaio di cinesi mi circondò, e benché io non sapessi una sillaba della loro lingua, né loro della mia, discorrevamo amichevolmente con l’aiuto della mimica e ci capivamo benissimo. Battere la mano sulla spalla in segno di amicizia è certo un linguaggio internazionale. Offrirsi mutualmente il tabacco e porgersi il fuoco, è anche essa una nuova prova internazionale di amicizia. Una cosa li interessava – che io, benché ancor giovane, portassi la barba. Essi non la portano mai prima della sessantina. E quando, a gesti, dissi loro che in caso di fame me la potevo mangiare, si raccontarono la barzelletta dall’uno all’altro, in tutta la folla. Ridevano di cuore e mi accarezzavano la spalla più gentilmente di prima. Mi condussero a spasso facendomi vedere le loro case, ognuno mi offerse la pipa e tutta la folla mi accompagnò, come se fossi stato un amico, fino al battello.
Devo dire che in quel villaggio non vi era neppure un “boško” (poliziotto). Negli altri villaggi i nostri soldati e gli ufficiali giovani fraternizzavano sempre con i Cinesi, ma appena appariva un “boško” tutto era finito. D’altra parte bisognava vedere le smorfie che essi facevano alle spalle del “boško”: era evidente che odiavano quei rappresentanti dell’autorità.
In seguito la nostra spedizione è stata dimenticata. L’astronomo T. Usoltzev e io ne pubblicammo il resoconto nelle memorie della Società Geografica siberiana; ma pochi anni dopo un grande incendio a Irkutsk distrusse tutti gli esemplari rimasti delle memorie, compresa la carta originale del Sungari e fu solo l’anno scorso, quando si iniziò la costruzione della ferrovia transmanciuriana, che i geografi russi disseppellirono i nostri rapporti e trovarono che il grande fiume era stato esplorato trentacinque anni prima!
Visto che non si parlava più di riforme, cercai di fare l’unica cosa che sembrasse possibile, date le circostanze – solo per convincermi dell’assoluta vanità di sforzi del genere. Nella mia nuova qualità di addetto al governatorato generale per gli affari dei Cosacchi, feci un’inchiesta rigorosa sulle condizioni economiche dei Cosacchi dell’Ussuri; essi perdevano tutti gli anni il raccolto, così che ogni inverno il governo doveva rifornirli per evitare una carestia. Quando ritornai dall’Ussuri con il mio rapporto ebbi rallegramenti da tutti, fui promosso e mi furono dati premi speciali. Tutti i provvedimenti che consigliavo furono accettati, furono concesse speciali concessioni in denaro per aiutare gli uni a emigrare, per fornire bestiame agli altri, secondo le mie proposte. Ma la realizzazione di queste misure fu affidata a qualche ubriacone, che sperperava il denaro e fustigava spietatamente i disgraziati Cosacchi, per vedere di farne dei buoni agricoltori. Era quello che succedeva dappertutto, dal Palazzo d’Inverno a Pietroburgo fino all’Ussuri e alla Kamčatka.
L’amministrazione superiore della Siberia era ispirata a buonissime intenzioni, e devo ripetere che, tutto considerato, era molto migliore, più illuminata, si interessava di più al benessere del popolo, dell’amministrazione di qualsiasi altra provincia della Russia. Ma era un’amministrazione – un ramo dell’albero che aveva le sue radici a Pietroburgo, e bastava questo per paralizzare tutte le sue ottime intenzioni, bastava per far sì che si interponesse e soffocasse ogni iniziativa, ogni vita e ogni progetto autonomo. Qualunque cosa si intraprendesse da parte degli abitanti per il bene del paese, destava sospetto e doveva subito arenarsi fra mille difficoltà, che provenivano non tanto da cattiva volontà degli amministratori, quanto dal fatto che quei funzionari appartenevano a un’amministrazione centralizzata e burocratica. Il solo appartenere a un governo che si irradiava da una capitale tanto lontana, faceva che essi considerassero ogni cosa dal punto di vista di funzionari governativi, si chiedessero anzitutto che cosa avrebbero detto i loro superiori e che effetto avrebbe avuto questo o quello sul meccanismo amministrativo. Gli interessi del paese passavano in seconda linea.
A poco a poco mi dedicai sempre più alle esplorazioni scientifiche. Nel 1865 esplorai i Monti Saiani occidentali dove feci nuove osservazioni sulla struttura degli altipiani siberiani e scoprii un’altra regione vulcanica lungo la frontiera cinese; e l’anno seguente poi intrapresi un lungo viaggio per trovare una via di comunicazione diretta tra le miniere d’oro della provincia di Jakutsk (sul Vitim e l’Olekma) e la Transbaikalia. Per molti anni i membri della spedizione siberiana (1860-1864) avevano cercato questa strada e avevano tentato di attraversare quella serie di alture parallele, selvagge e rocciose, che separano quelle miniere dalle pianure della Transbaikalia; ma quando, arrivando dal Sud, giungevano a quella desolata regione montagnosa e si vedevano davanti quelle melanconiche montagne che si stendevano verso il Nord per centinaia di miglia, tutti gli esploratori, salvo uno che fu ucciso dagli indigeni, erano tornati a Sud. Evidentemente per riuscire la spedizione doveva partire dal Nord e andare verso Mezzogiorno, dal deserto desolato e sconosciuto verso le regioni più note e popolate. Accadde anche che, mentre mi preparavo alla spedizione, mi mostrassero una carta tracciata da un tungo con la punta del coltello sulla corteccia di un albero. Questa piccola carta, luminoso esempio dell’utilità del senso di orientamento delle civiltà più primitive, che avrebbe più tardi interessato G. R. Wallace, mi diede una tale impressione di esattezza che me ne fidai completamente e incominciai il mio viaggio dal Nord, seguendo le sue indicazioni.
Accompagnato da un giovane e promettente naturalista, Polakov, e da un topografo, risalii prima il Lena fino alle miniere d’oro nel Settentrione. Là preparammo la spedizione approvvigionandoci per tre mesi e partimmo per il Sud. Un vecchio cacciatore jakuto, che vent’anni prima aveva una volta seguito la strada tracciata sulla carta dal tungo, si offri di farci da guida per attraversare la regione montana, larga 250 miglia, seguendo le vallate e le gole indicate dal tungo col suo coltello sulla pianta di scorza di betulla. E compii davvero quella straordinaria prova, benché non vi fosse alcuna pista di nessun genere da seguire e benché tutte le vallate, viste dalla cima dei monti, tutte ugualmente coperte di foreste, sembrassero assolutamente uguali a un occhio inesperto. Questa volta il passaggio fu scoperto. Girammo per tre mesi attraverso il deserto alpestre e lungo l’altipiano paludoso quasi completamente disabitato, finché arrivammo alla nostra meta, čita. Mi si dice che ora quel passaggio serve per condurre il bestiame dal Sud fino alle miniere d’oro; quanto a me il viaggio mi fu più tardi immensamente utile per risolvere l’enigma della struttura delle montagne e degli altipiani della Siberia; ma non sto scrivendo un libro di viaggi e interrompo qui il mio racconto.
Gli anni che passai in Siberia mi insegnarono molte cose che avrei potuto difficilmente imparare altrove. Mi convinsi ben presto dell’assoluta impossibilità di fare qualche cosa di veramente utile per il popolo servendosi del meccanismo amministrativo. Mi liberai per sempre di quella illusione. Incominciai poi a capire non solo gli uomini e la natura umana, ma anche gli intimi moventi della vita della società. Il lavoro costruttivo delle masse ignorate, di cui così poco si parla nei libri e l’importanza di quel lavoro costruttivo nello sviluppo delle forme sociali, mi si delineò con chiarezza. Vedere per esempio come le comunità dei Duchobory (i fratelli di coloro che ora si stabiliscono nel Canada e che sono stati tanto bene accolti dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti) migrarono nella regione dell’Amur; vedere gli immensi vantaggi che trassero dalla loro organizzazione fraterna semicomunista, e constatare il successo della loro colonizzazione in mezzo ai tanti fallimenti della colonizzazione di Stato, fu una lezione che avrei cercato inutilmente nei libri. E poi, vivere con gli indigeni, osservare in atto le forme complesse di organizzazione sociale che essi hanno elaborato lontano dall’influenza di qualsiasi civiltà, era fare provvista di una luce che avrebbe poi rischiarato i miei studi futuri. La parte che hanno le masse anonime in ogni avvenimento storico importante, persino nella guerra, mi fu rivelata da osservazioni fatte sul vero, e mi formai delle convinzioni simili a quelle espresse da Tolstoj nella sua opera monumentale, Guerra e pace, sui capi e sulle masse.
Educato in una famiglia di possessori di servi, come tutti i giovani del mio tempo fui abituato a pensare alla necessità di comandare, dare ordini, rimproverare, punire. Ma quando al principio della mia carriera dovetti dirigere imprese importanti e trattare con gli uomini, quando ogni errore avrebbe potuto avere serie conseguenze, incominciai ad apprezzare tutta la differenza che vi è fra l’azione fondata sull’autorità e la disciplina e quella fondata sul principio del mutuo accordo. La prima dà ottimi risultati in una parata militare, ma non vale niente quando si tratta della vita reale e quando lo scopo può solo essere raggiunto per mezzo dello sforzo costante di molte volontà convergenti. Benché allora non formulassi le mie osservazioni nei termini della lotta politica, posso dire che in Siberia persi tutta la fiducia che avevo avuto fino a quel momento nella disciplina dello Stato. Ero già pronto a diventare un anarchico.
Dai diciannove ai venticinque anni dovetti elaborare importanti schemi di riforme, trattare con centinaia di uomini sull’Amur, organizzare ed eseguire, con mezzi irrisori, missioni, spedizioni pericolose e così via; e se condussi a buon fine tutte queste imprese fu perché avevo capito ben presto che nel lavoro serio il comandare e la disciplina servono a ben poco. Vi è bisogno dappertutto di uomini che abbiano dell’iniziativa; ma una volta dato l’impulso l’impresa, soprattutto in Russia, dovrà essere condotta non con criteri militari, ma con mezzi comunitari, fondati sul mutuo accordo. Vorrei che tutti quelli che vanno elaborando sistemi di disciplina di Stato, prima di formulare le loro utopie autoritarie potessero allenarsi alla scuola della vera vita; allora si sentirebbe parlare molto meno dei sistemi di società a base militare e a forma di piramide.
Con tutto ciò la vita in Siberia mi piaceva sempre meno, quantunque mio fratello Aleksandr mi avesse raggiunto nel 1864 a Irkutsk, dove comandava uno squadrone di Cosacchi. Eravamo felici di essere insieme; leggemmo molto e discutemmo tutti i problemi filosofici, scientifici e sociali del momento; ma tutti e due anelavamo alla vera vita intellettuale, e questa in Siberia non si trovava. L’arrivo fortuito a Irkutsk di Raphael Pumpelly e di Adolf Bastian, i soli scienziati che visitarono la nostra capitale durante la mia permanenza laggiù, fu un vero avvenimento per noi due. La vita scientifica e specialmente quella politica dell’Europa occidentale, della quale avevamo notizia dai giornali, ci attirava e il ritorno in Russia formava continuamente argomento delle nostre conversazioni. La rivolta degli esiliati polacchi nel 1866, infine, ci rivelò tutta la falsità della nostra posizione come ufficiali dell’esercito russo.
Mi trovavo lontano, nelle montagne del Vitim, quando alcuni esuli polacchi, occupati ad aprire una nuova strada attraverso le rupi che circondano il lago Bajkal, fecero uno sforzo disperato per rompere le loro catene e fuggire in Cina attraverso la Mongolia. Furono mandati i soldati contro di loro e un ufficiale russo fu ucciso dagli insorti. Io lo seppi al mio ritorno a Irkutsk, dove una cinquantina di polacchi dovevano comparire davanti alla corte marziale. Dato che le sedute dei tribunali militari sono aperte al pubblico, assistetti a questo processo e ne presi delle note particolareggiate per un giornale di Pietroburgo, che le stampò per intero, con gran dispetto del governatore generale.
Undicimila polacchi, uomini e donne, erano stati deportati nella Siberia orientale dopo l’insurrezione del 1863. Erano soprattutto studenti, artisti, ex ufficiali, nobili e artigiani abili dell’intelligente e progredita popolazione di Varsavia e delle altre città. Un gran numero di questi erano stati messi ai lavori forzati, mentre altri erano sparsi per tutto il paese, in villaggi dove non potevano trovare lavoro e dove vivevano in uno stato che confinava con la miseria più assoluta. Quelli che erano stati condannati ai lavori forzati lavoravano a čita, costruendo le barche per l’Amur – erano i più fortunati – o nelle fonderie di rame della Corona, o alle saline. Io vidi alcuni di questi ultimi sul Lena, mezzi nudi in una baracca attorno ad una grande caldaia di salamoia, mescolare con lunghi cucchiai la densa miscela a una temperatura infernale, mentre le porte della baracca, tutte spalancate, lasciavano entrare una forte corrente di aria gelida. Dopo due anni di un lavoro simile questi martiri finivano per morire consunti.
Un numero considerevole di Polacchi, infine, era impiegato a costruire una strada lungo la costa meridionale del lago Bajkal. Questo stretto lago alpino, lungo quattrocento miglia, circondato da belle montagne alte fino a duemila metri sul suo livello, separa la Transbaikalia e l’Amur da Irkutsk. Durante l’inverno si può attraversarlo sul ghiaccio, d’estate vi sono i battelli, ma durante sei settimane in primavera e altre sei in autunno il solo mezzo per arrivare a čita e a Kjachta (per Pechino) da Irkutsk era di viaggiare a cavallo per una lunga strada circolare, attraverso montagne che hanno da 3500 a 4000 metri di altezza. Una volta percorsi questa strada, godendo profondamente lo spettacolo grandioso delle montagne ancora coperte di neve nel mese di maggio, ma un’altra volta il viaggio fu veramente disastroso. Per salire solo otto miglia, fino al passo principale, Chomar-daban, mi ci volle tutta la giornata, dalle tre del mattino alle otto di sera. I nostri cavalli cadevano continuamente sulla neve, tuffandosi insieme al cavaliere più volte in un giorno nell’acqua gelata sottostante alla leggera crosta di ghiaccio. Si decise di costruire una strada permanente lungo la costa meridionale del lago, facendo saltare la roccia per aprirsi un passaggio sulle rupi quasi verticali che fiancheggiano la costa e attraversando con dei ponti un centinaio di torrenti selvaggi che scendono furiosamente dai monti per gettarsi nel lago.
Gli esiliati polacchi furono impiegati in questo duro lavoro.
Schiere di esiliati politici russi furono mandati fin dal secolo scorso [XVIII secolo] in Siberia, ma con la rassegnazione e il fatalismo caratteristici dei Russi essi non si ribellarono mai; si lasciarono uccidere a poco a poco senza neppure tentare di liberarsi. I Polacchi al contrario (sia detto a loro onore) non furono mai altrettanto sottomessi e in quell’epoca si sollevarono apertamente. Non avevano evidentemente nessuna probabilità di successo, eppure si ribellarono. Avevano davanti a loro il grande lago e alle spalle una grande catena di montagne assolutamente impraticabili, oltre le quali incominciava il deserto della Mongolia settentrionale; nondimeno concepirono il progetto di disarmare i soldati che li custodivano, di fabbricare quelle terribili armi dell’insurrezione polacca – falci piantate come picche su dei lunghi pali – e di incamminarsi attraverso le montagne e la Mongolia verso la Cina, dove pensavano di trovare qualche nave inglese che li avrebbe raccolti. Un giorno arrivò a Irkutsk la notizia che una parte dei polacchi che lavoravano sulla strada del Bajkal aveva disarmato una dozzina di soldati e si era ribellata. Ottanta soldati fu tutto quello che si potè mandare contro di loro da Irkutsk. Attraversando il lago in piroscafo essi andarono ad aspettare gli insorti dall’altra parte del lago.
L’inverno del 1866 era stato estremamente tedioso a Irkutsk. Nella capitale siberiana non vi sono distinzioni di classe come nelle altre grandi città russe, e la “società” di Irkutsk, composta di numerosi ufficiali e funzionari, con le mogli e le figlie dei commercianti del luogo e anche i preti, si riuniva ogni martedì, durante l’inverno, nella sala delle Assemblee. Quell’inverno però non era molto propizio alle riunioni serali. Neppure le compagnie teatrali di dilettanti ebbero successo e persino il gioco, al quale di solito tutti si davano con passione sfrenata a Irkutsk, sembrava esser passato di moda; fra gli impiegati si faceva sentire una grande scarsità di denaro e anche l’arrivo di alcuni ufficiali delle miniere non portò con sé i mucchi di denaro con i quali questi privilegiati gentiluomini rallegravano di solito i frequentatori del tappeto verde. La “stagione” decisamente era melanconica – una stagione fatta apposta per gli esperimenti spiritici e le tavole parlanti. Un signore che l’inverno prima era stato il beniamino della società di Irkutsk per la sua arte di narratore, vedendo che l’interesse in lui e nei suoi racconti diminuiva, scelse lo spiritismo come nuovo divertimento. Era molto abile, e dopo una settimana tutte le signore di Irkutsk, andavano pazze per gli spiriti parlanti. Quelli che non sapevano come passare il loro tempo parvero risorti a nuova vita. Le tavole parlanti apparvero in ogni salotto e il fare all’amore procedeva di pari passo con le evocazioni spiritiche.
Un ufficiale, che chiamerò Potalov, prese uno straordinario interesse sia alle tavole parlanti che al fare l’amore. Fu forse meno fortunato con l’ultima che con la prima di queste cose; in ogni modo, quando arrivarono le notizie dell’insurrezione polacca, domandò di essere mandato sul posto con gli ottanta soldati. Sperava di ritornare con un’aureola di gloria militare. “Vado contro i polacchi”, scrisse nel suo diario, “sarebbe così interessante essere leggermente ferito!”...
Egli fu ucciso. Cavalcava vicino al colonnello che comandava i soldati, quando “la battaglia con gli insorti” – una brillante descrizione della quale si può leggere negli annali del generale Staff – incominciò. I soldati avanzavano lentamente lungo la via quando incontrarono una cinquantina di polacchi, cinque o sei di loro armati di fucili, il resto di falci e bastoni; occupavano la foresta e di tanto in tanto scaricavano i loro fucili. La catena dei soldati faceva lo stesso; il tenente Potalov chiese due volte il permesso di smontare e di buttarsi nella foresta, ma il colonnello gli comandò aspramente di restare dov’era. Nonostante questo, un momento dopo il tenente era scomparso. Nel bosco risuonarono alcuni colpi, seguiti da grida selvagge; i soldati si gettarono da quella parte e trovarono il tenente che giaceva sull’erba. I polacchi spararono i loro ultimi colpi e si arresero: la battaglia era finita! Potalov era morto. Era penetrato con la pistola in pugno nella macchia, dove si era imbattuto in alcuni polacchi armati di picche; aveva sparato a caso contro di loro tutti i colpi della pistola, ferendone uno mentre gli altri si gettarono su di lui con le loro picche.
All’altra estremità della strada, da questa parte del lago, due ufficiali russi si comportavano nel modo più abominevole verso quei polacchi che stavano costruendo la stessa strada, ma che non avevano preso parte all’insurrezione. Uno dei due ufficiali irruppe nella loro tenda bestemmiando e percuotendo con il calcio della pistola i pacifici deportati, ferendone due molto gravemente.
Ora, secondo la logica delle autorità militari siberiane, essendo stato ucciso un ufficiale russo si dovevano giustiziare alcuni polacchi. La Corte marziale ne condannò a morte cinque; Szaramowicz, un pianista, bell’uomo di trent’anni che era stato il capo dell’insurrezione; Celinski, un ex ufficiale dell’esercito russo, di sessant’anni, appunto perché era stato un tempo un ufficiale, e altri tre, dei quali non ricordo il nome. Il governatore generale telegrafò a Pietroburgo chiedendo di sospendere la condanna contro gli insorti, ma non venne nessuna risposta. Egli ci aveva promesso che non li avrebbe fatti giustiziare, ma dopo aver aspettato qualche giorno una risposta, ordinò che l’esecuzione avesse luogo segretamente all’alba.
La risposta da Pietroburgo venne quattro settimane dopo, per posta: il governatore era libero di agire “come credeva meglio”. Nel frattempo cinque uomini generosi erano stati fucilati.
L’insurrezione, dissero alcuni, era stata una follia. Eppure questo pugno di insorti ottenne qualche cosa. La notizia arrivò in Europa. Le esecuzioni, le brutalità dei due ufficiali, conosciute attraverso gli albi della Corte, produssero una certa commozione in Austria, e l’Austria intervenne in favore di quei Galiziani che avevano preso parte all’insurrezione del 1863 ed erano poi stati deportati in Siberia. Subito dopo l’insurrezione del Bajkal la sorte dei polacchi esiliati in Siberia migliorò sensibilmente, e questo si dovette agli insorti, a quei cinque coraggiosi fucilati a Irkutsk e a quelli che si erano battuti al loro fianco.
Questa insurrezione fu una grande lezione per me e per mio fratello. Comprendemmo quel che significava appartenere in un modo o nell’altro all’esercito. Io ero fuori, ma mio fratello era a Irkutsk e il suo squadrone fu mandato contro gli insorti. Per fortuna il comandante del reggimento a cui apparteneva mio fratello lo conosceva bene, e trovò un pretesto per darne il comando a un altro ufficiale, altrimenti Aleksandr avrebbe naturalmente rifiutato di ubbidire. Se fossi stato a Irkutsk avrei fatto altrettanto.
Decidemmo dunque di abbandonare il servizio militare e tornare in Russia; cosa non facile, specialmente per Aleksandr che si era ammogliato in Siberia; ma finalmente tutto fu sistemato e al principio del 1867 eravamo in viaggio per Pietroburgo.
Parte quarta
Pietroburgo
Nelle prime settimane dell’autunno del 1867, io, mio fratello e la sua famiglia ci stabilimmo a Pietroburgo. Mi iscrissi all’università e presi il mio posto fra quegli studenti, quasi ragazzi, molto più giovani di me. Quello che avevo tanto desiderato cinque anni prima era un fatto compiuto. Potevo studiare; e convinto che una seria preparazione è l’unico impulso al lavoro e al pensiero scientifico, mi iscrissi alla facoltà di fisica e matematica, seguendo la sezione di matematica. Mio fratello entrò all’Accademia militare di giurisprudenza mentre io abbandonavo del tutto il servizio militare con gran dispiacere di mio padre, che odiava persino il vestito borghese. Ormai tutti e due dovevamo contare interamente su noi stessi.
Per cinque anni gli studi universitari e il lavoro scientifico occuparono tutto il mio tempo. Uno studente di matematica ha naturalmente moltissimo da fare; ma i miei antichi studi di matematica superiore mi permettevano di dedicare un po’ di tempo alla geografia; e poi in Siberia non avevo perso l’abitudine di lavorare intensamente.
Il resoconto della mia ultima spedizione era stato pubblicato: ma nel frattempo mi si era posto un più vasto problema. I miei viaggi in Siberia mi avevano persuaso che le catene di montagne tracciate sulla carta dell’Asia settentrionale erano per lo più fantastiche e non davano nessuna idea della struttura topografica del paese. Gli autori di queste carte non avevano neppure sospettato i vasti altipiani, tanto caratteristici dell’Asia.
Al loro posto, varie grandi catene, come per esempio la parte orientale degli Stanovoi, che erano segnati allora come un grosso verme nero strisciante verso Oriente, erano state create nell’ufficio topografico, in contrasto con le indicazioni e anche con gli schizzi di esploratori come L. Schwartz. In realtà queste catene non esistono. Le sorgenti dei fiumi che scendono verso l’Artico da una parte e verso il Pacifico dall’altra si trovano mescolate su di uno stesso vasto altopiano: hanno origine dalle stesse paludi. Ma secondo il topografo europeo le più alte catene di montagne devono trovarsi lungo i fiumi principali, e i topografi avevano disegnato alte montagne delle quali in realtà non vi è traccia. Erano state disegnate molte catene di montagne immaginarie, che intersecavano in ogni senso l’Asia settentrionale.
Scoprire i veri princìpi che regolano la disposizione delle montagne dell’Asia – l’armonia della formazione orografica – diventò ora un problema che assorbì per anni la mia attenzione. Per un tempo considerevole le vecchie carte, e più ancora le generalizzazioni di Alexander von Humboldt, che dopo un lungo studio delle fonti cinesi aveva coperto l’Asia di una rete di montagne che correvano lungo i meridiani e i paralleli, ostacolarono le mie ricerche, finché finalmente vidi che anche le generalizzazioni di Humboldt, per quanto fossero state stimolanti, non andavano d’accordo con i fatti.
Riprendendo allora dal principio, con un metodo puramente induttivo, raccolsi tutte le osservazioni barometriche dei viaggiatori e con esse calcolai centinaia di altezze; segnavo su di una grande carta tutte le osservazioni geologiche e fisiche fatte dai diversi esploratori: i fatti, non le ipotesi; e cercai di scoprire quali linee di formazione corrispondessero ai fatti osservati. Questo lavoro di preparazione mi tenne occupato per più di due anni, seguiti da mesi di riflessione intensa per scoprire il significato recondito di questa caotica raccolta di fatti e di osservazioni sconnesse; finché un giorno improvvisamente tutto diventò chiaro e comprensibile, come illuminato da un fascio di luce. Le principali linee della struttura dell’Asia vanno non da nord a sud, o da est a ovest, bensì da sud-ovest a nord-est, come le Montagne Rocciose e gli altipiani dell’America vanno da nord-ovest a sud-est; soltanto le catene secondarie si spingono verso nord-ovest. Inoltre le montagne dell’Asia non sono fasci di catene separate come le Alpi, ma sono subordinate a un immenso tavolato, un vecchio continente che anticamente si protendeva verso lo stretto di Bering. Altre catene torreggiano ai suoi confini, e con il passare dei secoli delle terrazze formate da depositi posteriori si sono alzate dal mare, aggiungendosi dalle due parti a quella primitiva spina dorsale dell’Asia.
Ci sono nella vita di un uomo poche gioie paragonabili a quella che si prova all’improvvisa intuizione di una legge generale che illumina la mente dopo un lungo periodo di pazienti ricerche. Quello che per tanti anni era parso così caotico, così contraddittorio, così problematico, subito prende il suo posto in un insieme armonioso. Dall’intricata confusione di fatti e dall’incertezza delle supposizioni – contraddette appena sorte – emerge un quadro grandioso: come una catena alpina che improvvisamente esce dalle nebbie che la nascondevano un momento prima e si mostra sotto i raggi del sole in tutta la sua semplicità e varietà, in tutta la sua forza e bellezza. E quando si mette alla prova la legge generale applicandola a centinaia di fatti isolati che prima sembravano contraddirsi disperatamente, ognuno di essi prende il suo posto andando ad accrescere la maestà del quadro, accentuandone qualche linea caratteristica o aggiungendovi un particolare ancora insospettato ma pieno di significato.
Chi in vita sua ha provato una volta questa gioia della creazione scientifica non la dimenticherà mai più e anelerà sempre a rinnovarla; e non potrà che rammaricarsi che questa gioia sia riserbata a così pochi, quando tanti potrebbero provarla, in grande o in piccolo, se il metodo scientifico e il tempo necessario non fossero privilegio di pochi uomini.
Ritengo questo mio lavoro il mio principale contributo alla scienza. La mia prima intenzione era stata di pubblicare un grosso volume, nel quale le idee nuove sulle montagne e sugli altipiani dell’Asia settentrionale sarebbero state seguite da un esame particolare di ogni singola regione; ma nel 1873, quando mi accorsi che non avrei avuto il tempo di farlo, perché presto mi avrebbero arrestato, preparai solo una carta che dimostrava le mie idee, corredata da una spiegazione. Furono stampate tutte e due dalla Società Geografica a cura di mio fratello, mentre io mi trovavo nella fortezza dei SS. Pietro e Paolo. Petermann, che stava allora preparando una carta dell’Asia, e che conosceva il mio lavoro preliminare, si servì delle mie idee per la sua carta; essa è stata poi accettata da quasi tutti i topografi. La carta dell’Asia, così corretta, spiega secondo me le principali caratteristiche fisiche del grande continente, oltre la distribuzione del suo clima, della fauna e della flora, e anche la sua storia. Rivela poi, come ho potuto constatare nel mio recente viaggio in America, curiose analogie fra la struttura e lo sviluppo geologico dei due continenti dell’emisfero settentrionale. Pochissimi cartografi sarebbero ora in grado di dire come sono stati introdotti tutti questi cambiamenti nella carta dell’Asia; ma per la scienza è meglio che le idee si facciano strada indipendentemente da qualsiasi nome. Gli errori inevitabili in una prima generalizzazione vengono così corretti più facilmente.
Durante questo periodo lavorai moltissimo per la Società Geografica Russa, nella mia qualità di segretario della sezione di geografia fisica.
Si seguiva allora con molto interesse l’esplorazione del Turkestan e del Pamir. [Nikolaj] Severtsov ritornava allora da un viaggio durato parecchi anni. Grande zoologo, geografo geniale, è uno degli uomini più intelligenti che io abbia incontrato; come tanti Russi, odiava scrivere. Quando aveva fatto una comunicazione orale in un’assemblea della Società, non vi era mezzo di convincerlo a scrivere più della revisione dei resoconti della sua comunicazione; tutto quello che è stato pubblicato con il suo nome, quindi, non dà affatto un’idea del vero valore delle sue osservazioni e deduzioni. Questa riluttanza a scrivere i risultati delle proprie osservazioni e riflessioni è, purtroppo, comune in Russia. Le sue osservazioni, sull’orografia del Turkestan, sulla distribuzione geografica delle piante e degli animali e soprattutto sulla funzione degli uccelli ibridi nella formazione di nuove specie, che gli ho sentito fare, o sull’importanza del mutuo appoggio nel progressivo sviluppo delle specie, che ho trovato appena accennate in un paio di righe nel resoconto di qualche riunione, rivelano un’intelligenza e una originalità superiori alla media; ma gli mancava la capacità di esporre con forza in una forma bella e elegante, che ne avrebbe fatto uno dei primi scienziati del nostro tempo.
[Nikolaj] Miklucho Maklaj, conosciutissimo in Australia, che nei suoi ultimi anni diventò la sua patria di adozione, apparteneva a questa categoria di uomini, che hanno sempre tanto più da dire di quanto non abbiano pubblicato. Era piccolissimo, tutto nervi, vittima della malaria, e quando lo conobbi era appena ritornato dalle spiagge del Mar Rosso. Discepolo di [Ernst] Haeckel, aveva lavorato molto sugli invertebrati marini e sul loro ambiente. La Società Geografica riuscì poi a farlo trasportare su una corazzata russa in una parte sconosciuta della Nuova Guinea, dove voleva studiare i selvaggi più primitivi. Fu lasciato su di una spiaggia inospitale, in compagnia di un solo marinaio; si diceva che gli abitanti fossero dei cannibali. I due Robinson si costruirono una capanna e vissero per più di diciotto mesi vicino a un villaggio, in ottimi rapporti con gli indigeni. Essere sempre leale con loro, non ingannarli mai, neppure nelle cose più insignificanti, neppure per scopi scientifici – questo era il suo sistema, che seguì sempre scrupolosamente.
Quando più tardi viaggiò nella penisola di Malacca, aveva con sé un indigeno, che era entrato al suo servizio a patto di non essere mai fotografato. I selvaggi, come si sa, credono lasciandosi fotografare di perdere qualche cosa di se stessi. Maklaj, che stava facendo una raccolta di materiale antropologico, confessò di aver avuto una gran tentazione di fotografare un giorno il suo amico mentre questi dormiva, tanto più che era un rappresentante tipico della sua razza e che non si sarebbe mai accorto di essere stato fotografato. Ma Maklaj si ricordò della sua promessa e non lo fece. Quando lasciò la Nuova Guinea gli indigeni gli fecero promettere che sarebbe ritornato, e qualche anno dopo, benché gravemente ammalato, mantenne la promessa e ritornò. Quest’uomo di valore ha però pubblicato solo una piccolissima parte delle sue osservazioni, così importanti, veramente inestimabili.
Fedčenko, che aveva viaggiato molto e aveva fatto importanti ricerche zoologiche nel Turkestan, accompagnato da sua moglie, Olga Fedčenkova, naturalista anche lei, era, come dicevamo noi, un “europeo occidentale”. Lavorò assiduamente per elaborare i risultati delle sue osservazioni prima di pubblicarle, ma morì disgraziatamente durante un’ascensione in Svizzera. Caldo di giovanile ardore dopo la sua spedizione fra le montagne del Turkestan e pieno di fiducia nelle sue possibilità, intraprese un’ascensione senza guide adatte e trovò la morte in una tempesta di neve. Sua moglie condusse felicemente a termine la pubblicazione dei suoi Viaggi dopo la sua morte, e credo che abbia ora un figlio che continua l’opera del padre e della madre.
Vidi spesso anche Prjevalskij, o meglio, [Nikolaj] Prževal’skij, come dovrebbe essere scritto il suo nome polacco, benché egli stesso preferisse essere creduto un “patriota russo”. Era un cacciatore appassionato e l’entusiasmo col quale intraprese le sue esplorazioni dell’Asia centrale fu dovuto tanto al suo desiderio di cacciare ogni sorta di selvaggina rara, come daini, cammelli e cavalli selvatici, e così via, quanto al suo desiderio di scoprire terre nuove e di difficile accesso. Quando lo si induceva a parlare delle sue scoperte, interrompeva spesso il suo semplice racconto per esclamare: “Ma che selvaggina era quella! Che caccia!..”. E descriveva con passione come avesse percorso delle miglia strisciando per avvicinarsi e mettere a tiro qualche cavallo selvatico. Appena ritornato a Pietroburgo ideò un nuovo viaggio e economizzando metteva da parte il suo denaro, cercando di accrescerlo con delle operazioni di borsa, per una nuova spedizione. Era il vero tipo dell’esploratore per la sua forza fisica e la sua capacità di sopportare la vita piena di privazioni del cacciatore di montagna. Questo genere di vita lo rendeva felice. Aveva fatto il suo primo viaggio con tre soli compagni e sempre aveva conservato ottimi rapporti con gli abitanti. Le sue spedizioni successive, però, presero un carattere più militare, ed incominciò sfortunatamente a confidare nella forza della sua scorta armata più che nelle trattative pacifiche con gli indigeni, e ho sentito dire in circoli bene informati che se non fosse morto agli inizi della sua spedizione al Tibet – tanto ammirevolmente e pacificamente diretta, dopo la sua morte, dai suoi compagni Pevstov, Roborovskij e Kozlov – egli probabilmente non ne sarebbe tornato vivo.
A quest’epoca una notevole attività animava la Società Geografica ed erano numerosi i problemi geografici ai quali la nostra sezione, e quindi il suo segretario, prendeva un vivo interesse. Molte sono troppo tecniche perché se ne parli qui, ma devo ricordare il risveglio dell’interesse per la navigazione, la pesca e il commercio nelle regioni russe dell’Oceano Artico che si manifestò in quegli anni. Un mercante e cercatore d’oro siberiano, Sidorov, si sforzò con grande ostinazione di ridestare questo interesse. Calcolò che con poco, ristrutturando le scuole navali ed esplorando le coste di Murmansk e del Mar Bianco si sarebbe avuto un grande sviluppo della pesca e della marina russa. Ma disgraziatamente questo poco doveva passare da Pietroburgo: e la parte dominante degli abitanti di questa città cortigiana, burocratica, letteraria, artistica e cosmopolita non potè essere indotta a interessarsi a qualcosa che passava per “provinciale”. Povero Sidorov, non si guadagnò che del ridicolo, con tutti i suoi sforzi! Era dall’estero che doveva venire la spinta alla nostra Società Geografica Russa perché si occupasse del nostro estremo Settentrione.
Tra il 1869 e il 1871 i coraggiosi cacciatori di foche norvegesi avevano improvvisamente aperto il Mar di Kara alla navigazione. Con nostra grande sorpresa sentimmo in un resoconto della Società che il mare fra l’isola della Nuova Zemlja e la costa della Siberia, che noi fiduciosamente descrivevamo come impraticabile perché sempre ghiacciato, era stato navigato da un certo numero di schooner norvegesi e attraversato da loro in ogni senso. Persino la località dove aveva svernato il famoso olandese Barents, che credevamo per sempre nascosta agli occhi dell’uomo da banchi di ghiaccio antichi di centinaia di anni, era stata visitata da questi avventurosi navigatori norvegesi.
“Stagioni eccezionali e stato eccezionale del ghiaccio”, fu il responso dei nostri navigatori più anziani; ma ad alcuni di noi parve evidente che gli intrepidi cacciatori norvegesi, che si sentono in casa loro in mezzo ai ghiacci, con le loro piccole imbarcazioni e le loro piccole ciurme si erano avventurati a passare attraverso i ghiacci galleggianti che di solito sbarrano la via al Mar di Kara, mentre i comandanti delle imbarcazioni del governo russo, impacciati dalle responsabilità del servizio di Stato, non avevano mai osato farlo.
Un generale interesse per le esplorazioni artiche fu ridestato da queste scoperte; in realtà furono i cacciatori di foche ad aprire un’era nuova di entusiasmo per l’Artico, era che culminò con la circumnavigazione dell’Asia del capitano [Otto] Nordenskjöld e con l’apertura definitiva del passaggio di Nord-est della Siberia, nonché con la scoperta della Groenlandia settentrionale fatta da [Edward] Perry e con la spedizione della Fram di [Fridtjof] Nansen.
La nostra Società Geografica incominciò anch’essa a mettersi in moto e fu nominato un comitato per preparare il piano di una spedizione artica russa e per indicare il lavoro scientifico che si sarebbe potuto compiere. Alcuni specialisti si incaricarono di scrivere ognuno un capitolo particolare di questa relazione, ma, come spesso succede, solo pochi capitoli – la botanica, la geologia, la meteorologia – furono pronti a tempo e io, come segretario del comitato, dovetti scrivere il resto. Molti argomenti, per esempio la zoologia marina, il flusso e il riflusso delle maree, le osservazioni sulle oscillazioni del pendolo e sul magnetismo terrestre, erano per me assolutamente nuovi; ma l’enorme quantità di lavoro che può fare un uomo sano in un tempo abbastanza breve, se impiega tutte le sue forze e mira solo alla meta, è difficile da immaginare, e così la mia relazione fu pronta.
Essa concludeva con la proposta di una grande spedizione artica che avrebbe destato in Russia un interesse permanente per la questione artica e la navigazione artica; intanto una spedizione di avanscoperta a bordo di uno schooner norvegese con capitano norvegese si sarebbe spinta a Nord o a Nord-est della Nuova Zemlja. Noi suggerimmo che questa spedizione tentasse anche di raggiungere, o almeno di riconoscere una terra sconosciuta che doveva trovarsi a una certa distanza dalla Nuova Zemlja. La probabile esistenza di una tale terra era stata indicata da un ufficiale della flotta russa, il barone Schilling, in uno studio eccellente ma poco noto sulle correnti dell’Oceano Artico. La lettura di questa relazione e del Viaggio alla Nuova Zemlja di [Pëtr] Liitke mi diede una certa familiarità con le condizioni generali di questa parte dell’Oceano Artico, e vidi subito che questa supposizione doveva essere esatta. Vi doveva essere una terra a nord-ovest della Nuova Zemlja, e doveva raggiungere una latitudine più settentrionale dello Spitzberg. L’immobilità del ghiaccio a ovest della Nuova Zemlja, il fango e i sassi trovati e varie altre indicazioni di minore importanza confermavano l’ipotesi.
Se d’altra parte questa terra non vi fosse, la corrente del ghiaccio che va a Ovestdel meridiano dallo stretto di Bering alla Groenlandia – la corrente che portò alla deriva il Fram – dovrebbe, come stabilì con esattezza Schilling, raggiungere il Capo Nord e coprire di ghiacci le coste della Lapponia, precisamente come copre di ghiacci le coste settentrionali della Groenlandia. La corrente calda, che è solo una debole continuazione della Corrente del Golfo, non avrebbe potuto impedire da sola la grande accumulazione di ghiaccio sulle coste dell’Europa settentrionale. Questa terra, come si sa, fu poi scoperta due anni dopo dalla spedizione austriaca, e chiamata Terra di Francesco Giuseppe.
La relazione sui mari artici ebbe per me un effetto assolutamente inaspettato: mi fu offerto il comando di una spedizione di avanscoperta a bordo di uno schooner norvegese, armato a questo scopo. Naturalmente risposi che non avevo mai navigato, ma mi assicurarono che combinando l’esperienza di un Carlsen o di un Johansen con l’iniziativa di un uomo di scienza si sarebbero ottenuti dei risultati notevoli; e io avrei accettato se in quel momento il Ministero delle Finanze non fosse intervenuto a mettere il veto. La risposta fu che il Tesoro non si poteva permettere le tre o quattromila sterline che sarebbero state necessarie per la spedizione. Da allora in poi la Russia non ha più contribuito all’esplorazione dei mari artici. La terra che noi scorgemmo attraverso le nebbie subpolari fu scoperta da [Julius von] Payer e da [Karl] Wayprecht e gli arcipelaghi che devono esistere a nord della Nuova Zemlja – ne sono convinto ora anche più di allora – rimangono sconosciuti.
Invece di prendere parte a una spedizione artica, fui mandato dalla Società Geografica a fare un modesto viaggio in Finlandia e in Svezia allo scopo di esplorare i depositi glaciali e questo viaggio avviò poi la mia attività in una direzione affatto diversa.
L’Accademia russa delle scienze aveva mandato quell’estate due dei suoi membri, il vecchio geologo generale [Gregor von] Helmersen e Friedrich Schmidt, l’instancabile esploratore della Siberia, a studiare la struttura di quei lunghi filoni di depositi che si chiamano in Svezia e in Finlandia åsar, e esker, kames, ecc., nelle isole britanniche. La Società Geografica mi mandò in Finlandia allo stesso scopo; visitammo tutti e tre il bel banco di Pungahrju e poi ci separammo. Durante quell’estate lavorai molto, viaggiai in Finlandia e attraversai la Svezia, dove passai molte ore bellissime in compagnia di Nordenskjöld. Fin da allora – nel 1871 – mi parlò dei suoi piani per raggiungere la foce dei fiumi siberiani e anche lo stretto di Bering da Nord. Ritornato in Finlandia, continuai le mie ricerche fino all’autunno inoltrato e raccolsi una gran quantità di osservazioni interessantissime sulla glaciazione del paese; ma durante questo viaggio pensai anche molto alle questioni sociali, e queste riflessioni ebbero un’influenza decisiva sul mio avvenire.
Materiale di valore diversissimo, relativo alla geografia russa, passava attraverso le mie mani alla Società Geografica e a poco a poco mi venne l’idea di scrivere una geografia fisica definitiva di questa immensa parte della terra. La mia intenzione era di fare una descrizione completa della geografia del paese partendo dalle grandi linee della struttura generale, come avevo incominciato a fare per la Russia europea; e di tratteggiare in questa descrizione le diverse forme di vita economica che dovrebbero predominare nelle varie regioni fisiche. Prendete per esempio le vaste steppe della Russia meridionale, tanto sovente desolate dalla siccità che rovina i raccolti: queste siccità non dovrebbero essere considerate come una calamità accidentale; sono invece un fenomeno naturale di quella regione quanto la sua posizione meridionale, la sua fertilità e così via; e tutta la vita economica delle steppe meridionali dovrebbe essere organizzata prevedendo l’inevitabile ricorrere di queste siccità periodiche. Tutte le regioni dell’Impero russo dovrebbero essere trattate in questo modo scientifico, come Carl Ritter studiò parti dell’Asia nelle sue belle monografie.
Ma un lavoro simile avrebbe richiesto molto tempo e una completa libertà per l’autore: pensai spesso come il mio compito sarebbe stato più facile se un giorno avessi occupato il posto di segretario della Società Geografica. Ora nell’autunno del 1871, mentre lavoravo in Finlandia camminando verso la costa del mare lungo la nuova ferrovia e scrutando attentamente il punto dove apparivano le prime indubbie tracce dell’antica occupazione del mare post-glaciale, ricevetti un telegramma della Società Geografica: “Il Comitato vi prega di accettare il posto di segretario della Società”; contemporaneamente l’ex segretario nel lasciare il posto mi consigliava ardentemente di accettare l’offerta.
Le mie speranze si realizzavano. Ma nel frattempo altri pensieri e altri desideri si erano impadroniti di me. Pensai seriamente a quello che dovevo fare, e finalmente risposi: “Ringrazio di cuore, ma non posso accettare”.
Accade spesso che gli uomini seguano una certa linea politica, sociale e familiare semplicemente perché non hanno il tempo di domandarsi se la posizione che essi assumono e il lavoro che compiono sono buoni; se le loro occupazioni rispondono realmente ai loro intimi desideri e capacità e danno loro la soddisfazione che ognuno ha il diritto di aspettarsi dal proprio lavoro. Gli uomini d’azione sono particolarmente soggetti a trovarsi in queste condizioni. Ogni giorno porta con sé un obbligo nuovo di lavoro e uno si corica tardi nel suo letto senza aver compiuto tutto quello che pensava di poter fare; l’indomani mattina si affretta a terminare il compito del giorno precedente. La vita fugge e non c’è il tempo di pensare; non c’è il tempo di considerare la direzione che prende la vita di un uomo. Così era di me.
Ma ora, durante il mio viaggio in Finlandia io avevo tempo a disposizione. Mentre attraversavo in una karria finlandese a due ruote ampie pianure che non offrono interesse al geologo, o quando camminavo, martello sulle spalle, da una sabbionara all’altra, potevo pensare; e fra i lavori di geologia indubbiamente interessanti che andavo facendo, un’idea, che nel mio intimo mi attirava più forte della geologia, persistentemente lavorava nella mia mente.
Vedevo quale immenso sforzo richiedesse al contadino il lavoro di dissodare la terra e di rompere la dura argilla e mi dicevo: “Io scriverò, per esempio, la geografia fisica di questa parte della Russia e insegnerò al contadino i metodi migliori per coltivare il suo suolo. Qui un’estirpatrice americana avrebbe un valore incalcolabile, qui certi metodi di concimazione dovrebbero essere indicati dalla scienza... Ma a che scopo parlare a questo contadino delle macchine americane quando egli ha appena quanto basta per vivere da un raccolto all’altro; quando il fitto che deve pagare per questa terra dura e argillosa diventa sempre più grave in proporzione ai progressi e alle migliorie? Egli rosicchia il suo biscotto di segale, duro come un sasso, che fa cuocere due volte l’anno; vi aggiunge un merluzzo terribilmente salato e beve latte scremato. Come osare parlargli delle macchine americane, quando tutto quello che può coltivare deve venderlo per pagare le imposte e la pigione? È necessario che io viva con lui per aiutarlo a diventare libero proprietario di questa terra, e allora potrà leggere dei libri con profitto, ma non ora”.
E i miei pensieri andavano dalla Finlandia ai nostri contadini di Nikolskoje, che avevo visto da poco. Ora essi erano liberi e davano molto valore alla loro indipendenza. Ma non avevano prati. In un modo o nell’altro i proprietari erano riusciti a tenersi quasi tutte le praterie. Quando io ero un ragazzo i Savochin mettevano sei cavalli per volta al pascolo; i Tolkacev ne avevano sette. Ora queste famiglie avevano solo tre cavalli per una; altre famiglie che prima avevano tre cavalli ne avevano uno solo, o nessuno. Che cosa potevano fare con un solo misero cavallo? Niente prati, niente cavalli, niente concimi! Come potevo consigliarli a seminare prati? Erano già rovinati – poveri come Lazzaro – e in pochi anni sarebbero stati ridotti alla miseria dalle tasse pazzesche. Come erano stati felici quando avevo detto che mio padre dava loro il permesso di falciare l’erba nelle brevi radure della sua foresta di Kostino! “I vostri contadini di Nikolskoje sono feroci per il lavoro”, era un detto comune fra i nostri vicini; ma la terra arabile, che la nostra matrigna aveva escluso dai loro lotti in virtù della “legge del minimum” – questa clausola diabolica introdotta dai proprietari di servi quando era stato loro permesso di emendare a loro vantaggio la legge sull’emancipazione – è ora una foresta di rovi e i feroci lavoratori non hanno il permesso di coltivarla. E questo stato di cose è lo stesso in tutta la Russia. Era evidente fin da allora, e i commissari ufficiali l’avevano previsto, che la prima seria diminuzione del raccolto nella Russia media avrebbe avuto per risultato una terribile carestia – e la carestia venne nel 1876, nel 1884, nel 1891, nel 1895, e ancora nel 1898.
La scienza è una cosa eccellente. Io ne conoscevo e ne provavo le gioie e i tormenti forse più di quanto non facessero molti dei miei colleghi. Anche allora, mentre visitavo i laghi e le colline della Finlandia, mi si prospettavano nella loro bellezza nuove leggi generali. Vedevo, nel remoto passato, proprio all’alba dell’umanità, i ghiacci accumulatisi di anno in anno negli arcipelaghi nordici sopra la Scandinavia e la Finlandia. Un agglomerato immenso di ghiacci invase il Nord dell’Europa e lentamente avanzò fino al centro del continente. La vita si indebolì in questa parte dell’emisfero settentrionale e, immiserita, povera e incerta, fuggì sempre più verso il Sud davanti al freddo soffio che veniva da questa massa di ghiaccio. L’uomo – misero, debole, ignorante – dovette affrontare difficoltà enormi per conservare la sua precaria esistenza. Passarono le età, finché incominciò lo scioglimento dei ghiacci, e con questo giunse il periodo lacustre, quando si formarono innumerevoli laghi nelle cavità e una povera vegetazione sub-polare venne timidamente a installarsi nei vastissimi pantani di cui ogni lago era circondato. Un’altra serie di secoli passò prima che un processo estremamente lento di prosciugamento incominciasse, accompagnato da una lenta invasione della vegetazione dal mezzogiorno –, ora ci troviamo nell’epoca del rapido disseccamento, accompagnato dalla formazione di aride pianure e di steppe, e l’uomo deve ancora trovare il mezzo di frenare questo rapido disseccamento da cui è già stata colpita l’Asia centrale e che minaccia il Sud-est dell’Europa. L’ipotesi che un promontorio di ghiaccio avesse raggiunto l’Europa centrale, era a quest’epoca una grande eresia; ma ai miei occhi si affacciava un quadro grandioso, e io volevo disegnarlo in tutti i mille particolari che vi scoprivo, per servirmene come di una chiave per comprendere l’attuale distribuzione della fauna e della flora, per aprire nuovi orizzonti alla geologia e alla geografia fisica.
Ma quale diritto avevo io a queste gioie profonde, mentre intorno a me non vi era che miseria e lotta per un tozzo di pane ammuffito; quando tutto quello di cui io potevo aver bisogno per poter vivere in questo mondo di altissime emozioni doveva essere tolto dalla bocca di quelli che fanno crescere il grano e non hanno abbastanza pane per i loro bambini? Perché dalla bocca di qualcuno doveva ben essere tolto, visto che il complesso della produzione dell’umanità rimane così scarso!
Il sapere è una forza immensa. L’uomo deve sapere. Ma noi sappiamo già molto! Che cosa avverrebbe se questo sapere – e soltanto questo – fosse possesso di tutti? Non è probabile che la scienza stessa non procederebbe più a balzi e che la causa dell’umanità farebbe tali passi giganteschi nel campo della produzione, delle invenzioni e delle creazioni di interesse generale, che noi oggi non possiamo neppure concepire?
Le masse vogliono conoscere; esse sono pronte per conoscere; esse devono conoscere. Là, sulla vetta di quelle alte morene che corrono fra i laghi, come se i giganti le avessero accavallate furiosamente per collegare le due rive, sta un contadino finlandese assorto nella contemplazione dei bei laghi ingemmati di isole, che si stendono sotto di lui.
Non uno di questi contadini, per povero e oppresso che sia, passerà da questo punto senza fermarsi ad ammirare la scena. Là, sulla riva di un lago, sta un altro contadino, e canta qualche cosa di tanto bello che il miglior musicista ne invidierebbe la melodia per il suo sentimento e la sua potenza meditativa. Tutti e due sentono profondamente, tutti e due meditano, tutti e due pensano; essi sono pronti ad allargare le loro conoscenze, purché sia loro concesso di farlo e siano loro offerte le condizioni necessarie.
Questa è la via e questa è la gente per cui io debbo lavorare. Tutte le belle frasi sonore sono inutili, quando gli apostoli del progresso si tengono lontani da quelli che pretendono spingere avanti; quelle frasi non sono che sofismi di spiriti desiderosi di sfuggire a una contraddizione irritante.
Per questo dunque mandai alla Società Geografica la mia risposta negativa.
Pietroburgo era molto cambiata da quella che era quando l’avevo lasciata nel 1862. “Oh, sì, voi conoscete la Pietroburgo di černyševskij”, mi disse una volta il poeta Majkov. E veramente io conoscevo la Pietroburgo che černyševskij prediligeva. Ma come descrivere la città che trovai al mio ritorno? Forse come la Pietroburgo dei café-chantant, se la frase “tutta Pietroburgo” si può adoperare per indicare gli ambienti più in alto della società, quelli che si ispiravano alla vita della Corte.
A Corte e nei circoli di Corte le idee liberali erano molto male accolte e tutte le personalità eminenti attorno al ’60, e persino uomini moderati come Nikolaj Muravëv e Nikolaj Miljutin erano trattati come sospetti. Soltanto Dmitrij Miljutin, ministro della Guerra, era stato mantenuto al suo posto da Aleksandr II, perché la riforma in corso nell’esercito richiedeva molti anni per essere completata. Tutti gli altri che avevano partecipato attivamente all’epoca delle riforme erano stati messi da parte.
Parlai una volta con un alto funzionario del Ministero degli Esteri; egli criticava aspramente un altro funzionario e io osservai, in difesa di quest’ultimo: “Si può dire però a suo merito che non ha mai voluto accettare un incarico sotto Nicola I”.
“E ora serve sotto il regno di šuvalov e Trepov”, mi fu risposto. E questo descriveva tanto bene la situazione, che non vi era altro da aggiungere.
Il generale šuvalov, capo della polizia di Stato, e il generale Trepov, capo della polizia di Pietroburgo, erano i veri governanti della Russia. Aleksandr II era solo il loro esecutore, il loro strumento. Regnavano con il terrore. Trepov aveva tanto terrorizzato Aleksandr con lo spettro di una rivoluzione che doveva scoppiare a Pietroburgo, che se l’onnipotente capo della polizia tardava di qualche minuto a fare il suo rapporto quotidiano a Palazzo, l’imperatore chiedeva subito “se tutto era tranquillo”.
Poco tempo dopo aver dato un “congedo assoluto” alla principessa X, Aleksandr fu preso da una calda amicizia per il generale Fleury, l’aiutante di campo di Napoleone III, quell’uomo losco che era stato l’anima del colpo di Stato del 2 dicembre 1852. Si vedevano sempre assieme e Fleury raccontò un giorno ai Parigini il grande onore che gli aveva fatto lo zar di Russia. Questi, mentre passeggiava in vettura sulla Prospettiva Nevskij vide un giorno Fleury e lo pregò di salire con lui in carrozza; un égoiste che aveva un solo piccolo sedile a un posto; il generale francese narrava come lo zar e lui, abbracciandosi stretti, stessero per metà fuori del sedile troppo stretto. Basta il nome di questo amico, arrivato allora da Compiègne, per capire cosa volesse dire questa amicizia.
šuvalov capì l’orientamento del suo padrone e quanto la situazione gli fosse favorevole; preparava una misura reazionaria dopo l’altra, e se Aleksandr si mostrava riluttante a firmarne qualcuna, Šuvalov gli parlava della prossima rivoluzione e del destino di Luigi XVI e lo pregava, “per la salvezza della dinastia” di firmare nuove aggiunte alle leggi repressive. Nondimeno, di tempo in tempo la tristezza e il rimorso non lasciavano pace ad Alessandro. Era allora in preda a una tetra melanconia e parlava con tristezza degli inizi brillanti del suo regno e della piega reazionaria che ora prendeva. Allora šuvalov organizzava qualche caccia all’orso, di eccezionale allegria. Cacciatori, allegri cortigiani e carrozze piene di ballerine partivano per le foreste di Novgorod. Aleksandr ammazzava un paio di orsi: era un bravo tiratore e permetteva di solito che l’animale si avvicinasse fino a pochi metri dalla sua carabina; e là, in mezzo all’eccitamento della caccia, Šuvalov otteneva dal suo padrone il consenso per qualsiasi progetto reazionario egli immaginasse.
Alessandro II non era certo un essere volgare; ma esistevano in lui due uomini diversi, completi tutti e due e in lotta l’uno con l’altro, e questa lotta si fece sempre più violenta con il passare degli anni. Poteva comportarsi in un modo incantevole, e pochi minuti dopo essere di una brutalità eccessiva. Aveva il coraggio calmo e ragionatore di fronte a un reale pericolo, ma viveva nel continuo terrore di pericoli che esistevano solo nel suo cervello. Non era certo un vigliacco; sapeva affrontare un orso faccia a faccia; una volta che l’animale non fu ucciso al primo colpo e l’uomo che stava dietro lo zar, corso avanti con una picca, fu buttato a terra dall’orso, Aleksandr gli venne in aiuto e uccise la belva sparandole a bruciapelo, con evidente pericolo della sua vita; eppure fu perseguitato tutta la vita da terrori immaginari e da una coscienza inquieta. Era capace di gentilezza nel trattare con gli amici, ma la sua bontà era accompagnata da una crudeltà terribilmente calcolatrice, settecentesca, e ne dette prova nella repressione dell’insurrezione polacca e più tardi nel 1880, quando furono prese misure analoghe per schiacciare la rivoluzione della gioventù russa – una crudeltà della quale nessuno lo avrebbe creduto capace. Visse così una duplice vita, e all’epoca di cui parlo firmava allegramente i decreti più reazionari per disperarsene poi! Verso la fine della vita questa lotta interiore, come vedremo, si fece sempre più acuta e assunse un carattere quasi tragico.
Nel 1872 šuvalov fu nominato ambasciatore in Inghilterra, ma il suo amico, il generale Potapov continuò la stessa politica fino al principio della guerra con la Turchia, nel 1877. Durante tutto questo periodo continuò in misura enorme il più scandaloso saccheggio del tesoro dello Stato e delle terre della Corona, delle tenute confiscate in Lituania dopo l’insurrezione, delle terre dei Baškiry attorno a Orenburg [čkolov] e così via. Alcuni di questi scandali furono scoperti e alcuni furono giudicati dal Senato, convocato in Alta Corte di Giustizia, poiché dopo la pazzia di Potapov e la destituzione di Trepov i loro rivali a Palazzo si misero a mostrarli ad Aleksandr nella loro vera luce. In una di queste inchieste giudiziarie fu scoperto che un amico di Potapov aveva spudoratamente derubato i contadini di una tenuta lituana delle loro terre; poi, autorizzato dai suoi amici al Ministero dell’Interno aveva fatto arrestare i contadini che chiedevano giustizia, li aveva fatti fustigare e fucilare dalla truppa. Questa fu una delle storie più disgustose del genere, negli annali di Russia, che sono pieni ancor oggi di simili ruberie. Fu solo dopo che Vera Zasulič ebbe tirato su Trepov e lo ebbe ferito (per vendicare uno dei prigionieri politici che egli aveva fatto frustare in prigione), che i furti di questo partito furono conosciuti a fondo, e Trepov scacciato. Credendosi sul punto di morire, egli scrisse il suo testamento, dal quale risultò che quest’uomo, che aveva fatto credere allo zar di essere povero, benché avesse occupato per diversi anni il posto redditizio di capo della polizia di Pietroburgo, lasciava in realtà una notevole fortuna ai suoi eredi. Alcuni cortigiani portarono la notizia ad Aleksandr II: Trepov perdette la fiducia di cui godeva e si iniziarono allora davanti al Senato i processi contro la banda šuvalov, Potapov, Trepov.
Le ruberie comuni in tutti i ministeri e specialmente nel campo delle ferrovie e delle imprese industriali di ogni specie, erano veramente enormi. Furono ammassate allora enormi fortune. La marina, come Aleksandr II stesso disse una volta a uno dei suoi figli, era “nelle tasche del tal dei tali”. Il costo delle ferrovie, garantito dallo Stato, era semplicemente favoloso. Si sapeva benissimo che nessuna impresa commerciale poteva essere lanciata senza la promessa di una precisa percentuale sui dividendi ai funzionari dei vari ministeri. Un mio amico, che voleva iniziare una certa impresa a Pietroburgo, si sentì dire francamente al Ministero dell’Interno che doveva pagare il 25% dei profitti netti a una certa persona, il 15% a un funzionario del Ministero delle Finanze, il 10% a un’altra persona dello stesso Ministero e il 5% a una quarta persona! Queste trattative venivano condotte senza farne mistero, e Aleksandr II le conosceva. Ne fanno fede le sue osservazioni, scritte sui rapporti del Controllore generale. Ma egli vedeva in questi ladri i suoi protettori contro la rivoluzione e li tenne al loro posto fino al giorno in cui le loro disonestà diventarono uno scandalo pubblico.
I giovani granduchi, ad eccezione del principe ereditario, più tardi Aleksandr III, che fu sempre un buono ed economo pater familias, seguivano l’esempio di chi stava più in alto. Le orge che uno di essi aveva l’abitudine di consumare in un piccolo ristorante della Prospettiva Nevskij erano tanto scandalose e vergognose, che una notte il capo della polizia dovette intervenire e ammonire il proprietario del ristorante che lo avrebbe mandato in Siberia se avesse dato ancora una volta la sua “camera del granduca” al granduca stesso. “Immaginate la mia perplessità”, mi diceva egli una volta, mentre mi mostrava la stanza, che aveva le pareti e il soffitto tappezzati di spessi cuscini di seta. “Da una parte io dovevo offendere un membro della famiglia imperiale, che poteva fare di me quel che voleva; dall’altra il generale Trepov mi minacciava la Siberia! Naturalmente io obbedii al generale: egli è ora, voi lo sapete, onnipotente”.
Un altro granduca diventò famoso per certe abitudini che appartengono al regno della psicopatia; un terzo fu esiliato nel Turkestan per aver rubato i diamanti di sua madre.
L’imperatrice Maria Aleksandrovna, abbandonata da suo marito e probabilmente scandalizzata dal tono che prendeva la vita di Corte, si diede al bigottismo e ben presto cadde completamente nelle mani dei preti di palazzo, rappresentati da un tipo assolutamente nuovo nella Chiesa russa, il gesuita! Questa nuova genia di preti, ben tenuti, depravati e ipocriti, fece a quell’epoca rapidi progressi e lavorava già attivamente e con successo per diventare un potere nello Stato e mettere le mani sulle scuole.
È stato provato più volte che il clero nelle campagne è troppo occupato dalle sue funzioni – battesimi e matrimoni, la comunione ai moribondi e così via – per potersi curare delle scuole; anche quando il prete è pagato per insegnare la dottrina nella scuola di un villaggio, egli per lo più affida questo lavoro a qualcun altro, perché non ha tempo di occuparsene. Ciò nonostante l’alto clero, sfruttando l’odio di Aleksandr II per il cosiddetto spirito rivoluzionario, incominciò la sua campagna per impadronirsi delle scuole. “Nessuna scuola che non sia in mano del clero”, fu la parola d’ordine. Tutta la Russia chiedeva l’istruzione, ma persino la somma ridicolmente piccola di due milioni di rubli, che figurava ogni anno nel bilancio dello Stato per le scuole primarie, non veniva spesa dal ministro della Pubblica Istruzione, mentre quasi altrettanto veniva dato al Sinodo, come sussidio per aprire nuove scuole da affidarsi ai preti di campagna, molte delle quali esistevano, ed esistono, solo sulla carta.
Tutta la Russia chiedeva l’istruzione tecnica, ma il Ministero aprì soltanto i ginnasi classici, perché i formidabili corsi di latino e di greco erano considerati il mezzo migliore per impedire ai giovani di leggere e di pensare. In questi ginnasi solo il due o il tre per cento dei ragazzi riusciva a portare a termine il corso di otto anni, perché tutti i ragazzi che promettevano qualche cosa e che mostravano indipendenza di pensiero venivano decisamente allontanati prima che raggiungessero l’ultima classe, e molte misure furono prese per ridurre il numero degli studenti. L’educazione, tranne che per pochissimi, era considerata un lusso. Contemporaneamente il ministro dell’Istruzione era continuamente impegnato in una lotta appassionata contro tutti i privati e le istituzioni – distretti e assemblee provinciali, comuni e simili – che cercavano di aprire seminari per insegnanti o scuole tecniche, o anche, semplicemente, scuole elementari. L’istruzione tecnica – in un paese dove c’è tanta domanda di ingegneri, periti agrari e geologi – era trattata come un’istituzione rivoluzionaria! Era proibita, perseguitata, così che oggi ancora ogni autunno circa due o tremila giovani si vedono rifiutata l’ammissione alle scuole tecniche superiori semplicemente per mancanza di posti. Un senso di disperazione si impossessò di tutti quelli che non potevano far nulla di utile nella vita pubblica; mentre i contadini erano rovinati con una rapidità spaventosa dalle soprattasse e dall’imposizione del pagamento degli arretrati per mezzo di spedizioni semimilitari che li rovinavano per sempre. I soli governatori di provincia ben visti alla capitale erano quelli che riuscivano a spremere tasse nel modo più severo.
Questa era la Pietroburgo ufficiale. Questa era l’influenza che esercitava sopra la Russia.
Preparandoci a lasciare la Siberia mio fratello ed io parlavamo spesso della vita intellettuale che avremmo trovato a Pietroburgo e delle interessanti relazioni che avremmo potuto coltivare in quei circoli letterari. Facemmo difatti alcune conoscenze fra i radicali e fra gli slavofili moderati, ma devo confessare che rappresentarono per noi una delusione. Incontrammo molti uomini eccellenti – la Russia è piena di uomini eccellenti – ma essi non rispondevano al nostro ideale di scrittori politici. I migliori scrittori – černyševskij, Michailov, Lavrov, erano in esilio, o chiusi nella fortezza dei SS. Pietro e Paolo, come Pisarev. Altri, vedendo la situazione oscura, avevano cambiato opinione e caldeggiavano una specie di assolutismo paternalistico, mentre i più, sebbene conservassero ancora la loro fede, erano diventati tanto cauti nel manifestarla, che la loro prudenza equivaleva a una diserzione.
Nel momento culminante del periodo delle riforme, quasi tutti nei circoli letterari di avanguardia avevano avuto relazione con Herzen, o con Turgenev e i suoi amici, o con “La Grande Russia”, o con “Terra e Libertà”, società segrete che avevano avuto un’effimera esistenza durante quel periodo. Ora quegli stessi uomini erano i più ansiosi di seppellire il più profondamente possibile le loro simpatie di un tempo, per apparire al di sopra di ogni sospetto politico.
Una o due delle riviste liberali che ancora erano tollerate, grazie soprattutto all’abilità diplomatica dei loro direttori, avevano raccolto un materiale eccellente, capace di provare la miseria sempre crescente e le condizioni disperate della gran massa dei contadini, e mettevano in luce gli ostacoli cui si trovava di fronte chi avesse realmente voluto lavorare per il progresso. L’insieme di questi fatti era sufficiente per gettare chiunque nella disperazione. Ma nessuno osava suggerire un rimedio, o additare un’azione possibile o una via d’uscita da una situazione giudicata disperata. Alcuni scrittori speravano ancora che Aleksandr II riassumesse l’atteggiamento di riformatore, ma fra la maggioranza la paura di vedersi soppresse le riviste e di veder mandare i direttori e i loro collaboratori “in posti più o meno remoti dell’Impero”, dominava ogni altro sentimento. Paura e speranza li paralizzavano in egual misura.
Quanto più radicali erano stati dieci anni prima, tanto più grandi erano i loro terrori. Mio fratello ed io fummo accolti molto bene in uno o due di questi circoli letterari, e ogni tanto andavamo alle loro amichevoli riunioni; ma appena la conversazione incominciava a perdere il suo carattere frivolo, o se mio fratello, che aveva un grande talento per intavolare discussioni serie, portava il discorso sugli affari interni o sulle condizioni della Francia, dove Napoleone III correva verso la catastrofe del 1870, si poteva star certi di un’interruzione di questo genere: “Che ne pensate, signore, dell’ultima rappresentazione della Belle Hélène?”. Oppure: “Qual è la vostra opinione su questo pesce in conserva?”, fatta da uno degli ospiti più anziani; e la conversazione era lasciata cadere.
Fuori dai circoli letterari le cose erano anche peggiori. La Russia del Sessanta, specialmente a Pietroburgo, abbondava di uomini dalle idee avanzate, che sembravano pronti, allora, a qualsiasi sacrificio per la loro fede. “Che cos’è accaduto di loro?”, mi domandavo, e cercavo per trovarne qualcuno. Ma “Silenzio, giovanotto”, era tutto quello che sapevano dirmi, “il ferro è più forte della paglia”, oppure: “non si può dar la testa nel muro” e proverbi del genere, anche troppo numerosi, purtroppo, nella lingua russa, costituivano il nuovo codice di filosofia pratica. “Noi abbiamo fatto qualche cosa nella nostra vita, non chiedeteci di più”; oppure: “abbiate pazienza, questo stato di cose non durerà”, dicevano; mentre noi, i giovani, eravamo pronti a riprendere la lotta, ad agire, ad arrischiare, a sacrificare tutto, se necessario, e chiedevamo loro solo dei consigli, una guida e l’aiuto della loro intelligenza.
Turgenev in Fumo ha dipinto alcuni degli ex riformatori dell’alta società, e la pittura è scoraggiante. Ma è specialmente nelle sconsolate novelle e nei bozzetti della signora Chvoščinskaja, che scriveva sotto lo pseudonimo di V. Krestovskij (da non confondersi con l’altro romanziere Vsevolod Krestovskij) che si può vedere nei suoi vari aspetti la degradazione in cui erano caduti a quel tempo i “liberali del Sessanta”. La gioia di vivere – forse la gioia di essere sopravvissuti – diventò la loro dea, appena le oscure folle che dieci anni prima avevano fatto la forza del movimento riformista rifiutarono di porgere ascolto a “tutto quel sentimentalismo”. Essi si affrettarono a godere delle ricchezze che affluivano nelle mani degli uomini “pratici”.
Con l’abolizione della servitù si offrivano molti mezzi nuovi di far fortuna, e gli arrivisti si precipitavano con ardore verso le nuove vie. Si costruivano febbrilmente le ferrovie; i proprietari terrieri venivano numerosi alle nuove banche private, aperte da poco, a ipotecare le loro tenute; i notai privati, un’istituzione recente, e gli avvocati dei tribunali entrarono in possesso di forti rendite; le società per azioni si moltiplicarono con rapidità sorprendente e gli imprenditori prosperavano. Una classe di persone che prima avrebbe vissuto in campagna con la modesta rendita di una piccola tenuta coltivata da un centinaio di servi, o sul salario anche più modesto di un funzionario al tribunale civile, ora faceva fortuna e aveva rendite quali al tempo della servitù erano possibili solo ai grandi proprietari terrieri.
Gli stessi gusti della “società” erano degenerati. L’Opera italiana, che si prestava un tempo alle dimostrazioni radicali, ora era deserta; l’Opera russa, che affermava timidamente i diritti dei suoi grandi compositori, era frequentata solo da pochi entusiasti. L’una e l’altra erano considerate “noiose” e il fiore della società di Pietroburgo affollava un teatro volgare, dove le stelle di second’ordine dei teatri parigini guadagnavano facili allori fra gli ammiratori appartenenti alla jeunesse dorée, o andava a vedere la Belle Hélène, che si rappresentava al teatro russo, mentre i nostri grandi autori erano dimenticati e la musica di Offenbach trionfava.
E necessario dire che l’atmosfera politica era tale da scusare almeno l’inerzia dei nostri uomini migliori. Dopo che [Dmitrij] Karakozov nell’aprile del 1866 attentò alla vita di Aleksandr II, la polizia di Stato divenne onnipotente. Chiunque fosse sospetto di “radicalismo”, qualunque cosa avesse fatto o non fatto, doveva vivere nella paura di essere arrestato di notte da un momento all’altro, per la simpatia che poteva aver dimostrato per questo o quello dei coinvolti in qualche processo politico, o per una lettera innocente intercettata in qualche perquisizione notturna, o semplicemente per le sue “pericolose opinioni”; e un arresto per sospetti politici poteva significare qualsiasi cosa: anni di reclusione nella fortezza dei SS. Pietro e Paolo, deportazione in Siberia o anche la tortura nelle casematte della fortezza.
Questo movimento rivoluzionario di Karakozov è rimasto finora poco conosciuto anche in Russia. Io ero allora in Siberia e lo conosco solo attraverso i “si dice”. Sembra però che in esso si incontrassero due correnti diverse. Una era il principio di quel grande movimento sociale “verso il popolo”, che più tardi ebbe una formidabile estensione, mentre l’altra corrente era essenzialmente politica. Gruppi di giovani, alcuni dei quali si avviavano a diventare brillanti professori universitari o uomini di valore come storici, o etnografi, si riunirono verso il 1864 con l’intenzione di portare al popolo educazione e istruzione a dispetto dell’opposizione governativa. Essi andarono come semplici artigiani nelle grandi città industriali e vi organizzarono associazioni, cooperative e scuole libere, nella speranza che, usando molto tatto e molta pazienza, sarebbero riusciti a educare il popolo e quindi a creare i primi centri dai quali gradualmente avrebbero diffuso fra le masse più alte e più nobili idee. Il loro zelo fu grande; fortune considerevoli furono messe al servizio della causa; e sono propenso a credere che, in confronto a movimenti simili sorti più tardi, questo era forse fondato sulle basi più concrete. I suoi iniziatori erano veramente molto vicini al popolo lavoratore. D’altra parte, con alcuni dei membri di queste associazioni – Karakozov, [Nikolaj] Išutin e i loro amici più intimi – il movimento prese un indirizzo politico. Negli anni che corrono fra il 1862 e il 1866 la politica di Aleksandr II prese un carattere decisamente reazionario; egli si circondò di uomini del tipo più reazionario, prendendoli come i suoi più intimi consiglieri; le importanti riforme che avevano fatto la gloria del principio del suo regno venivano ora rese vane per mezzo di decreti e circolari ministeriali; tra quanti rimpiangevano il passato si invocava apertamente un ritorno alla giustizia feudale e a un larvato servaggio, mentre nessuno a quell’epoca poteva sperare che la riforma più importante – l’abolizione della servitù – potesse resistere agli assalti che le sferrava contro lo stesso partito che aveva sede al Palazzo d’Inverno.
Questo stato di cose deve aver indotto Karakozov e i suoi amici a pensare che il prolungarsi del regno di Aleksandr II fosse una minaccia anche per quel poco che era stato guadagnato e che la Russia sarebbe ritornata agli orrori di Nicola I se Aleksandr avesse continuato a dominare. Allo stesso tempo si nutrivano grandi speranze – è questa una storia vecchia e sempre nuova – sulle tendenze liberali dell’erede al trono e di suo zio Costantino. Devo anche dire che prima del 1866 timori e considerazioni del genere venivano espressi di frequente in molti circoli posti più in alto con i quali Karakozov sembra essere stato in contatto. In ogni modo Karakozov sparò su Aleksandr II un giorno che questi usciva dal Giardino d’Estate per salire in carrozza. Il colpo falli e Karakozov fu arrestato sul posto.
Katkov, il capo del partito reazionario a Mosca, abilissimo anche a trarre profitto pecuniario da ogni turbamento politico, accusò immediatamente i liberali e i radicali di complicità con Karakozov, cosa indubbiamente falsa, e insinuò nel suo giornale, cosa che tutta Mosca credette, che Karakozov fosse un semplice strumento nelle mani del granduca Costantino, il capo del partito delle riforme nelle alte sfere. Si può immaginare come sfruttassero queste accuse, e i terrori di Aleksandr II, i due governatori Suvalov e Trepov.
Michail Muravëv, che durante l’insurrezione polacca si era guadagnato il soprannome di “impiccatore”, ricevette l’ordine di svolgere una severa inchiesta e di scoprire con tutti i mezzi possibili il complotto di cui si supponeva l’esistenza. Egli fece degli arresti in tutte le classi sociali, ordinò centinaia di processi e si vantò dicendo che “avrebbe trovato il mezzo di rendere i prigionieri più comunicativi”. Non era certamente uomo da indietreggiare neppure davanti alle torture; e a Pietroburgo l’opinione pubblica era unanime nel ritenere che Karakozov fosse stato torturato per ottenerne delle confessioni, che egli però non fece.
I segreti di Stato sono ben conservati nelle fortezze, soprattutto in quell’enorme colosso di pietra che sorge di fronte al Palazzo d’Inverno, testimone di tanti orrori, solo nei tempi più recenti svelati dagli storici. Là dentro sono i segreti di Muravëv! Tuttavia quel che sto per raccontare getterà forse un po’ di luce su quei fatti. Nel 1866 mi trovavo in Siberia. Uno dei nostri ufficiali siberiani, viaggiando verso la fine dell’anno dalla Russia a Irkutsk, incontrò a una stazione di posta due gendarmi. Avevano accompagnato in Siberia un funzionario condannato per furto, e tornavano a casa. Il nostro ufficiale di Irkutsk, uomo piacevolissimo, trovò i gendarmi alla tavola del tè una fredda notte d’inverno, si unì a loro a chiacchierare mentre si cambiavano i cavalli. Uno dei due aveva conosciuto Karakozov.
“Era un uomo furbo”, diceva. “Quando fu in fortezza ci ordinarono, due per volta (montavamo la guardia ogni due ore), di non lasciarlo dormire. Noi lo tenevamo quindi seduto su di un piccolo sgabello e appena incominciava a prendere sonno lo scuotevamo per tenerlo sveglio... Che volete? Ci si comandava cosi!... Bene, guardate un po’ com’era furbo: egli sedeva con le gambe incrociate, dondolando una delle gambe per farci credere di esser sveglio, e intanto riusciva a fare un piccolo sonno, continuando a dondolare la gamba. Ma noi ce ne accorgemmo presto e lo dicemmo a quelli che venivano dopo di noi, così che lo si scuoteva e svegliava ogni momento, sia che scuotesse la gamba o no”. “E per quanto tempo faceste questo?”... “Oh, per parecchi giorni; più di una settimana!”...
Il tono ingenuo del racconto è di per se stesso una prova della sua veridicità: non può essere stato inventato, e si può considerare assolutamente certo che Karakozov sia stato torturato fino a questo punto.
Uno dei miei amici del Corpo dei Paggi fu presente alla esecuzione di Karakozov con il suo reggimento di corazzieri. “Quando fu portato fuori dalla fortezza”, egli mi disse, “e fatto sedere sull’alta piattaforma del carro, che sobbalzava sugli aspri spalti della fortezza, la mia prima impressione fu che si fosse portato fuori un fantoccio di gomma per essere impiccato, e che Karakozov fosse già morto. Immaginate che la testa, le mani, tutto il corpo ciondolava come se in esso non vi fossero ossa, o come se le ossa fossero state tutte rotte. Era veramente una cosa terribile vederlo, per i pensieri che il suo stato suscitava. Tuttavia, quando due soldati lo fecero scendere dal carro, vidi che egli muoveva le gambe e faceva sforzi disperati per camminare e salire la scala del patibolo. Non era dunque un fantoccio, né poteva essere svenuto. Tutti gli ufficiali erano molto perplessi di questa circostanza, e non se la sapevano spiegare”. Quando però io suggerii al mio amico che forse Karakozov era stato torturato, egli arrossì e rispose: “Lo pensammo tutti!”.
La mancanza di sonno per parecchie settimane è certo sufficiente a spiegare lo stato in cui si trovava quest’uomo, di un’altissima forza morale, durante l’esecuzione. Posso aggiungere che ho l’assoluta certezza che – almeno in un caso – furono somministrate delle pozioni nocive a un prigioniero della fortezza, a un certo Subarov, nel 1879. Muravëv limitò a questo la tortura? Gli fu impedito di proseguire con questi sistemi? Io non lo so. Ma questo so con certezza: che ho udito sovente alti ufficiali a Pietroburgo dire che in questo caso si era ricorsi alla tortura. Muravëv aveva promesso di sradicare tutti gli elementi radicali di Pietroburgo, e tutti quelli che avevano un certo passato politico sospetto vivevano ora sotto la paura di cadere nelle mani del despota. Essi si tenevano lontani prima di tutto dai giovani, per il timore di essere coinvolti con loro in qualche pericolosa associazione politica. Si apri così un abisso non solo fra i “padri” e i “figli”, come li descrive Turgenev nel suo romanzo, non solo fra le due generazioni, ma anche fra gli uomini che avevano passato la trentina e quelli che erano nella prima giovinezza. La gioventù russa si trovava quindi nella situazione non solo di dover combattere nei propri padri i difensori della servitù, ma di essere lasciata del tutto a se stessa dai suoi fratelli maggiori, non disposti a unirsi a lei nella sua tendenza al socialismo e timorosi di appoggiarla anche nella sua lotta per la libertà politica. Vi furono mai prima d’allora nella storia, mi chiedo, dei giovani impegnati in una lotta contro un nemico tanto formidabile, e così abbandonati dai loro padri e persino dai loro fratelli maggiori, anche se questi giovani avevano solo a cuore, e avevano cercato di realizzare, l’eredità spirituale di quegli stessi padri e fratelli? Vi fu mai lotta intrapresa in condizioni più tragiche di questa?
L’unico punto luminoso che trovai nella vita di Pietroburgo fu un serio movimento d’avanguardia fra la gioventù d’ambo i sessi. Varie correnti vi confluirono e produssero quella fervida agitazione che prese ben presto un carattere clandestino e rivoluzionario, e attirò l’attenzione della Russia durante i quindici anni che seguirono. Vi accennerò in un prossimo capitolo, ma devo ora ricordare il movimento che si sviluppò apertamente fra le nostre donne, per ottenere l’ammissione agli studi superiori. In questo periodo Pietroburgo ne era il centro principale.
Ogni pomeriggio la giovane sposa di mio fratello, al suo ritorno dal corso di pedagogia per le donne che seguiva, aveva qualche novità da raccontarci a proposito dell’animazione che vi regnava. Si formulavano delle proposte per aprire delle università e delle accademie di medicina per donne; discussioni sulle scuole e sui diversi metodi di educazione venivano organizzate contemporaneamente ai corsi, e centinaia di donne prendevano un appassionato interesse a queste questioni, discutendone a lungo tra di loro. Si costituivano società di traduttori, editori, stampatori, legatori, allo scopo di dar lavoro alle sorelle più povere della comunità che affollavano Pietroburgo, pronte a fare qualsiasi cosa, nella speranza di ottenere anch’esse, un giorno, la loro parte nell’educazione superiore. Una vita rigogliosa, esuberante regnava in questi centri femminili, in sorprendente contrasto con quello che potevo osservare altrove.
Poiché il governo si era mostrato deciso a non voler ammettere donne alle università esistenti, esse diressero i loro sforzi a ottenere l’apertura di proprie università. Era stato loro detto al Ministero della Pubblica Istruzione che le ragazze provenienti dai ginnasi femminili (le scuole normali) non erano preparate per seguire i corsi universitari.
“Bene”, replicarono “permetteteci di aprire corsi intermedi preparatori all’università e imponeteci il programma che preferite: noi non chiediamo aiuti allo Stato. Dateci solo il permesso e noi lo faremo”. Naturalmente il permesso non fu concesso.
Istituirono allora corsi privati e sale di lettura in ogni parte di Pietroburgo. Parecchi professori universitari, simpatizzanti con il movimento, si offrirono a dare lezione. Poveri essi stessi, avvertirono le organizzatrici che ogni proposta di compenso sarebbe stata considerata un’offesa personale. Ogni estate di solito si facevano escursioni speciali nei dintorni di Pietroburgo per lo studio delle scienze naturali, sotto la guida di professori universitari, e le donne formavano la massa degli escursionisti. Nei corsi per levatrici obbligarono i professori a trattare a fondo ogni argomento, più di quanto fosse richiesto dal programma, o ad aprire corsi supplementari. Approfittavano di ogni possibilità, di ogni breccia aperta nella fortezza per smantellarla. Ottennero l’ammissione al laboratorio di anatomia del vecchio dottor Gruber, e con il loro ammirevole lavoro conquistarono alla loro causa questo entusiasta dell’anatomia. Se venivano a sapere che un professore era disposto a lasciarle lavorare nel proprio laboratorio la domenica e la sera dei giorni feriali, approfittavano subito del permesso e lavoravano fino a tarda notte durante la settimana e tutto il giorno la domenica.
Finalmente, nonostante l’opposizione del Ministero, si aprirono i corsi intermedi, con il modesto nome di corsi pedagogici. Era possibile, difatti, proibire a delle future madri di studiare i metodi educativi? Più tardi anche l’insegnamento della botanica e della matematica e delle altre scienze fu introdotto nei corsi pedagogici, che divennero così corsi preparatori all’università.
Poco per volta le donne conquistarono così più ampi diritti. Appena si veniva a sapere che in qualche università tedesca un professore apriva i suoi corsi ad alcune donne, esse battevano alla sua porta e venivano ammesse. Studiavano legge e storia ad Heidelberg e matematica a Berlino; a Zurigo più di cento studentesse frequentarono l’università e il politecnico. Qui esse si guadagnarono qualche cosa di più che le lauree di dottore in medicina: ottennero cioè la stima dei più famosi professori, che espressero più volte pubblicamente il loro compiacimento. Quando andai a Zurigo nel 1872 e feci la conoscenza di alcuni studenti, fui sorpreso nel vedere ragazze giovanissime che studiavano al politecnico, risolvere complicati problemi sulla teoria del calore con l’aiuto del calcolo differenziale, con tanta facilità, come se avessero avuto anni e anni dietro di sé di studio della matematica. Una delle ragazze che studiavano matematica con Weierstrass a Berlino, Sofia Kovalevskij, diventò una matematica famosa e le fu offerta una cattedra all’università di Stoccolma; credo che sia stata la prima donna del secolo che abbia insegnato in un’università per uomini. Era tanto giovane che in Svezia nessuno la chiamava altrimenti che con il suo diminutivo di Sonia.
A dispetto dell’odio aperto che Aleksandr II nutriva per le donne istruite – quando durante le sue passeggiate incontrava una ragazza con gli occhiali e il berretto alla garibaldina incominciava a tremare, pensando che potesse essere una nichilista decisa ad attentare alla sua vita – a dispetto della cieca opposizione della polizia di Stato, che rappresentava ogni studentessa come una rivoluzionaria, a dispetto dei fulmini e delle basse accuse che Katkov in ogni numero del suo velenoso giornale scagliava contro tutto il movimento, le donne riuscirono, sotto il naso del governo, a dar vita a una serie di istituzioni educative. Quando un buon numero di loro ebbero ottenuto il diploma in medicina all’estero, nel 1872 costrinsero il governo a lasciar aprire con i loro mezzi un’Accademia di medicina. E quando le donne russe furono richiamate da Zurigo, per impedire che avessero rapporti con i rivoluzionari che vi si erano rifugiati, esse obbligarono lo Stato a lasciar aprire quattro università femminili, che ben presto ebbero più di mille studentesse. Sembra incredibile, ma è un fatto che nonostante tutte le persecuzioni che l’Accademia medica femminile dovette subire e la sua temporanea chiusura vi sono oggi in Russia più di seicentosettanta donne che esercitano la medicina.
Fu certamente un grande movimento, sorprendente per i suoi successi e istruttivo al più alto grado. Fu soprattutto grazie all’infinita dedizione di una folla di donne di ogni condizione se esse poterono raggiungere il loro scopo. Avevano lavorato come infermiere durante la guerra di Crimea, poi come organizzatrici di scuole, insegnando con abnegazione nelle scuole dei villaggi, come levatrici istruite e come assistenti medici in mezzo ai contadini. Durante la guerra contro la Turchia, nel 1878, andarono come infermiere e dottoresse negli ospedali e si guadagnarono l’ammirazione dei comandanti militari e dello stesso Aleksandr II. Conosco due signore, tutte e due attivamente ricercate dalla polizia di Stato, che servirono come infermiere durante la guerra, con falso nome e passaporti falsi; una di loro, la più pericolosa “criminale” delle due, che aveva preso parte attiva alla mia fuga, fu persino nominata capo infermiera in un grande ospedale per i soldati feriti, mentre la sua compagna quasi moriva di tifo. In breve, le donne penetrarono in tutti i posti, per umili che fossero nella scala sociale e per quante privazioni questi richiedessero, pur di essere utili al popolo; e non furono poche quelle di loro che si sacrificarono, ma centinaia e migliaia. Esse hanno conquistato i loro diritti nel vero senso della parola.
Un’altra caratteristica del movimento fu questa: nelle donne la separazione fra le due generazioni – le sorelle più vecchie e le più giovani – non esisteva, o almeno era molto attenuata. Quelle che erano state alla testa del movimento fin dalle origini non ruppero i legami che le univano alle loro sorelle più giovani, anche se queste avevano idee molto più audaci delle loro compagne più anziane.
Queste ultime continuavano a lottare per i loro ideali fra le classi più alte; si tenevano accuratamente fuori da ogni agitazione politica; ma non commisero mai l’errore di dimenticare che la loro vera forza consisteva in quella numerosa schiera di giovani donne, un gran numero delle quali andava poi a ingrossare le file dei circoli radicali e rivoluzionari. Erano la correttezza in persona – io le consideravo troppo corrette – ma non si separarono mai da quelle giovani studentesse che furono poi le tipiche nichiliste dai capelli corti, che sdegnavano la crinolina e che rivelavano il loro spirito democratico in tutta la loro condotta. Non andavano con loro, e qualche volta anche i dissensi si accentuarono, ma non le ripudiarono mai – una grande cosa, io penso, in tempi come quelli, di pazze e rabbiose persecuzioni.
Sembravano dire alle donne più giovani e più democratiche: “Noi porteremo i nostri abiti di velluto e ci pettineremo alla moda, perché abbiamo a che fare con degli stupidi, che vedono nell’abito di velluto e nella pettinatura alla moda il segno della ‘fiducia politica’: ma voi ragazze, seguite liberamente i vostri gusti e le vostre idee”. Quando le donne che studiavano a Zurigo ebbero dal governo russo l’ordine di ritornare in patria, queste signore non si schierarono contro le ribelli. Dissero semplicemente al governo: “Non vi piace? Bene, aprite qui delle università femminili, altrimenti le nostre ragazze andranno all’estero in numero anche maggiore, e naturalmente si metteranno in contatto con i rifugiati politici”. Quando furono accusate di educare dei rivoluzionari e si minacciò di chiudere le loro accademie e università, esse replicarono: “È vero, molti studenti diventano dei rivoluzionari; ma è una buona ragione per chiudere le università?”. Come sono pochi i dirigenti politici che hanno il coraggio morale di non mettersi contro l’ala più avanzata del loro stesso partito!
Il vero segreto della loro abilità e del loro successo è che nessuna delle donne che furono l’anima di questo movimento fu puramente “femminista”, spinta dall’ambizione di una posizione privilegiata nella società e nello Stato. Al contrario, le simpatie di molte di esse erano per le masse popolari. Ricordo la parte attivissima che la signorina Stasova, la più anziana dirigente dell’agitazione, prese alle scuole domenicali nel 1861, l’amicizia stretta da lei e dai suoi amici con le giovani operaie, l’interesse che essa prese alla dura vita di queste ragazze fuori dalla scuola, le lotte che combatté contro l’egoismo dei padroni. Ricordo l’interesse profondo che dimostravano le donne, nell’istituto di pedagogia, per le scuole rurali e per l’opera di quei pochi che, come il barone Korf, poterono per un certo tempo fare qualche cosa per l’istruzione femminile, e lo spirito di solidarietà che regnava fra di loro. I diritti per cui esse lottavano non erano solo i diritti individuali a un’educazione superiore, ma molto di più, moltissimo di più, il diritto di lavorare e di rendersi utili in mezzo al popolo.
Questa fu la ragione del loro successo.
Negli ultimi anni la salute di mio padre era andata sempre peggiorando, e quando mio fratello Aleksandr ed io andammo a trovarlo nella primavera del 1871, sapemmo dai medici che con i primi freddi dell’autunno avrebbe finito di soffrire. Aveva continuato a vivere secondo le vecchie abitudini, nella Staraja Konjusennaja, ma intorno a lui, in questo quartiere aristocratico, tutto era cambiato. I ricchi proprietari di servi, che un tempo predominavano nel quartiere, erano scomparsi. Dopo aver speso con imperdonabile leggerezza il denaro dei riscatti, che avevano ricavato all’epoca dell’emancipazione, e dopo aver ipotecate e sopra-ipotecate le loro tenute presso le nuove banche agricole che si impinguavano sulla loro incapacità, essi infine si erano ritirati in campagna o nelle città di provincia, dove venivano dimenticati. Le loro case erano state prese da “intrusi” – ricchi mercanti, costruttori di ferrovie, ecc. – mentre in quasi ognuna delle famiglie aristocratiche che ancora rimanevano nel vecchio Quartiere degli Scudieri, una giovane vita lottava per affermare i propri diritti sulle rovine della vecchia. Due generali in ritiro, che maledicevano i nuovi tempi e si consolavano predicendo alla Russia una sicura e rapida rovina sotto il nuovo ordine di cose, e alcuni parenti che venivano a trovarlo di tanto in tanto era tutta la compagnia che aveva allora nostro padre. Dei nostri numerosi parenti, quasi una ventina di famiglie a Mosca durante la mia infanzia, erano rimaste nella capitale due sole famiglie, e queste partecipavano alla nuova vita, le madri discutendo con i loro ragazzi e con le figlie di argomenti del giorno, quali le scuole popolari e le università femminili. Mio padre osservava tutto questo con disprezzo. La mia matrigna e la mia sorellastra Paolina, che non erano cambiate, facevano del loro meglio per consolarlo; ma esse stesse si sentivano a disagio in questo nuovo ambiente.
Mio padre era stato sempre severo e ingiusto verso mio fratello Aleksandr, ma Aleksandr era incapace di portar rancore ad alcuno. Quando entrò nella camera dove egli giaceva malato, lo guardò con lo sguardo dolce e profondo dei suoi occhi azzurro scuro e con il sorriso che diceva la sua infinita bontà; e quando ebbe trovato immediatamente il modo di accomodare meglio il malato nella sua poltrona, lo fece con tanta naturalezza, come se avesse lasciato la camera del malato un’ora prima; l’ammalato ne fu certo confuso, e guardava continuamente suo figlio senza comprenderlo.
La nostra visita portò un po’ di vita nella casa tetra e melanconica; le cure all’infermo erano meno gravose, la mia matrigna, Paolina, persino le persone di servizio si rianimarono, e mio padre si accorse del cambiamento avvenuto.
Una cosa però lo turbava. Si era aspettato di vederci tornare come figli prodighi, imploranti pentiti il suo aiuto. Ma quando cercava di indirizzare la conversazione sulle nostre condizioni, noi lo interrompevamo dicendo allegramente: “Oh, non datevi pensiero per questo, noi stiamo benissimo”, ed egli rimaneva più confuso che mai. Si era aspettato una scena vecchio stile: i figli pentiti e che chiedevano denaro; forse al momento gli dispiacque un po’ che non fosse così, ma ci considerò con maggior rispetto. Al momento della separazione eravamo tutti e tre commossi. Sembrava quasi temesse di ritornare alla sua triste solitudine, circondato dalle rovine di un sistema che egli aveva sempre voluto, ma Aleksandr doveva tornare al suo servizio militare e io partivo per la Finlandia.
Quando fui richiamato a casa dalla Finlandia, corsi a Mosca e trovai il servizio funebre già incominciato, nella stessa vecchia chiesa rossa dove mio padre era stato battezzato e dove erano state recitate le ultime preghiere per sua madre. Mentre il corteo funebre seguiva la vecchia strada di cui fin dall’infanzia conoscevo ogni casa, notai esternamente ben pochi cambiamenti, ma sapevo che in ognuna di esse una vita nuova era incominciata.
In un palazzo che prima era stato proprietà di nostra nonna, poi della principessa Mirskij, e che era stato comperato recentemente dal generale N., un vecchio abitante del quartiere, l’unica figlia sostenne per due anni una lotta penosa contro i suoi genitori, pieni di buone intenzioni ma ostinati, che l’adoravano ma non volevano lasciarle seguire i corsi universitari che erano stati aperti per le signorine di Mosca. Ottenne finalmente il permesso di frequentare la scuola, vi andava però in un’elegante carrozza, sotto l’occhio vigile della madre, che sedeva coraggiosamente per lunghe ore sulle panche in mezzo agli studenti, vicino all’amata figlia; eppure, nonostante tutte queste cure e precauzioni, due anni dopo la figlia si iscrisse al partito rivoluzionario, fu arrestata e passò un anno nella fortezza dei SS. Pietro e Paolo.
Nella casa di fronte due dispotici genitori, il conte e la contezza Z., sostenevano un’aspra lotta contro le loro due figlie, stanche della vita oziosa e inutile imposta loro dalla famiglia e desiderose di unirsi a quelle altre ragazze che, libere e felici, accorrevano agli studi universitari. La lotta durò lunghi anni; questa volta i genitori non cedettero, con il risultato che la figlia maggiore si uccise avvelenandosi, dopo di che la sorella minore ebbe il permesso di realizzare i propri desideri. Nella casa vicina, che era stata nostra per un anno, quando vi entrai con čajkovskij per tenervi la prima riunione segreta di un circolo che avevamo fondato a Mosca, riconobbi allora subito le stanze che mi erano state familiari, in condizioni così diverse, da bambino. Ora apparteneva alla famiglia di Natalia Armfeld, quella “deportata” di Cara, così simpatica, descritta con tanta tenerezza da George Kennan nel suo libro sulla Siberia.
E fu in una casa a pochi passi da quella dove morì mio padre che, pochi mesi più tardi, io accolsi [Sergej Kravtjinskij] Stepnjak vestito da contadino, fuggito da un villaggio dove faceva propaganda socialista in mezzo ai contadini.
Tale era il cambiamento avvenuto nell’ambiente del Vecchio Quartiere degli Scudieri negli ultimi quindici anni. Anche questa roccaforte dell’antica nobiltà era ormai invasa dallo spirito moderno.
L’anno seguente, al principio della primavera, feci il mio primo viaggio nell’Europa occidentale. Passata la frontiera russa, provai, con intensità maggiore di quanto avrei creduto, quello che ogni russo sente lasciando la patria. Finché il treno attraversa il territorio russo, specialmente nelle province scarsamente popolate del Nord-ovest, pare di percorrere un deserto. Per centinaia di chilometri il terreno è coperto di boscaglia che non merita il nome di foresta. Qua e là l’occhio scopre qualche paesello povero e squallido, sepolto sotto la neve, o qualche strada di villaggio, stretta e impraticabile per il fango. Ma tutto, paesaggio e ambiente, cambia aspetto improvvisamente appena il treno entra nella Prussia, con le sue borgate pulite e le sue fattorie, i suoi giardini e le sue strade lastricate, e il contrasto si fa sempre più sentire a mano a mano che si penetra in Germania. Anche la monotona Berlino sembra animata in confronto delle nostre città russe.
E quale differenza di clima! Due giorni prima avevo lasciato Pietroburgo sotto la neve alta, e ora, nella Germania centrale, passeggiavo senza cappotto, al sole caldo, ammirando i fiori che sbocciavano. Poi venne il Reno e finalmente la Svizzera, luminosa di sole, con i suoi alberghi piccoli e lindi dove si prendeva la colazione all’aperto, godendo il panorama delle montagne coperte di neve. Mai prima di allora avevo capito così chiaramente quale importanza abbia per la Russia la sua posizione settentrionale, e quanto abbia influito sulla storia della nazione russa il fatto che i suoi centri principali si siano dovuti sviluppare a delle latitudini tanto settentrionali quanto le spiagge del Golfo di Finlandia. Solo allora compresi l’attrazione che i paesi meridionali hanno sempre avuto per i Russi, gli sforzi immensi che essi hanno fatto per raggiungere il Mar Nero e la pressione continua dei coloni siberiani verso il mezzogiorno, giù nella Manciuria.
A quel tempo Zurigo era piena di studenti russi, uomini e donne. La famosa Oberstrasse, vicina al Politecnico, era un angolo di Russia, dove la lingua russa aveva il sopravvento su tutte le altre. Gli studenti vivevano come vive la maggior parte della gioventù russa, soprattutto le donne – cioè di pochissimo. Il tè e il pane, un po’ di latte e una fettina di carne cotta sul fornello a spirito e mangiata fra le discussioni animate sulle ultime notizie dal mondo socialista o sull’ultimo libro letto, era il loro regime abituale. Quelli che avevano più del denaro necessario per fare una vita del genere lo davano per “la causa comune” – la biblioteca, la rivista russa che si stava per pubblicare, e a sostegno dei giornali operai svizzeri. Quanto ai loro abiti, prevaleva la più rigida economia. Puskin ha scritto i versi famosi: “Quale cappello non starebbe bene a una fanciulla di sedici anni?”. Le nostre ragazze a Zurigo sembravano sfidare gli abitanti della vecchia città zwingliana con questa domanda: “Vi può essere semplicità negli abiti che non si addica a una ragazza, quando è giovane, intelligente e piena di energia?”.
Con tutto questo la piccola attiva comunità lavorava più alacremente di qualsiasi altra da che esistono le università a questo mondo, e i professori di Zurigo non si stancavano di citare i progressi delle donne russe, come incitamento agli uomini.
Da molti anni desideravo ardentemente informarmi su quanto riguardava l’Associazione Internazionale dei Lavoratori. I giornali russi la citavano non di rado nelle loro colonne, ma era proibito parlare del suo programma o della sua attività. Indovinavo che doveva essere un gran movimento, gravido di conseguenze, ma non riuscivo ad afferrare i suoi scopi e le sue tendenze. Ora, libero nella Svizzera, decisi di appagare il mio desiderio.
L’Associazione aveva raggiunto allora il suo pieno sviluppo. Grandi speranze si erano destate tra il 1840 e il 1848 nel cuore dei lavoratori europei. Incominciamo solo ora a renderci conto dell’enorme quantità di letteratura socialista pubblicata durante quegli anni dai socialisti di ogni colore, cristiani, socialisti di Stato, fourieristi, sansimoniani, owenisti e così via, e solo ora si incominciava a capire tutta l’importanza di quel movimento e a scoprire che molte cose che la nostra generazione ha creduto il risultato del pensiero contemporaneo erano già state dette e sviluppate – spesso con grande profondità – durante quegli anni. Allora i repubblicani intendevano con il termine “repubblica” una cosa ben diversa dall’organizzazione democratica del regime capitalista che oggi passa sotto quel nome. Quando parlavano degli Stati Uniti d’Europa intendevano la fratellanza dei lavoratori, le armi trasformate in strumenti di lavoro e questi strumenti adoperati da tutti i componenti la società, per il bene di tutti – “il ferro restituito alle mani dell’operaio” – come disse Pierre Dupont in una delle sue canzoni. Intendevano non soltanto l’uguaglianza davanti alla legge penale e dei diritti politici, ma soprattutto l’uguaglianza economica. I nazionalisti stessi sognavano la Giovane Italia, la Giovane Germania e la Giovane Ungheria mettersi alla testa di vaste riforme agrarie ed economiche.
La sconfitta di giugno a Parigi, quella dell’Ungheria davanti agli eserciti di Nicola I, e dell’Italia colpita dall’Austria e dalla Francia, e la terribile reazione nel campo della politica e delle idee che ne fu la conseguenza dappertutto in Europa, distrussero completamente quel movimento. La sua letteratura, le sue imprese, gli stessi suoi princìpi di rivoluzione economica e di fratellanza universale andarono perduti, dimenticati durante il ventennio seguente.
Un’idea però era sopravvissuta – l’idea di una fratellanza internazionale di tutti i lavoratori, che alcuni emigranti francesi continuarono a predicare negli Stati Uniti, e i seguaci di Robert Owen in Inghilterra. L’accordo fra alcuni lavoratori inglesi e pochi delegati operai francesi all’Esposizione Internazionale di Londra nel 1862 fu il punto di partenza di un movimento formidabile, che ben presto si diffuse per tutta l’Europa, contando nelle sue file parecchie migliaia di lavoratori. Le speranze assopite da vent’anni si ridestarono quando i lavoratori furono esortati a unirsi “senza distinzione di fede, sesso, nazionalità, razza o colore”, per proclamare che “l’emancipazione dei lavoratori deve essere frutto dei loro stessi sforzi” e per portare all’evoluzione dell’umanità le forze di un’organizzazione internazionale salda e unita – non in nome dell’amore e della carità, ma in quello della giustizia, della forza che possiede un gruppo di uomini fatto cosciente delle proprie mete e delle proprie aspirazioni.
Due scioperi avvenuti a Parigi nel 1868 e nel 1869, sostenuti più o meno da piccole contribuzioni ricevute dall’estero, specialmente dall’Inghilterra, anche se di per se stesse insignificanti, e le persecuzioni del governo imperiale contro l’Internazionale, dettero origine a un vasto movimento che proclamò la solidarietà dei lavoratori di tutti i paesi di fronte alle rivalità fra gli Stati. L’idea di un’unione internazionale di tutti i lavoratori e di una lotta contro il capitale sostenuta internazionalmente esaltava anche i lavoratori più indifferenti. Il movimento si diffuse rapido come il fuoco in Francia, nel Belgio, in Italia e in Spagna, facendo conoscere un gran numero di operai intelligenti, attivi e devoti e attirando nelle sue fila molti uomini e donne di intelligenza superiore delle classi ricche e colte. Una forza, fino a quel momento insospettata, si faceva ogni giorno più sentire in Europa; e se lo sviluppo del movimento non fosse stato arrestato dalla guerra franco-prussiana, si sarebbero senza dubbio verificati grandi avvenimenti in Europa, capaci di modificare profondamente la nostra civiltà e indubbiamente di accelerare il progresso dell’umanità. Disgraziatamente la vittoria schiacciante dei Tedeschi produsse condizioni anormali in Europa; arrestò per un quarto di secolo lo sviluppo della Francia e gettò l’Europa intera in un periodo di militarismo che perdura ancora.
A quell’epoca si discorreva fra i lavoratori del grande problema sociale e si proponevano mille soluzioni: la cooperazione, le associazioni di produzione sovvenzionate dallo Stato, le banche popolari, il credito gratuito, e così via. Ognuna di queste soluzioni veniva presentata alle “sezioni” dell’Associazione per essere poi discussa calorosamente nei Congressi locali, regionali, nazionali e internazionali. Ogni Congresso annuale dell’Associazione segnava un nuovo passo avanti nell’elaborazione delle idee sulla questione sociale che si pone di fronte alla nostra generazione, esigendo una soluzione. Non è mai stata abbastanza apprezzata la somma di cose interessanti che furono dette a questi Congressi, e di idee scientificamente corrette e profondamente meditate che vi furono esposte, come risultato del pensiero collettivo dei lavoratori. Non è un’esagerazione dire che tutti i progetti di ricostruzione sociale che si comprendono ora sotto la denominazione di “socialismo scientifico” o di “anarchismo” ebbero la loro origine nelle discussioni e nei rapporti dei vari Congressi dell’Associazione Internazionale. I pochi uomini di cultura che si unirono al movimento non fecero altro che dare una forma teorica alle critiche e alle aspirazioni esposte nelle sezioni prima e poi nei Congressi dai lavoratori stessi.
La guerra del 1870-1871 frenò lo sviluppo dell’Associazione, ma non lo arrestò. In tutti i centri industriali della Svizzera esistevano numerose e attive sezioni dell’Internazionale e migliaia di operai accorrevano alle riunioni nelle quali si dichiarava guerra all’attuale sistema della proprietà privata della terra e delle fabbriche e si proclamava prossima la fine del regime capitalistico. In vari punti del paese si tenevano Congressi locali, e in ognuna di queste riunioni venivano discussi i problemi più ardui dell’attuale organizzazione sociale, con una competenza e una profondità di concetti che spaventava la borghesia anche più del numero degli aderenti alle varie sezioni o ai gruppi dell’Internazionale. Incominciavano a dissolversi quelle gelosie e quei pregiudizi che esistevano in Svizzera fra i mestieri privilegiati (come gli orologiai e i gioiellieri) e quelli meno qualificati (tessitori, muratori, ecc.), che aveva impedito fino a quel momento la loro unione nelle lotte operaie. Gli operai affermavano con enfasi sempre maggiore che di tutte le divisioni che esistono nella società moderna la più importante è quella fra i possessori del capitale e quelli che nascono sprovvisti di tutto e sono condannati a vivere come produttori di ricchezza per i pochi privilegiati.
In Italia, specialmente nell’Italia centrale e settentrionale, pullulavano i gruppi e le sezioni dell’Internazionale, e questi dichiaravano che l’Unità italiana, per la quale si era tanto lottato, non era che una delusione. Si esortavano gli operai a compiere la loro rivoluzione, i contadini a impossessarsi della terra, gli operai delle fabbriche, e ad abolire l’organizzazione accentratrice e oppressiva dello Stato, la cui missione storica è sempre stata di proteggere e mantenere lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo.
Nella Spagna organizzazioni del genere erano numerose in Catalogna, a Valenza e nell’Andalusia; erano aiutate e unite dai potenti sindacati operai di Barcellona, che avevano già ottenuto la giornata di otto ore per i muratori e i lavoratori affini. L’Internazionale contava non meno di ottantamila iscritti spagnoli, tutti paganti regolarmente la quota. Raccoglieva tutti gli elementi attivi e intelligenti e si era guadagnata la grande simpatia delle masse rifiutandosi decisamente di partecipare agli intrighi politici nel 1871-1872. Le sedute dei suoi Congressi provinciali e nazionali e i manifesti diramati da loro erano dei modelli di critica delle condizioni attuali, condotta con logica stringente e dichiarazioni di ammirevole lucidità degli ideali della classe operaia.
In Belgio, in Olanda e anche in Portogallo si diffondeva lo stesso movimento e già la grande maggioranza e gli elementi migliori dei minatori e tessitori del Belgio erano entrati nell’Associazione. In Inghilterra i sindacati operai si erano anch’essi associati al movimento, almeno in teoria, e senza accettare il socialismo erano pronti ad aiutare i loro fratelli del Continente nelle lotte contro il capitale, specialmente negli scioperi. In Germania i socialisti si erano uniti ai numerosi seguaci di Lassalle, e si gettarono così le prime basi del partito socialdemocratico. L’Austria e l’Ungheria seguivano la stessa strada, e benché un’organizzazione internazionale non fosse allora possibile in Francia, dopo la disfatta della Comune e la conseguente reazione (leggi draconiane erano state promulgate contro gli aderenti all’Internazionale) pure tutti erano convinti che quel periodo di reazione non sarebbe durato a lungo e che presto la Francia si sarebbe associata all’Internazionale e avrebbe avuto in essa un posto importante.
Quando giunsi a Zurigo mi iscrissi in una delle sezioni locali dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori. Chiesi anche ai miei amici russi dove avrei potuto imparare qualche cosa del grande movimento che si sviluppava negli altri paesi. “Leggete”, mi risposero; e mia cognata, che studiava allora a Zurigo, mi portò un gran numero di libri e raccolte di giornali degli ultimi due anni. Passai le giornate e le notti a leggere e ne ebbi un’impressione profonda e incancellabile. Il diluvio di nuove idee che si destavano in me si associa nel mio ricordo a una stanzetta piccolissima e pulita, nell’Oberstrasse, la cui finestra si apriva sul lago azzurro e sulle montagne lontane, dove gli Svizzeri si erano battuti per la loro indipendenza, e sugli svelti campanili della vecchia città, teatro di tante lotte religiose.
La letteratura socialista non è mai stata ricca di volumi. È scritta per i lavoratori, per i quali ogni soldo rappresenta qualche cosa, e la sua forza principale sta negli opuscoletti e nei giornali. E poi chi cerca di imparare qualche cosa sul socialismo trova poco di utile nei libri. Essi contengono le teorie e gli argomenti scientifici in favore delle aspirazioni socialiste, ma non danno idea del modo in cui l’operaio accetta gli ideali socialisti e come conta di metterli in pratica. Non c’è altra risorsa che prendere le collezioni dei giornali e leggerli da cima a fondo, le notizie non meno degli articoli politici, anzi, le prime forse più degli ultimi. Questa lettura rivela tutto un nuovo mondo di rapporti sociali e di metodi di pensiero e d’azione e dà il modo di conoscere ciò che altrove non si trova, la serietà e la forza morale del movimento, come le nuove teorie si siano impadronite degli uomini, il loro desiderio di realizzarle nella vita quotidiana e la forza di soffrire per esse. Tutte le discussioni sull’impossibilità di attuazione del socialismo e sulla necessaria lentezza dell’evoluzione valgono poco, perché solo l’intima conoscenza degli individui della cui evoluzione parliamo può permetterci di giudicare della sua rapidità. Come sarebbe possibile sommare delle cifre ignorandone il valore?
Più leggevo e più mi persuadevo che un nuovo mondo, che sino ad allora avevo ignorato, mi si apriva davanti, un mondo del tutto sconosciuto agli eruditi elaboratori di teorie sociologiche; un mondo che potevo conoscere solo vivendo in mezzo all’Associazione Internazionale dei Lavoratori e partecipando alla loro vita quotidiana. Decisi dunque di fare quella vita per due mesi. I miei amici russi mi incoraggiarono e dopo pochi giorni passati a Zurigo mi recai a Ginevra, che era allora il grande centro del movimento internazionale.
Il luogo dove si riunivano le sezioni ginevrine era il Temple Unique, sede della loggia massonica. Nelle sue ampie sale si potevano radunare più di duemila persone per le riunioni generali, e tutte le sere nelle aule laterali si tenevano riunioni di sezioni e di comitati di ogni genere, o corsi di storia, di fisica, di ingegneria, ecc. I pochi, pochissimi borghesi che si erano uniti al movimento, per lo più francesi rifugiatisi dopo la Comune, davano lezioni gratuite ai lavoratori. Era nello stesso tempo un’università popolare e una fucina d’idee.
Fra i principali capi del movimento del Temple Unique vi era un russo, Nicola Utin, un uomo allegro, intelligente e pieno di vita; e la vera animatrice ne era una signora russa simpaticissima, ben conosciuta fra gli operai con il nome di Madame Olga. Era lei la forza animatrice di tutti i comitati. Fui accolto cordialmente da Utin e da Madame Olga, che mi fecero fare la conoscenza degli uomini più notevoli delle sezioni dei vari mestieri e mi invitarono alle riunioni del Comitato. Vi andai, ma preferivo trovarmi con i lavoratori stessi. Bevendo un bicchiere di vino ad una delle tavole della grande sala, passavo tutte le mie serate in mezzo agli operai e feci presto amicizia con parecchi di loro e con uno scalpellino alsaziano, che aveva lasciato la Francia dopo l’insurrezione della Comune. Aveva dei figli della stessa età dei miei nipotini, persi così improvvisamente pochi mesi prima, e per mezzo dei bambini strinsi presto amicizia con la sua famiglia e con i loro amici. Ebbi così la possibilità di seguire il movimento intimamente e lo conobbi da un punto di vista veramente operaio.
I lavoratori avevano riposto tutte le loro speranze nella unione internazionale. Giovani e vecchi accorrevano al Temple Unique dopo una lunga giornata di lavoro, per approfittare di quel poco di istruzione che vi potevano ottenere o per ascoltare gli oratori che promettevano loro un meraviglioso avvenire, fondato sul possesso collettivo di tutto ciò che occorre agli uomini per la produzione della ricchezza e sulla fratellanza umana, senza distinzione di classe, razza o nazionalità. Tutti speravano che una grande rivoluzione sociale, pacifica o no, non avrebbe tardato a cambiare radicalmente le condizioni economiche. Nessuno desiderava la lotta di classe, ma tutti dicevano che se le classi dirigenti l’avessero reso inevitabile con la loro cieca ostinazione, sarebbe stato necessario combattere perché la lotta portasse come risultato il benessere e la libertà per le masse degli oppressi.
Bisognava aver vissuto in mezzo ai lavoratori in quel periodo per capire l’effetto che ebbe su di loro l’improvviso sviluppo dell’Associazione, la fiducia che vi avevano riposta, l’affetto con cui ne parlavano, i sacrifici che facevano per essa. Ogni giorno, una settimana dopo l’altra, un anno dopo l’altro, migliaia di lavoratori davano il loro tempo e il loro denaro, privandosi anche del cibo pur di assicurare la vita di ogni gruppo, far stampare i giornali, far fronte alle spese dei Congressi, venire in aiuto ai compagni colpiti nella lotta per l’Associazione. Fui impressionato anche dall’azione moralizzatrice esercitata dall’Internazionale. Moltissimi degli internazionalisti parigini erano astemi e tutti avevano abbandonato il vizio di fumare. “Perché dovrei permettermi questo lusso?”, dicevano. Tutto quello che era meschino o volgare spariva, di fronte alle aspirazioni nobili ed elevate.
I profani non possono neppure immaginare i sacrifici fatti dagli operai per sostenere il loro movimento. Ci voleva non poco coraggio per associarsi apertamente a una sezione dell’Internazionale e per affrontare il malcontento del padrone, la possibilità di essere licenziato alla prima occasione e quindi i lunghi mesi senza lavoro che ne seguivano. Ma anche quando tutto va bene il fatto di appartenere a un sindacato di mestiere o a un qualsiasi partito di avanguardia richiede una serie ininterrotta di sacrifici. Anche i pochi soldi dati per la causa comune rappresentano una sottrazione non indifferente al meschino salario dell’operaio europeo, e bisognava sborsare molti soldi ogni settimana. Anche frequentare le riunioni significava un sacrificio. Per noi può essere piacevole passare un paio di ore a una riunione, ma quando si tratta di uomini che incominciano a lavorare alle cinque o alle sei della mattina, vuol dire che devono rubare questo tempo al sonno.
Questa loro devozione era per me un continuo rimprovero. Vedevo come gli operai desiderassero istruirsi e come fossero disperatamente pochi quelli che si offrivano di aiutarli. Vedevo come fosse necessario alle masse affaticate l’aiuto di persone colte e pronte a disporre del loro tempo per la diffusione e lo sviluppo dell’organizzazione; ma erano ben pochi quelli che davano il loro aiuto senza pensare di servirsi della potenza delle masse per i loro interessi politici! Sentivo ogni giorno di più il dovere di unire il mio destino al loro. Nel romanzo La carriera di un nichilista Stepnjak dice che nella vita di ogni rivoluzionario c’è stato un momento in cui qualche circostanza, in se stessa forse insignificante, lo ha spinto a votarsi alla rivoluzione; per me quel momento venne dopo una delle riunioni al Temple Unique, quando sentii profondamente tutta la viltà degli uomini colti che esitano a dedicare la loro cultura, le loro cognizioni, la loro energia a vantaggio di coloro che di quelle conoscenze e di quell’energia hanno tanto bisogno. “Ecco degli uomini”, mi dicevo, “consci della loro servitù, che lavorano per emanciparsi; ma dove sono quelli che possono aiutarli? Dove sono quelli che si dichiarano pronti a servire le masse e non a sfruttarle per i loro scopi ambiziosi?”.
A poco a poco, però, incominciavo ad avere dei dubbi sulla sincerità dell’agitazione che si faceva nel Temple Unique. Una sera un noto avvocato di Ginevra, il signor A., venne alla riunione e dichiarò che se non si era ancora iscritto all’Associazione era perché aveva dovuto prima occuparsi dei suoi affari; ma che ora, dato che li aveva sistemati, si associava al movimento operaio. Fui nauseato da questa confessione cinica e quando ne parlai al mio [amico] scalpellino egli mi spiegò che questo signore era stato sconfitto alle ultime elezioni come candidato del partito radicale e che sperava adesso di farsi eleggere con i voti degli operai. “Accettiamo il loro aiuto per il momento”, concluse il mio amico, “ma quando verrà la rivoluzione il nostro primo pensiero sarà di sbarazzarci di gente simile”.
Vi fu poi una grande riunione, indetta in gran fretta, per protestare, si diceva, contro le calunnie del “Journal de Genève”. Questo organo della borghesia ginevrina aveva osato dire che il Temple Unique preparava dei tumulti e che i muratori e lavoratori affini avrebbero fatto un altro sciopero generale come quello che avevano inscenato nel 1869. I capi del Temple Unique convocarono la riunione. La sala era gremita da migliaia di operai e Utin li pregò di approvare un ordine del giorno che mi sembrò molto strano: era una protesta sdegnosa contro l’asserzione del giornale, del resto inoffensiva, che gli operai preparavano uno sciopero. Perché, mi chiedevo, questa dichiarazione era considerata una calunnia? Era forse un delitto scioperare? Utin intanto terminava un discorso affrettato a favore dell’ordine del giorno, concludendo con queste parole: “Se lo accettate, amici, lo manderò subito alla stampa”. Stava per lasciare la tribuna quando qualcuno nella sala disse che una discussione non sarebbe stata inopportuna. Si alzarono allora, uno dopo l’altro, i rappresentanti dei muratori e dichiararono che negli ultimi tempi i salari erano stati tanto bassi da essere insufficienti a vivere, che si prevedeva per la primavera l’inizio di molti lavori e che si proponevano di approfittare di questa circostanza per chiedere un aumento di salario; aggiungevano che se questo aumento fosse stato rifiutato avrebbero fatto uno sciopero generale.
Io ero furibondo, e il giorno dopo rimproverai aspramente Utin. “Tu, come capo”, gli dissi, “dovevi sapere che si stava realmente preparando uno sciopero!”. Ero troppo ingenuo per sospettare i veri motivi dei dirigenti e fu lo stesso Utin che mi fece capire come uno sciopero in quel momento sarebbe stato disastroso per il successo elettorale dell’avvocato A. e del signor B.!
Non potevo conciliare questi intrighi dei capi con i discorsi infiammati che li avevo sentiti pronunciare. Mi sentivo scoraggiato e parlai a Utin della mia intenzione di mettermi in rapporto con l’altra sezione dell’Associazione Internazionale a Ginevra, conosciuta come quella dei bakuninisti. La parola “anarchico” non si usava ancora. Utin mi diede una lettera di presentazione per un altro russo, Nikolaj žukovskij, che apparteneva a quella sezione, e guardandomi in faccia mi disse sospirando: “Ebbene, non tornerai più fra noi, rimarrai con loro”. E la profezia si avverò.
Mi recai prima di tutto a Neuchâtel e passai poi una settimana o due fra gli orologiai delle montagne del Giura.
Conobbi così quella famosa Federazione del Giura che ebbe tanta parte negli anni seguenti nello sviluppo del movimento socialista introducendovi la tendenza antistatale o anarchica.
Nel 1872 la Federazione del Giura incominciava a ribellarsi all’autorità del Consiglio generale dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori. L’Associazione era essenzialmente un’organizzazione operaia e i lavoratori volevano che fosse un movimento sindacale, non un partito politico. Tanto che nel Belgio orientale avevano introdotto un paragrafo per cui nessuno poteva appartenere a una sezione se non lavorava a qualche mestiere manuale: ne erano esclusi persino i capi-operai.
Gli operai poi erano federalisti. Ogni nazione, ogni regione e persino ogni sezione doveva essere libera di svilupparsi secondo il proprio modo di vedere. Ma i rivoluzionari borghesi della vecchia scuola, che erano entrati nell’Internazionale, saturi delle organizzazioni segrete, centralizzate e autoritarie del loro tempo, avevano introdotto le loro idee in seno all’Internazionale. Oltre ai Consigli federali e nazionali, a Londra fu nominato un Consiglio generale che mantenesse il collegamento fra i vari Consigli nazionali. Marx e Engels ne erano l’anima e lo dirigevano. Ben presto però incominciò ad apparire che il fatto stesso dell’esistenza di una simile organizzazione centrale era fonte di inconvenienti non lievi. Il Consiglio generale non si accontentò della parte di ufficio di corrispondenza; cercò di dirigere il movimento, approvando o biasimando la condotta delle federazioni e delle sezioni locali e anche dei singoli soci. Quando scoppiò a Parigi l’insurrezione della Comune (i capi non potevano che lottare, senza poter dire dove sarebbero andati a finire nelle ventiquattr’ore) il Consiglio generale insistette per dirigere l’insurrezione da Londra. Pretendeva rapporti quotidiani sugli avvenimenti, diramava ordini, approvava questo, cercava di impedire quello, e dette così la prova degli inconvenienti dell’esistenza di una specie di governo anche in seno all’Associazione. Questo inconveniente apparve ancora più evidente quando in una riunione segreta del 1871 il Consiglio generale, con l’approvazione di pochi delegati, decise di servirsi delle forze dell’Associazione per un’agitazione elettorale. Questo portò tutti a riflettere sulle funeste conseguenze di ogni governo accentrato, sia pure radicalmente democratico; nacque allora la prima scintilla del movimento anarchico. La Federazione del Giura diventò il centro dell’opposizione al Consiglio generale.
La divisione fra i capi e gli operai che avevo osservato al Temple Unique di Ginevra non esisteva fra i montanari del Giura. Vi era un gruppo di uomini che si distinguevano per la loro intelligenza e attività; ma era tutto. James Guillaume, uno degli uomini più intelligenti e colti che abbia incontrato in vita mia, era il correttore di bozze e il proto di una piccola tipografia. Guadagnava così poco, che era obbligato a lavorare di notte a tradurre romanzi dal tedesco in francese per otto lire ogni sedici pagine! Quando arrivai a Neuchâtel, mi disse che disgraziatamente non poteva disporre del suo tempo neppure per una conversazione amichevole di un paio d’ore. La tipografia pubblicava quel pomeriggio il primo numero di un giornale locale e oltre il suo lavoro di correttore di bozze e redattore egli doveva scrivere un migliaio di indirizzi di persone a cui mandare i tre primi numeri, e naturalmente preparare la spedizione.
Mi offrii di aiutarlo a scrivere gli indirizzi, ma non fu possibile, perché o li sapeva a memoria o li aveva scritti su pezzetti di carta in una calligrafia illeggibile... “Ebbene”, gli dissi, “verrò nel pomeriggio in ufficio, vi aiuterò nella spedizione e mi dedicherete poi il tempo che avrete risparmiato”.
Ci intendemmo. Guillaume mi strinse cordialmente la mano e fu quello il principio della nostra amicizia. Passammo tutto il pomeriggio in ufficio: egli scriveva gli indirizzi, io chiudevo le buste e un comunardo francese, tipografo, chiacchierava con noi ininterrottamente mentre componeva rapidamente, alla cassa dei caratteri, un romanzo, mescolando la conversazione con le frasi composte, che leggeva ad alta voce.
“La lotta nella strada”, diceva, “divenne terribilmente aspra...”. “Cara Maria ti amo...”. “Gli operai erano furibondi e si batterono come leoni a Montmartre...”, “ed egli cadde in ginocchio davanti a lei...”, “e questo durò quattro giorni. Sapevamo che Galliffet fucilava tutti i prigionieri, e la lotta si fece anche più crudele”, e così di seguito, mentre sceglieva rapidamente le lettere tipografiche.
Era già sera inoltrata quando Guillaume si levò il grembiale e uscimmo per chiacchierare, poi dovette rimettersi al lavoro come redattore del “Bollettino della Federazione del Giura”.
A Neuchâtel conobbi anche [Benoît] Malon. Era nato in un paesino e da ragazzo aveva fatto il pastore. Più tardi era andato a Parigi e vi aveva imparato un mestiere, il cestaio, e con il rilegatore di libri [Eugéne] Varlin e il falegname [Johannard] Pindy, che aveva avuto compagni nell’Internazionale, si era fatto conoscere come uno dei soci più attivi dell’Associazione, quando fu processato da Napoleone III nel 1869. Tutti e tre si erano guadagnati l’affetto dei lavoratori parigini e quando scoppiò l’insurrezione della Comune furono eletti membri del Consiglio con una votazione plebiscitaria. Malon fu anche sindaco di uno degli arrondissement di Parigi. In Svizzera si guadagnava da vivere facendo canestri. Aveva affittato per pochi soldi una baracca fuori della città da cui, mentre lavorava, poteva godere un magnifico panorama del lago di Neuchâtel. Di notte scriveva lettere, un libro sulla Comune e brevi articoli per i giornali operai: divenne così scrittore. Andavo a trovarlo tutti i giorni per sentire questo comunardo dalla faccia larga, laborioso, tranquillo, buono e d’animo poetico raccontare gli episodi dell’insurrezione nella quale aveva avuto tanta parte, e che aveva allora descritto nel suo libro, La terza sconfitta del proletariato francese.
Una mattina, salita la collina e arrivato alla sua baracca, lo vidi venirmi incontro tutto raggiante, dicendo: “Sapete, Pindy è vivo! Ecco la sua lettera, è in Svizzera”. Non si avevano più notizie di Pindy da quando era stato visto l’ultima volta il 25 o 26 marzo alle Tuileries e lo si credeva morto, mentre in verità era rimasto nascosto a Parigi. E Malon, mentre aggiustava abilmente i vimini facendone un elegante cestino, raccontava con la sua voce tranquilla, turbata solo a momenti da un tremito leggero, quanti uomini erano stati fucilati dai soldati di Versailles, perché si credeva fossero Pindy, Varlin o lui stesso, o qualcun altro dei capi. Mi disse quello che sapeva della morte di Varlin, il legatore di libri, l’idolo degli operai parigini, e del vecchio [Louis Charles] Delescluze, che non aveva voluto sopravvivere alla sconfitta, e di molti altri. E mi raccontava gli orrori di cui era stato testimone durante quell’orgia di sangue con la quale i ricchi parigini celebrarono il loro ritorno alla capitale, e poi il desiderio di vendetta che si era impadronito della folla, capitanata da Raoul Rigault, quando vennero messi a morte gli ostaggi della Comune.
Le sue labbra tremavano parlando dell’eroismo dei giovani e non poté frenare la sua emozione quando mi disse di quel ragazzo che i soldati versagliesi stavano per fucilare e che pregò l’ufficiale di accordargli prima il permesso di restituire l’orologio d’argento, che portava, a sua madre che abitava là vicino. L’ufficiale, cedendo a un moto di compassione, lo lasciò andare, sperando probabilmente che non sarebbe tornato. Ma dopo un quarto d’ora il ragazzo era di ritorno, e, mettendosi al muro in mezzo ai cadaveri, diceva: “Sono pronto”. Dodici palle misero fine a quella giovane vita!
Credo di non aver mai sofferto tanto quanto leggendo quel terribile libro, Le livre rouge de la justice rurale che conteneva solo estratti delle lettere dei corrispondenti dello “Standard”, “Daily Telegraph” e “Times”, scritte da Parigi durante gli ultimi giorni del maggio 1871, con il racconto degli orrori commessi dall’esercito versagliese agli ordini di Galliffet, e poche note di “Le Figaro” di Parigi, ispirate a concetti sanguinari contro gli insorti. Leggendo quelle pagine disperavo dell’umanità, e quella disperazione sarebbe durata se non avessi visto poi nei vinti, sopravvissuti a tanti orrori, quella fiducia nel trionfo finale delle loro idee, quello sguardo triste ma calmo, rivolto all’avvenire, quella prontezza a dimenticare l’incubo del passato, che mi colpì in Malon e che notai in quasi tutti i rifugiati della Comune che conobbi a Ginevra e che ancora vedo in Louise Michel, [Gustave] Lefrançais, Elisée Réclus e altri amici.
Da Neuchâtel andai a Sonvilliers. In una piccola vallata in mezzo alle montagne del Giura si susseguono una serie di cittadine e paesi la cui popolazione di lingua francese era allora esclusivamente occupata nei vari rami dell’industria degli orologi; intere famiglie lavoravano nelle loro piccole botteghe. In una di esse trovai un altro capo, Adhemar Schwitzguebel, con il quale entrai poi in una grande intimità. Sedeva in mezzo a una dozzina di giovani occupati a incidere casse di orologi in oro e in argento. Mi pregò di accomodarmi su una panca e ben presto fummo tutti immersi in una discussione sul socialismo, sullo Stato e sull’abolizione dello Stato e sui prossimi Congressi.
La sera sopravvenne una tormenta di neve; ci accecava gelandoci fino alle ossa, mentre camminavamo faticosamente verso il paese vicino. Ma nonostante la tempesta una cinquantina di orologiai, quasi tutti uomini attempati, vennero dalle cittadine e dai paesi vicini – alcuni lontani anche sette miglia – per partecipare a una riunione familiare convocata per quella sera.
L’organizzazione stessa dell’industria degli orologiai, che rende possibile agli associati di conoscersi bene e di lavorare in casa propria, dove sono liberi di parlare liberamente, spiega la ragione per cui il livello intellettuale è più alto che non fra coloro che passano tutta la vita, fin dall’infanzia, nelle fabbriche. Fra gli operai della piccola industria vi è più indipendenza e più originalità di pensiero. Ma anche l’assenza di divisione fra i capi e le masse che c’era nella Federazione del Giura contribuì a far sì che in ogni questione i soci della Federazione cercassero di formarsi un’opinione personale. Vidi che gli operai qui non erano una massa ignara, asservita agli interessi politici di pochi; i loro capi erano semplicemente i più attivi di loro, che più che dirigere, davano l’esempio agli altri. Mi fece una grande impressione la chiarezza di intuito, il buon senso, la capacità di orientarsi e concludere in problemi sociali complessi, di cui davano prova questi operai, specialmente i più anziani; e sono fermamente convinto che se la Federazione del Giura ha avuto una parte importante nel dare impulso al socialismo, non fu solo per l’importanza delle sue teorie federaliste e contro lo Stato, ma anche grazie al significato particolare che il buon senso degli orologiai del Giura aveva dato a queste idee. Senza di loro le teorie anarchiche che allora predominavano sarebbero rimaste per lungo tempo ancora allo stato di semplici astrazioni.
Le teorie anarchiche, come allora incominciavano a essere formulate nella Federazione del Giura, specialmente da Bakunin, la critica al socialismo di Stato, la paura di una tirannide economica molto più pericolosa di una semplice tirannide politica, di cui sentivo parlare, e il carattere rivoluzionario preso dall’agitazione, mi fecero un’impressione molto favorevole. E i rapporti fraterni che prevalevano nel Giura, l’indipendenza di pensiero e di parola che trovavo fra gli operai e la loro sconfinata devozione alla causa mi conquistarono definitivamente: quando lasciai quelle montagne dopo una settimana passata fra gli orologiai, le mie idee in fatto di socialismo erano chiare: ero un anarchico!
Un viaggio che feci poi in Belgio, dove ebbi modo di paragonare l’agitazione politica accentrata che si faceva a Bruxelles con l’agitazione di carattere economico, indipendente, dei tessitori di Verviers, mi confermò ancor più nei miei propositi. Questi tessitori costituivano una delle popolazioni più simpatiche che io abbia incontrato nell’Europa occidentale.
Bakunin si trovava allora a Locarno. Io non lo vidi e mi dispiacque molto, perché quando quattro anni dopo tornai in Svizzera, era già morto. Fu lui ad aiutare i compagni del Giura a veder chiaro nelle loro idee, a dare forma alle loro aspirazioni, ad ispirarli con il suo possente, ardente e irresistibile entusiasmo di rivoluzionario. Appena venne a sapere che un piccolo giornale, che Guillaume aveva incominciato a pubblicare fra le montagne del Giura (a Locle), dava un nuovo contributo di pensiero indipendente al movimento socialista, andò a Locle, parlò alcuni giorni e alcune notti con i suoi nuovi amici, sulla necessità storica di un nuovo passo verso l’anarchia; scrisse su questo giornale una serie di articoli profondi e brillanti sul progresso dell’umanità verso la libertà, entusiasmò i suoi compagni e creò quel centro di propaganda da cui il movimento anarchico si irradiò negli altri paesi d’Europa.
Dopo la sua partenza per Locarno – da dove diede inizio a un movimento simile in Italia e, per mezzo del suo capace e simpatico rappresentante [Giuseppe] Fanelli, anche in Spagna – i giurassiani stessi continuarono per proprio conto il lavoro che egli aveva cominciato nelle montagne del Giura. Il nome di “Michele” ritornava di frequente nelle loro conversazioni, ma non come quello di un capo assente, le cui opinioni fossero legge, bensì come quello di un amico personale, di cui ognuno parla con affetto e con amicizia. Quello che più mi colpì fu l’influenza di Bakunin, grande non tanto per la sua autorità intellettuale, quanto per la sua personalità morale. Quando si parlava di anarchia o della condotta che doveva seguire la Federazione, non sentivo mai dire: “Bakunin ha detto questo” o “Bakunin pensa cosi”, per concludere una discussione. I suoi scritti e le sue parole non erano un testo a cui tutti dovessero obbedienza, come avviene purtroppo nei partiti politici. In tutte le questioni dove l’intelligenza è il giudice supremo, ognuno nella discussione portava i propri argomenti. L’impulso generale e il metodo potevano essergli stati suggeriti da Bakunin, o Bakunin poteva esserseli presi dai suoi compagni del Giura, ma in ogni individuo gli argomenti conservavano il loro carattere individuale. Una volta sola sentii il nome di Bakunin invocato come un’autorità per se stesso, e mi impressionò tanto, che ricordo ancora il luogo dove si svolse questa conversazione e le circostanze particolari. I giovani avevano incominciato in presenza delle donne dei discorsi troppo liberi e non abbastanza rispettosi per il sesso gentile, quando una di loro vi mise fine bruscamente esclamando: “Peccato che Michele non sia qui, vi avrebbe messi subito a posto!”. La colossale figura del rivoluzionario, che aveva dato tutto per amore della rivoluzione e viveva per essa soltanto, attingendo alle sue convinzioni la concezione più alta e più pura della vita, continuava a essere il loro ispiratore.
Tornai da questo viaggio con delle idee ben chiare in fatto di sociologia, che ho conservato anche in seguito, sviluppandole meglio che ho potuto in una forma sempre più concreta e precisa.
Ma vi fu un punto che non accettai prima di avervi dedicato molta riflessione e molte ore delle mie notti. Vedevo con chiarezza che il profondo mutamento indispensabile per mettere tutte le cose necessarie alla vita e alla produzione nelle mani della società (sia essa lo Stato popolare dei socialisti democratici o le libere unioni di gruppi associati, propugnate dagli anarchici), avrebbe richiesto una rivoluzione molto più profonda di quante la storia abbia mai registrato finora. Aggiungete che nel caso di una rivoluzione simile gli operai avrebbero per nemico non la generazione effeminata di aristocratici contro la quale dovettero lottare nel secolo precedente i contadini e i repubblicani francesi (e anche quella fu una lotta disperata), ma la borghesia, tanto più forte, intellettualmente e materialmente, avendo a sua disposizione tutto il potente meccanismo dello Stato moderno. Ma mi resi conto ben presto che nessuna rivoluzione, pacifica o violenta, si è mai avverata, senza che la classe stessa che è stata attaccata nei suoi privilegi economici o politici fosse profondamente imbevuta delle nuove idee.
Testimone dell’emancipazione dei servi in Russia, sapevo che se la classe dei proprietari di servi non fosse stata convinta in gran parte dell’ingiustizia dei propri diritti (convinzione che era la conseguenza di una precedente evoluzione e delle rivoluzioni avvenute nell’Europa occidentale) l’emancipazione non avrebbe potuto aver luogo tanto facilmente come avvenne nel 1861. E vidi che il concetto della liberazione dei lavoratori dal sistema attuale del salario si faceva largo anche in mezzo alla stessa borghesia. I più strenui difensori delle odierne condizioni economiche non parlavano di un preteso diritto per difendere i loro privilegi, parlavano invece dell’inopportunità di simili cambiamenti. Non negavano che fosse desiderabile qualche mutamento in quel senso; solo si chiedevano se una nuova organizzazione economica come quella propugnata dai socialisti sarebbe stata migliore di quella esistente; se una società nella quale i lavoratori avessero una parte preponderante avrebbe saputo organizzare la produzione meglio dei vari capitalisti, spinti solo da considerazioni egoistiche.
Incominciavo poi a capire che le rivoluzioni – i periodi cioè di evoluzione accelerata e di cambiamenti rapidi – sono proprie della società umana quanto l’evoluzione lenta che procede senza sosta fra i popoli civili. E ogni volta che incomincia uno di questi periodi di evoluzione accelerata e di rinnovamento sociale, la guerra civile può scoppiare su scala più o meno grande. Si tratta dunque non tanto di evitare le rivoluzioni, quanto di ottenere i risultati migliori limitando il più possibile la guerra civile, il numero delle vittime e il sopravvento di odi reciproci. Per raggiungere questo scopo non vi è che un mezzo: e cioè che la parte oppressa della società sappia con la maggior chiarezza possibile quello che vuole ottenere e come ottenerlo, e che abbia lo slancio necessario per riuscirvi; in questo caso è certa di attirare nelle sue file le forze migliori per intelligenza ed energia della classe che vanta privilegi consacrati dalla storia.
La Comune di Parigi fu il terribile esempio di un’insurrezione senza uno scopo ben preciso. Quando, nel marzo 1871, gli operai diventarono padroni della grande città, non attaccarono i diritti di proprietà della borghesia. Al contrario, difesero questi diritti. I capi della Comune difesero con i loro corpi la Banca Nazionale e, malgrado la crisi che paralizzò l’industria e la conseguente miseria di una gran parte dei lavoratori, con i loro decreti difesero i diritti dei padroni delle fabbriche, delle industrie e i proprietari delle case di Parigi. Ma quando l’insurrezione fu schiacciata la borghesia non tenne conto della modestia delle rivendicazioni comunarde. I ricchi francesi, vissuti per due mesi nel terrore che i loro diritti di proprietari venissero violati, si vendicarono sui lavoratori come se quei diritti fossero stati violati realmente. Come si sa, quasi 30.000 lavoratori furono massacrati, non in combattimento, ma dopo che avevano perduto la loro battaglia. Se i lavoratori avessero cercato di socializzare la proprietà, la vendetta non avrebbe potuto essere più terribile.
Giunsi quindi alla conclusione che, se vi sono dei periodi nell’evoluzione della società umana, nei quali la lotta è inevitabile e la guerra civile scoppia, indipendentemente dalla volontà degli individui, si deve almeno fare in modo che questo avvenga non in base a vaghe aspirazioni, ma con uno scopo preciso; non su questioni di importanza secondaria, il cui valore limitato non rende la lotta meno aspra, ma in favore di grandi ideali, che per la vastità dell’orizzonte che fanno intravedere suscitano l’entusiasmo degli uomini. In quest’ultimo caso il risultato della lotta dipenderà meno dall’efficacia delle armi che dalla forza del genio creatore che si manifesta nel lavoro di ricostruzione della società. Dipenderà soprattutto dal libero corso dato alle forze costruttive della società; dalla nobiltà superiore delle aspirazioni che conquisteranno così la simpatia anche di quelli che, per interesse di classe, sono contrari a un cambiamento. La lotta, portata così su di un piano più elevato, purificherà da sé l’atmosfera sociale; e il numero delle vittime delle due parti sarà certo inferiore a quello che si avrebbe se la lotta si combattesse su problemi di importanza secondaria, dove hanno libero gioco le passioni umane più meschine.
Tutto preso da queste idee feci ritorno in Russia.
Durante il mio viaggio avevo comperato molti libri e parecchie collezioni di giornali socialisti. Tutte queste pubblicazioni erano “assolutamente proibite” dalla censura russa, e alcune delle collezioni di giornali e di resoconti dei Congressi internazionali non si potevano comperare a nessun prezzo neppure in Belgio. “Posso disfarmene, quando mio fratello e i miei amici di Pietroburgo sarebbero tanto felici di leggerli?” mi chiedevo; e finii col decidere di portarli a ogni costo in Russia.
Tornai a Pietroburgo passando per Vienna e Varsavia. Migliaia di Ebrei vivono di contrabbando lungo il confine polacco, e pensai che se potevo trovarne uno, i miei libri avrebbero attraversato sani e salvi la frontiera. Non sarebbe stato prudente, però, scendere a una piccola stazione di confine mentre tutti gli altri viaggiatori proseguivano la strada, per mettermi alla ricerca dei contrabbandieri; presi quindi una linea secondaria e andai a Cracovia. “La capitale della vecchia Polonia è vicina alla frontiera”, pensavo, “e là troverò qualche ebreo che mi condurrà dagli uomini che cerco”.
Arrivai di sera nella città, un tempo così ricca e famosa, e uscii il giorno dopo di buon mattino per le mie ricerche. Rimasi però interdetto vedendo a ogni angolo, e dovunque volgessi gli occhi nel mercato deserto, un ebreo vestito con la lunga zimarra tradizionale, con la lunga zazzera voluta dall’antico costume, in attesa di qualche nobile o mercante polacco che lo mandasse a fare qualche commissione, per il compenso di pochi soldi. Cercavo un ebreo, e ora ne vedevo troppi. Quale dovevo avvicinare? Percorsi tutta la città e infine, disperato, decisi di rivolgermi all’ebreo che stava alla porta del mio albergo – un vecchio palazzo immenso, ogni sala del quale nei tempi andati era stata affollata da sciami di ballerini e di ballerine eleganti, ma che ora serviva prosaicamente a dare vitto e alloggio a pochi forestieri. Spiegai all’ebreo come desiderassi portare in Russia, di contrabbando, un pacco molto pesante di libri e giornali.
“È facile, signore”, mi rispose. “Vi condurrò il rappresentante della Compagnia Universale per lo Scambio Internazionale dei cosiddetti ‘Cenci e Ossa’. Ha il più grande commercio di contrabbando del mondo, e sono certo che ne sarete contento”. Mezz’ora dopo ritornò davvero con il rappresentante della compagnia, un giovanotto elegantissimo che parlava perfettamente il russo, il tedesco e il polacco.
Guardò il mio pacco, lo soppesò e mi chiese che libri contenesse.
“Veramente sono tutti proibiti dalla censura russa, è per questo che devono passare di contrabbando”.
“I libri”, mi disse, “non sono precisamente il nostro genere: noi traffichiamo in sete preziose. Se dovessi pagare i miei uomini secondo il peso, com’è prescritto nella nostra tariffa per la seta, dovrei chiedervi un prezzo veramente esagerato. A dir la verità, poi, non mi piace molto immischiarmi in affari di libri. Il minimo contrattempo, e ‘loro’ ne farebbero una questione politica, e costerebbe una somma enorme alla Compagnia Universale dei Cenci e Ossa uscirne fuori”.
Probabilmente avevo un’aria molto afflitta, perché il giovane elegante subito aggiunse: “Ma non disperatevi. Lui (l’ebreo dell’albergo) troverà modo di servirvi in qualche altro modo”.
“Ma sì, vi sono tanti mezzi per risolvere un’inezia come questa”, disse il mio intermediario con accento gioviale, e mi lasciò.
Dopo un’ora fece ritorno con un altro giovane. Questi prese il pacco, lo posò vicino alla porta e mi disse: “Va bene, se partite domani troverete i vostri libri alla tale stazione in Russia”, e mi spiegò come avrebbe fatto.
“Quanto costerà?”, domandai.
“Quanto siete disposto a pagare?”, fu la risposta.
Vuotai il mio portafoglio sulla tavola e dissi: “Questo è per il mio viaggio, il resto è vostro. Viaggerò in terza classe”.
“Ahi! Ahi! Ahi!”, esclamarono in coro tutti e due. “Cosa dite, signore? Un pari vostro viaggiare in terza classe! Mai! No, no, no, così non può andare... Bastano otto rubli per noi, poi un rublo circa per l’intermediario... se vi piace. Non siamo dei ladri, ma onesti commercianti”. E si rifiutarono assolutamente di accettare altro denaro.
Avevo sentito spesso parlare dell’onestà dei contrabbandieri ebrei alla frontiera, ma non mi sarei mai aspettato di averne una simile prova. Più tardi, quando il nostro circolo importò molti libri dall’estero o più tardi ancora, quando tanti rivoluzionari e profughi attraversarono la frontiera uscendo dalla Russia o rientrandone, non una volta accadde che qualcuno fosse tradito dai contrabbandieri o che chiedessero un compenso eccessivo per i loro servizi approfittando delle circostanze.
Il giorno dopo partii da Cracovia, e alla stazione russa stabilita, un facchino si avvicinò al mio scompartimento e, parlando ad alta voce, in modo da farsi sentire anche dal poliziotto che camminava lungo la piattaforma, mi disse: “Ecco la valigia che vostra Altezza ha lasciato qui l’altro giorno”, e mi consegnò il pacco prezioso.
Ero così contento di averlo che non mi fermai neanche a Varsavia, ma proseguii fino a Pietroburgo per mostrare i miei trofei a mio fratello.
Un movimento formidabile si stava intanto sviluppando in Russia fra la gioventù colta. La servitù era abolita, ma tutto un sistema di usi e costumi di schiavitù domestica, di assoluto disprezzo per la persona umana, di tirannia dei padri e di ipocrita sottomissione delle spose e dei figli, si era sviluppato durante i due secoli e mezzo di vita che contava la servitù. Dappertutto in Europa al principio del secolo scorso prevaleva la tirannide domestica – Dickens e Thackeray ne danno una prova convincente nei loro scritti – ma in nessun altro paese quella tirannide era così rigogliosamente sviluppata come in Russia. Tutta la vita, nelle famiglie, nei rapporti fra superiori e inferiori, fra ufficiali e soldati, fra padroni e operai, ne portava l’impronta. Tutto un mondo di abitudini di vita e di pensiero, di pregiudizi e di vigliaccherie morali, di usi nutriti da un’esistenza oziosa, si era sviluppato: e anche gli uomini migliori di quel tempo pagavano un largo tributo a questi frutti dell’epoca della servitù.
La legge non poteva influire su questo stato di cose. Soltanto da un vigoroso movimento sociale, che attaccasse il male alle radici stesse, si poteva sperare una riforma degli usi e delle abitudini quotidiane; e in Russia questo movimento – questa ribellione dell’individuo – assunse un carattere molto più grandioso e le sue lotte furono improntate a una critica molto più energica e radicale che altrove nell’Europa occidentale o in America. Questo movimento fu battezzato con il nome di “nichilismo” da Turgenev, nel suo grande romanzo Padri e figli.
Nell’Europa occidentale esso viene spesso frainteso. Per esempio, nella stampa si confonde il nichilismo con il terrorismo. I torbidi rivoluzionari che scoppiarono in Russia verso la fine del regno di Aleksandr II e che terminarono con la tragica morte dello zar, vengono spessissimo chiamati nichilisti. Ma questo è un errore. È tanto sbagliato confondere il nichilismo con il terrorismo quanto sarebbe confondere un movimento filosofico come lo stoicismo o il positivismo con un movimento politico come, poniamo, il repubblicanesimo. Il terrorismo nacque da alcune particolari condizioni della lotta politica in un determinato momento storico. Visse e morì. Potrebbe rinascere e morire di nuovo. Ma il nichilismo ha lasciato la sua impronta su tutta la vita delle classi colte in Russia, e quell’impronta durerà ancora per molti anni. È il nichilismo, spogliato di alcune delle sue forme più brutali, inevitabili in un giovane movimento di quel genere, a dar ora alla vita di gran parte delle classi colte in Russia un certo carattere particolare, di cui noi Russi compiangiamo la mancanza nell’Europa occidentale. Ed è il nichilismo nelle sue varie manifestazioni a dare a tanti dei nostri scrittori quella grande sincerità, quell’abitudine di pensare ad alta voce che stupisce i lettori dell’Europa occidentale.
Prima di tutto il nichilista dichiarò guerra a fondo contro tutte le “menzogne convenzionali della civiltà”. La sincerità assoluta era la sua più notevole caratteristica, e in nome di quella sincerità abbandonò, e pretese che gli altri abbandonassero, quelle superstizioni, quei pregiudizi, usi e costumi che la ragione non poteva giustificare. Rifiutava di piegarsi di fronte a qualsiasi autorità che non fosse la ragione e nell’analizzare costumi e istituzioni sociali si ribellava ai sofismi di ogni genere, più o meno mascherati.
Abbandonò naturalmente le superstizioni dei padri e nella sua concezione filosofica era positivista, agnostico, evoluzionista spenceriano o materialista scientifico, e benché non attaccasse mai la fede religiosa semplice e sincera che come sentimento è una necessità psicologica, combatteva aspramente l’ipocrisia per cui la gente riveste una maschera che poi getta come un inutile ingombro.
La vita dell’uomo civile è piena di piccole bugie convenzionali. Persone che si odiano si sorridono amabilmente raggianti se si incontrano per strada: il nichilista rimaneva impassibile e sorrideva solo a quelli che era veramente contento di incontrare. Tutte le cortesie superficiali, che non sono che ipocrisia, gli erano altrettanto ripugnanti, ed egli si comportava con una certa rudezza esteriore, come per una protesta contro la cortesia leziosa dei suoi padri. Egli li vedeva parlare con esaltazione, come degli idealisti sentimentali, mentre si comportavano da veri barbari con le loro mogli, i loro figli, i loro servi; si ribellava contro quel genere di sentimentalismo che, dopo tutto, si adattava tanto facilmente alle condizioni tutt’altro che ideali della vita russa. L’arte era compresa nella stessa negazione universale. Le chiacchiere senza fine sulla bellezza, l’ideale, l’arte per l’arte, l’estetica e simili, che si fanno tanto volentieri, mentre ogni oggetto d’arte è comperato con il denaro preso a contadini affamati o agli operai mal pagati, e il cosiddetto “culto della bellezza” non è che una maschera per nascondere la più volgare dissolutezza, lo disgustavano; e le critiche sull’arte formulate ora con tanta efficacia da uno dei maggiori artisti del secolo, Tolstoj, il nichilista l’esprimeva in una dichiarazione sferzante: “Un paio di scarpe vale più di tutte le vostre madonne e di tutti i vostri discorsi su Shakespeare”.
Il matrimonio senza amore e la familiarità senza amicizia erano ripudiati. La ragazza nichilista, costretta dai suoi a essere una bambola in una casa di bambole e a sposarsi per denaro, preferiva abbandonare la casa e gli abiti di seta; vestiva un abitino di lana semplicissimo, si tagliava i capelli e andava a un ginnasio per conquistarsi la sua indipendenza. La donna che vedeva come il suo matrimonio non fosse più un matrimonio, quando né l’amore né l’amicizia legavano più quelli che continuavano a essere considerati marito e moglie, preferiva spezzare un legame che non aveva più nessuna delle sue ragioni essenziali di esistere; e spesso se ne andava con i suoi figli a lottare contro la miseria, preferendo la solitudine e i disagi a una vita che, date le convenzioni sociali, sarebbe stata una continua menzogna.
Il nichilista portava il suo amore per la sincerità anche nei minimi particolari della vita quotidiana. Scherniva il linguaggio convenzionale della società ed esprimeva le proprie opinioni con poche parole brusche, anche con una certa affettazione di ruvidezza.
A Irkutsk avevamo l’abitudine di riunirci una volta la settimana in un circolo a ballare. Frequentai per un certo tempo assiduamente queste soirée, ma a poco a poco, per ragioni di lavoro, le abbandonai. Una sera, dato che non mi si vedeva al circolo da diverse settimane, una delle signore chiese a un mio giovane amico la ragione della mia assenza. “Ora preferisce cavalcare, quando ha bisogno di moto”, fu la risposta piuttosto scortese del mio amico. “Ma potrebbe venire a passare un paio d’ore con noi, anche senza ballare”, osò aggiungere una delle signore. “Che cosa farebbe qui?”, rispose il mio amico nichilista. “Parlerebbe con voi di moda e di abiti? Ne ha abbastanza di queste sciocchezze”. “Ma ogni tanto incontra la signorina X”, osservò timidamente una delle ragazze presenti. “Sì, ma quella è una ragazza studiosa”, rispose il mio amico, “ed egli l’aiuta a studiare il tedesco”. Devo aggiungere che questo rimprovero, indubbiamente sgarbato, ebbe per risultato che quasi tutte le ragazze di Irkutsk incominciarono poi ad assediare mio fratello, il mio amico e me con richieste di consigli sulle loro letture e su altri studi. Il nichilista parlava con la stessa franchezza alle sue conoscenze, dicendo loro che tutte le chiacchiere su “questa povera gente” non erano che ipocrisia finché seguitavano a vivere sul lavoro mal retribuito di quelli che commiseravano, conversandone comodamente, riuniti in salotti riccamente addobbati; e con la stessa franchezza un nichilista affermava a un alto funzionario che non si interessava affatto al benessere dei suoi dipendenti, ma che era semplicemente un ladro.
Il nichilista rimproverava con una certa severità la donna che indulgeva a conversazioni frivole, compiacendosi delle sue maniere “femminili” e degli abiti eleganti. Diceva sgarbatamente a una donnina graziosa: “Come non vi vergognate di dire tante sciocchezze e di portare quei capelli falsi?”. Desiderava trovare nella donna una compagna, con una propria personalità – non una bambola o una “ragazza di mussola” – e rifiutava assolutamente di compiere quelle piccole cortesie che gli uomini tributano a quelle che tanto si compiacciono di considerare il “sesso debole”. Quando una signora entrava in una stanza, il nichilista non si affrettava a offrirle la sua sedia, a meno che non la vedesse stanca e che non vi fosse un’altra sedia nella stanza; si comportava con lei come avrebbe fatto con un compagno del suo sesso; ma se una donna – anche sconosciuta per lui – manifestava il desiderio di imparare qualche cosa che egli sapeva e che essa ignorava, era capace di andare a piedi tutte le sere in un quartiere lontano della città per aiutarla a studiare. Il giovane che rifiutava di muoversi per porgere una tazza di tè a una signora, spesso cedeva alla ragazza che arrivava a Mosca o a Pietroburgo per studiare l’unica ora di lezione che aveva e che gli dava il pane quotidiano, dicendo con semplicità: “Per un uomo è molto più facile trovare lavoro. La mia offerta non è una forma di cavalleria, non è dovuta che a un sentimento di uguaglianza”.
Due grandi romanzieri russi, Turgenev e [Ivan] Goncarov, hanno cercato di rappresentare questo nuovo tipo nei loro romanzi. Goncarov nel suo romanzo II burrone dipinse un individuo di questo genere, vero ma non abbastanza rappresentativo, e fece una caricatura del nichilismo. Turgenev era troppo artista e ammirava troppo questo tipo di uomo per commettere l’errore della caricatura, ma anche il suo nichilista, Bazarov, non ci soddisfece. Lo giudicammo troppo duro, specialmente nei suoi rapporti con i vecchi genitori, e gli rimproveravamo il fatto che sembrava trascurare i suoi doveri di cittadino. La gioventù russa non poteva accontentarsi dell’atteggiamento puramente negativo dell’eroe di Turgenev. Il nichilismo, con la sua affermazione dei diritti dell’individuo e con la negazione di ogni forma di ipocrisia, non era che il primo passo verso un nuovo tipo più elevato di uomini e di donne liberi ed eguali, ma che vivono per una grande causa. Nei nichilisti che černyševskij ha ritratto nel suo libro Che fare?, essi si vedevano dipinti con arte minore ma con maggior fedeltà.
“È amaro il pane fatto dagli schiavi”, scriveva il nostro poeta Nekrasov. La nuova generazione rifiutò di cibarsi di questo pane e di godere delle ricchezze accumulate nelle case paterne grazie al lavoro servile, sia dei servi della gleba che degli schiavi dell’attuale sistema industriale.
Fu con stupore che la Russia lesse nell’accusa portata in tribunale contro Karakozov e i suoi amici che questi giovani, proprietari di belle fortune, vivevano in tre o quattro in una camera sola, non spendendo mai più di dieci rubli al mese per sé, e adoperando tutto il loro patrimonio a favore di associazioni, di cooperative (in cui lavoravano essi stessi) e così via. Ma cinque anni dopo migliaia e migliaia di giovani russi – tutti i migliori – facevano altrettanto. La loro parola d’ordine era v narod (andate verso il popolo, siate con il popolo). Fra il 1860 e il 1865 quasi in ogni famiglia ricca si combatteva un’aspra lotta fra i padri, che avrebbero voluto continuare le vecchie tradizioni, e i figli e le figlie, che difendevano il loro diritto di disporre della propria vita secondo i propri ideali. I giovani abbandonavano il servizio militare, il banco, il negozio, e accorrevano alle università. Ragazze allevate nelle famiglie più aristocratiche si affollavano senza un soldo a Pietroburgo, a Mosca, a Kiev, ansiose di imparare una professione che potesse liberarle dal giogo domestico, e forse un giorno dalla schiavitù coniugale. Molte di esse dopo lotte aspre e inumane, riuscivano a conquistarsi quella libertà personale e ora volevano servirsene, non per il loro piacere, ma per comunicare al popolo quel sapere che le aveva rese libere.
In ogni città della Russia, in ogni quartiere di Pietroburgo si costituivano piccoli gruppi per l’autoeducazione, per aiutarsi a progredire; gli scritti dei filosofi, i trattati degli economisti, i lavori della giovane scuola storica russa furono letti attentamente in questi circoli, e le letture davano luogo a discussioni senza fine. Lo scopo di tutte queste letture e discussioni era di risolvere il grande problema: come essere utili alle masse popolari? A poco a poco si persuasero che l’unico mezzo era quello di stabilirsi in mezzo al popolo e di viverne la vita. I giovani andavano nei villaggi come medici, assistenti sanitari, insegnanti, scrivani, anche come lavoratori della terra, fabbri ferrai, boscaioli e così via, e cercavano di vivere in continuo contatto con i contadini. Le ragazze prendevano diplomi d’insegnante, imparavano a fare le levatrici e le infermiere e andavano a centinaia nei villaggi, dedicandosi esclusivamente alla parte più povera della popolazione. Andavano senza nessuna idea di ricostruzione sociale, nessun pensiero di rivoluzione: desideravano semplicemente insegnare a leggere alla massa dei contadini, istruirla, darle un’assistenza medica, aiutarla insomma in tutti i modi a uscire dalla miseria e dall’ignoranza, e al tempo stesso imparare dalla massa i suoi ideali di una migliore vita sociale.
Quando tornai dalla Svizzera trovai questo movimento in pieno sviluppo.
Mi affrettai naturalmente a comunicare ai miei amici le mie impressioni sull’Associazione Internazionale dei Lavoratori e a mostrare loro i miei libri. All’università non avevo amici nel vero senso della parola; ero più anziano della maggior parte dei miei compagni, e fra i giovani una differenza di pochi anni costituisce sempre un ostacolo a una vera intimità. Bisogna anche dire che dopo l’adozione, nel 1861, del nuovo regolamento per l’ammissione all’università, i giovani migliori, i pensatori più audaci e indipendenti furono eliminati dai ginnasi e non furono più ammessi alle università. Di conseguenza i miei compagni erano per lo più dei bravi ragazzi, studiosi, ma che si interessavano esclusivamente dei loro esami.
Avevo tra di loro un solo amico: lo chiamerò Dmitrij Kelnitz. Era oriundo della Russia meridionale e benché avesse un nome tedesco parlava appena quella lingua e la sua fisionomia era piuttosto di un russo del Sud che di un tedesco. Era molto intelligente, aveva letto molto e meditato seriamente sulle sue letture. Amava la scienza e la rispettava profondamente, ma come molti di noi era arrivato alla conclusione che seguire la carriera dello scienziato equivaleva a ingrossare la schiera dei filistei e che vi era molto lavoro diverso e molto più urgente da fare. Seguì per due anni i corsi universitari, poi li abbandonò per dedicarsi esclusivamente al lavoro sociale. Visse come poteva: non so neppure se avesse un alloggio fisso. Veniva da me ogni tanto e mi chiedeva: “Hai della carta?”. Come gliela davo, si sedeva a un angolo del tavolo e per un paio d’ore lavorava intensamente a una traduzione. Il poco che guadagnava a quel modo era più che sufficiente per le sue modeste necessità. Si affrettava quindi ad accorrere in un quartiere remoto della città per vedere un compagno o per aiutare un amico bisognoso; o attraversava Pietroburgo a piedi e si recava in qualche lontano sobborgo per fare ottenere l’entrata gratuita in un collegio a qualche ragazzo di cui i compagni si interessavano. Era senza dubbio un uomo di talento. Nell’Europa occidentale si sarebbe conquistato una posizione influente nella politica o nel socialismo. Questo pensiero non si affacciò mai alla mente di Kelnitz. Non aveva il minimo desiderio di dirigere altri uomini e non vi era lavoro che gli sembrasse insignificante. Questo modo di sentire però non era una sua particolarità; tutti quelli che vissero per alcuni anni nei circoli degli studenti di quel periodo sentivano profondamente come lui.
Poco dopo il mio ritorno Kelnitz mi invitò a entrare in un circolo, noto fra i giovani con il nome di “Circolo di čajkovskij”. Questo circolo ebbe una parte importante nella storia del movimento sociale in Russia e il suo nome non sarà dimenticato dalla storia. “I soci”, mi disse Kelnitz, “per la maggior parte sono stati finora costituzionalisti; ma sono persone eccellenti, aperte a ogni idea onesta; hanno molti amici in tutta la Russia e vedrai più tardi quello che potrai fare”. Conoscevo già čajkovskij e pochi altri soci del circolo. čajkovskij conquistò il mio cuore al nostro primo incontro e la nostra amicizia è durata poi per ventisette anni.
Questa società era stata iniziata da un piccolissimo gruppo di giovani e di ragazze, tra le quali anche Sofia Perovskaja; si riunivano per istruirsi e perfezionarsi. čajkovskij era fra di loro. Nel 1869 Nečaev cercò di fondare un’organizzazione segreta rivoluzionaria in mezzo alla gioventù progressista accesa dal desiderio di lavorare fra il popolo e per raggiungere questo scopo ricorse al sistema dei vecchi cospiratori, senza esitare di fronte all’inganno quando voleva costringere i suoi soci a seguire le sue idee. Sistemi simili non potevano aver successo in Russia e ben presto la sua società si sciolse. Tutti i soci furono arrestati e alcuni degli elementi migliori e più puri della gioventù russa andarono in Siberia prima di aver potuto fare qualsiasi cosa. Il circolo educativo del quale parlo fu istituito in opposizione ai sistemi di Nečaev. Il piccolo gruppo di amici si era persuaso, e giustamente, che solo individui ispirati a una morale superiore potevano costituire la base di ogni organizzazione, qualunque politica potesse seguire e qualunque fosse il programma pratico che gli avvenimenti futuri potessero indurlo ad adottare. Fu questa la ragione per cui il Circolo di čajkovskij, allargando gradatamente il suo programma, si diffuse tanto in Russia e ottenne risultati così importanti; e più tardi, quando le persecuzioni feroci del governo portarono alla lotta rivoluzionaria, produsse quella nobile schiera di uomini e di donne, che caddero nella terribile lotta contro l’autocrazia.
In quegli anni però – cioè nel 1872 – il Circolo non aveva niente di rivoluzionario. Se fosse rimasto un semplice circolo educativo non avrebbe tardato a mummificarsi come un monastero. Ma i soci trovarono un lavoro adatto per loro. Cominciarono a diffondere i libri buoni. Comperavano le opere di Lassalle, [Vasilij] Bervi (sulle condizioni dei lavoratori in Russia), Marx, opere storiche russe e così via – edizioni intere – e li distribuivano fra gli studenti, nelle province. In pochi anni non vi fu una città importante nelle “trentotto province dell’impero russo”, per servirci della fraseologia ufficiale, nella quale questo Circolo non avesse un gruppo di compagni occupati a diffondere i libri di questo genere. A poco a poco, seguendo l’indirizzo del momento e incoraggiati dalle notizie che arrivavano dall’Europa occidentale sul rapido sviluppo del movimento operaio, il Circolo divenne sempre più un centro di propaganda socialista in mezzo alla gioventù colta e il naturale intermediario fra un gran numero di circoli provinciali; venne poi il giorno in cui fu rotto il ghiaccio fra gli studenti e gli operai, e si stabilirono allora relazioni dirette con i lavoratori a Pietroburgo e in alcune province. Fu in questo momento che io mi associai al Circolo, nella primavera del 1872.
Ogni società segreta viene perseguitata ferocemente in Russia, e forse il lettore occidentale si aspetterà ora una descrizione della mia iniziazione e del mio giuramento di fedeltà. Ma dovrò deluderlo, poiché non avveniva nulla di simile, né sarebbe potuto avvenire: saremmo stati i primi a ridere di cerimonie del genere e Kelnitz non avrebbe mancato di lanciare una delle sue battute ironiche che avrebbe messo fine a qualsiasi rituale. Non vi era neppure uno statuto. Il Circolo accettava come soci solo persone ben conosciute e provate in varie circostanze, delle quali sentiva di potersi fidare assolutamente. Prima di essere accettato, ogni nuovo socio era discusso con quella franchezza e quella serietà che distinguevano il nichilista. La minima prova di poca sincerità o di vanità avrebbe impedito la sua ammissione. Il Circolo non si curava di aumentare il numero dei soci e non cercava di accentrare in sé tutta l’attività che la gioventù andava svolgendo, o di abbracciare in un’unica organizzazione tutti i circoli che esistevano nella capitale o nelle province. Con la maggior parte di essi si mantenevano rapporti di amicizia, aiutandosi a vicenda, ma non si attentava alla loro autonomia.
Il Circolo preferiva rimanere un gruppo di amici legati strettamente; e non ho mai più trovato un gruppo di uomini e di donne di tanta altezza morale come la ventina di persone che conobbi alla prima riunione del Circolo di čajkovskij. Sono ancora fiero di essere stato ammesso in quella famiglia.
Quando entrai a far parte del Circolo di čajkovskij vi si discuteva appassionatamente l’indirizzo che i soci dovevano dare alla loro attività. Alcuni erano favorevoli a continuare una propaganda radicale e socialista in mezzo alla gioventù colta, ma altri pensavano che il nostro solo scopo dovesse essere di preparare degli uomini capaci di risvegliare le inerti masse popolari, e che la nostra attività dovesse svolgersi fra i contadini e i lavoratori delle città. Questa discussione ferveva in tutti i circoli e gruppi che si formavano allora a centinaia a Pietroburgo e nelle province, e ovunque la seconda tendenza trionfava sulla prima.
Se la nostra gioventù avesse aderito solo teoricamente al socialismo, avrebbe potuto accontentarsi di una semplice dichiarazione di princìpi socialisti, compreso, come fine ultimo, “il possesso comune degli strumenti di produzione”, e avrebbe potuto intanto portare avanti qualche tipo di agitazione politica. Molti politicanti socialisti della borghesia dell’Europa occidentale e d’America fecero così. Ma i nostri giovani erano arrivati al socialismo per ben altra via. Non facevano discussioni teoriche sul socialismo, ma erano arrivati al socialismo vivendo poveramente come vivono gli operai senza fare differenza fra il mio e il tuo nei loro circoli, rifiutando di godere egoisticamente delle ricchezze ereditate dai loro padri. Avevano fatto nei riguardi del capitalismo quello che Tolstoj consiglia ora di fare nei riguardi della guerra – invece di condannarla, cioè, continuando a portare l’uniforme, ognuno dovrebbe rifiutare di prestare il servizio militare e di servirsi delle armi, così i nostri giovani russi rifiutarono individualmente di approfittare della ricchezza dei propri padri. Giovani come questi dovevano andare verso il popolo – e così fu. Migliaia e migliaia di giovani e ragazze avevano già abbandonato le loro famiglie e cercavano ora di vivere nei paesi e nelle città industriali occupandosi come potevano. Non si trattava di un movimento organizzato: fu uno di quei movimenti di massa che si verificano in certi momenti di improvviso risveglio della coscienza umana.
Ora che dei piccoli gruppi organizzati erano sorti, disposti a uno sforzo sistematico per diffondere in Russia le idee di libertà e di ribellione, essi dovevano necessariamente fare la loro propaganda in mezzo alle oscure masse della campagna e agli operai delle città. Molti scrittori hanno cercato di spiegare questo movimento “verso il popolo” con un’influenza straniera – “gli agitatori stranieri” offrono dappertutto una comoda spiegazione di simili fenomeni. È indubbiamente vero che la nostra gioventù ascoltò la voce potente di Bakunin e che l’agitazione dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori esercitò su di noi un grande fascino. Ma il movimento v narod (verso il popolo), ebbe origine ben più profonda: esso incominciò prima che gli “agitatori stranieri” avessero parlato alla gioventù russa e anche prima della fondazione dell’Associazione Internazionale. Incominciò già nel 1866 con i gruppi di Karakozov; Turgenev lo prevedeva e vi accennava già nel 1859. Io feci del mio meglio per promuovere questo movimento nel Circolo di čajkovskij; ma non facevo che seguire la corrente, che era infinitamente più forte di qualsiasi influenza individuale.
Naturalmente si parlava spesso della necessità di una agitazione politica contro il nostro governo dispotico. Ci rendevamo già conto di come le masse dei contadini fossero spinte inevitabilmente alla rovina completa dalle tasse assurde e dall’abitudine ancor più stupida di vendere il loro bestiame per pagare le imposte arretrate. Noi, i “visionari”, prevedevamo quella rovina completa di tutta una popolazione, che si è già, purtroppo, realizzata in un grado spaventevole nella Russia centrale, e che lo stesso governo deve ammettere. Sapevamo in che modo scandaloso la Russia fosse saccheggiata da ogni parte. Conoscevamo l’arbitrio dei funzionari e la quasi incredibile brutalità di qualcuno di loro, e tutti i giorni ne avevamo nuove prove. Si sentiva dire continuamente di amici perquisiti la notte dalla polizia, o scomparsi nelle prigioni; più tardi venivamo a sapere che senza processo erano stati deportati nei paesi di qualche lontana provincia della Russia. Sentivamo quindi la necessità della lotta politica contro questa terribile potenza che soffocava le forze migliori del paese. Ma non riuscimmo a trovare un terreno legale o semilegale sul quale combattere questa lotta.
I nostri fratelli maggiori non volevano sentir parlare delle nostre aspirazioni socialiste, e noi non ce ne potevamo staccare. E se anche qualcuno di noi l’avesse fatto, non sarebbe servito a nulla. Tutta la giovane generazione era considerata “sospetta” e la generazione più anziana temeva di aver rapporti con lei. Agli occhi della polizia di Stato ogni giovane di princìpi democratici, ogni ragazza iscritta a un corso di studi superiori erano sospetti, e Katkov li denunciava come nemici dello Stato. Ogni ragazza che portasse i capelli corti e gli occhiali, ogni studente che si coprisse di un plaid invece di portare il cappotto – indizi di semplicità nichilista e di democrazia – erano denunciati come “politicamente sospetti”. Se la camera di uno studente era frequentata dai suoi compagni, veniva periodicamente invasa dalla polizia e perquisita. Le perquisizioni notturne erano così frequenti negli appartamenti di certi studenti, che Kelnitz disse una volta all’incaricato che lo perquisiva, con la tranquilla ironia che usava sempre: “Perché esaminate tutti i nostri libri ogni volta che venite? Tanto varrebbe farne una lista e venire una volta al mese a controllarli, aggiungendo di tanto in tanto i nuovi”. Il minimo sospetto di eresia politica bastava perché un giovane fosse tolto da una scuola superiore, imprigionato per diversi mesi e mandato finalmente in qualche lontana provincia degli Urali “per un tempo indeterminato”, per usare la frase ufficiale. Anche nel periodo in cui il circolo di čajkovskij non faceva altro che distribuire libri stampati con il permesso della censura, čajkovskij fu arrestato due volte e fu tenuto in prigione quattro o sei mesi, la seconda volta in un momento critico per la sua carriera di chimico. I suoi studi erano stati pubblicati recentemente nel “Bollettino dell’Accademia delle Scienze”, e si era presentato per l’esame finale di laurea. Finalmente fu rilasciato perché la polizia non poteva trovare prove sufficienti per giustificare la sua relegazione agli Urali! “Ma se vi arrestiamo un’altra volta”, gli dissero, “vi manderemo in Siberia”. Aleksandr II sognava realmente di fondare in qualche punto delle steppe un’apposita città, sorvegliata notte e giorno da guardie e Cosacchi, dove poter relegare tutti i giovani sospetti; una città di dieci o ventimila abitanti: e solo l’idea del pericolo che avrebbe potuto risultare da una città simile lo distolse dall’esecuzione di questo progetto, degno davvero di un autocrate asiatico.
Un ufficiale nostro compagno aveva fatto parte di un gruppo di giovani che si proponevano di prestare servizio negli zemstva provinciali (Consigli di distretto e di provincia). Pensavano a questo lavoro come a un’alta missione e vi si preparavano studiando seriamente le condizioni economiche della Russia centrale. Molti giovani avevano di queste speranze; speranze che svanivano al primo contatto con il meccanismo governativo... Il governo, dopo aver concesso una forma limitatissima di autonomia amministrativa a certe province russe, fece subito tutto il possibile per rendere vana questa riforma e privarla di ogni ragione d’essere, di ogni vitalità. Il “governo autonomo” provinciale dovette accontentarsi della funzione di semplice impiegato dello Stato, con l’incarico di percepire certe nuove imposte e di spenderle per le necessità locali dello Stato. Ogni sforzo di questi Consigli provinciali a favore delle scuole, dei collegi per insegnanti, misure sanitarie, migliorie nell’agricoltura e così via destava i sospetti del governo centrale, anzi il suo risentimento, e veniva denunciato dalla “Gazzetta di Mosca” come un tentativo “separatista”, come la “creazione di uno Stato dentro lo Stato”, come una ribellione all’autocrazia.
Se qualcuno per esempio raccontasse la vera storia del Collegio normale di Tver e di qualsiasi iniziativa del genere presa in quegli anni da uno zemstvo, dicendo tutte le persecuzioni meschine, le proibizioni, le sospensioni e così via che venivano a mettere i bastoni nelle ruote, nessun europeo dei paesi occidentali e soprattutto nessun americano potrebbe credervi. Butterebbe via il libro, dicendo: “Non può essere vero, è troppo stupido per essere vero”. Eppure era così. Interi gruppi di membri eletti agli zemstva furono destituiti, esiliati dalle loro province e dalle loro proprietà o confinati per aver osato fare, nella forma più legale, una petizione allo zar in favore di quei diritti che per legge appartenevano agli zemstva. “I consiglieri provinciali eletti devono essere dei semplici funzionari ministeriali e ubbidire al ministro degli Interni”: questa era la teoria del governo a Pietroburgo. Quanto alle persone meno importanti – insegnanti, dottori e così via, al servizio dei Consigli provinciali – venivano destituiti e esiliati dalla polizia di Stato entro le ventiquattro ore, senza altre formalità che un ordine della onnipotente Terza Sezione della cancelleria imperiale. Soltanto l’anno scorso una signora, moglie di un ricco proprietario che occupa una posizione importante in uno zemstvo e che si interessa essa stessa di insegnamento, invitò otto insegnanti a una festa data in occasione del suo onomastico. “Poveretti”, pensava, “non vedono mai altro che dei contadini”. Il giorno dopo il delegato della polizia del paese andò al suo palazzo e insistette per avere i nomi degli otto insegnanti, per poterli comunicare alle autorità di polizia. La signora rifiutò di darli. “Bene”, egli rispose, “li scoprirò lo stesso e farò il mio rapporto. Gli insegnanti non devono riunirsi e se lo fanno io devo fare un rapporto”. Quella volta la posizione della signora protesse gli insegnanti, ma se si fossero riuniti in casa di uno di loro avrebbero avuto una visita della polizia di Stato e la metà sarebbe stata destituita dal ministro dell’Istruzione; se poi a qualcuno fosse sfuggita durante la perquisizione una parola di protesta, sarebbe certo stato mandato in qualche provincia degli Urali. Ecco quello che succede oggi, trentatré anni dopo l’istituzione dei Consigli provinciali e distrettuali; ma nel Settanta le cose erano peggio ancora. Che base potevano offrire istituzioni simili per una lotta politica?
Quando ereditai da mio padre la sua proprietà di Tambov pensai seriamente di stabilirmi là e di dedicare tutte le mie energie a lavorare nello zemstvo locale. Alcuni contadini e i preti più poveri della zona mi pregavano di farlo. Quanto a me sarei stato contento di fare qualche cosa, per piccola che fosse, capace di alzare il livello intellettuale e materiale dei contadini. Ma un giorno chiesi ad alcuni dei miei consiglieri, che si erano riuniti: “Se volessi istituire una scuola, una fattoria modello, un’azienda cooperativa, e contemporaneamente mi incaricassi della difesa di quel contadino del nostro paese che è stato oppresso ingiustamente, credete che le autorità me lo concederebbero?”. “Mai!”, mi risposero tutti.
Un vecchio prete dai capelli bianchi, molto stimato nel nostro paese, qualche giorno dopo venne da me in compagnia di due influenti scismatici e mi disse: “Parlate con questi due. Andate con loro, se vi è possibile, e con la Bibbia alla mano predicate ai contadini... Voi sapete cosa predicare... Nessuna polizia al mondo potrà trovarvi se essi vi nascondono... Non c’è altro da fare: ecco il consiglio che vi do io, che sono vecchio”.
Gli spiegai con franchezza le ragioni che mi impedivano di fare la parte di un John Wycliffe. Ma il vecchio aveva ragione. Un movimento simile a quello dei Lollardi si sviluppa ora rapidamente in mezzo ai contadini russi. Le torture inflitte ai poveri Duchobory che si rifiutano di prestare il servizio militare e la persecuzione contro i contadini scismatici della Russia meridionale nel 1887, quando i loro bambini furono rapiti per essere educati nei monasteri ortodossi, non fanno che dare al movimento una forza che non avrebbe avuto venticinque anni fa.
Poiché il problema di un’agitazione in favore di una Costituzione tornava continuamente nelle nostre discussioni, feci nel nostro circolo la proposta che ce ne occupassimo seriamente e scegliessimo il metodo adatto a questo scopo. Pensavo sempre che quando il Circolo fosse arrivato a una conclusione accettata all’unanimità, sarebbe stato dovere di tutti i compagni mettere da parte le proprie preferenze e contribuire al lavoro con tutte le proprie forze. “Se decidete in favore di un’agitazione per una Costituzione”, dissi, “ecco la mia proposta: mi allontanerò da voi, apparentemente, mantenendo i contatti con uno solo dei soci – diciamo čajkovskij – che mi terrà al corrente dei vostri progressi e che vi comunicherà a grandi linee il mio lavoro. Questo sarà fatto in seno alla Corte e fra gli alti funzionari. Ho in quell’ambiente molte conoscenze e so di molti che sono disgustati delle condizioni attuali. Li metterò in relazione tra di loro e, se possibile, li unirò in una specie di organizzazione, e un giorno dirigeremo tutte queste forze per costringere Aleksandr II a concedere una Costituzione alla Russia. Verrà certo un momento in cui tutte queste persone, sentendosi compromesse, nel loro stesso interesse faranno un passo decisivo. Se sarà necessario, alcuni di noi che siamo stati ufficiali potremo giovare molto alla causa facendo propaganda fra gli ex compagni d’armi; ma dovrà essere un’azione a parte, anche se parallela alla vostra. Vi ho pensato seriamente, so quali sono le mie relazioni e di chi mi posso fidare, e credo che alcuni dei malcontenti vedono già in me un possibile centro per un’azione del genere. Non è la via che avrei scelto per me, ma se vi pare che sia la migliore, mi ci metterò con tutte le mie forze”.
Il Circolo non accettò la mia proposta. Ci conoscevamo tutti intimamente e i miei compagni pensarono senza dubbio che facendo così non avrei agito secondo la mia natura. Per la mia felicità personale, per la mia vita stessa, non sarò mai abbastanza grato a quelli che rifiutarono la mia proposta. Avrei seguito una strada che non era quella che mi indicava il mio temperamento, e non avrei trovato quella felicità che ho poi trovato altrove. Ma quando sei o sette anni dopo i terroristi si impegnarono nella terribile lotta contro Aleksandr II, rimpiansi che un altro non avesse saputo fare quel lavoro che mi ero offerto di svolgere fra la nobiltà di Pietroburgo. Un’intesa precedente stretta in quell’ambiente e le fila che questa intesa avrebbe certo teso per tutto l’Impero, avrebbero evitato che fosse vano il sacrificio di quelli che si sacrificarono. In ogni modo il lavoro segreto del Comitato Esecutivo avrebbe dovuto avere l’appoggio di un’agitazione parallela nel Palazzo d’Inverno.
La necessità di un’azione politica fu dibattuta più volte nel nostro piccolo circolo, senza risultati. L’apatia, l’indifferenza delle classi abbienti erano sconfortanti e l’eccitazione della gioventù perseguitata non aveva ancor raggiunto quel grado che diede vita, sei anni più tardi, alla lotta dei terroristi sotto la guida del Comitato Esecutivo. Anzi – ed è questo uno degli esempi più tragici dell’ironia della storia – questa gioventù che Aleksandr II, accecato dall’ira e dalla paura, condannò ai lavori forzati e mandò a morire lentamente in esilio, fu quella che lo protesse negli anni fra il 1871 e il 1878! La propaganda stessa dei circoli socialisti era tale da impedire che si ripetesse un attentato alla vita dello zar come quello di Karakozov. “Organizzate in Russia un grande movimento popolare socialista fra gli operai e i contadini” – ecco la parola d’ordine di quel periodo. “Non preoccupatevi dello zar e dei suoi consiglieri; se si inizierà un movimento come questo, se i contadini vi si associeranno per chiedere la terra e l’abolizione dell’imposta di redenzione dalla servitù, la potenza imperiale sarà la prima a cercare un appoggio nelle classi ricche e tra i proprietari fondiari, e a convocare il Parlamento – proprio come in Francia l’insurrezione nelle campagne nel 1789 obbligò la monarchia a convocare l’Assemblea Nazionale; altrettanto avverrà in Russia”.
Ma v’era di più. Uomini e singoli gruppi, quando si accorsero che il regno di Aleksandr II era condannato irrevocabilmente a sprofondare sempre più nella reazione, spinti da vaghe speranze nel supposto liberalismo dell’erede al trono (i prìncipi ereditari da giovani sono sempre giudicati liberali) tornavano ostinatamente all’idea che si dovesse seguire l’esempio di Karakozov. I circoli organizzati invece si opposero risolutamente a questa idea e insistettero presso i loro compagni perché abbandonassero questa linea d’azione. Posso oggi rivelare questo episodio, ignorato finora: quando un giovane delle province meridionali venne a Pietroburgo con il proposito ben determinato di uccidere Aleksandr II, alcuni soci del Circolo čajkovskij, venuti a conoscenza della cosa, non solo cercarono con tutti i mezzi di dissuadere il giovane, ma quando videro che era impossibile gli fecero sapere che lo avrebbero sorvegliato e avrebbero impedito anche con la forza che portasse a termine il suo attentato. So bene quanto fosse deficiente allora la sorveglianza al Palazzo d’Inverno e posso affermare senz’altro che essi salvarono la vita di Aleksandr II. Tanto la gioventù era allora contraria alla forma di lotta a cui si diede più tardi, quando il calice delle sue sofferenze fu troppo colmo.
I due anni in cui rimasi nel Circolo čajkovskij, prima del mio arresto, lasciarono un’orma profonda in tutta la mia vita e nel mio pensiero. In quei due anni vissi di una vita intensa – provai quell’esuberante vitalità che ci fa sentire in ogni istante la pulsazione violenta di tutte le più intime fibre dell’esistenza e che ci fa capire che la vita merita di essere vissuta. Facevo parte di una famiglia di uomini e di donne così strettamente uniti da uno scopo comune e così intelligentemente e delicatamente umani nei loro rapporti reciproci, che mi è impossibile oggi ricordare qualche malinteso, qualche turbamento. Chi ha qualche esperienza delle agitazioni politiche saprà apprezzare l’importanza di questa osservazione.
Prima di abbandonare completamente la mia carriera scientifica consideravo mio dovere portar a termine il resoconto del mio viaggio in Finlandia per la Società Geografica, e anche certi lavori che avevo incominciato per la stessa Società; e i miei nuovi amici furono i primi ad approvare questa mia decisione. Non sarebbe stato giusto agire altrimenti, dicevano. Lavorai quindi intensamente per terminare i miei libri di geologia e di geografia.
Le riunioni del nostro Circolo erano frequenti e non vi mancavo mai. Ci riunivamo allora in un quartiere della periferia di Pietroburgo, in una casetta di cui risultava affittuaria Sofia Perovskaja, che viveva allora con il nome e il passaporto falso della moglie di un artigiano. Apparteneva a una famiglia molto aristocratica e suo padre era stato per un certo tempo il governatore militare di Pietroburgo; ma con il consenso di sua madre, che l’adorava, aveva abbandonato la casa paterna per entrare in una scuola superiore, e insieme alle tre sorelle Kornilov – figlie di un ricco industriale – aveva fondato quella piccola cerchia di autodidatti che diventò più tardi il nostro Circolo. Ora, nel suo carattere di moglie di un artigiano, vestita di cotonina, con le scarpe da uomo e un fazzoletto in testa, a vederla mentre portava sulle spalle due secchi di acqua attinti alla Neva, nessuno avrebbe riconosciuto in lei la signorina che pochi anni prima brillava in uno dei saloni più eleganti della capitale. Tutti avevamo una predilezione per lei, e ognuno di noi, entrando in quella casa aveva per lei il sorriso più cordiale – anche quando lei, che si considerava in dovere di mantenere una certa pulizia, ci sgridava per il fango che noi, rivestiti di pelli di montone e calzati di stivaloni, introducevamo sui pavimenti, dopo le nostre corse attraverso le strade fangose dei sobborghi. Si sforzava allora di dare al suo visino giovanile, dallo sguardo puro e intelligentissimo, l’espressione della più grande severità. In fatto di moralità era una “rigorista”, ma non aveva niente del moralista ad oltranza. Quando disapprovava la condotta di qualcuno sapeva lanciargli uno sguardo severo di sotto le ciglia; ma in quel suo sguardo si rivelava il suo temperamento generoso, umano e comprensivo. Su un punto solo era inesorabile. “Un donnaiolo”, disse una volta parlando di un uomo; e l’espressione e il modo sprezzante di pronunciare la parola, senza interrompere il lavoro, non l’ho mai dimenticato.
Perovskaja era una “populista” fino in fondo al cuore, e al tempo stesso una rivoluzionaria, una combattente di una tempra a tutta prova. Non aveva bisogno di abbellire i contadini e gli operai di virtù immaginarie per poterli amare e lavorare per loro. Li accettava come erano, e una volta mi disse: “Abbiamo incominciato una grande opera. Saranno forse sacrificate due generazioni in questa lotta, pure bisogna condurla a fondo”. Nessuna delle donne del nostro Circolo avrebbe esitato davanti alla certezza della morte sul patibolo; ognuna di loro avrebbe guardato la morte in faccia. Ma in quel periodo della nostra propaganda nessuna prevedeva un simile destino. Il noto ritratto della Perovskaja è eccezionalmente vero; esprime così bene il suo coraggio e la sua forza, la sua intelligenza vivace e il suo cuore caldo. La lettera che scrisse alla madre poche ore prima di salire sul patibolo è una delle espressioni più belle di un’anima ardente, che mai cuore di donna abbia dettato.
Questo aneddoto mostrerà come erano le altre donne del nostro circolo. Una notte Kuprejanov ed io andammo da Varvara B., alla quale dovevamo fare una commissione urgente. La mezzanotte era passata, ma la sua finestra era ancora illuminata, e salimmo. Era seduta nella sua minuscola cameretta a copiare un programma del nostro Circolo; conoscevamo il suo coraggio e ci venne l’idea di farle uno di quegli stupidi scherzi che gli uomini a volte credono spiritosi. “B”., io dissi, “veniamo a cercarvi, vogliamo tentare un colpo molto pericoloso per liberare dalla fortezza i nostri amici”. Non ci fece nessuna domanda. Depose tranquillamente la sua penna, si alzò e disse con semplicità: “Andiamo”. Parlò con un accento così semplice e sincero che capii subito di essere stato sciocco e le dissi la verità.
Ricadde sulla sua sedia con le lacrime agli occhi e con voce disperata mi chiese: “Non era altro che uno scherzo, allora? Perché fate simili scherzi?”. Compresi allora tutta la crudeltà del mio atto.
Un altro dei favoriti del nostro Circolo era Sergej Kravcinskij, tanto noto poi in Inghilterra e negli Stati Uniti sotto il nome di Stepnjak. Lo chiamavano spesso “il bambino”, tanto era il suo sprezzo del pericolo; ma la sua temerarietà era semplicemente effetto dell’assoluta assenza in lui della paura, una qualità che, dopo tutto, è la politica più saggia per un ricercato dalla polizia. Non tardò a farsi notare per la sua propaganda in seno ai circoli operai, propaganda che faceva sotto il suo vero nome di battesimo di Sergej. Era ricercato dalla polizia, ma non si preoccupava affatto di nascondersi e ricordo che un giorno fu molto rimproverato a una delle nostre riunioni per una delle sue cosiddette imperdonabili imprudenze. Avendo fatto tardi, come al solito, per la riunione, e dovendo percorrere una lunghissima strada per arrivare alla nostra casa, egli, vestito da contadino, con indosso una pelle di montone, era arrivato correndo nel bel mezzo della via principale. “Perché hai fatto una cosa simile?”, gli dicevamo rimproverandolo. “Avresti potuto insospettire e farti arrestare come un volgare ladro”. Ma vorrei che tutti avessero avuto la sua prudenza nelle questioni che potevano compromettere gli altri.
La nostra intimità era incominciata a proposito del libro di [Henry] Stanley, Come trovai Livingstone. Una notte la nostra riunione si era prolungata fino a mezzanotte e al momento di separarci una delle Kornilov entrò con un libro in mano e chiese chi di noi poteva tradurre per la mattina dopo alle otto sedici pagine del libro di Stanley. Io esaminai le pagine e dissi che se qualcuno mi voleva aiutare, si poteva fare nella notte. Sergej si offrì di farlo e alle quattro della mattina le sedici pagine erano pronte. Ci leggemmo la nostra traduzione, con l’occhio attento al testo inglese, poi divorammo una pentola di minestrone russo che era stato messo sulla tavola per noi e uscimmo insieme per tornare a casa. Da quella notte fummo amici intimi.
Ho sempre avuto simpatia per le persone capaci di lavorare molto e che lavorano bene. Quella traduzione, quindi, e la capacità di Sergej di lavorare in fretta mi avevano già predisposto in suo favore. Ma quando lo conobbi più intimamente provai un affetto sincero per la sua natura franca e leale, per la sua energia giovanile, per il suo buon senso, la sua intelligenza, la semplicità e la sincerità eccezionali e per il suo coraggio superiore e la sua tenacia. Aveva molto letto e pensato e avevamo lo stesso modo di considerare la natura rivoluzionaria della lotta che avevamo intrapreso. Di dieci anni più giovane di me, forse non vedeva con chiarezza quanto sarebbe stata aspra la lotta futura per la rivoluzione. Ci narrò più tardi con molto spirito come avesse lavorato una volta in campagna fra i contadini. “Un giorno”, raccontò, “camminavo lungo la strada con un compagno quando fummo raggiunti da un contadino con la slitta. Incominciai a dirgli che non doveva pagare le imposte, che i funzionari derubano il popolo, e cercai di provargli per mezzo di citazioni bibliche che doveva ribellarsi. Il contadino frustò il cavallo, ma noi lo seguimmo camminando rapidamente; mise il cavallo al trotto, e noi gli corremmo dietro; intanto gli parlavo continuamente di imposte e di ribellione. Finalmente mise il suo cavallo al galoppo: ma la bestia non valeva molto – un cavallino mal nutrito da contadini – e così il mio compagno ed io potemmo tenere il passo e continuammo la nostra propaganda finché non ci mancò il respiro”.
Per un certo tempo Sergej rimase a Kazan e io dovetti mantenermi in corrispondenza con lui. Aveva sempre aborrito scrivere lettere cifrate, così gli proposi un sistema che aveva spesso servito ai cospiratori: si scrive una lettera comune parlando un po’ di tutto, ma in questa lettera soltanto certe parole – una ogni cinque, per esempio – hanno un vero significato. Così si scrive: “Scusate la mia lettera affrettata. Venite dunque questa sera a vedermi, domani mattina andrò via di qui, da mia sorella Olga. Mio fratello Nicola è molto peggiorato: era troppo tardi per fare un’operazione”. Leggendo una parola ogni cinque, si trova: “Venite domani da Nicola tardi”. Bisognava scrivere delle lettere di cinque o sei pagine per poter dare una pagina di notizie, ed era necessaria una fantasia sbrigliata per poter riempire le lettere di ogni genere di frasi, per potervi mettere le parole necessarie. Sergej, dal quale era inutile sperare una lettera cifrata, si interessò a questo genere di corrispondenza, e mi mandava delle lettere piene di incidenti emozionanti che si concludevano drammaticamente. Mi disse più tardi che queste lettere aiutarono la sua formazione letteraria. Quando le capacità ci sono tutto contribuisce al loro sviluppo.
Nel gennaio, o febbraio, del 1874 mi trovavo a Mosca in una delle case in cui avevo trascorso la mia infanzia. Una mattina presto mi fu detto che un contadino desiderava vedermi. Uscii e trovai che era Sergej, fuggito allora allora da Tver. Era robusto e con un altro ex-ufficiale, Rogacov, dotato di altrettanta forza fisica, girava le campagne come segatore di alberi. Un lavoro faticoso, specialmente per chi non fosse abituato, ma piaceva a tutti e due; e nessuno avrebbe riconosciuto degli ufficiali travestiti nella persona di quei due robusti boscaioli. Girarono così una quindicina di giorni senza destar sospetti e fecero dovunque propaganda rivoluzionaria senza timore. Talvolta Sergej, che sapeva quasi a memoria il Vangelo, parlava ai contadini come un predicatore religioso, dimostrando loro con la Bibbia alla mano che era loro dovere incominciare una rivoluzione. Talvolta difendeva i suoi argomenti con citazioni prese dagli economisti. I contadini ascoltavano i due come se fossero stati veri apostoli, li conducevano da una casa all’altra e rifiutavano di farsi pagare per il cibo. In quindici giorni avevano commosso profondamente parecchi villaggi, mentre la loro fama si spandeva nei dintorni. I contadini, vecchi e giovani, incominciavano a sussurrare gli uni agli altri nelle loro capanne gli argomenti dei “missionari”; incominciavano a dire più forte del solito che presto si toglierebbe la terra ai proprietari, i quali sarebbero pensionati dallo zar. I più giovani si mostravano più aggressivi verso i funzionari di polizia, dicendo: “Aspettate un po’, non tarderà a venire anche la vostra ora, voi Erodi non regnerete a lungo”. Ma la fama dei due segatori giunse all’orecchio di qualche autorità di polizia ed essi furono arrestati. Fu dato ordine di condurli da un alto funzionario che stava a dieci miglia di distanza.
Furono condotti sotto la sorveglianza di diversi contadini e strada facendo attraversarono un villaggio in festa. “Prigionieri? Bene, venite qui zio”, dicevano i contadini. Furono trattenuti quasi tutto il giorno in quel paese, dove i contadini li condussero di casa in casa brindando con loro e bevendo birra fatta in casa. Le guardie non si facevano pregare. Bevvero e insistettero perché bevessero anche i prigionieri. “Per fortuna”, raccontò poi Sergej, “ci davano la birra in certe scodelle di legno così larghe e profonde facendole passare in giro, che potevo accostare le labbra alla scodella e fingere di bere senza che vedessero quanta birra avessi ingoiata”. Verso sera tutte le guardie erano ubriache e preferirono non presentarsi in quello stato davanti al questore; decisero quindi di rimanere al villaggio fino alla mattina. Sergej continuava a parlare e tutti lo ascoltavano, rammaricandosi che un così bravo giovane fosse prigioniero. Quando stavano per addormentarsi un giovane contadino sussurrò all’orecchio di Sergej: “Quando andrò a chiudere il cancello lascerò il chiavistello aperto”. Sergej e il suo compagno approfittarono dell’avviso e come tutti si furono addormentati uscirono sulla strada. Si misero in cammino di buon passo e alle cinque della mattina erano già a venti miglia dal paese, a una piccola stazione ferroviaria, dove presero il primo treno per Mosca. Sergej vi rimase e più tardi, quando noi a Pietroburgo fummo tutti arrestati, il circolo di Mosca, guidato da lui, diventò il principale centro dell’agitazione.
Piccoli gruppi di propagandisti si erano stabiliti qua e là nelle città e nei paesi, impiegandosi in vari modi. Erano state fondate botteghe da fabbro e fattorie, dove lavoravano giovani delle famiglie più ricche, per potersi trovare quotidianamente in contatto con le masse lavoratrici. A Mosca diverse ragazze di famiglie ricche, studentesse all’università di Zurigo e organizzatrici di un proprio circolo, si decisero persino a entrare nei cotonifici, dove lavoravano dalle quattordici alle sedici ore al giorno, e vivevano nelle caserme delle fabbriche la misera vita delle operaie russe.
Fu un glorioso movimento nel quale ebbero una parte attiva, secondo i calcoli più prudenti, dalle due alle tremila persone, mentre moltissimi altri simpatizzanti, due o tre volte tanti, aiutarono questa avanguardia in un modo o nell’altro. Con una buona metà di questo esercito il nostro Circolo di Pietroburgo manteneva una corrispondenza attiva, naturalmente sempre cifrata.
La letteratura che si poteva stampare in Russia data la severità della censura – il più lontano accenno al socialismo era proibito – fu ben presto insufficiente, e fondammo una tipografia nostra all’estero. Bisognava scrivere opuscoli per gli operai e i contadini, e il nostro piccolo “comitato letterario”, del quale facevo parte, era sovraccarico di lavoro. Sergej scrisse due di questi opuscoli, uno nello stile di Lamennais e un altro che, sotto forma di favola, dava una spiegazione del socialismo, e tutti e due ebbero una larga diffusione. I libri e gli opuscoli stampati all’estero entravano in Russia, di contrabbando, a migliaia, venivano immagazzinati in determinate località e poi spediti ai circoli locali, che li distribuivano agli operai e ai contadini. Tutto questo richiedeva una vasta organizzazione, oltre molti viaggi e una corrispondenza colossale, soprattutto per proteggere i nostri associati e le nostre librerie dalla polizia. Avevamo speciali cifrari per i diversi circoli di provincia e spesso, dopo sei o sette ore di discussione su tutti i particolari, le donne, che non si fidavano della nostra esattezza nella corrispondenza cifrata, passavano tutta la notte a coprire fogli di cifre e frazioni cabalistiche.
Nelle nostre riunioni prevaleva sempre la massima cordialità. Presidenti e ogni genere di formalismo sono così contrari alla natura russa, che li ignoravamo; e benché le nostre discussioni fossero spesso accaloratissime, soprattutto quando si trattava del “programma”, tutto andava bene senza dover ricorrere ai formalismi occidentali. La più assoluta sincerità, il desiderio di tutti di giungere alla miglior soluzione possibile e un deciso disprezzo per tutto ciò che potesse anche solo avvicinarsi all’affettazione teatrale, erano sufficienti. Se uno di noi si fosse azzardato a ricercare effetti retorici in un discorso, gli scherzi amichevoli degli altri gli avrebbero subito fatto capire che non era il caso di fare sfoggio di oratoria. Ci accadeva spesso di mangiare durante queste riunioni e i pasti consistevano invariabilmente di pane di segale, cetrioli, un pezzo di formaggio e molto tè leggero per toglierci la sete. Non perché ci mancasse il denaro: ce ne era sempre a sufficienza, benché non fosse mai più di quanto occorresse per le spese di stampa, sempre maggiori, per il trasporto dei libri, per nascondere i compagni ricercati dalla polizia e per intraprendere cose nuove.
A Pietroburgo non tardammo ad avere rapporti con un gran numero di operai. Serdukov, un giovane eccezionalmente colto, si era fatto molti amici in mezzo ai meccanici, occupati in gran parte in una fabbrica governativa di artiglieria, e aveva organizzato un circolo di una trentina di soci, che si riunivano per la lettura e la discussione. I meccanici guadagnavano molto a Pietroburgo e quelli che non avevano famiglia stavano bene. Si familiarizzarono ben presto con la letteratura socialista e radicale più conosciuta e i nomi di [Thomas] Buckle, di Lassalle, Mill, [John] Draper e [Friedrich] Spielhagen erano loro familiari; nel loro aspetto questi meccanici si distinguevano poco dagli studenti. Io, Kelnitz e Sergej visitavamo spesso il loro gruppo, e davamo loro lezioni su ogni genere di argomenti. Le nostre speranze, però, di vedere questi giovani diventare ardenti propagandisti fra le classi operaie più povere furono in gran parte deluse: in un regime libero essi sarebbero stati gli oratori abituali delle riunioni pubbliche, ma, come gli operai privilegiati delle orologerie di Ginevra, ostentavano un certo disprezzo per la massa dei lavoratori e non avevano nessun desiderio di diventare i martiri della causa socialista. Solo dopo essere stati arrestati e tenuti tre o quattro anni in carcere per aver osato pensare come socialisti, e dopo aver sperimentato gli orrori dell’assolutismo russo, allora soltanto molti di loro diventarono propagandisti convinti, soprattutto di una rivoluzione politica.
Le mie simpatie erano in particolare per i tessitori e gli operai dei cotonifici. A Pietroburgo ve ne sono parecchie migliaia che lavorano in fabbrica durante l’inverno e ritornano per i tre mesi estivi nei loro paesi a coltivare la terra.
Mezzo contadini, mezzo operai, conservavano di solito lo spirito socievole del contadino russo. Nel loro ambiente il movimento si estese con rapidità straordinaria. Era necessario frenare lo zelo dei nostri nuovi amici, altrimenti avrebbero condotto i loro compagni a centinaia, vecchi e giovani, a casa nostra. Vivevano per lo più in piccole associazioni o artel; dieci o dodici di loro affittavano un appartamento in comune, mangiavano insieme e ognuno pagava la sua parte delle spese. Frequentavamo questi appartamenti e i tessitori ci misero presto in rapporto con gli artel degli scalpellini, dei falegnami, ecc. In alcuni di questi artel Sergej, Kelnitz e altri due nostri amici si trovavano come in casa propria e vi passavano notti intere a parlare di socialismo. Avevamo poi in diversi quartieri di Pietroburgo degli appartamenti affittati da alcuni dei nostri, dove dieci o dodici operai venivano ogni sera per imparare a leggere e a scrivere, e dopo le lezioni si discuteva. Di tanto in tanto uno di noi andava nei villaggi dei nostri amici di città e vi passava un paio di settimane a far propaganda fra i contadini, quasi apertamente.
Naturalmente quelli di noi che avevano rapporti con questi operai dovevano vestirsi come loro, portare cioè l’abito da contadino. La distanza che passa fra i contadini e le classi colte in Russia è così grande, e i rapporti fra di loro sono così poco frequenti, che non solo l’arrivo in un paese di qualcuno che indossi l’abito cittadino desta l’attenzione generale, ma anche in città se uno che per il modo di vestire e di parlare rivela di non essere un operaio è visto in giro in compagnia di operai, sveglia subito i sospetti della polizia. “Perché andrebbe in giro con della ‘gente volgare’ se non avesse delle cattive intenzioni?”.
Molte volte, dopo aver pranzato in un ricco palazzo, o anche al Palazzo d’Inverno, dove andavo di frequente a trovare un mio amico, saltavo in carrozza, correvo alla camera di un povero studente in un lontano sobborgo, cambiavo i miei abiti eleganti con una camicia di cotone, gli stivaloni di campagna e una pelle di montone, e scherzando con i contadini che incontravo strada facendo andavo a trovare i miei amici operai in qualche tugurio. Là raccontavo quello che avevo visto all’estero del movimento operaio. Mi ascoltavano avidamente senza perdere una sillaba, poi veniva la domanda: “Che cosa possiamo fare in Russia?”. “Agitatevi, organizzatevi”, rispondevamo, e leggevamo loro una storia popolare della Rivoluzione francese ridotta dall’eccellente Histoire d’un paysan di [Emile] Erckmann-[Alexandre] Chatrian. Ammiravano tutti M. Chovel, che girava per la campagna a fare il propagandista, distribuendo libri proibiti, e avrebbero desiderato tutti seguirne l’esempio. “Parlate agli altri”, dicevamo, “riunitevi; poi quando saremo più numerosi vedremo cosa si possa ottenere”. Capivano perfettamente e non ci restava che frenare il loro zelo.
Passai in mezzo a loro le mie ore più felici. Ricordo particolarmente il capodanno del 1874, l’ultimo passato in Russia in libertà. La sera prima mi ero trovato in nobile compagnia; erano state pronunciate parole ispirate e alte sui doveri del cittadino, sul bene della patria e simili. Ma dietro tutti questi discorsi vibranti si sentiva la stessa nota: come avrebbe potuto ognuno degli oratori salvaguardare il proprio benessere personale? Eppure nessuno aveva il coraggio di dire francamente, sinceramente che era disposto a fare solo quel tanto che non mettesse in pericolo il suo piccolo mondo. Sofismi, sofismi senza fine sulla lentezza dell’evoluzione, sull’inerzia della plebe, sull’inutilità del sacrificio furono pronunciati per giustificare tutto questo, e il tutto mescolato alle dichiarazioni di ognuno di loro di essere pronto a fare dei sacrifici. Tornai a casa preso a un tratto da una profonda malinconia in mezzo a tutte quelle chiacchiere.
La mattina seguente andai a una delle riunioni dei nostri tessitori. Si teneva in un buio stanzone sotterraneo; io ero vestito da contadino e sperduto in mezzo alla folla degli altri vestiti di pelle di montone. Il mio compagno, che essi già conoscevano, mi presentò semplicemente: “Borodin, un nostro amico”. “Raccontaci, Borodin, quello che hai visto all’estero”, egli mi disse. E io parlai del movimento operaio nell’Europa occidentale, delle sue lotte, delle sue difficoltà, delle sue speranze.
Il pubblico era composto in gran parte di uomini sulla quarantina. Era profondamente interessato; mi fecero delle domande, tutte intelligenti, sui più minuti particolari dei sindacati operai, sugli scopi dell’Associazione Internazionale e le sue probabilità di successo; poi vennero le domande su quello che si poteva fare in Russia e sulle prospettive della nostra propaganda. Non cercavo mai di nascondere i pericoli della nostra agitazione e dissi francamente quello che pensavo. “Noi saremo probabilmente mandati in Siberia uno di questi giorni; e voi – una parte almeno – dovrete passare lunghi mesi in carcere per averci ascoltato”. Questa triste prospettiva non li spaventava. “Dopo tutto ci sono anche degli uomini in Siberia, non solo degli orsi! Dove vivono degli uomini, degli altri possono vivere”. “Il diavolo non è così brutto come lo si dipinge”. “Se avete paura del lupo, non andate mai nel bosco”, ci dissero congedandosi. E quando più tardi diversi di loro furono arrestati, si comportarono quasi tutti coraggiosamente, ci aiutarono e non tradirono mai nessuno.
Nei due anni che seguirono furono fatti molti arresti a Pietroburgo e nelle province. Non passava forse un mese senza qualche grave perdita di compagni o la notizia che membri di questo o quel gruppo di provincia erano scomparsi. Sulla fine del 1873 gli arresti si fecero sempre più frequenti. In novembre la polizia scoperse uno dei nostri gruppi più importanti nei dintorni di Pietroburgo. Perdemmo la Perovskaja e altri tre amici e tutto il nostro lavoro fra gli operai di quel sobborgo dovette essere interrotto.
Fondammo un nuovo gruppo in una località più lontana, ma dovemmo scioglierlo presto. La polizia divenne molto vigile e la presenza di uno studente nei quartieri operai era subito notata; numerose spie si aggiravano in mezzo agli operai, sui quali esercitavano un’attiva vigilanza. Dmitrij Kelnitz, Sergej ed io nelle nostre pelli di montone, con il nostro aspetto bonario continuavamo a frequentare i soliti luoghi. Ma Dmitrij e Sergej, i cui nomi erano molto conosciuti nei circoli operai, erano ricercati attivamente dalla polizia e se in qualche perquisizione notturna in casa di amici fossero stati trovati, sarebbero subito stati arrestati. Durante certi periodi Dmitrij dovette cercare ogni giorno un posto nuovo dove passare la notte con relativa sicurezza. “Posso dormire da te?”, chiedeva, entrando nella camera di qualche compagno alle dieci di sera. “Impossibile! il mio alloggio è sorvegliato severamente in questi giorni. Va’ piuttosto da N.”. “Vengo proprio da lui e mi ha detto che le spie brulicano attorno a casa sua”. “Allora va da M.: è mio caro amico e al di sopra di ogni sospetto. Ma sta lontano di qui, prendi una carrozza. Ecco del denaro”. Dmitrij rifiutava per principio di prendere una carrozza e se ne andava a piedi all’altra estremità della città o finiva per fermarsi da un amico, le cui stanze potevano essere perquisite da un momento all’altro.
I primi di gennaio del 1873 perdemmo un altro gruppo, che era il centro della propaganda fra i tessitori. Alcuni dei nostri migliori propagandisti sparirono dietro il cancello della misteriosa Terza Sezione. Il nostro circolo si restringeva, le riunioni generali diventavano sempre più difficili e ogni attività era diretta a creare nuovi circoli di giovani capaci di continuare il lavoro che avevamo incominciato, dopo il nostro arresto. čajkovskij era nella Russia meridionale e obbligammo Dmitrij e Sergej a lasciare Pietroburgo – li obbligammo letteralmente – ordinando loro severamente di partire. Non rimasero che cinque o sei di noi per sbrigare tutto il lavoro del nostro Circolo. Appena avessi consegnato il mio rapporto alla Società Geografica intendevo andare nella Russia Sud-occidentale per organizzarvi una specie di lega di contadini, sul tipo di quella che diventò tanto forte in Irlanda verso il 1880.
Dopo due mesi di relativa tranquillità, verso la metà di marzo sapemmo che quasi tutti i compagni del circolo dei meccanici erano stati arrestati, e con loro un giovane, di nome Nizovkin, un ex studente che disgraziatamente godeva della loro fiducia e che eravamo sicuri si sarebbe affrettato a scolparsi raccontando tutto quello che sapeva sul nostro conto. Oltre a Dmitrij e Sergej conosceva Serdukov, il fondatore del circolo, e me e avrebbe certo fatto i nostri nomi appena messo alle strette negli interrogatori. Pochi giorni dopo due tessitori, due individui malfidi che avevano persino truffato i loro compagni (e che mi conoscevano con il nome di Borodin) furono arrestati. Non vi era dubbio che essi avrebbero subito messo la polizia sulle tracce di Borodin, un uomo vestito da contadino, che veniva a parlare alle riunioni dei tessitori. In una settimana tutti i soci del nostro circolo, tranne me e Serdukov, furono arrestati.
Non ci restava che fuggire da Pietroburgo, ed era proprio quello che non volevamo fare. Tutta la nostra vastissima organizzazione per fare stampare all’estero gli opuscoli e introdurli di contrabbando in Russia, tutta la rete di circoli, fattorie, gruppi di campagna con cui eravamo in corrispondenza in quaranta delle cinquanta province della Russia europea, e che erano stati creati a poco a poco durante gli ultimi due anni, e finalmente i nostri gruppi operai a Pietroburgo e i quattro diversi centri per la propaganda nella capitale: come si poteva abbandonare tutto questo prima di aver trovato gli uomini che mantenessero i contatti e continuassero la corrispondenza? Serdukov e io decidemmo di far entrare due nuovi soci al nostro circolo e di consegnare il lavoro nelle loro mani. Ci incontravamo ogni sera in diversi quartieri della città e siccome non si conservavano mai i nomi e gli indirizzi per scritto – solo gli indirizzi per il contrabbando erano stati depositati al sicuro e cifrati – bisognava insegnare ai nuovi soci centinaia di nomi e di indirizzi e una dozzina di cifrari, ripetendoli e ripetendoli, finché i nostri compagni li avessero imparati a memoria. Ogni sera percorrevamo così la carta della Russia, fermandoci soprattutto alla frontiera occidentale, che formicolava di uomini e donne occupati a ricevere libri dai contrabbandieri, e le province orientali dove avevamo i nostri gruppi più importanti. Poi, sempre travestiti, dovevamo condurre i nuovi soci in città dai nostri simpatizzanti e presentarli a quelli che non erano ancora stati arrestati.
In questi casi la prima cosa da farsi era di sparire dal proprio alloggio per riapparire da qualche altra parte sotto falso nome, Serdukov aveva abbandonato la sua residenza, ma essendo senza passaporto doveva nascondersi in casa di amici. Io avrei dovuto fare altrettanto, ma una curiosa circostanza me lo impediva. Avevo finito il mio rapporto sul periodo glaciale in Finlandia e in Russia, e questo rapporto doveva essere letto in una seduta della Società Geografica. Erano già stati diramati gli inviti, ma il caso volle che il giorno stabilito le due società geologiche di Pietroburgo tenessero una riunione generale: pregarono quindi la Società Geografica di rimandare di una settimana la lettura del mio rapporto. Si sapeva che io avrei espresso la mia opinione sull’estensione dello strato glaciale fino alla Russia centrale, e i nostri geologi, ad eccezione del mio amico e professore Friedrich Schmidt, la consideravano un’ipotesi troppo ardita, e desideravano discuterla ampiamente. Dovetti quindi rimandare la mia partenza di un’altra settimana.
Facce sospette gironzolavano attorno a casa mia e vennero a vedermi con pretesti inverosimili: uno di loro voleva comperare una foresta nella mia proprietà di Tombov, situata in mezzo a praterie assolutamente prive di alberi. Notai nella mia via, l’elegante Morskaja, uno dei due tessitori arrestati di cui ho parlato, e mi persuasi quindi che la mia casa era sorvegliata. Ma dovevo comportarmi come se non fosse accaduto niente di straordinario, perché la sera del venerdì, dovevo presentarmi alla riunione della Società Geografica.
Venne la riunione. La discussione fu molto animata e almeno un punto fu vinto. Fu riconosciuto che tutte le vecchie teorie sul periodo diluviale in Russia erano prive di fondamento e che per risolvere il problema bisognava ricominciare da un nuovo punto di partenza. Ebbi la soddisfazione di sentir dire dal nostro eminente geologo [Nikolaj] Barbot de Marny: “Strato glaciale o no, signori, dobbiamo riconoscere che tutte le nostre convinzioni attuali sull’azione dei ghiacci non erano suffragate da alcuna seria esplorazione”. E in questa adunanza fui proposto per la nomina a presidente della sezione di geografia fisica... e io intanto mi chiedevo se avrei passato o meno quella notte nelle prigioni della Terza Sezione!
Avrei fatto meglio a non tornare a casa mia, ma ero morto di stanchezza dopo le fatiche degli ultimi giorni, e andai a casa. Quella notte non vi furono perquisizioni. Esaminai le mie carte, distrussi tutto quello che poteva essere compromettente per chiunque, imballai tutte le mie cose e mi preparai a partire. Sapevo che la mia casa era sorvegliata, ma speravo che la polizia non sarebbe venuta a cercarmi prima della notte inoltrata, e che al crepuscolo avrei potuto uscire di casa senza essere osservato. Venne la sera e al momento della partenza una delle domestiche mi disse: “Fareste meglio a uscire dalla scala di servizio”. Capii quello che voleva dire, scesi rapidamente la scala e uscii. Vi era una carrozza sola ferma al cancello e vi saltai dentro. Il vetturino mi portò alla grande Prospettiva Nevskij. Dapprima non mi seguiva nessuno e mi credetti salvo, ma dopo poco notai un’altra carrozza che rincorreva rapidamente la mia; il nostro cavallo fu ritardato da qualche ostacolo e l’altra vettura ci sorpassò.
Con grande sorpresa vidi in essa uno dei due tessitori arrestati, accompagnato da un altro individuo. Egli mi fece un cenno con la mano, come se avesse qualche cosa da dirmi. Feci fermare la carrozza. “Forse”, pensai, “è stato rilasciato e ha qualche comunicazione importante da farmi”. Ma appena mi fui fermato l’uomo che accompagnava il tessitore – un poliziotto – gridò ad alta voce: “Signor Borodin, principe Kropotkin, siete in arresto!”. Fece un cenno ai poliziotti, che incrociano in quantità lungo la via principale di Pietroburgo, e intanto saltò nella mia carrozza, facendomi vedere una carta con il timbro della polizia di Pietroburgo. “Ho l’ordine di condurvi dal governatore generale per una spiegazione”, mi disse. Era impossibile opporre resistenza – avevo già ai fianchi due guardie – e ordinai al cocchiere di condurmi al palazzo del governatore generale. Il tessitore rimase nella sua carrozza e ci seguì.
Era ormai evidente che durante dieci giorni la polizia non aveva osato arrestarmi perché non aveva prove sufficienti che Borodin e io fossimo la stessa persona. La mia risposta al cenno fattomi dal tessitore aveva risolto i loro dubbi!
Il caso aveva voluto che proprio nel momento di lasciare la casa un giovane fosse venuto da Mosca con una lettera del mio amico Voinaralskij e un’altra di Dmitrij, indirizzata al nostro amico Polakov. La prima annunciava l’impianto di una nuova stamperia clandestina a Mosca, ed era piena di notizie importanti sull’attività svolta in quella città. L’avevo letta e distrutta. Visto che la seconda lettera non conteneva che innocenti chiacchiere, l’avevo invece portata con me. Ora che ero stato arrestato pensai bene di distruggerla e pregai il poliziotto di farmi vedere ancora il suo mandato; approfittai del momento in cui cercava nella sua tasca per lasciar cadere la lettera sulla strada senza che egli se ne accorgesse. Appena arrivati al palazzo del governatore generale, però, il tessitore la consegnò al poliziotto dicendo: “Ho visto che il signore ha lasciato cadere questa lettera per strada e l’ho raccolta”.
Seguì una lunga, noiosa attesa per l’arrivo del rappresentante dell’autorità giudiziaria, il procuratore o pubblico ministero. Questo funzionario fa la parte dell’uomo di paglia: la polizia si serve di lui durante le perquisizioni, è lui che dà un’apparenza di legalità alla procedura poliziesca. Passarono molte ore prima che questo signore fosse trovato e condotto per assolvere la sua funzione di finto rappresentante della giustizia. Finalmente il procuratore arrivò e fui ricondotto a casa, dove le mie carte furono perquisite attentamente; questo ci tenne occupati fino alle tre del mattino, ma non si trovò una riga sola che potesse danneggiare me o altri.
Da casa mia fui condotto alla Terza Sezione, quella istituzione onnipotente che ha governato la Russia dal principio del regno di Nicola I a oggi – un vero “Stato nello Stato”. Ebbe origine con Pietro I, nel Dipartimento Segreto, dove gli avversari del fondatore dell’impero militare russo furono sottoposti alle più abominevoli torture, sotto le quali morirono; continuò con la Cancelleria Segreta durante i regni delle imperatrici, quando la camera di tortura del potente Minič terrorizzava tutta la Russia, e deve la sua organizzazione attuale a quell’inflessibile despota che fu Nicola I, il quale la pose alle dipendenze del capo dei gendarmi. Questi divenne quindi molto più temuto, in tutto l’impero russo, dello stesso imperatore.
In ogni provincia della Russia, in ogni città di una certa importanza e persino in ogni stazione di provincia, ci sono i gendarmi che fanno rapporto direttamente ai propri generali e colonnelli, i quali a loro volta comunicano con il comandante capo, e quest’ultimo, che vede tutti i giorni l’imperatore, gli fa i rapporti che crede necessari. Tutti i funzionari dell’impero sono sottoposti alla sorveglianza dei gendarmi; è un dovere per i loro generali e colonnelli tener d’occhio la vita pubblica e privata di ogni suddito dello zar, persino dei governatori delle province, dei ministri e dei granduchi. L’imperatore stesso è segretamente sorvegliato da loro, e poiché sono perfettamente al corrente della minuta cronaca di Palazzo e seguono ogni passo dell’imperatore quando esce, il comandante dei gendarmi diventa, per così dire, il confidente intimo di tutti gli affari dei sovrani russi.
A quest’epoca del regno di Aleksandr II la Terza Sezione era assolutamente onnipotente. I colonnelli facevano perquisizioni a migliaia senza preoccuparsi minimamente dell’esistenza delle leggi e dei tribunali. Arrestavano arbitrariamente, trattenevano in carcere finché credevano e trasferivano centinaia di persone nella Russia Nord-orientale o in Siberia, a piacer loro; la firma del ministro degli Interni era una semplice formalità, perché egli non esercitava nessun controllo su di loro e non era al corrente di quanto facevano.
Il mio interrogatorio incominciò alle quattro del mattino. “Siete accusato”, mi dissero solennemente, “di aver appartenuto a una società segreta, che ha per scopo il sovvertimento dell’attuale governo, e di cospirazione contro la sacra persona di Sua Maestà Imperiale. Siete colpevole di questo delitto?”.
“Fin che non mi condurrete davanti a un tribunale dove potrò parlare pubblicamente, non vi darò nessuna risposta”.
“Scrivete”, dettò il procuratore allo scrivano. “Non si riconosce colpevole. Eppure”, continuò dopo un momento, “devo farvi alcune domande: conoscete una persona di nome Nikolaj čajkovskij?”.
“Se insistete a interrogarmi, allora scrivete no a tutte le domande che volete farmi”.
“Ma se vi domando, per esempio, se conoscete quel signor Polakov del quale avete parlato un momento fa?”.
“Dal momento che voi mi fate la domanda, scrivete senz’altro no. E se mi domanderete se conosco mio fratello, mia sorella o la mia matrigna, scrivete no. Non avrete nessun’altra risposta da me; perché se dicessi di sì riguardo a qualcuno, voi cerchereste subito di fargli del male, perquisendolo o peggio, e poi direste che io vi ho dato il suo nome”.
Mi lessero allora una lunga lista di domande, a ognuna delle quali rispondevo pazientemente: “Scrivete ‘no’”. Durò così per un’ora, e seppi che tutti gli arrestati, salvo i due tessitori, si erano comportati bene. I tessitori sapevano solo che mi ero trovato due volte con una dozzina di operai e i gendarmi non sapevano niente del nostro Circolo.
“Ma che cosa fate, principe?”, mi disse un ufficiale dei gendarmi mentre mi accompagnava nella mia cella. “Il vostro rifiuto di rispondere costituirà un’accusa gravissima contro di voi”.
“Sono nel mio diritto, non è vero?”.
“Sì, ma sapete... Spero che vi troverete comodo in questa camera. È stata riscaldata per voi”.
La trovai molto comoda e mi addormentai profondamente. La mattina dopo fui svegliato da un gendarme che mi portava il tè. Fu presto seguito da un altro che mi sussurrò con l’aria più disinvolta: “Ecco un foglio di carta e una matita, scrivete la vostra lettera”. Era un simpatizzante, che conoscevo di nome; si era incaricato della corrispondenza con gli altri prigionieri della Terza Sezione.
Sentivo bussare sui muri da tutte le parti, a colpi che si succedevano rapidamente. Erano i prigionieri che comunicavano per mezzo di tocchi leggeri; ma essendo novizio non riuscivo a capire i rumori, che sembravano arrivarmi contemporaneamente da tutte le parti dell’edificio.
Mi impensieriva una cosa. Durante la perquisizione in casa mia avevo sentito il procuratore dire sottovoce all’ufficiale dei gendarmi di fare una perquisizione in casa del mio amico Polakov, al quale era indirizzata la lettera di Dmitrij. Polakov era un giovane studente, zoologo e botanico di valore, che mi aveva accompagnato nella mia spedizione al Vitim in Siberia. Era nato in una famiglia povera di Cosacchi sulla frontiera della Mongolia e dopo difficoltà di ogni genere era venuto a Pietroburgo, si era iscritto all’università dove si era fatto conoscere come uno dei più promettenti zoologi, e si stava ora preparando agli esami di laurea. Eravamo diventati molti amici dopo il nostro lungo viaggio e avevamo vissuto insieme a Pietroburgo per un certo tempo, ma egli non si interessava della mia attività politica.
Ne parlai al procuratore. “Vi do la mia parola d’onore”, gli dissi, “che Polakov non ha mai partecipato a questioni politiche. Domani deve dare un esame, e rovinerete per sempre la carriera scientifica di un giovane che ha sofferto tante privazioni e ha lottato per degli anni contro ostacoli di ogni specie per raggiungere la sua posizione attuale. So che non ve ne importa molto, ma all’università lo considerano una delle glorie future della scienza russa”.
Fecero ugualmente la perquisizione, ma gli fu concesso un rinvio di tre giorni per fare gli esami. Più tardi fui chiamato dal procuratore che mi fece vedere con aria di trionfo una busta, con l’indirizzo scritto da me; conteneva un biglietto, pure di mia mano, dov’era scritto: “Vi prego di consegnare questo pacco a V. E. e di dirgli di tenerlo fino a quando gli sarà richiesto in forma regolare”. Il biglietto non portava il nome del destinatario.
“Questa lettera”, mi disse il procuratore, “è stata trovata in casa del signor Polakov; e ora, principe, il suo destino è nelle vostre mani: se mi dite il nome di V. E. il signor Polakov sarà rilasciato, ma se vi rifiutate di farlo egli sarà trattenuto finché si deciderà a rivelarci questo nome”.
Mentre guardavo la busta, intravidi l’indirizzo, scritto con una matita speciale, mentre la lettera era scritta con una matita comune e mi ricordai a un tratto delle circostanze in cui le due lettere erano state scritte. “Sono sicuro”, esclamai immediatamente, “che la lettera e la busta non sono state trovate insieme! Siete voi che avete messo la lettera nella busta!”.
Il procuratore arrossì. “Volete farmi credere”, continuai, “che voi, pratico del mestiere, non vi siete accorto che le due lettere sono state scritte con due matite diverse? E adesso volete farmi credere che erano insieme! Allora, signore, vi dichiaro che questa lettera non era indirizzata a Polakov”.
Egli esitò un momento, poi riacquistando la sua sicurezza, mi disse: “Polakov ha confessato che questa lettera è stata indirizzata a lui”.
Ora sapevo che mentiva. Polakov avrebbe potuto confessare tutto quello che lo riguardava personalmente, ma si sarebbe messo in cammino per la Siberia, piuttosto di compromettere un altro. Fissando il procuratore negli occhi gli dissi quindi: “No, signore, quello non lo ha mai detto, e voi sapete benissimo che le vostre parole non sono vere”.
Diventò furioso, o finse di esserlo. “Ebbene”, disse, “aspettate un momento e vi porterò una dichiarazione scritta da Polakov. Sta subendo un interrogatorio nella camera qui vicino”.
“Sono pronto ad aspettare finché volete”.
Mi sedetti ad aspettare, fumando una sigaretta dopo l’altra. La dichiarazione non venne né allora né mai.
Naturalmente non esisteva. Incontrai Polakov nel 1873 a Ginevra e facemmo insieme una bellissima escursione al ghiacciaio di Aletsch. È superfluo dire che le sue risposte furono esattamente quelle che mi aspettavo: aveva negato recisamente di riconoscere la lettera e la persona dalle iniziali V. E. Ci scambiavamo continuamente molti libri e la lettera era stata trovata appunto in un libro, mentre la busta era stata scoperta nella tasca di una vecchia giacca.
Fu detenuto per diverse settimane, poi rilasciato grazie all’intervento dei suoi amici scienziati. V. E. non fu disturbato e consegnò a suo tempo le mie carte.
Più tardi, tutte le volte che vedevo il procuratore, gli chiedevo per fargli dispetto: “E questa dichiarazione di Polakov, quando verrà?”.
Non fui ricondotto nella mia cella, ma un’ora dopo entrò il procuratore accompagnato da un ufficiale dei gendarmi. “L’interrogatorio è terminato”, mi disse; “vi condurranno in un altro posto”.
Davanti al cancello c’era una carrozza chiusa. Mi dissero di entrarvi e un grosso ufficiale di origine caucasica mi si sedette al fianco. Gli parlai, ma non fece che russare. La carrozza attraversò il Ponte delle Catene, passò davanti al campo delle riviste e corse lungo i canali, come se cercasse di evitare le strade principali. “Andiamo al carcere Litovskij?”, domandai all’ufficiale. Sapevo che molti dei nostri compagni vi si trovavano già. Egli non mi rispose. Il sistema del silenzio assoluto che usarono con me nei due anni che seguirono incominciava in quella carrozza; ma quando attraversammo il ponte del Palazzo, capii che mi si conduceva nella fortezza dei SS. Pietro e Paolo.
Ammirai il bel fiume, sapendo bene che non lo avrei rivisto tanto presto. Il sole tramontava. Fitte nuvole grigiastre sovrastavano a Occidente il golfo di Finlandia e nuvole leggere volavano sopra la mia testa, mostrando qua e là sprazzi di azzurro. Poi la carrozza svoltò a sinistra ed entrò in un corridoio oscuro a volta, l’ingresso della fortezza.
“Ora dovrò restare qui un paio di anni!”, dissi all’ufficiale.
“Ma no, perché tanto così?”, rispose il circasso, che all’interno della fortezza aveva recuperato il dono della parola. “Il vostro affare è quasi terminato e potrà essere portato in tribunale fra una quindicina di giorni”.
“Il mio affare è semplicissimo”, risposi, “ma prima di rinviarmi al tribunale cercherete di arrestare tutti i socialisti che ci sono in Russia, e ve ne sono molti, moltissimi, in due anni non avrete finito!”. Non credevo allora che le mie parole sarebbero state tanto profetiche.
La carrozza si fermò davanti alla porta del comandante militare della fortezza ed entrammo nella sua sala da ricevimento. Il generale Korsakov, un vecchio magro, entrò con viso arcigno. L’ufficiale gli parlò a voce bassa e il vecchio rispose “va bene”, guardandolo con un’espressione sdegnosa, poi voltò gli occhi su di me. Evidentemente non gli piaceva affatto di dover accogliere un nuovo inquilino e si vergognava un po’ della sua posizione; ma sembrava dicesse: “Io sono soldato e faccio il mio dovere”. Poco dopo risalimmo in carrozza e ci fermammo quasi subito davanti a un altro cancello, dove aspettammo un bel po’, finché ci venne aperto dall’interno da alcuni soldati. Avanzando a piedi lungo stretti corridoi arrivammo a un terzo cancello di ferro che dava su di un corridoio a volta, tenebroso, dal quale entrammo in una stanzetta scura e umida.
Diversi sottufficiali della guarnigione della fortezza giravano silenziosi con le loro scarpe felpate, senza aprir bocca, mentre il capocarceriere firmava sul libro del circasso, la ricevuta di un nuovo prigioniero. Mi comandarono di spogliarmi completamente e di rivestire l’abito carcerario – una vestaglia di flanella verde, camicia e calze di lana di una grossezza incredibile e pantofole gialle a forma di barca, così grandi che riuscivo a stento a tenerle ai piedi quando provai a camminare. Ho sempre detestato vestaglie e pantofole e le grosse calze mi disgustavano. Dovetti anche spogliarmi di una maglia di seta che mi sarebbe stata molto utile nella fortezza umida, ma non era permesso tenerla. Naturalmente incominciai a protestare e a far rumore, e dopo un’oretta mi fu riconsegnata per ordine del generale Korsakov.
Poi fui condotto attraverso un corridoio buio, dove potei intravedere le sentinelle armate che facevano la ronda, e fui messo in una cella; una pesante porta di quercia si richiuse dietro di me, la chiave girò nella serratura e mi trovai solo nella stanza semibuia.
Parte quinta
La fortezza. La fuga
Era dunque questa la terribile fortezza dove era perita tanta parte delle forze migliori della Russia durante gli ultimi due secoli, e di cui persino il nome viene pronunciato sottovoce a Pietroburgo.
Qui Pietro I torturò suo figlio Alessio e lo uccise di propria mano; qui la principessa Tarakanova fu tenuta in una cella che si riempi d’acqua durante un’inondazione – i topi le si arrampicavano addosso per salvarsi; qui il terribile Minič torturò i suoi nemici e Caterina II seppellì quelli che la incolpavano di aver assassinato il marito. E dai tempi di Pietro I per centosettant’anni gli annali di questo ammasso di pietre, che si erge sulla Neva di fronte al Palazzo d’Inverno, sono annali di assassinii e torture, di uomini sepolti vivi, condannati a una lenta morte o spinti alla pazzia dalla solitudine nelle carceri umide e buie.
Qui i decabristi, che per i primi alzarono in Russia la bandiera dell’idea repubblicana e dell’emancipazione dei servi, fecero le loro prime prove nel martirio, e ancora se ne trovano le tracce in questa Bastiglia russa. Qui furono imprigionati i poeti Ryleev e ševčenko, Dostoevskij, Bakunin, černyševskij, Pisarev e tanti altri dei nostri scrittori contemporanei. Qui Karakozov fu torturato e impiccato.
Qui, in qualche antro del fossato di Alessio era ancora rinchiuso Nečaev, consegnato dalla Svizzera alla Russia come delinquente comune, ma trattato come un pericoloso prigioniero politico, destinato a non rivedere più la luce. Nello stesso fossato erano due o tre uomini che si diceva fossero stati imprigionati a vita per ordine di Aleksandr II per quello che sapevano, e che avrebbero dovuto ignorare, di qualche mistero di palazzo. Uno di loro, con una lunga barba grigia, fu visto nella fortezza da un amico mio.
Tutti questi fantasmi mi si presentarono all’immaginazione. Ma il mio pensiero tornava soprattutto a Bakunin, il quale, benché fosse stato chiuso in una fortezza austriaca dopo il 1848, incatenato al muro e poi consegnato a Nicola I, che lo tenne in questa fortezza altri sei anni, quando la morte del crudele Zar di Ferro lo liberò dopo otto anni di carcere, ne uscì più fresco e vigoroso dei suoi compagni rimasti liberi. “Egli è sopravvissuto”, mi dicevo, “e così devo fare io; non voglio finire qui”.
Il mio primo impulso fu quello di avvicinarmi alla finestra, messa tanto in alto che potevo appena toccarla alzando le braccia. Era un’apertura lunga e stretta in un muro grosso cinque piedi, protetta da una grata e da un doppio telaio di ferro. A una distanza di una dozzina di metri da questa finestra intravedevo il muro esterno della fortezza di un enorme spessore, in cima al quale si vedeva la garitta grigia della sentinella. Solo guardando in alto potevo vedere un lembo di cielo.
Esaminai minuziosamente la stanza dove avrei ormai dovuto passare chissà quanti anni. Dalla posizione dell’alta ciminiera della Zecca indovinai di essere nell’angolo sud-ovest della fortezza, in un bastione prospiciente la Neva. La costruzione in cui ero rinchiuso non era però il vero e proprio bastione, ma quello che in termini di fortificazione si chiama un ridotto, cioè un fabbricato interno a due piani, pentagonale, che si alza un po’ al di sopra delle mura del bastione, costruito per contenere due fila di cannoni. La stanza in cui mi trovavo era una casamatta destinata a un grosso pezzo di artiglieria, e la finestra era una feritoia. I raggi del sole non vi potevano mai penetrare, neppure d’estate, si perdevano nello spessore delle mura. La stanza conteneva un letto di ferro, un tavolo e uno sgabello di quercia. Il pavimento era ricoperto di feltro verniciato e le mura tappezzate di carta gialla. Ma per rendere la stanza sorda a ogni suono la carta non era appiccicata direttamente al muro, era incollata su di un canovaccio e dietro trovai un reticolato di fil di ferro e poi ancora uno strato di feltro; solo al di là del feltro potevo sentire il muro di pietra. Sul lato più interno della stanza c’era un lavatoio e una grossa porta di quercia, nella quale individuai un’apertura chiusa a chiave per farvi passare il cibo e una piccola apertura protetta da un vetro e da un’imposta esterna: era la “spia”, attraverso la quale il prigioniero poteva essere continuamente sorvegliato. La sentinella che stava nel corridoio alzava spesso l’imposta per guardare dentro; le sue scarpe scricchiolavano ogni volta che si avvicinava alla porta. Cercai di attaccar discorso, ma l’occhio che potevo vedere attraverso l’apertura prendeva un’espressione di terrore e l’apertura si chiudeva subito, per essere furtivamente riaperta un momento dopo; ma non riuscii a strappare una sola parola alla sentinella.
Regnava tutto intorno il più profondo silenzio. Tirai il mio sgabello sotto la finestra e guardai il piccolo lembo di cielo che mi era possibile vedere; cercai di afferrare qualche suono dalla Neva o dalla città sulla riva opposta del fiume, ma non vi riuscivo. Questo silenzio assoluto incominciava a diventare opprimente e cercai di cantare, prima a bassa voce, poi sempre più forte.
“Devo dunque dire addio per sempre all’amore”, mi sorpresi a cantare, dall’aria della mia opera prediletta, Ruslan e Ljudmila di [Michail] Glinka.
“Signore, vi prego, non cantate”, risuonò una voce bassa attraverso l’apertura della porta.
“Voglio cantare e canterò”.
“Non potete”.
“Canterò lo stesso”.
Venne allora il capocarceriere che cercò di convincermi che non potevo cantare, perché altrimenti avrebbe dovuto fare rapporto al comandante della fortezza.
“Ma la mia gola si chiuderà e i miei polmoni si atrofizzeranno, se non parlo e non posso cantare”, dissi cercando di convincerlo.
“Sarebbe meglio che lo faceste sottovoce, solo per voi”, disse con accento supplichevole il vecchio capocarceriere.
Ma tutto questo era inutile. Dopo pochi giorni persi ogni voglia di cantare, cercai di farlo per principio, ma inutilmente.
“La cosa più importante”, mi dicevo, “è conservare le forze. Non mi voglio ammalare. Fingiamo di essere obbligato a passare due anni in una capanna nelle regioni artiche durante una spedizione polare. Farò molti esercizi, farò della ginnastica e non mi lascerò abbattere dall’ambiente. Dieci passi da un angolo all’altro della cella è già qualche cosa. Se li ripeto centocinquanta volte, avrò percorso una versta” (poco più di un chilometro). Decisi di fare sette verste al giorno: due la mattina, due prima di pranzo, due dopo pranzo e una prima di addormentarmi. “Se metto sulla tavola dieci sigarette e ne muovo una ogni volta che passo davanti alla tavola, sarà facile contare le trecento volte che devo andare in su e in giù. Dovrò camminare rapidamente, ma voltarmi lentamente all’angolo per evitare il capogiro, e voltarmi ogni volta nel senso contrario. Due volte al giorno poi farò della ginnastica con lo sgabello”. Lo alzai per la gamba tenendolo a braccio teso.
Era abbastanza pesante. Lo feci roteare, e presto imparai a gettarlo da una mano all’altra sopra la testa, dietro la schiena e attraverso le gambe.
Poche ore dopo la mia entrata in prigione il capocarceriere venne ad offrirmi alcuni libri, e fra questi trovai una mia vecchia e cara conoscenza, il primo volume della Fisiologia di Georges Lewes in una traduzione russa; ma mancava il secondo volume, che avrei tanto desiderato rileggere. Naturalmente chiesi di avere carta, penna e calamaio, ma mi fu recisamente negato. Penna e carta non si concedevano mai in fortezza, a meno di un permesso speciale dell’imperatore stesso. Soffrivo molto di quest’ozio forzato e incominciai a comporre con la fantasia una serie di romanzi popolari, presi dalla storia russa, un po’ sul tipo dei Mysterès du Peuple [corretto: de Paris] di Eugène Sue. Composi l’intreccio, le descrizioni, i dialoghi, e cercai di imparare tutto a memoria dal principio alla fine. È facile immaginare come mi avrebbe stancato un lavoro simile se lo avessi dovuto continuare per più di due o tre mesi.
Mio fratello Aleksandr ottenne per me la penna e il calamaio. Un giorno mi fecero salire in una carrozza chiusa in compagnia dello stesso circasso muto, ufficiale dei gendarmi, di cui ho già parlato. Fui condotto alla Terza Sezione, dove mi fu concesso un colloquio con mio fratello alla presenza di due ufficiali.
Aleksandr si trovava a Zurigo quando avvenne il mio arresto. Fin dalla prima giovinezza aveva desiderato ardentemente di andare all’estero, dove gli uomini pensano come vogliono, leggono quello che preferiscono e esprimono liberamente i loro pensieri. La vita russa gli era odiosa. La sincerità – la sincerità assoluta – e la franchezza più aperta erano le sue qualità più caratteristiche; non poteva soffrire la doppiezza e neppure l’ostentazione, in nessuna forma. La mancanza di libertà di parola in Russia, la facilità con cui i Russi accettano l’oppressione, le espressioni velate a cui ricorrono i nostri scrittori, ripugnavano alla sua natura schietta e leale. Poco dopo il mio ritorno dall’Europa occidentale era andato in Svizzera e aveva deciso di stabilirvisi. Dopo la morte dei suoi due figli – uno morto in poche ore di colera e l’altro di tisi – stare a Pietroburgo gli era diventato doppiamente odioso.
Mio fratello non partecipava al nostro lavoro di agitazione. Non credeva possibile un sollevamento popolare e concepiva la rivoluzione solo come l’azione di un corpo rappresentativo, simile all’Assemblea Nazionale di Francia nel 1789- Quando all’agitazione socialista la capiva solo se fatta per mezzo di riunioni pubbliche, non con il lavoro segreto e minuto di propaganda capillare al quale noi ci dedicavamo. In Inghilterra sarebbe stato con John Bright e i Cartisti. Se fosse stato a Parigi durante la rivoluzione del giugno 1848 si sarebbe certo battuto con l’ultimo gruppo di operai dietro l’ultima barricata, ma durante il periodo preparatorio avrebbe seguito Louis Blanc o Ledru-Rollin.
In Svizzera si stabilì a Zurigo e le sue simpatie erano per l’ala moderata dell’Internazionale. Socialista convinto, metteva in pratica i suoi princìpi con il suo modo di vivere sobrio e laborioso, dedicandosi con passione al suo grande lavoro scientifico, lo scopo principale della sua vita, un’opera che avrebbe dovuto essere il seguito per il diciannovesimo secolo, del famoso Tableau de la Nature degli Enciclopedisti. Divenne presto amico intimo del vecchio rifugiato, il colonnello P. L. Lavrov, con il quale condivideva le idee filosofiche di Kant.
Quando seppe del mio arresto Aleksandr abbandonò immediatamente tutto, il suo lavoro, la vita stessa in libertà che gli era necessaria come l’aria a un uccello e tornò a Pietroburgo che odiava, solo per aiutarmi a sopportare la prigionia.
Al nostro incontro eravamo tutti e due profondamente commossi. Mio fratello era molto emozionato. La sola vista dell’uniforme turchina dei gendarmi, questi strangolatori di ogni libertà di pensiero in Russia, gli era odiosa, e esprimeva liberamente i suoi sentimenti anche davanti a loro. Quanto a me, vederlo a Pietroburgo mi dava un senso di apprensione e di angoscia. Ero felice di vedere il suo viso schietto, i suoi occhi pieni di amore e di sapere che l’avrei visto una volta al mese; eppure avrei voluto saperlo cento miglia lontano di là, dove era entrato libero quel giorno, ma dove inevitabilmente sarebbe tornato qualche notte scortato dai gendarmi. “Perché sei venuto nella tana del leone? Riparti subito!”, gridava tutto il mio essere; eppure sapevo che sarebbe rimasto tanto quanto sarebbe durata la mia prigionia.
Nessuno meglio di lui sapeva che l’ozio mi avrebbe ucciso, e aveva già fatto domanda per ottenere il permesso per me di terminare il mio libro.
La Società Geografica desiderava che io continuassi il mio lavoro sul periodo glaciale e mio fratello mise sottosopra l’intero ambiente scientifico di Pietroburgo per ottenere l’appoggio alla sua domanda. L’Accademia delle Scienze si interessò alla questione e finalmente dopo due o tre mesi dalla mia incarcerazione, il governatore venne nella mia cella e mi informò che avevo il permesso dell’imperatore di terminare il mio rapporto alla Società Geografica e che mi sarebbero stati concessi per questo penna e calamaio. “Solo fino al tramonto”, soggiunse. Il tramonto a Pietroburgo, d’inverno, è alle tre del pomeriggio, ma non c’era nulla da fare. “Fino al tramonto”, erano state le parole adoperate da Aleksandr II quando aveva dato il permesso.
Potevo dunque lavorare!
Non mi sarebbe facile esprimere ora l’immenso sollievo che provai nel potermi rimettere a scrivere. Avrei accettato di vivere a pane e acqua e nel sotterraneo più umido, se solo mi fosse stato concesso di lavorare.
In quel periodo ero però il solo prigioniero a cui fosse stato accordato il materiale per scrivere. Diversi dei miei compagni passarono in carcere tre anni e anche di più prima del processo “dei centonovantatré”, e non ottennero che una lavagna! Naturalmente anche la lavagna era la benvenuta in quella tetra solitudine, e se ne servivano per scrivere gli esercizi nelle lingue che stavano studiando o per svolgere problemi di matematica, ma quello che si scriveva sulla lavagna non poteva durare che poche ore.
La mia vita in carcere prendeva ora un carattere di maggiore regolarità. Avevo ormai uno scopo immediato. Alle nove di mattina avevo già fatto i primi trecento passi attraverso la cella e aspettavo che mi fossero consegnate le mie matite e le mie penne. Il lavoro che avevo preparato per la Società Geografica conteneva, oltre a un rapporto sulle mie esplorazioni in Finlandia, anche una discussione sui possibili fondamenti dell’ipotesi glaciale. Ora che sapevo di avere molto tempo a disposizione ero deciso a riscrivere e ampliare questa parte del mio lavoro.
L’Accademia delle Scienze mise a mia disposizione la sua mirabile biblioteca, e un angolo della mia cella non tardò a essere ingombro di libri e carte, comprese tutte le eccellenti pubblicazioni della Società Geologica svedese, una raccolta quasi completa dei viaggi artici e intere annate del “Quarterly Journal of the London Geological Society”. Il mio libro raggiunse durante la prigionia l’ampiezza di due grossi volumi. Il primo fu pubblicato a cura di mio fratello e di Polakov nelle Memorie della Società Geografica, il secondo, ancora incompleto, rimase nelle mani della Terza Sezione all’epoca della mia fuga. Il manoscritto fu ritrovato solo nel 1895 e consegnato alla Società Geografica russa, che me lo fece pervenire a Londra.
Alle cinque del pomeriggio, e d’inverno alle tre, appena mi veniva portata la piccola lampada, matite e penne venivano portate via e dovevo interrompere il mio lavoro. Allora di solito leggevo, per lo più libri di storia. Generazioni di prigionieri politici, che vi erano stati confinati, avevano formato nella fortezza una vera biblioteca. Mi fu permesso di aggiungervi diverse opere importanti di storia russa, e con i libri portatimi dai miei parenti potei leggere quasi tutte le opere e le raccolte di atti e documenti relative al periodo moscovita della storia russa. Gustai la lettura non solo degli annali russi, soprattutto quelli bellissimi della repubblica democratica medioevale di Pskov, forse il meglio che vi sia in Europa per la storia di quel tipo di città medioevali, ma anche di ogni genere di documenti assolutamente aridi, e persino le vite dei santi, che contengono talvolta fatti della vita delle masse popolari, che non si trovano da nessun’altra parte. Lessi pure in quel periodo una gran quantità di romanzi e mi preparai un piccolo regalo per la Vigilia di Natale: i miei parenti riuscirono a farmi avere allora i Racconti di Natale di Dickens e passai la festa a piangere e ridere su quelle bellissime creazioni del grande romanziere.
Mi pesava soprattutto il silenzio come di tomba che mi circondava. Invano bussavo alle pareti e battevo il pavimento con il piede, aspettando il più lieve rumore di risposta. Non ne sentivo nessuno. Passò un mese, poi due, tre, quindici mesi, ma non ebbi nessuna risposta ai miei segnali. Eravamo solo sei, distribuiti in trentasei casematte, dato che tutti i miei compagni arrestati erano detenuti nella prigione di Litovskij Zamok. Quando il sottufficiale entrava nella mia cella per condurmi alla passeggiata, io gli chiedevo: “Che tempo fa? Piove?”. Egli mi gettava un’occhiata di sfuggita e senza aprir bocca si ritirava rapidamente dietro la porta, dove una sentinella e un altro sottufficiale lo sorvegliavano. L’unico essere vivente dal quale potevo ascoltare qualche parola era il capocarceriere, che veniva tutte le mattine a darmi il buon giorno e a chiedermi se volevo comperare del tabacco o della carta. Cercavo di farlo parlare, ma anche lui lanciava occhiate furtive ai sottufficiali che stavano nel vano della porta, come dicesse: “Vedete, sono sorvegliato anch’io”. Solo i piccioni non avevano paura di aver rapporti con me. Tutte le sere e tutte le mattine venivano alla mia finestra a prendere da mangiare attraverso l’inferriata.
Non si sentiva altro rumore che lo scricchiolio delle scarpe della sentinella, il suono appena percettibile dell’imposta della “spia” e il rintocco delle campane della chiesa della fortezza. Suonavano il “Signore salvatemi” (Gospodi pomilni) ogni quarto d’ora, una, due, tre, quattro volte. Poi, ogni ora, la campana più grossa suonava con lenti rintocchi, separati da lunghi intervalli. Seguiva un inno lugubre, suonato con le campane che a ogni mutar di temperatura si scordavano, producendo un’orribile cacofonia che faceva pensare alle campane a morto. Per di più, all’ora tetra della mezzanotte l’inno era seguito dalle note discordanti di un “Dio salvi lo zar”. Tutto questo durava un buon quarto d’ora, e appena cessava un nuovo “Signore salvatemi” annunciava al prigioniero insonne che era passato un altro quarto d’ora della sua inutile esistenza e che molti quarti d’ora, e ore e giorni e mesi della stessa vita vegetativa dovevano passare prima che i suoi carcerieri, o forse la morte, venissero a liberarlo.
Ogni mattina mi conducevano nel cortile della prigione per farvi mezz’ora di passeggiata. Il cortile era un pentagono piccolo, con un marciapiede stretto attorno e nel mezzo una piccola baracca, la camera del bagno. Ma quelle passeggiate mi piacevano.
In prigione la necessità di qualche cosa di nuovo è tanto grande, che mentre passeggiavo nello stretto cortile tenevo sempre gli occhi fissi all’alta guglia dorata della cattedrale della fortezza. Era l’unica cosa che vedessi cambiare aspetto, e mi piaceva vederla luccicare come oro puro quando il sole brillava nel cielo sereno e azzurro, o prendere un tono fantastico quando una leggera nebbia azzurrognola scendeva sulla città, o diventare di un grigio acciaio quando le nubi pesanti incominciavano ad addensarsi.
Durante quelle passeggiate vedevo di tanto in tanto la figlia del nostro capocarceriere, una ragazza di diciotto anni, attraversare per pochi passi il nostro cortile, uscendo dall’abitazione di suo padre per giungere al cancello, unica uscita nella costruzione. Affrettava sempre il passo e teneva gli occhi bassi, come se provasse vergogna di essere la figlia di un carceriere. Suo fratello minore, invece, un cadetto che vidi due o tre volte nel cortile, mi guardava sempre in faccia con un’espressione di così sincera simpatia, che ne fui impressionato, tanto da parlarne poi a qualcuno dopo la mia liberazione. Quattro o cinque anni più tardi, quando era già ufficiale, fu esiliato in Siberia. Si era iscritto al partito rivoluzionario e immagino che avrà aiutato a tenere una corrispondenza con i prigionieri della fortezza.
Per chi non può frequentare le strade sfarzosamente illuminate, Pietroburgo è tetra d’inverno. Naturalmente era ancora più tetra in una casamatta. Ma l’umidità era peggio ancora del buio. Per asciugare l’umidità, la casamatta veniva riscaldata eccessivamente e non potevo respirare, ma quando ottenni finalmente di avere una temperatura più sopportabile, allora il muro stillava umidità e le pareti sembravano bagnate ogni giorno con dei secchi d’acqua: la conseguenza fu che incominciai ben presto a soffrire molto di reumatismi.
Nonostante tutto però conservavo il buon umore, continuavo a scrivere e a disegnare carte geografiche al buio, temperando le mie matite con un pezzetto di vetro che ero riuscito a procurarmi in cortile; facevo scrupolosamente i miei sette chilometri al giorno in cella e facevo ginnastica con lo sgabello di quercia. Passò del tempo. Ma poi il dolore visitò la mia cella e quasi mi abbatté! Mio fratello Aleksandr era stato arrestato!
Verso la fine del dicembre 1874 mi era stato concesso un colloquio con lui e con nostra sorella Elena, nella fortezza, alla presenza di un ufficiale dei gendarmi. Le visite, concesse a lunghi intervalli, eccitano sempre il prigioniero e i suoi parenti. Vediamo i volti amati, sentiamo le care voci e sappiamo che tutto ciò non durerà che pochi istanti; ci si sente tanto vicini eppure tanto lontani, perché non vi può essere conversazione intima alla presenza di un estraneo, di un nemico e di una spia. Mio fratello e mia sorella poi erano impensieriti per la mia salute, sulla quale le giornate tetre e buie e l’umidità avevano lasciato i primi segni. Ci separammo pieni di tristi presentimenti.
Una settimana dopo quel colloquio invece della lettera che aspettavo da mio fratello a proposito della pubblicazione del mio volume ricevetti un biglietto di Polakov. Mi informava che d’ora in poi avrebbe corretto le mie bozze di stampa e che avrei dovuto indirizzare a lui quanto riguardava la pubblicazione del volume. La forma stessa della lettera mi faceva capire che qualche disgrazia era successa a mio fratello. Se fosse stato solo ammalato, Polakov me lo avrebbe scritto. Seguirono per me giorni di ansia terribile. Aleksandr doveva essere stato arrestato e io ne dovevo essere la causa. La vita perdette improvvisamente per me ogni senso. Le mie passeggiate, la mia ginnastica, il mio lavoro persero ogni interesse.
Camminavo tutto il giorno incessantemente su e giù per la mia cella, non pensando ad altro che all’arresto di Aleksandr. Per me, che ero celibe, la prigione non era che un inconveniente personale; ma egli era ammogliato, amava appassionatamente sua moglie e avevano ormai un figlio, sul quale concentravano tutto l’amore che avevano avuto per i due primi bambini.
La cosa più terribile era l’incertezza. Che cosa poteva aver fatto? Per quale ragione era stato arrestato? Che cosa gli avrebbero fatto? Passarono varie settimane, la mia ansietà cresceva sempre più, ma non avevo nessuna notizia, finché seppi indirettamente che era stato arrestato per una lettera scritta a P. L. Lavrov.
Conobbi i particolari solo molto più tardi. Dopo l’ultimo colloquio avuto con me aveva scritto al suo vecchio amico, che dirigeva allora a Londra una rivista socialista russa, intitolata “Avanti!”. In questa lettera parlava delle preoccupazioni per la mia salute; parlava dei molti arresti che si facevano in Russia ed esprimeva liberamente il suo odio per il regime dispotico. La lettera fu intercettata alla posta dalla Terza Sezione e la vigilia di Natale andarono a perquisire il suo appartamento. La perquisizione fu condotta con maggior brutalità del solito. Dopo la mezzanotte parecchi poliziotti invasero le sue stanze e misero tutto sottosopra. Esaminarono persino i muri; il bambino malato fu levato dal letto per poterne esaminare i materassi. Non trovarono nulla, e non vi era nulla da trovare.
Mio fratello si risentì molto per questa perquisizione e, con la solita franchezza, disse all’ufficiale dei gendarmi che la dirigeva: “Contro di voi, capitano, non ho nessuna lagnanza da fare. Avete avuto un’istruzione limitata e non vi rendete conto di quello che fate. Ma quanto a voi, signore”, prosegui rivolgendosi al procuratore, “voi sapete che parte recitate in questa faccenda, siete stato all’università, conoscete il diritto e sapete che mettete tutta la legge, così com’è, sotto i vostri piedi e che con la vostra presenza proteggete gli atti illegali di questi uomini; voi siete semplicemente un mascalzone”.
Essi giurarono di vendicarsene. Lo tennero prigioniero alla Terza Sezione fino a maggio. Il figlio di mio fratello, un ragazzo piacevolissimo, reso ancor più affettuoso e intelligente dalla malattia – moriva di tisi. I medici dissero che non aveva più che pochi giorni di vita. Aleksandr, che non aveva mai chiesto un favore ai suoi nemici, li pregò in questa occasione di lasciargli rivedere il figlio per l’ultima volta. Supplicò di avere il permesso di tornare a casa per un’ora, sulla parola d’onore che tornerebbe, o almeno di esservi condotto con una scorta. Gli fu rifiutato! Non potevano rinunciare a questa vendetta!
Il bambino morì e sua madre si trovava di nuovo in uno stato che rasentava la follia, quando mio fratello seppe che sarebbe stato trasportato nella Siberia orientale, nella piccola città di Minusinsk. Avrebbe fatto il viaggio in un carretto fra due gendarmi e sua moglie avrebbe potuto raggiungerlo più tardi, ma non avrebbe potuto viaggiare con lui.
“Ditemi almeno di cosa sono colpevole”, egli diceva, ma non vi era alcuna accusa contro di lui, salvo quella lettera. Questa deportazione sembrava tanto arbitraria, una così brutale vendetta da parte della Terza Sezione, che nessuno dei nostri parenti credette che l’esilio si sarebbe protratto oltre qualche mese. Mio fratello fece pervenire una protesta al Ministero dell’Interno. Gli fu risposto che il ministro non poteva opporsi alla volontà del comandante dei gendarmi; fu fatta un’altra protesta al Senato: tutto inutilmente!
Due anni più tardi nostra sorella Elena, di sua iniziativa, fece una supplica allo zar. Nostro cugino Dmitrij, governatore generale di Char’kov, aiutante di campo dell’imperatore e molto ben visto a Corte, consegnò personalmente la supplica allo zar, aggiungendo alcune parole per appoggiarla. Ma il sentimento della vendetta caratteristico dei Romanov era molto forte in Aleksandr II. Scrisse sulla supplica: “Pust posidit” (vi stia ancora). Mio fratello rimase in Siberia dodici anni e non rivide più la Russia.
Gli innumerevoli arresti fatti durante l’estate del 1874 e il tono spietato dato dalla polizia all’istruzione del processo contro il nostro Circolo, cambiarono profondamente le idee della gioventù russa. Fino allora l’idea più diffusa era stata quella di scegliere in mezzo agli operai, e poi in mezzo ai contadini, un certo numero di individui pronti a diventare dei propagandisti del socialismo. Ma ora le fabbriche erano invase dalle spie ed era evidente che, qualunque cosa avessero fatto, i propagandisti e gli operai non avrebbero tardato ad essere arrestati e sepolti per sempre in Siberia. Incominciò allora un gran movimento verso il popolo, ma in una forma nuova, e centinaia di giovani e di ragazze, sprezzando tutte le precauzioni osservate sinora, invasero le campagne, viaggiarono attraverso le città e i villaggi, incitando le masse alla ribellione, distribuendo quasi apertamente opuscoli, canzoni, manifesti. Nei nostri circoli quell’estate fu conosciuta col nome di “estate folle”!
I gendarmi persero la testa. Non avevano braccia sufficienti per fare tutti gli arresti, né occhi bastanti per seguire i passi di ogni propagandista. Eppure non meno di mille e cinquecento persone furono arrestate durante quella caccia, e una metà fu tenuta in carcere per diversi anni.
Un giorno, nell’estate del 1875, sentii nella cella vicina alla mia i passi leggeri di scarpe dal tacco alto, e poco dopo afferrai i frammenti di una conversazione. Una voce femminile parlò dalla cella e una profonda voce bassa – evidentemente quella della sentinella – borbottò una risposta. Riconobbi poi il risuonare degli speroni del colonnello che avanzava a passi rapidi, bestemmiando contro la sentinella, e il clic della chiave nella serratura. Egli osservò qualche cosa e una voce femminile rispose con vivacità: “Non abbiamo parlato insieme, l’ho solo pregato di chiamare il sottufficiale”. Poi la porta si chiuse e sentii il colonnello che bestemmiava di nuovo sottovoce contro la sentinella.
Non ero dunque più solo. Avevo come vicina una signora, che non tardò a distruggere la severa disciplina che aveva regnato fino allora fra i soldati. Da quel giorno le mura della fortezza, mute durante quei quindici mesi, incominciarono ad animarsi. Da tutte le parti sentivo battere col piede sul pavimento: uno, due, tre, quattro... undici colpi, ventiquattro colpi, quindici colpi, poi un intervallo seguito da tre colpi e una lunga fila di trentatré colpi. Questi colpi si ripetevano più volte nello stesso ordine, finché il vicino riusciva a capire che indicavano le parole “Kto vy?”, (chi siete), poiché la lettera v è la terza del nostro alfabeto. Dopo di questo non tardammo a intavolare vere conversazioni, e ci servivamo di solito dell’alfabeto abbreviato; cioè dell’alfabeto diviso in sei gruppi di cinque lettere ciascuno, ogni lettera indicata dal suo gruppo e dalla sua posizione in quel gruppo.
Con mio gran piacere scoprii di avere alla mia sinistra il mio amico Serdukov, con il quale ben presto potei parlare di tutto, specialmente quando ci servimmo del nostro cifrario. Ma i rapporti con gli altri portavano con sé al tempo stesso conforto e dolore. Sotto di me era stato messo un contadino che Serdukov conosceva. Gli parlava con i colpi e anche involontariamente, spesso inconsciamente mentre lavoravo, seguivo le loro conversazioni. Gli parlavo anch’io. Ora l’isolamento in una cella, senza nessuna occupazione, se è penoso per un uomo colto è infinitamente più penoso per un contadino abituato al lavoro fisico e che non ha nessuna consuetudine con la lettura. Il nostro amico contadino era assolutamente disperato, e avendo già passato quasi due anni in un altro carcere prima di essere condotto in fortezza – la sua colpa era di aver ascoltato i socialisti – era già profondamente abbattuto. Non tardai ad accorgermi, con terrore, che di tanto in tanto vaneggiava. Poco per volta i suoi pensieri si fecero più confusi e Serdukov ed io avemmo modo di renderci conto giorno per giorno come la sua ragione vacillasse, finché i suoi discorsi furono quelli di un pazzo. Poi la casamatta prese a risuonare di suoni e grida orribili: il nostro vicino era impazzito, ma rimase lì in quello stato ancora per diversi mesi prima di essere trasferito nel manicomio, dal quale non sarebbe più uscito. Era terribile assistere alla rovina di una intelligenza in condizioni simili! Sono certo che tutto questo deve aver contribuito ad aumentare l’irritabilità nervosa del mio buono e fedele amico Serdukov. Quando, dopo quattro anni di carcere, fu assolto dal tribunale e liberato, si uccise con una revolverata.
Un giorno ricevetti una visita inaspettata. Il granduca Nicola, fratello di Aleksandr II, che faceva un’ispezione in fortezza, entrò nella mia cella, seguito solo dal suo aiutante di campo. La porta fu chiusa dietro di lui. Mi si avvicinò rapido, dicendomi: “Buon giorno, Kropotkin!”. Mi conosceva personalmente e mi parlò col tono di bonaria familiarità di una vecchia conoscenza. “Com’è possibile, Kropotkin, che voi, un paggio dell’imperatore, un sergente del Corpo dei Paggi, siate implicato in questa faccenda e vi troviate ora qui, in questa orrenda casamatta?”.
“Ognuno ha le sue opinioni”, risposi.
“Opinioni! Allora la vostra opinione era che si doveva suscitare una rivoluzione?”.
Che cosa dovevo rispondere? Sì? Allora si sarebbe detto che io, dopo aver rifiutato di rispondere ai gendarmi, avevo “tutto confessato” al fratello dello zar. Egli si comportava come il comandante di una scuola militare che cerca di ottenere una “confessione” da un cadetto. Eppure dire di no avrebbe significato mentire. Non sapevo che cosa dire e rimasi in silenzio.
“Vedete! Ora ve ne vergognate”.
Questa osservazione mi irritò e risposi subito un po’ bruscamente: “Ho risposto al giudice istruttore e non ho altro da aggiungere”.
“Ma vi prego di osservare, Kropotkin”, rispose subito con l’accento più amichevole, “che io non vi parlo come un giudice istruttore, parlo come un privato cittadino, un semplice privato”, ripeteva abbassando la voce.
Vari pensieri si incalzavano nel mio cervello. Dovevo fare la parte del marchese di Posa? Parlare all’imperatore per mezzo del granduca, delle miserie della Russia, della rovinosa situazione dei contadini, degli arbitrii dei funzionari, delle terribili carestie che incombevano? Dire che desideravamo aiutare i contadini a uscire dalle loro condizioni disperate, insegnare loro a rialzare il capo, e con tutto questo cercare di influire sull’animo di Aleksandr II? Questi pensieri si susseguivano rapidamente, ma alla fine mi dissi: “Mai, sarebbe assurdo! Conoscono già tutto questo; sono i nemici del paese e discorsi simili non li farebbero cambiare”.
Gli risposi che era sempre un personaggio ufficiale e che non potevo considerarlo un privato.
Incominciò allora a farmi altre domande in tono noncurante.
“Non è stato in Siberia, a contatto dei decabristi, che avete incominciato a coltivare queste idee?”.
“No, conoscevo solo un decabrista e non gli ho quasi mai parlato”.
“È stato a Pietroburgo allora che le avete assorbite?”.
“Sono sempre stato cosi”.
“Come! Eravate così anche al Corpo dei Paggi?”, mi chiese tutto spaventato.
“Quando ero al Corpo ero un ragazzo, e quello che è ancor vago nel ragazzo si precisa nell’uomo”.
Mi fece altre domande di questo genere, e mentre parlava vedevo perfettamente quale fosse il suo scopo; cercava di ottenere da me delle confessioni, e la mia immaginazione me lo dipingeva mentre diceva a suo fratello: “Tutti questi giudici istruttori sono degli idioti. Non ha voluto rispondere a loro, ma io gli ho parlato dieci minuti e mi ha raccontato tutto”. La cosa incominciava a seccarmi; e quando mi disse su per giù: “Ma come avete potuto mettervi con della gente simile, contadini e persone senza nome?”. Gli risposi seccamente: “Vi ho già detto che ho risposto al giudice istruttore”. Allora lasciò bruscamente la cella.
Più tardi i soldati di guardia crearono una vera leggenda intorno a questa visita. La persona che venne con la carrozza per portarmi via al momento della mia fuga, aveva un berretto militare e dei baffi biondi... assomigliava lontanamente al granduca Nicola. Nacque così fra i soldati della guarnigione di Pietroburgo la leggenda che il granduca in persona fosse venuto per liberarmi e che mi avesse rapito. così nascono le leggende anche nel nostro tempo, all’epoca della diffusione dei giornali e dei dizionari biografici.
Passarono così due anni. Molti dei miei compagni erano morti, altri erano impazziti, ma non si parlava ancora di portare in tribunale il nostro processo.
La mia salute venne meno prima della fine del secondo anno. Ormai lo sgabello di quercia mi pesava nella mano e i sette chilometri mi sembravano enormemente lunghi. Eravamo in sessanta nella fortezza e le giornate d’inverno erano brevi, così che ci conducevano una volta ogni tre giorni a fare una passeggiata di venti minuti nel cortile. Feci tutto il possibile per conservare le mie forze, ma l’“inverno polare” senza l’intervallo estivo, mi vinse. Dai miei viaggi in Siberia avevo riportato leggeri sintomi di scorbuto; ora nell’umidità e nell’oscurità della prigione essi si accentuarono, finché lo scorbuto, questo flagello delle prigioni, mi colpì definitivamente.
Nel marzo o nell’aprile del 1876 ci fu annunciato che la Terza Sezione aveva completato l’istruttoria. Il processo era stato deferito alle autorità giudiziarie, e fummo perciò trasferiti a un carcere dipendente dal tribunale, la Casa di Detenzione.
Si trattava di un’enorme prigione modello, costruita sul tipo di quelle francesi o belghe, consistente in quattro piani di piccole celle, ognuna delle quali ha una finestra che si apre sul cortile interno e una porta che dà su un balcone di ferro; i balconi dei diversi piani sono collegati da scale.
Per la maggior parte dei miei compagni il cambiamento di carcere costituiva un grande vantaggio. Questo era molto più animato della fortezza, vi erano maggiori possibilità dì comunicare, di vedere i nostri parenti, di avere rapporti fra di noi. I colpi sui muri risuonavano indisturbati tutto il giorno, e mi fu possibile raccontare a un mio giovane vicino la storia della Comune di Parigi, dal principio alla fine. Mi ci volle però un’intera settimana di colpi!
Quanto alla mia salute diventò anche peggiore di quanto non fosse ultimamente nella fortezza. Non potevo sopportare l’atmosfera rinchiusa della piccola cella, lunga solo quattro passi da un angolo all’altro e dove, appena accesi i caloriferi, la temperatura cambiava da un freddo artico a un insopportabile calore. Per muovermi dovevo girare continuamente su me stesso, perciò dopo pochi minuti di passeggiata venivo preso dal capogiro, e i dieci minuti di moto all’aperto, nell’angolo di un cortile chiuso fra alte mura di mattoni, non mi ristoravano affatto. Quanto al medico, che non voleva sentir parlare di scorbuto nella “sua prigione”, è meglio non parlarne.
Ottenni il permesso di ricevere cibo da casa, poiché una mia parente, moglie di un avvocato, abitava a pochi passi dal tribunale. Ma non potevo più digerire e lo stomaco non tollerava altro che un pezzetto di pane e uno o due uova al giorno. Le mie forze declinavano rapidamente e tutti mi credevano vicino a morire.
Quando salivo la scala che conduceva alla mia cella, posta al secondo piano, dovevo fermarmi due o tre volte per riposare, e ricordo che un soldato anziano che mi accompagnava un giorno mi disse: “Poveretto, non arriverete alla fine dell’estate”.
I miei parenti erano seriamente allarmati. Mia sorella Elena cercò di ottenere la mia liberazione dietro cauzione, ma il procuratore Subin le rispose con un sorriso sardonico: “Se mi portate un certificato medico con la dichiarazione che non vivrà più di dieci giorni, lo libererò”. Ebbe la soddisfazione di vedere mia sorella cadere su una poltrona e singhiozzare disperatamente davanti a lui. Però le fu concesso di farmi visitare da un bravo medico, il capo servizio dell’ospedale militare della guarnigione di Pietroburgo.
Era un vecchio generale intelligente, comprensivo, che mi visitò meticolosamente e si convinse che non avevo nessuna malattia organica, solo soffrivo di insufficiente ossidazione del sangue. “Avete bisogno solo di aria”, mi disse. Poi esitò un momento e aggiunse con tono risoluto: “È inutile parlare, qui non potete restare: bisognerà trasferirvi”.
Una decina di giorni dopo fui mandato all’ospedale militare, alle porte di Pietroburgo, che possiede una piccola prigione speciale per gli ufficiali e i soldati che si ammalano sotto processo. Due miei compagni vi erano già stati trasferiti, quando era stato accertato che sarebbero presto morti di tisi.
All’ospedale incominciai subito a ristabilirmi. Mi assegnarono una stanza spaziosa a pianterreno, vicino alla sala di guardia. Aveva una grandissima finestra, munita di un’inferriata, che guardava a mezzogiorno e dava su un vialetto con due file di alberi, e oltre il viale si vedeva un grande spiazzo dove duecento falegnami erano occupati a costruire delle baracche di legno per i malati di tifo. Ogni sera passavano un’ora o due a cantare in coro, un coro particolare, proprio dei grandi artel di falegnami.
Una sentinella passeggiava su e giù per il viale, la sua garitta era posta in faccia alla mia stanza.
La finestra era tenuta aperta tutto il giorno e mi scaldavo ai salutari raggi del sole, che avevo tanto desiderato! Respiravo a pieni polmoni l’aria balsamica di maggio e la mia salute migliorò rapidamente – troppo rapidamente, incominciai a pensare. Presto incominciai a poter digerire cibi leggeri, riprendevo le forze e mi rimisi al lavoro con rinnovata energia. Siccome non avevo la possibilità di continuare il secondo volume della mia opera, ne scrissi un riassunto che fu pubblicato come appendice del primo.
Nella fortezza un compagno che era stato nel carcere dell’ospedale mi aveva detto che non sarebbe stato difficile fuggire, e informai i miei amici del luogo dove mi trovavo. La fuga però apparve molto più difficile di quanto mi avevano indotto a credere. Una sorveglianza rigidissima si esercitava inesorabilmente su di me, più severa di quanto si fosse mai visto prima. La sentinella che passeggiava in corridoio era comandata alla mia porta e non mi si permetteva mai di uscire dalla mia stanza. I soldati dell’ospedale e gli ufficiali di guardia che vi entravano di tanto in tanto non osavano fermarsi più di un minuto o due. I miei amici immaginarono vari mezzi per liberarmi, alcuni molto curiosi. Dovevo, per esempio, limare l’inferriata della mia finestra, poi una notte di pioggia, mentre la sentinella sonnecchiava nella sua garitta, due uomini si sarebbero fatti avanti pian piano, rovesciando la garitta in modo da farla cadere sulla sentinella, chiudendovela come un topo in trappola, senza però fargli del male. Intanto io dovevo saltare dalla finestra. Ma si arrivò a una soluzione migliore in un modo inaspettato.
“Chiedete il permesso di fare una passeggiata”, mi sussurrò un giorno un soldato. Lo feci, il dottore appoggiò la mia domanda e ogni pomeriggio alle quattro mi fu permesso di passeggiare un’ora nel cortile della prigione. Dovevo tenermi addosso la vestaglia di flanella verde che portavano i malati, ma le mie scarpe, il panciotto e i pantaloni mi venivano consegnati tutti i giorni.
Non dimenticherò mai la mia prima passeggiata. Quando fui condotto all’aperto mi vidi davanti un cortile lungo ben trecento passi e largo più di duecento, tutto coperto d’erba. Il cancello era aperto e fuori vedevo la strada, l’enorme ospedale dirimpetto e il viavai di passanti. Mi fermai un momento sulla porta della prigione, incapace di muovermi quando vidi quel cortile e quel cancello.
A un’estremità del cortile si trovava la prigione, un edificio stretto, lungo circa centocinquanta passi, con garitte per le sentinelle alle due estremità. Le due sentinelle marciavano su e giù davanti al fabbricato e con i loro passi avevano segnato un sentiero in mezzo all’erba. Mi dissero di camminare in mezzo a questo sentiero e le due sentinelle continuavano la loro strada, così che non mi trovavo mai a più di dieci o quindici passi da una di loro. Tre soldati dell’ospedale sedevano vicino alla porta. All’altra estremità di questo lungo cortile dei contadini stavano scaricando della legna da una dozzina di carri e la deponevano lungo il muro. Tutto il cortile era chiuso da uno steccato costruito con grosse tavole. Il cancello era aperto per lasciar passare i carri.
Quel cancello aperto mi affascinava. “Non devo fissarlo”, mi dicevo, eppure non ne staccavo mai gli occhi. Appena mi ricondussero in cella scrissi ai miei amici per comunicare loro la bella notizia. “Non riesco quasi a servirmi delle cifre”, scrissi con mano tremante tracciando geroglifici quasi illeggibili al posto delle cifre; “questo approssimarsi della libertà mi fa tremare come se avessi la febbre. Oggi mi hanno condotto fuori del cortile; il cancello era aperto e nessuna sentinella lo custodiva. Da quel cancello io fuggirò; le mie sentinelle non mi prenderanno” e stesi il piano della fuga. “Una signora deve venire in carrozza aperta all’ospedale. Scenderà e la carrozza l’aspetterà nella strada a una cinquantina di passi dal cancello. Quando uscirò alle quattro camminerò per un poco con il cappello in mano e qualcuno dal di fuori starà a vedere e l’interpreterà come il segnale che tutto va bene nella prigione. Allora tocca a voi rispondere: ‘la strada è libera’. Senza di ciò non mi muoverò, una volta passato il cancello non devo essere ripreso. Potrete servirvi solo della luce o del suono come segnale. Il cocchiere potrebbe proiettare un raggio di luce, i raggi del sole riflessi dal suo cappello lucido sul fabbricato principale dell’ospedale, che a quell’ora è in ombra, o meglio ancora un canto che continuasse tutto il tempo che la strada resta libera; a meno che non vi riuscisse di affittare il villino grigio che vedo dal cortile, e allora potreste fare un segnale dalla finestra. La sentinella correrà come un cane dietro la lepre, facendo una curva, mentre io correrò in linea retta e guadagnerò cinque o dieci passi. Arrivato nella strada salterò nella carrozza e partiremo al galoppo. Se la sentinella facesse fuoco – ebbene, sarà quel che sarà, questo è al di fuori delle nostre possibilità d’azione; e poi di fronte alla certezza di morire in prigione val bene la pena di correre il rischio”.
Furono proposti degli altri progetti, ma si finì con l’adottare questo.
Il nostro Circolo si incaricò della cosa, persone che neppure conoscevo se ne interessarono come si fosse trattato della liberazione del più caro dei loro fratelli.
Dovevano però superare grandi difficoltà, e il tempo volava con una rapidità spaventosa. Lavoravo intensamente e studiavo fino a notte tarda, ma nonostante questo la mia salute migliorava così rapidamente che ne ero sorpreso. Quando ero stato condotto nel cortile la prima volta potevo solo trascinarmi a passo di tartaruga sul sentiero battuto; ora sentivo la forza di correre. È vero che continuavo a camminare con lo stesso passo di lumaca, per evitare che mi si proibissero le passeggiate; ma la mia naturale vivacità poteva tradirmi da un momento all’altro. E intanto i miei compagni dovevano trovare più di una ventina di persone che partecipassero all’impresa, trovare un cavallo sicuro, un cocchiere esperto e pensare a cento particolari imprevisti, che sorgono sempre in complotti del genere. Questi preparativi si protrassero per circa un mese e da un giorno all’altro mi si poteva trasferire alla Casa di detenzione.
Finalmente fu fissato il giorno della fuga. Il 29 giugno, vecchio stile, è il giorno dei Santi Pietro e Paolo. I miei amici volevano liberarmi proprio quel giorno, aggiungendo una sfumatura sentimentale alla loro impresa. Mi avevano fatto sapere che in risposta al mio segnale – tutto bene all’interno – mi avrebbero comunicato con un palloncino rosso da bambini mandato in aria che tutto andava bene anche fuori. Allora la carrozza si sarebbe avvicinata e qualcuno avrebbe cantato una canzone per farmi sapere che la strada era libera.
Uscii, presi il cappello in mano e aspettai il palloncino. Ma non si vide per nulla. Passò una mezz’ora. Sentivo il rumore di una carrozza che si avvicinava. Sentivo una voce d’uomo che cantava una canzone che non conoscevo, ma non c’era il palloncino.
L’ora era passata e pieno d’angoscia ritornai nella mia stanza. “Deve essere successa qualche disgrazia”, mi dicevo.
L’impossibile era successo quel giorno. A Pietroburgo, vicino al Gostiny Dvor sono sempre in vendita centinaia di palloncini per bambini. Quella mattina non c’erano e non fu possibile trovarne uno! Finalmente ne trovarono uno nelle mani di un bambino, ma era floscio e non voleva alzarsi. I miei amici corsero allora nel negozio di un ottico, comperarono un apparecchio per fabbricare l’idrogeno e ne riempirono il palloncino: ma questo si ostinava a non alzarsi: l’idrogeno non era abbastanza secco. Il tempo incalzava. Una signora legò allora il palloncino al suo ombrello e tenendolo ben in alto passeggiò su e giù per la strada lungo il muro esterno del nostro cortile: ma io non avevo visto nulla. O il muro era troppo alto o la signora troppo piccola.
Fu una vera fortuna e non avrebbe potuto succederci nulla di meglio della mancanza di questo palloncino, perché quando, finita l’ora della mia passeggiata, la carrozza percorse l’itinerario fissato per la mia fuga, in una strada stretta fu fermata da una dozzina di carri che portavano legna per l’ospedale. Successe una confusione, alcuni dei carri erano sulla destra, altri sulla sinistra della strada e la carrozza dovette passare in mezzo a loro a passo d’uomo e a un angolo dovette fermarsi. Se vi fossi stato dentro mi avrebbero ripreso.
Fu stabilito allora tutto un sistema di segnali lungo la strada che dovevo percorrere dopo la fuga, per farmi sapere se la via era libera o no. Per un tratto di due miglia dall’ospedale i miei compagni si appostarono in vedetta. Uno avrebbe passeggiato su e giù con un fazzoletto in mano, che all’avvicinarsi dei carri avrebbe messo in tasca; un altro doveva sedere sul marciapiede e mangiare delle ciliegie, fermandosi se i carri si fossero avvicinati, e così via. Tutti questi segnali trasmessi lungo la via sarebbero finalmente arrivati alla carrozza. I miei amici avevano anche preso in affitto il villino grigio che vedevo dal cortile e in quella casa, alla finestra, stava un violinista, pronto a suonare quando il segnale – via libera – gli fosse arrivato.
Il tentativo fu fissato per il giorno dopo: sarebbe stato pericoloso aspettare ancora. Il personale dell’ospedale doveva aver notato la presenza della carrozza e qualche sospetto doveva essere arrivato alle orecchie delle autorità, perché la notte prima della mia fuga sentii l’ufficiale di guardia che chiedeva alla sentinella di servizio davanti alla mia finestra: “Dove sono le tue cartucce?”. Il soldato incominciò a levarle lentamente dalla cartucciera, mettendoci un buon paio di minuti. L’ufficiale di guardia prese a redarguirlo aspramente: “Non ti hanno detto che questa notte devi tenere quattro cartucce nella tasca della giacca?”, e restò vicino alla sentinella finché questa si fu messa le quattro cartucce in tasca. “Sta’ attento”, gli disse allontanandosi.
Bisognava comunicarmi il nuovo codice di segnali; il giorno dopo alle due una signora, una mia cara parente, venne alla prigione e pregò che mi consegnassero un orologio. Ogni oggetto doveva passare dalle mani del procuratore, ma trattandosi di un orologio a calotta semplice, lo accettarono. Dentro vi era un piccolissimo biglietto cifrato che spiegava tutto. Quando lo trovai fui terrorizzato da tanta audacia. La signora, ricercata anche lei dalla polizia per ragioni politiche, sarebbe stata immediatamente arrestata se qualcuno avesse pensato di aprire la calotta. Ma la vidi uscire tranquillamente dalla prigione e allontanarsi lentamente lungo il viale.
Uscii come al solito alle quattro e diedi il segnale. Poi sentii il rumore di una carrozza e pochi minuti dopo il suono di un violino arrivava dalla casa grigia al nostro cortile. Ma mi trovavo in quel momento all’altra estremità del fabbricato. Quando arrivai all’estremità del sentiero più vicina al cancello, la sentinella mi stava proprio alle spalle. “Ancora un giro”, pensai, ma prima che io arrivassi in fondo, il violino tacque improvvisamente.
Passò più di un quarto d’ora, pieno di angoscia per me, prima che capissi la ragione dell’interruzione. Allora una dozzina di carri ben carichi entrarono dal cancello e andarono a disporsi in fondo al cortile.
Subito il violinista, davvero bravissimo, intonò una mazurka vivacissima di [Anton de] Kontskij, quasi volesse dirmi: su, avanti, ecco il momento. Mi incamminai lentamente lungo il viottolo dalla parte più vicina al cancello, tremando al pensiero che la mazurka potesse interrompersi prima che lo raggiungessi.
Quando vi arrivai mi detti un’occhiata intorno. La sentinella si era fermata a cinque o sei passi dietro di me e guardava dall’altra parte. Ricordo che mi balenò un momento il pensiero: ora o mai! Buttai via la vestaglia verde e incominciai a correre.
Per molti giorni mi ero esercitato a liberarmi di quell’indumento tanto lungo e ingombrante. Era così lungo che ne tenevo l’estremità sul braccio sinistro, come fanno le signore con lo strascico. Per quanto facessi, non riuscivo a spogliarmene con una mossa sola; l’avevo anche scucito sotto le ascelle, ma non serviva. Decisi allora di esercitarmi a buttarlo via in due mosse, liberando il braccio dalla coda e lasciando cadere l’accappatoio in terra. Provai e riprovai con pazienza nella mia camera finché riuscii a farlo con la stessa precisione con cui i soldati maneggiano le carabine, – uno, due – e la vestaglia era in terra.
Non mi fidavo molto delle mie forze e incominciai a correre piuttosto adagio per non esaurirle subito. Ma avevo appena fatto qualche passo quando i contadini che accatastavano la legna dall’altra parte del cortile si misero a gridare: “Scappa, fermatelo! Arrestatelo!”, e correvano per tagliarmi la strada al cancello. Accelerai allora disperatamente. Non pensai più che a correre e saltai il solco che le ruote dei carri avevano scavato davanti al cancello. Via, via, con tutte le mie forze!
Gli amici che assistevano alla scena dalla casetta grigia mi dissero più tardi che la sentinella mi rincorreva, seguita dai tre soldati che stavano seduti davanti alla porta. La sentinella mi seguiva tanto da vicino, che si sentiva sicura di prendermi. Diverse volte diede un balzo in avanti con la carabina, cercando di colpirmi nella schiena con la baionetta. A un certo punto i miei amici dalla finestra credettero che mi avesse raggiunto. Il soldato era così convinto di potermi prendere a quel modo, che non fece fuoco. Ma io mantenni la distanza ed egli dovette fermarsi al cancello.
Uscito che fui dal cancello mi accorsi con terrore che la carrozza era occupata da un borghese che portava un berretto militare e sedeva con la testa voltata. “Perduto”, fu il mio primo pensiero. I compagni nella loro ultima lettera mi avevano scritto: “Arrivato in strada non lasciarti prendere, vi saranno degli amici pronti a difenderti se ve ne sarà bisogno”. Non volevo saltare nella carrozza che mi sembrava occupata da un nemico. A mano a mano che mi avvicinavo, però riconobbi che l’uomo aveva i baffi biondi di un mio carissimo amico. Non apparteneva al nostro Circolo, ma eravamo molto amici personalmente e avevo avuto più di una volta l’occasione di conoscere il suo straordinario coraggio e la sua forza, che diventava improvvisamente erculea quando c’era un pericolo in vista. “Come mai lui? È possibile?”, pensavo, e stavo per gridare il suo nome quando mi trattenni a tempo e battei invece le mani, mentre correvo ancora, per attirare la sua attenzione. Voltò gli occhi verso di me e lo riconobbi.
“Salta dentro, svelto, svelto!”, gridò con voce terribile, ingiuriando me e il cocchiere con tutti i titoli possibili, un revolver in mano pronto a tirare. “Galoppa, galoppa o ti ammazzo!”, gridava al cocchiere.
Il cavallo, un bellissimo cavallo da corsa comperato per l’occasione, partì a tutto galoppo. Dietro di noi si alzavano da tutte le parti grida di “Fermateli, arrestateli!”. Mentre il mio amico mi aiutava a infilare un elegante soprabito e un gibus. Ma il pericolo vero non era tanto negli inseguitori quanto in un soldato messo di sentinella alla porta dell’ospedale, quasi di faccia al punto in cui la carrozza doveva aspettarmi: avrebbe potuto impedirmi di saltare in carrozza o avrebbe potuto fermarla se si fosse gettato avanti di qualche passo.
In previsione di questo un compagno era stato incaricato di distrarne l’attenzione chiacchierando con lui. La cosa ebbe il più grande successo. Poiché il soldato aveva prestato servizio per un certo tempo all’infermeria dell’ospedale, il mio amico dette un tono scientifico alla conversazione, intrattenendolo sul microscopio e sulle meraviglie che rivela. Parlando di un certo parassita del corpo umano, gli chiese: “Avete visto che razza di coda ha?”. “Ma come, una coda?”. “Sì, una coda; al microscopio la si vede grossa cosi”. “Non raccontatemi frottole!”, rispose il soldato, “lo so bene. È stata la prima cosa che ho guardato in un microscopio”. Questa vivace discussione si svolgeva proprio nel momento in cui io gli correvo davanti e saltavo in carrozza. Pare inventata, ma è la verità.
La carrozza voltò di scatto imboccando uno stretto vicolo lungo quello stesso muro del cortile dove i contadini avevano accatastato la legna, che tutti avevano ormai abbandonato per correre dietro a me. La curva fu presa con tanta rapidità che per poco la carrozza non si rovesciava, ma io mi buttai verso l’interno tirandomi dietro il mio amico, e questa mossa improvvisa ristabilì l’equilibrio della vettura.
Attraversammo il vicolo al trotto e voltammo a sinistra. Due gendarmi erano fermi davanti alla porta di una birreria e salutarono militarmente vedendo il berretto del mio amico. “Zitto, zitto!”, gli dicevo io, perché era sempre in uno stato di orgasmo terribile. “Va tutto bene, i gendarmi ci salutano!”. Allora il cocchiere voltò il viso verso di me e riconobbi in lui un altro amico sorridente di gioia.
Dappertutto vedevamo degli amici che ci facevano cenni di intesa o ci davano il “buon viaggio” mentre passavamo al trotto del nostro magnifico cavallo. Entrammo nella Prospettiva Nevskij, voltammo in una strada laterale e scendemmo davanti a una porta, congedando il cocchiere. Salii le scale di corsa e giunto in cima caddi nelle braccia di mia cognata che mi aspettava con ansia dolorosa. Rideva e piangeva nello stesso tempo, incitandomi a fare in fretta a cambiare abito e tagliarmi la barba lunga. Dieci minuti dopo uscivo dalla casa con il mio amico e salivo su una carrozza pubblica.
Alla prigione intanto l’ufficiale di guardia e i soldati dell’ospedale si erano precipitati in strada, non sapendo bene cosa fare. Per un miglio intorno non vi era una carrozza, essendo state tutte prese dai miei compagni. Una vecchia contadina tra la folla fu la più pronta di tutti. “Poveretti”, disse quasi parlando fra di sé, “usciranno certo sulla Prospettiva, e là saranno presi, se qualcuno corre lungo quel vicolo, che va direttamente alla Prospettiva”. Aveva perfettamente ragione, e l’ufficiale corse alla vettura del tram più vicina e chiese ai tramvieri che gli dessero i loro cavalli per poter mandare qualcuno fino al Prospekt. Ma essi rifiutarono recisamente e l’ufficiale non volle imporlo con la forza.
Quanto al violinista e alla signora che avevano affittato la casa grigia, corsero giù dalle scale e si mescolarono anch’essi alla folla raccoltasi intorno alla vecchietta che stava dando consigli, e quando la folla si sciolse essi se ne andarono tranquillamente.
Il pomeriggio il tempo era bello. Ci facemmo condurre alle isole dove la nobiltà di Pietroburgo va nelle belle giornate di primavera ad ammirare il tramonto e per via ci fermammo in una strada secondaria da un barbiere, dove mi feci radere la barba, operazione che mutò un poco il mio aspetto, ma non troppo. Ci facemmo scarrozzare senza meta su e giù, ma non sapevamo che cosa fare, perché ci avevano detto di non andare al recapito dove avrei dormito, prima di notte tardi. “Che cosa fare in tutte queste ore?”, domandai al mio amico. Ci pensò su un poco. “Va’ da Donon!”, ordinò a un tratto al cocchiere, nominando uno dei migliori ristoranti di Pietroburgo. “Nessuno penserà mai di venirti a cercare da Donon”, osservò tranquillamente. “Ti cercheranno dappertutto, ma non lì, e potremo pranzare e anche bere in onore del successo della tua fuga!”.
Che cosa potevo obiettare a una proposta così ragionevole? Andammo da Donon, attraversammo le sale sfolgoranti di luce e affollate per il pranzo e ci facemmo condurre in una sala privata, dove restammo fino all’ora stabilita. La casa dove ero stato subito dopo la fuga fu perquisita meno di due ore dopo la nostra partenza, come gli appartamenti di quasi tutti i nostri amici. Nessuno pensò di cercarmi da Donon.
Due giorni dopo dovevo entrare in un appartamento preso in affitto per me, dove potevo restare con un passaporto falso. Ma la signora che doveva condurmi in carrozza prese la precauzione di andarci prima da sola. Era tutta circondata dalle spie! Tanti dei miei amici vi erano andati per vedere se ero al sicuro, che la polizia si era insospettita. Inoltre il mio ritratto era stato stampato dalla Terza Sezione e distribuito a centinaia di copie alle guardie e ai questurini. Tutti i poliziotti che mi conoscevano di vista mi cercavano per le strade e quelli che non mi avevano mai visto erano accompagnati da soldati e secondini che mi avevano avvicinato durante la prigionia. Lo zar era furioso all’idea che una fuga simile avesse potuto avvenire nella sua capitale, in pieno giorno, e aveva esclamato: “Si deve riprenderlo!”.
Non mi fu possibile restare a Pietroburgo e mi nascosi in varie villette nei dintorni. Accompagnato da una mezza dozzina di amici mi fermai in un paese frequentato in quella stagione dai pietroburghesi, che lo sceglievano come meta delle loro gite. Fu deciso che io partissi per l’estero. Ma avevamo saputo da un giornale straniero che tutte le stazioni di frontiera e le stazioni capolinea delle province baltiche e finlandesi erano strettamente sorvegliate da poliziotti che mi conoscevano di vista. Decisi quindi di dirigermi dove meno mi si aspettava. Munito del passaporto di un amico e accompagnato da un altro, attraversai la Finlandia dirigendomi a Nord, verso un lontano punto del golfo di Botnia, da cui mi imbarcai per la Svezia.
Quando già ero salito sul piroscafo e mentre stavo per partire, l’amico incaricato di accompagnarmi alla frontiera mi diede le notizie di Pietroburgo, che i compagni gli avevano fatto promettere di non comunicarmi prima di quel momento. Mia sorella Elena era stata arrestata, come la sorella di mia cognata, che era venuta a trovarmi in prigione una volta al mese dopo la partenza di mio fratello e di sua moglie per la Siberia.
Mia sorella non sapeva assolutamente nulla dei preparativi fatti per la mia fuga. Solo quando tutto era stato fatto un amico era corso da lei a comunicarle la bella notizia. Inutilmente protestò di essere innocente; fu separata dai suoi figli e tenuta per quindici giorni in prigione. Quanto alla sorella di mia cognata, sapeva vagamente che si doveva tentare qualche cosa, ma non partecipò ai preparativi. Il buon senso avrebbe dovuto dire alle autorità che una persona autorizzata a venirmi a trovare in prigione non poteva essere coinvolta in una faccenda del genere, invece fu trattenuta in prigione più di due mesi. Suo marito, un avvocato famoso, cercò inutilmente di ottenerne la liberazione. Gli ufficiali dei gendarmi gli dissero: “Ormai sappiamo bene che non ha partecipato alla cosa, ma capirete, il giorno della fuga abbiamo fatto un rapporto all’imperatore dicendo di aver scoperto e arrestato la persona che aveva organizzato la fuga. Ora ci vorrà un po’ di tempo per preparare l’imperatore all’idea che non si tratta della vera colpevole”.
Attraversai la Svezia senza fermarmi e andai a Cristiania, dove aspettai per qualche giorno la partenza di un piroscafo diretto a Hull, raccogliendo intanto notizie sul partito dei contadini allo Storting norvegese. Mentre mi avviavo al battello mi chiedevo con ansia: “Sotto quale bandiera naviga, norvegese, tedesca, inglese?”. Vidi finalmente a prua sventolare la bandiera inglese, sotto la quale tanti profughi, russi, italiani, francesi, ungheresi, esuli di tutti i paesi, hanno trovato asilo. Salutai quella bandiera dal più profondo del cuore.
Parte sesta
L’Europa occidentale
In vicinanza delle coste dell’Inghilterra, nel Mare del Nord, si scatenò una tempesta. Ma salutai la tempesta con gioia. Godevo della lotta fra il nostro battello e le ondate furiose, e passai delle ore a prua mentre la schiuma del mare mi sferzava il viso. Dopo due anni trascorsi in un carcere tetro ogni riposta fibra del mio essere sembrava palpitare di vita, avida di goderla in tutta la sua pienezza e intensità.
Mi proponevo allora di non restare all’estero più di qualche settimana o di qualche mese: giusto il tempo necessario a lasciar quietare l’interesse e il chiasso destato dalla mia fuga, e anche di rimettermi un po’ in salute. Sbarcai sotto il nome di Levašov, che avevo scelto alla mia partenza dalla Russia; evitai Londra, dove le spie dell’ambasciata russa mi si sarebbero messe ben presto alle calcagna, e andai dapprima a Edimburgo.
E invece non dovevo più tornare in Russia!
Ben presto fui assorbito dal movimento anarchico che si sviluppava allora nell’Europa occidentale, e sentivo di poter essere più utile aiutando quel movimento a trovare la propria espressione di quanto avrei potuto esserlo in Russia. Ero troppo conosciuto in patria per poter fare propaganda aperta, soprattutto fra operai e contadini, e più tardi, quando in Russia il movimento rivoluzionario prese la forma di una cospirazione e di una lotta armata contro il rappresentante dell’autocrazia, si dovette abbandonare anche l’idea di un movimento popolare; le mie simpatie invece mi spingevano sempre di più a condividere la sorte delle masse lavoratrici. Comunicare loro i concetti capaci di aiutarli a indirizzare i loro sforzi al più grande vantaggio di tutti i lavoratori; approfondire e allargare le idee e i princìpi su cui si fonderà la rivoluzione sociale; spiegare questi ideali e questi princìpi ai lavoratori, perché diventassero non già comandi ricevuti dai loro capi, ma il risultato dei loro stessi ragionamenti, e risvegliare così il loro spirito di iniziativa, ora che erano destinati ad agire sulla scena della storia quali costruttori di una nuova e giusta organizzazione sociale, tutto questo mi pareva tanto necessario al progresso dell’umanità quanto quello che mi sarebbe stato possibile fare in quel momento in Russia. Mi unii quindi ai pochi uomini che lavoravano a questo scopo nell’Europa occidentale, prendendo il posto di quelli che lunghi anni di lotta durissima avevano abbattuto.
Quando sbarcai a Hull e mi recai a Edimburgo informai del mio felice arrivo in Inghilterra solo pochi amici in Russia e della Federazione del Giura. Un socialista deve sempre vivere del frutto del proprio lavoro, e appena mi fui sistemato in una cameretta nei sobborghi della capitale della Scozia mi misi quindi alla ricerca di qualche lavoro.
Sul piroscafo avevo fatto conoscenza con un professore norvegese e avevo cercato con lui di ricordare quel poco che avevo studiato di lingua svedese. Il professore parlava il tedesco. “Ma poiché voi parlate un poco di norvegese”, mi disse, “se vi sforzate un poco riusciremo a parlarlo insieme”.
“Volete dire che parlo lo svedese?”. domandai esitando. “Parlo lo svedese, non è vero?”.
“Ma, io direi piuttosto il norvegese; certamente non lo svedese”, mi rispose.
Mi successe così quello che era accaduto a uno degli eroi di Verne, il quale per errore aveva imparato il portoghese invece dello spagnolo! Parlai molto, comunque con il professore – diciamo pure in norvegese – ed egli mi diede un giornale di Cristiania con il resoconto di una spedizione norvegese nei mari dell’estremo Nord atlantico, che era proprio allora tornata in patria. Appena arrivato a Edimburgo scrissi in inglese un breve articolo su queste esplorazioni e lo mandai alla rivista “Nature”, una pubblicazione che io e mio fratello leggevamo regolarmente a Pietroburgo fin dalle sue origini. Il direttore mi scrisse ringraziandomi e osservando, con la grande indulgenza che ho poi incontrato tante volte in Inghilterra, che il mio inglese era “ottimo”, ma che si allontanava alquanto dalla “lingua parlata”. In realtà avevo studiato l’inglese in Russia e avevo tradotto con mio fratello la Filosofìa della Geologia di Page e i Princìpi di Biologia di Herbert Spencer. Ma l’avevo studiato sui libri e lo pronunciavo malissimo, tanto che riuscivo appena a farmi capire dalla mia padrona di casa scozzese. Sua figlia e io avevamo preso l’abitudine di scrivere su dei pezzi di carta quello che ci dovevamo dire; devo perciò aver fatto degli errori curiosissimi. Ricordo comunque di aver protestato, per iscritto, chiedendo non “una tazza di tè”, ma molte tazze; la mia poca conoscenza della lingua parlata mi fece esprimere in modo tale da farmi giudicare dalla mia ospite un ghiottone; ma devo dire per scusarmi che né i libri di geologia che avevo letto in inglese, né la Biologia di Spencer contenevano allusioni a qualcosa di così importante come il modo di bere il tè!
Dalla Russia ricevevo il “Bollettino della Società Geografica Russa” e presto incominciai a scrivere per il “Times” degli stelloncini di attualità sulle esplorazioni geografiche russe. Prževal’skij faceva allora il suo viaggio attraverso l’Asia centrale e in Inghilterra seguivano con interesse i suoi progressi.
Il denaro che avevo portato con me scemava però rapidamente, e poiché le lettere che spedivo in Russia venivano intercettate, non riuscivo a far conoscere ai miei parenti il mio indirizzo. Dopo alcune settimane mi trasferii quindi a Londra, nella speranza di trovarvi del lavoro più sicuro. P. L. Lavrov, il vecchio fuoruscito, continuava a redigere a Londra la sua rivista “Avanti!”, ma avevo ancora la speranza di tornare presto in Russia e non volli andarvi, prevedendo che la redazione del giornale russo doveva essere strettamente sorvegliata dalle spie.
Andai, naturalmente, alla redazione della rivista “Nature”, dove fui ricevuto cordialmente dal suo redattore capo, J. Scott Keltie. Il direttore desiderava dare maggior spazio alla rubrica delle note, e trovava che io le scrivevo appunto com’egli desiderava. Mi fu perciò riservato un tavolo nell’ufficio dove si ammonticchiavano le riviste in tutte le lingue possibili. “Venite tutti i lunedì, signor Levašov”, mi dissero, “date un’occhiata a queste riviste e se trovate qualche articolo interessante scrivete uno stelloncino, o segnalateci l’articolo e noi lo spediremo a uno specialista”. Il signor Keltie non immaginava certo che io trascrivessi ogni articolo tre o quattro volte, prima di osare sottoporgli il mio inglese; ma mi portavo le riviste a casa e non tardai a guadagnarmi la vita discretamente.
La mia collaborazione al “Times” mi era pagata regolarmente il giovedì, un’istituzione eccellente, trovavo. Purtroppo c’erano settimane nelle quali mancavano notizie da Prževal’skij, e le notizie dalle altre parti della Russia non erano considerate interessanti, e allora... facevo penitenza con solo pane e tè.
Un giorno però il signor Keltie tolse dagli scaffali diversi libri russi e mi pregò di farne delle recensioni per la sua rivista. Guardai i libri e fui molto imbarazzato vedendo che erano le mie opere sul periodo glaciale, e su l’orografia dell’Asia. Mio fratello non si era dimenticato di spedirli al nostro prediletto “Nature”. Mi trovai in una posizione imbarazzante, misi i libri nella borsa e me li portai a casa, per riflettere su quello che dovevo fare. Dicevo fra di me: “Non posso lodarmi, perché li ho scritti io e non posso criticare troppo l’autore perché le sue idee sono le mie”. Decisi di riportarli il giorno dopo e di spiegare al signor Keltie, che, pur essendomi presentato a lui con il nome di Levasov, ero l’autore di quei libri e non potevo quindi recensirli.
Il signor Keltie aveva saputo dai giornali della fuga di Kropotkin e apprese con molto piacere la notizia che il fuggiasco era al sicuro in Inghilterra. Quanto ai miei scrupoli, osservò giustamente che non era necessario che io lodassi o criticassi l’autore, ma che potevo semplicemente informare i lettori del contenuto dei volumi. Da quel giorno data un’amicizia che dura ancor oggi fra noi.
In novembre o dicembre del 1876 vidi nella “Piccola Posta” del giornale di P. L. Lavrov un invito a K. di andare alla redazione per farsi consegnare una lettera dalla Russia, e credendo si trattasse di me vi andai e ben presto feci amicizia con il direttore e con i giovani che facevano il giornale.
La prima volta che andai al giornale – la barba rasata e la tuba in capo – e chiesi alla signora che mi aprì, nel mio migliore inglese: “È in casa il signor Lavrov?”, pensavo che nessuno mi avrebbe riconosciuto prima che io mi presentassi. Ma la signora, che non mi conosceva affatto, ma che aveva conosciuto mio fratello durante il suo soggiorno a Zurigo, mi riconobbe subito, come mi disse più tardi, “dai vostri occhi, che mi ricordarono gli occhi di vostro fratello”.
Non mi fermai allora molto a lungo in Inghilterra. Mantenevo una corrispondenza regolare con il mio amico James Guillaume della Federazione del Giura, e appena ottenni l’incarico di un lavoro di geografia che potevo fare tanto in Svizzera quanto a Londra, partii per la Svizzera. Le lettere che finalmente ricevetti da casa mi dicevano che dovevo restare all’estero, perché in Russia si poteva fare ben poco. In quel momento il paese era percorso da un’ondata di entusiasmo per gli slavi che si ribellavano alla secolare oppressione dei turchi, e i miei migliori amici, Sergej (Stepnjak), Kelnitz e diversi altri erano già partiti per la penisola balcanica a raggiungere gli insorti. “Leggiamo nelle corrispondenze del ‘Daily News’, mi scrivevano i miei amici, “gli orrori commessi in Bulgaria; li leggiamo piangendo e poi partiamo ad arruolarci o come volontari nelle bande degli insorti bulgari o come infermieri”.
Appena giunto in Svizzera mi iscrissi alla Federazione del Giura dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori e, seguendo i consigli degli amici svizzeri, mi stabilii a La Chaux-de-Fonds.
La Federazione del Giura ha dato un notevole contributo all’attuale sviluppo del socialismo.
Accade sovente che un partito politico, dopo essersi prefisso un certo scopo e aver proclamato solennemente di non volersene allontanare, si trovi invece costretto a dividersi in due frazioni. Una rimane fedele alle origini, mentre l’altra, pur pretendendo di non cambiare, accetta dei compromessi e poco per volta, di compromesso in compromesso, si allontana dal programma iniziale e si trasforma in un modesto partito di riformisti.
Una scissione del genere era avvenuta in seno all’Associazione Internazionale dei Lavoratori. Da principio lo scopo dell’Associazione era ben chiaro, e si trattava addirittura dell’espropriazione degli attuali proprietari fondiari e dei capitalisti, e del passaggio di tutti i mezzi di produzione della ricchezza ai produttori stessi. I lavoratori di tutti i paesi erano chiamati a organizzarsi per una lotta immediata contro il capitalismo, a elaborare i mezzi per socializzare la produzione e la distribuzione della ricchezza e, quando fossero stati pronti, a impossessarsi dei mezzi di produzione e a controllarne il prodotto senza preoccuparsi dell’attuale organizzazione politica, che avrebbe dovuto subire una completa riorganizzazione. L’Associazione doveva dunque essere lo strumento per preparare una profonda e vastissima rivoluzione nel pensiero umano prima e poi, più tardi, nelle forme stesse della vita, una rivoluzione che avrebbe aperto all’umanità una nuova era di progresso, fondata sulla solidarietà universale. Questo era l’ideale che destò dal sonno milioni di operai europei e che attirò all’Associazione le migliori forze intellettuali.
Non tardarono però a manifestarsi due tendenze. Quando la guerra del ’70 terminò con la completa sconfitta della Francia, quando la rivolta della Comune fu schiacciata e le leggi draconiane decretate contro l’Associazione ne esclusero tutti gli operai francesi, e quando d’altra parte nella “Germania unita” fu instaurato il regime parlamentare, la meta a cui tendevano i radicali dopo il 1848, i Tedeschi si sforzarono di modificare i fini e i mezzi dell’intero movimento socialista. “La conquista del potere negli Stati attuali” divenne la parola d’ordine della tendenza che prese il nome di socialdemocrazia. I primi successi di questo partito nelle elezioni al Reichstag tedesco destarono grandi speranze. Poiché il numero dei deputati socialisti era aumentato da due a sette e poi a nove, si vide in ciò, da parte di uomini altrimenti ragionevoli, la prova certa che prima della fine del secolo i socialisti avrebbero ottenuto una maggioranza al parlamento tedesco e avrebbero introdotto lo “Stato popolare” socialista per mezzo di una legislazione favorevole a loro. A poco a poco l’ideale socialista di questo partito si spogliò della sua caratteristica: quella cioè di essere elaborato dalle masse lavoratrici organizzate; si trasformò nell’organizzazione dell’industria da parte dello Stato, cioè nel socialismo di Stato, nel capitalismo di Stato. Oggi in Svizzera gli sforzi dei socialdemocratici sono diretti contro il federalismo in favore del centralismo, e a promuovere l’esercizio di Stato delle ferrovie, il monopolio di Stato delle banche e della distribuzione dei liquori. Lo sfruttamento da parte dello Stato della terra e delle principali industrie, e anche la distribuzione della ricchezza, sarebbe il prossimo passo che si compirebbe in un avvenire più o meno lontano.
A poco a poco tutta la vita e l’attività del partito socialista tedesco furono subordinate alle esigenze elettorali. I sindacati operai furono considerati con disprezzo e gli scioperi disapprovati, perché distraevano gli operai dalla lotta elettorale. Ogni sollevazione popolare, ogni agitazione rivoluzionaria, in qualsiasi paese d’Europa, ebbe un biasimo anche più severo dai capi del partito socialdemocratico e dalla stampa capitalista.
Questa nuova linea politica ebbe però pochi aderenti nei paesi latini. Le sezioni e le federazioni dell’Internazionale rimasero fedeli ai princìpi che avevano prevalso al momento della fondazione dell’Associazione. I lavoratori latini, federalisti per tradizione, ostili all’idea dello Stato centralizzato ed eredi di tradizioni rivoluzionarie, non potevano seguire l’evoluzione dei Tedeschi.
La scissione fra le due tendenze socialiste si manifestò immediatamente dopo la guerra franco-germanica. Come ho già osservato, l’Internazionale era retta da un governo, sotto forma di un Consiglio generale residente a Londra, e poiché questo Consiglio era diretto da due tedeschi, Engels e Marx, non tardò a diventare la roccaforte della nuova tendenza socialdemocratica; Bakunin e i suoi amici, invece, erano gli ispiratori e la mente dirigente delle federazioni latine.
La lotta fra marxisti e bakuninisti non era una questione di uomini. Era la lotta inevitabile fra i princìpi del federalismo e quelli del centralismo, fra il Comune libero e l’autorità paternalistica dello Stato, fra l’azione autonoma delle masse popolari e il miglioramento delle attuali condizioni capitaliste attraverso la legislazione, una lotta fra lo spirito latino e il tedesco Geist. I Tedeschi, sconfitta la Francia sui campi di battaglia, pretendevano ora la supremazia nella scienza, nella politica, nella filosofia e anche nel socialismo, attribuendo alla loro tendenza la qualifica di “scientifica” e considerando “utopistica” ogni altra interpretazione.
Al Congresso dell’Associazione Internazionale tenutosi all’Aja nel 1872, il Consiglio generale di Londra, per mezzo di una maggioranza fittizia, espulse Bakunin, il suo amico Guillaume e persino la Federazione del Giura dall’Associazione Internazionale. Ma poiché si sapeva che la maggioranza dell’Internazionale, cioè le federazioni spagnole, italiane e belghe, erano favorevoli ai giurassiani, il Congresso cercò di sciogliere l’Associazione. Un nuovo Consiglio generale, composto da pochi socialdemocratici fu nominato a New York, dove non esistevano né organizzazioni, né operai affiliati all’Associazione, che la potessero sorvegliare, e non se ne è più saputo nulla. Intanto le federazioni dell’Internazionale spagnole, italiane, belghe e del Giura sopravvissero e si riunirono, come sempre, nei cinque o sei anni seguenti, nei loro Congressi internazionali annuali.
Al mio arrivo in Svizzera la Federazione del Giura era il centro e l’organismo più autorevole delle federazioni internazionaliste. Bakunin era morto da poco (il 1 luglio 1876) ma la federazione conservava la posizione che aveva raggiunto sotto il suo impulso.
In Francia, in Spagna e in Italia solo per il persistere dello spirito rivoluzionario penetrato fra le masse popolari per merito degli internazionalisti prima della guerra franco-tedesca si poté impedire ai governi l’instaurazione di un regno del terrore. Si sa come i Borboni per poco non riprendessero il potere a Parigi; il Maresciallo Mac-Mahon, come presidente della Repubblica, doveva preparare il ritorno della monarchia. A Parigi era tutto pronto per l’ingresso trionfale di Enrico V e si preparavano già le gualdrappe dei cavalli, ornate della corona e delle iniziali del pretendente. Se il colpo di Stato non riuscì, fu solo perché Gambetta e Clemenceau, l’opportunista e il radicale, avevano saputo seminare per tempo la Francia di comitati armati e pronti alla rivolta. Ma la vera forza di questi comitati era negli operai, una gran parte dei quali era appartenuta all’Internazionale e ne aveva conservato lo spirito rivoluzionario. E posso aggiungere, per quello che ne so personalmente, che mentre i capi radicali dei comitati, appartenenti alla media borghesia, avrebbero forse esitato al momento dell’azione, gli operai invece si sarebbero sollevati, prima per la difesa della Repubblica e poi forse anche per il trionfo dell’ideale socialista.
Così avvenne in Spagna. Appena l’ambiente clericale e aristocratico che circondava il re cercò di spingerlo alla reazione, i repubblicani minacciarono un movimento nel quale sapevano bene che la forza combattiva era costituita dagli operai. La sola Catalogna contava più di centomila uomini fortemente organizzati nei sindacati operai, ed erano più di ottantamila gli spagnoli iscritti all’Internazionale, che tenevano regolarmente i loro Congressi e pagavano puntualmente i loro contributi all’Associazione, con un senso del dovere veramente spagnolo. Parlo di queste organizzazioni per esperienza personale, acquistata sul posto, e so che erano pronte a proclamare gli Stati Uniti di Spagna, ad abbandonare le colonie e, nelle regioni più avanzate, a fare dei seri passi verso il collettivismo. Questa continua minaccia impediva alla monarchia spagnola di sciogliere tutte le organizzazioni operaie e contadine e di instaurare un regime apertamente reazionario e clericale.
E in Italia le condizioni erano esattamente le stesse. I sindacati operai dell’Italia settentrionale non avevano allora la forza che hanno oggi; ma intere province formicolavano di sezioni internazionaliste e di gruppi repubblicani. La monarchia si sarebbe trovata in serio pericolo se i repubblicani borghesi avessero fatto appello agli elementi rivoluzionari popolari.
Insomma, quando ripenso a quegli anni da cui ci divide ormai un quarto di secolo, sono convinto che se l’Europa dopo il 1871 non cadde sotto un regime di profonda reazione, si deve allo spirito rivoluzionario diffuso dall’Internazionale nell’Europa occidentale prima della guerra franco-prussiana, alimentato poi dagli internazionalisti anarchici, dai blanquisti, dai mazziniani e dai repubblicani “cantonalisti” di Spagna.
Naturalmente i marxisti, preoccupati delle lotte elettorali locali, non si occupavano di tutto ciò. Desiderosi di non attirarsi i fulmini di Bismarck e temendo più di ogni altra cosa che lo spirito rivoluzionario potesse diffondersi in Germania e provocare repressioni che non si sentivano in grado di fronteggiare, non solo per ragioni di tattica, negarono ogni simpatia ai rivoluzionari occidentali, ma non tardarono a odiare lo spirito rivoluzionario e lo rinnegarono violentemente dovunque si manifestasse, anche quando incominciò a delinearsi in Russia.
A quell’epoca, sotto il maresciallo Mac-Mahon, non si poteva pubblicare in Francia nessun giornale rivoluzionario, era un delitto persino cantare la Marsigliese e fui sorpreso una volta nel notare il terrore di alcuni miei compagni di viaggio, quando sentirono alcuni coscritti intonare l’inno rivoluzionario (nel maggio 1878). “Ma è permesso ancora cantare la Marsigliese?”, si chiedevano meravigliati. In Francia la stampa socialista era stata soppressa. I giornali spagnoli erano fatti molto bene e alcuni manifesti dei loro Congressi erano esposizioni mirabili del socialismo anarchico; ma chi conosce le cose spagnole fuori della Spagna? Quanto ai giornali italiani erano tutti di vita breve, nascevano, scomparivano, morivano e tornavano a nascere sotto titolo diverso; e benché alcuni fossero eccellenti, non circolavano fuori d’Italia. Di conseguenza la Federazione del Giura, con i suoi giornali redatti in lingua francese, diventò il centro animatore dello spirito rivoluzionario nei paesi latini, spirito che, ripeto, risparmiò all’Europa un periodo di reazione. E in questo centro le teorie dell’anarchia furono sviluppate da Bakunin e dai suoi compagni in una lingua compresa in tutta l’Europa continentale.
Appartenevano allora alla Federazione del Giura molti uomini notevoli di diversi paesi, che erano stati quasi tutti amici personali di Bakunin. Il redattore capo del nostro principale giornale, il “Bollettino della Federazione”, era James Guillaume, un insegnante, membro di una famiglia aristocratica di Neuchâtel. Piccolo, magro, dall’aspetto rigido e risoluto di un Robespierre, con un cuore d’oro, che si rivelava solo nell’intimità dell’amicizia, la sua straordinaria capacità di lavoro, la sua tenace attività ne facevano un capo nato. Per otto anni lottò contro difficoltà di ogni genere per mantenere vivo il giornale, interessandosi attivamente a tutti i particolari della vita della Federazione, finché dovette lasciare la Svizzera per l’impossibilità di trovare lavoro, e si stabilì in Francia, dove il suo nome sarà ricordato un giorno con onore nella storia della pedagogia.
Adhemar Schwitzguebel, pure svizzero, era il prototipo degli orologiai di lingua francese, cordiali, allegri, arguti, come se ne trovano nel Giura bernese. Incisore di orologi di mestiere, non cercò mai di abbandonare la sua condizione di operaio, e sempre allegro e attivo riusciva a mantenere la sua famiglia numerosa anche nei periodi più duri di morta stagione e di salari ridotti.
Aveva una meravigliosa capacità di afferrare un problema difficile di economia o di politica e, dopo maturo esame, di considerarlo dal punto di vista dell’operaio, senza spogliarlo del suo senso più profondo. Tutti lo conoscevano nelle “montagne” ed era il beniamino degli operai di tutti i paesi.
Completamente diverso era un altro svizzero, anche lui orologiaio, [Auguste] Spichiger. Era un filosofo, lento nei movimenti e nel pensiero, di aspetto inglese; cercava di approfondire la conoscenza del valore di ogni fatto e ci impressionava sempre con la giustezza delle conclusioni a cui arrivava, meditando sui problemi più diversi, mentre lavorava a curvare le calotte degli orologi.
Attorno a questi tre si radunavano molti operai di mezza età o vecchi, onesti e seri, appassionatamente amanti della libertà, felici di appartenere a un movimento così promettente, e anche un centinaio di giovani pieni di vita, per lo più orologiai, tutti indipendenti, di cuore, allegri e pronti a qualsiasi sacrificio.
Diversi esuli della Comune di Parigi si erano iscritti alla Federazione. Fra questi c’era Elisée Réclus, il grande geografo, tipo di vero puritano per la sua vita e di filosofo enciclopedista francese del secolo scorso per la sua mentalità; uomo che animava gli altri, ma che non ha mai comandato nessuno, né mai lo farà. È l’anarchico la cui fede è l’essenza della sua conoscenza vasta e profonda della vita umana in tutte le sue manifestazioni, in tutti i paesi e a tutti i gradi di civiltà, i cui libri sono fra i migliori del secolo; il cui stile, di notevole bellezza, colpisce la mente e la coscienza; che quando entra nella redazione di un giornale anarchico dice al direttore – che di fronte a lui è forse un ragazzo: “Ditemi che cosa devo fare”, e siede, come un collaboratore qualunque, a scrivere poche righe per riempire una lacuna sul numero che si sta stampando. Durante la Comune di Parigi si armò di un fucile e prese il suo posto fra i combattenti. Se invita qualcuno a collaborare alla sua Geografia di fama mondiale, e il collaboratore chiede timidamente: “Che cosa devo fare?”. egli risponde: “Ecco i libri, ecco una tavola. Fate quello che volete”.
Al suo fianco era [Gustave] Lefrançais, un uomo anziano che era stato insegnante e che tre volte aveva conosciuto l’esilio: dopo il giugno 1848, dopo il colpo di Stato di Napoleone e dopo il 1871. Ex membro della Comune, e come tale uno di quelli che dicevano avessero abbandonato Parigi portandosi via dei milioni, lavorava come facchino alla stazione di Losanna e per poco non soccombette a quel lavoro, che richiedeva spalle più giovani delle sue. Il suo libro sulla Comune di Parigi è quello che mette nella sua vera luce l’importanza storica di quel movimento. “Sono comunardo, ma anarchico no”, diceva: “non posso lavorare con dei pazzi come voi”. Eppure lavorava solo con noi. “Perché”, soggiungeva, “voi pazzi siete sempre quelli che amo di più. Con voi si può lavorare conservando la propria individualità”.
Un altro ex membro della Comune che stava con noi era [Johannard] Pindy, un falegname del Nord della Francia, ma figlio adottivo della capitale. Si era fatto molto notare a Parigi per la sua energia e la sua intelligenza vivace durante uno sciopero appoggiato dall’Internazionale, ed era stato eletto membro della Comune, che lo nominò comandante del Palazzo delle Tuileries. Quando i Versagliesi entrarono a Parigi, fucilando a centinaia i prigionieri, non meno di tre persone furono fucilate in diversi punti della città, per essere state scambiate per Pindy. Finita la battaglia, invece, fu nascosto da una ragazza coraggiosa, una cucitrice in bianco, che lo salvò grazie alla sua calma quando la casa fu perquisita dalla polizia: quella ragazza diventò poi sua moglie. Solo dopo dodici mesi riuscirono a lasciare Parigi di nascosto e a venire in Svizzera. Qui Pindy imparò l’arte del saggiatore di metalli, in cui divenne abilissimo, e passava le giornate vicino alla sua stufa infuocata, dedicandosi poi di notte con passione al lavoro di propaganda, che svolgeva unendo mirabilmente l’ardore del rivoluzionario al buon senso e alle capacità organizzative dell’operaio parigino.
Paul Brousse era allora un giovane dottore dal cervello sempre in attività, rumoroso, sempre in moto, allegro, pronto a sviluppare con logica rigorosa qualunque idea fino alle estreme conseguenze; potente nelle sue critiche dello Stato e dell’organizzazione statale, trovava il tempo di redigere due giornali, uno in francese e l’altro in tedesco, di scrivere dozzine di lettere voluminose, di essere l’anima di una riunione serale di operai; sempre pronto ad organizzare altri compagni, con la sua intelligenza sottile da vero meridionale.
Tra gli italiani che lavorarono con noi in Svizzera c’erano due uomini i cui nomi inseparabili saranno ricordati in Italia da più di una generazione, due grandi amici personali di Bakunin, Cafiero e Malatesta. Cafiero era un idealista dei più nobili e puri, che diede alla causa una fortuna considerevole e che non si domandava mai come sarebbe vissuto il giorno dopo; un pensatore assorto nelle sue speculazioni filosofiche; un uomo che non avrebbe mai fatto del male a nessuno, e che ciò nonostante prese il fucile e si mise in marcia per le montagne del beneventano quando a lui e ai suoi amici parve possibile tentare un’insurrezione di carattere socialista, anche solo per dimostrare al popolo che le insurrezioni dovrebbero avere uno scopo più vasto di quello delle semplici ribellioni contro gli agenti del fisco. Malatesta era uno studente di medicina che aveva abbandonato la professione e anche la ricchezza per la causa della rivoluzione; un uomo pieno di fuoco e di intelligenza, un idealista puro, che in tutta la sua vita – e ormai ha quasi cinquant’anni – non si è mai preoccupato di sapere se avrebbe avuto un pezzo di pane per la sua cena o un letto per riposarvi la notte. Senza neppure una stanza che potesse dire sua, vendeva per le vie di Londra i gelati per guadagnarsi da vivere e la sera scriveva articoli pieni di acume per i giornali italiani. Arrestato in Francia, rimesso in libertà, espulso; condannato di nuovo in Italia, confinato in un’isola, fuggito di nuovo in Italia travestito; sempre dove la lotta è più aspra, sia in Italia che altrove, ha continuato a fare questa vita per trent’anni di seguito. E quando lo incontriamo di nuovo, uscito da una prigione o fuggito da un’isola, lo ritroviamo sempre uguale a quando l’avevamo lasciato: sempre disposto a ricominciare la lotta, animato dallo stesso amore per gli uomini, senza livore per i suoi avversari e carcerieri, con lo stesso affettuoso sorriso per gli amici, la stessa carezza per un bimbo.
C’erano pochi Russi fra di noi, la maggioranza si era messa con i socialisti tedeschi. C’era però žukovskij, un amico di Herzen, che aveva lasciato la Russia nel 1863 – un aristocratico, brillante, elegante, intelligentissimo, con una grande popolarità fra gli operai, che aveva più di tutti noi quello che i Francesi chiamano “l’oreille du peuple”, perché sapeva come entusiasmarli facendo vedere loro quale parte avrebbero avuto nella ricostruzione della società, sapeva elevarli aprendo ai loro occhi vasti orizzonti storici, proiettando un raggio di luce sui più ardui problemi economici, ed elettrizzarli con la sua convinzione sincera. Per un certo periodo avemmo con noi Sokolov, che era stato ufficiale di Stato maggiore in Russia, ammiratore dell’audacia di Paul Louis Courier e delle idee filosofiche di Proudhon, che aveva convertito molti al socialismo in Russia, grazie ai suoi numerosi scritti sui periodici del tempo.
Faccio qui solo il nome di quelli che si resero particolarmente celebri come scrittori, o come delegati ai Congressi o per qualche altra ragione. Eppure mi domando se non dovrei piuttosto parlare di quelli di cui non si seppe mai il nome, ma che ebbero tanta parte nella vita della Federazione quanto qualsiasi scrittore, quelli che combatterono come semplici soldati e che erano sempre pronti a partecipare a qualunque lavoro, senza mai chiedere se il loro compito sarebbe stato grande o piccolo, importante o modesto – se avrebbe avuto grandi risultati o se avrebbe fruttato solo infinite noie a loro e alle loro famiglie.
Dovrei anche ricordare i tedeschi [Emil] Werner e [Otto] Rinke, lo spagnolo [Severino] Albarracin e molti altri; ma temo con questi miei poveri ricordi di non ispirare al lettore lo stesso senso di rispetto e d’amore che ognuno dei membri di questa piccola famiglia destava in quelli che li conoscevano personalmente.
Di tutte le città svizzere che conosco, La Chaux-de-Fonds è forse la meno piacevole. È posta su di un altopiano completamente privo di vegetazione, esposta ai venti gelidi dell’inverno e la neve non resta alta come a Mosca, ma si scioglie e torna a cadere, tante volte quanto a Pietroburgo. Ci interessava peraltro fare conoscere le nostre idee in questo centro e rianimare la propaganda locale. Là c’erano Pindy, Spichiger, Albarracin, i due blanquisti [Hippolyte] Ferré e [Pierre] Jaillot e potevo vedere ogni tanto Guillaume a Neuchâtel e Schwitzguebel nella valle di Saint-Imier.
Si iniziava ora per me una vita attiva, di lavoro, come appunto mi piace. Tenevamo molte riunioni e diffondevamo noi stessi i manifestini nei caffè e nelle fabbriche. Una volta la settimana la nostra sezione si riuniva e si svolgevano allora le discussioni più animate; andavamo poi a predicare l’anarchia anche nelle riunioni dei vari partiti politici, viaggiai molto, recandomi presso altre sezioni e aiutandole.
Ci guadagnammo molte simpatie quell’inverno, ma il nostro lavoro regolare fu molto ostacolato da una crisi dell’industria degli orologi. Metà degli operai erano disoccupati o lavoravano poco, tanto che il comune dovette aprire delle mense economiche. L’officina cooperativa aperta dagli anarchici a La Chaux-de-Fonds, dove tutti i guadagni venivano divisi in parti eguali fra gli aderenti, ebbe molte difficoltà a trovare lavoro, benché godesse di un’ottima fama, e Spichiger dovette più volte mettersi a cardar lana per un tappezziere per guadagnarsi da vivere.
Quell’anno partecipammo tutti, a Berna, a una manifestazione fatta con la bandiera rossa. L’ondata della reazione era arrivata anche in Svizzera e la polizia di Berna, sfidando la Costituzione, aveva proibito che si esponesse la bandiera degli operai. Era quindi necessario dimostrare che almeno qua e là gli operai non permettevano che si calpestassero i loro diritti e che erano pronti a resistere. Andammo tutti a Berna per l’anniversario della Comune di Parigi e portammo per le strade la bandiera rossa, nonostante la proibizione. Naturalmente ci fu uno scontro con la polizia, due compagni ebbero delle sciabolate e due poliziotti furono feriti piuttosto gravemente. Ma la bandiera rossa fu portata trionfalmente alla sala della riunione, e si tenne un’adunanza animatissima. Non c’è bisogno di aggiungere che i cosiddetti capi erano in prima fila e si batterono come gli altri. Nel processo furono implicati una trentina di cittadini svizzeri che chiedevano tutti di essere processati, e quelli che avevano ferito i due poliziotti assunsero spontaneamente la loro responsabilità. Il processo ci conquistò molte simpatie; si capiva che era necessario difendere gelosamente tutte le libertà che non si volevano perdere. Le condanne furono quindi molto lievi e non sorpassarono i tre mesi di carcere.
Il governo di Berna, però, proibì che la bandiera rossa fosse portata nel territorio del Cantone; la Federazione del Giura, allora, decise di portarla, malgrado la proibizione, a Saint-Imier, dove quell’anno si teneva il nostro Congresso. Questa volta eravamo in gran parte armati e disposti a difendere fino all’ultimo la nostra bandiera. Una compagnia di poliziotti era stata messa nella piazza per fermare la nostra colonna; un distaccamento della milizia si teneva pronto in un campo vicino, con il pretesto del tiro a segno, e potevamo sentire distintamente i colpi di arma da fuoco, mentre attraversavamo la città. Ma quando la nostra colonna giunse nella piazza e dal suo aspetto imponente si capì che qualsiasi aggressione sarebbe stata seguita da spargimento di sangue, il sindaco ci permise di continuare indisturbati la nostra marcia fino alla sala della riunione. Nessuno di noi desiderava la battaglia; ma la tensione di quella marcia, incolonnati e pronti a tutto, al suono di una musica marziale, era stata tale che non saprei dire, i primi minuti dopo il nostro arrivo nella sala, quale fosse il sentimento predominante: se il sollievo per il fatto che ci era stata risparmiata la necessità di una battaglia che non desideravamo, o il rammarico perché la battaglia non aveva avuto luogo – l’animo umano è molto complesso davvero.
La nostra maggiore attività fu però rivolta a sviluppare la teoria e la pratica del socialismo anarchico, e in questo senso la Federazione del Giura ha certo svolto un lavoro che avrà un effetto duraturo.
Vedevamo che nei paesi civili stava maturando una nuova forma di società, che dovrà prendere il posto della vecchia: una società di eguali che non saranno obbligati a vendere le loro braccia e la loro intelligenza a coloro che decidono di servirsene a caso, ma che saranno in grado di utilizzare le loro conoscenze e le loro capacità per la produzione, in un organismo costruito in modo da saper unire tutti gli sforzi per procurare il massimo di benessere possibile per tutti, pur lasciando piena e assoluta libertà a ogni iniziativa individuale. Questa società sarà composta di una moltitudine di associazioni, federate per tutti gli obiettivi che richiedano una federazione; federazioni di lavoratori per ogni genere di produzione – agricola, industriale, intellettuale, artistica; comuni di consumo che provvederanno alle abitazioni, all’illuminazione e al riscaldamento, alle riserve alimentari, alle attrezzature sanitarie, ecc.; federazioni fra le varie comuni e federazioni di comuni e di organismi di produzione; e infine gruppi più vasti, comprendenti tutto il paese o vari Paesi, composti di uomini che collaborino per soddisfare quelle esigenze economiche, intellettuali, artistiche e morali che non sono limitate a un solo territorio. Tutti questi concorreranno direttamente, grazie ad accordi stretti liberamente fra di loro, allo stesso modo in cui ora collaborano le ferrovie o le poste di paesi diversi, anche se le une sono gestite a fini puramente egoistici e le altre appartengono a Stati diversi e spesso ostili fra di loro; o come gli scienziati, le associazioni alpinistiche, le società di salvataggio in Inghilterra, le associazioni fra i ciclisti, gli insegnanti e così via, che uniscono i loro sforzi per compiere opere di carattere intellettuale o semplicemente di svago. La libertà più completa favorirà lo sviluppo di nuove forme di produzione, di organizzazione, e di nuove invenzioni; l’iniziativa individuale sarà incoraggiata e ogni tendenza all’uniformità e alla centralizzazione combattuta.
Questa società poi, non sarà cristallizzata in forme determinate e fisse, ma si modificherà continuamente, perché sarà un organismo vivo in evoluzione; non si sentirà la necessità di un governo, perché gli uomini liberi e la federazione lo possono sostituire in tutte quelle funzioni che i governi considerano oggi loro proprie, e perché, essendo molto ridotti i motivi di contrasto, le lotte che ancora potranno sorgere verranno sottoposte ad arbitrato.
Nessuno di noi minimizzava l’importanza e la profondità del cambiamento a cui aspiravamo. Capivamo che le opinioni attuali sulla necessità della proprietà privata della terra, delle fabbriche, delle miniere, delle case e così via, al fine di assicurare il progresso industriale, e del salariato, come mezzo per obbligare gli uomini al lavoro, non avrebbero ceduto facilmente il posto ai concetti più elevati della proprietà e della produzione sociale. Sapevamo che un faticoso periodo di propaganda e una lunga serie di lotte, di rivolte individuali e collettive contro le forme di proprietà che ora prevalgono, di sacrifici individuali, di parziali ricostruzioni e di rivoluzioni parziali, avrebbe dovuto essere affrontato prima che si modificassero le idee che predominano oggi in fatto di proprietà privata. E capivamo anche che le attuali idee sulla necessità dell’autorità – nelle quali siamo stati educati tutti – non potevano essere abbandonate a un tratto dalla società. Sarebbero stati necessari lunghi anni di propaganda e una lunga serie di atti parziali di ribellione all’autorità, così come una completa revisione degli insegnamenti che si deducono oggi dalla storia, prima che gli uomini arrivassero a rendersi conto dell’errore in cui cadono quando attribuiscono ai governi e alle leggi quello che in realtà deriva dai loro stessi sentimenti e costumi sociali. Sapevamo tutto questo. Ma sapevamo anche che predicando un mutamento verso gli ideali del comunismo anarchico, avremmo lavorato nella corrente del progresso dell’umanità.
Una conoscenza più intima delle classi operaie e dei loro simpatizzanti fra le classi più colte mi persuase che si dava maggior valore alla libertà personale che al benessere individuale. Cinquant’anni fa gli operai erano pronti a vendere la loro libertà personale a reggitori di ogni sorta, anche a un Cesare, in cambio della promessa del benessere materiale, ma non era più così ora. Vedevo che la fede cieca nei governanti eletti, anche se scelti fra i migliori capi del movimento operaio, si andava spegnendo fra gli operai latini. “Prima di tutto dobbiamo sapere di cosa abbiamo bisogno, e poi lo sapremo fare meglio da noi stessi”: era questa un’idea che trovava molto credito in mezzo a loro, molto più di quanto di solito si creda. La frase dello statuto dell’Associazione Internazionale: “L’emancipazione degli operai dovrà essere opera degli operai stessi”, aveva incontrato il favore generale e si era ben radicata nel loro cervello. La triste esperienza della Comune di Parigi non fece che rafforzarla.
Quando questa insurrezione era scoppiata, moltissimi, anche appartenenti ai ceti medi, erano pronti a fare, o almeno a tentare, un’immediata trasformazione sociale. “Quando mio fratello ed io scendemmo dalla nostra stanzetta nella strada”, mi disse una volta Elisée Réclus, “da ogni parte persone delle classi più ricche ci chiedevano: ‘Che cosa dobbiamo fare? Siamo pronti a tutto!’. Ma noi non sapevamo che cosa rispondere!”.
Mai si era visto un governo che rappresentasse tanto bene tutti i partiti progressisti quanto il Consiglio della Comune, eletto il 25 marzo 1871. Tutte le gradazioni del pensiero rivoluzionario – blanquisti, giacobini, internazionalisti – vi erano rappresentate in giusta misura. Eppure, poiché gli operai stessi non avevano idee precise in fatto di riforme sociali da comunicare ai loro rappresentanti, il governo della Comune non fece nulla in questo senso. Il fatto stesso di essere divisi dalle masse e rinchiusi nell’Hôtel de Ville li paralizzava. Perché il socialismo vincesse era necessario che le idee dell’abolizione di ogni forma di governo, della necessità di fare da sé, lasciando libertà di iniziativa ad ognuno – in una parola le teorie anarchiche – fossero state diffuse contemporaneamente all’idea della socializzazione dei prodotti e dei mezzi di produzione.
Naturalmente ci rendevamo conto che, lasciando all’individuo piena libertà di esprimere le proprie idee e di agire, ci si sarebbe trovati di fronte a certe esagerazioni stravaganti dei nostri princìpi. Io l’avevo già visto in Russia nel movimento nichilista. Ma avevamo fiducia – e l’esperienza ci ha dato ragione – nel fatto che la stessa vita sociale, sostenuta da una critica franca e aperta delle idee e delle azioni, sarebbe stato il mezzo più efficace per vagliare le opinioni e spogliarle delle inevitabili esagerazioni. In realtà seguivamo l’antica massima, che la libertà è il rimedio più saggio agli inconvenienti passeggeri della libertà stessa. C’era nella società umana un’ossatura di abitudini sociali retaggio del passato, non ancora abbastanza apprezzate; queste abitudini non ci sono imposte da nessuna coercizione esterna, al contrario esse sono superiori a qualsiasi imposizione. È questa la base di ogni progresso e finché gli uomini non degenereranno fisicamente e intellettualmente, questa ossatura di abitudini resisterà a tutti gli attacchi della critica e a tutte le occasionali ribellioni. La mia esperienza degli uomini e delle cose non ha fatto che confermare ogni giorno di più questa convinzione.
Si intuiva anche che un mutamento simile non poteva essere il risultato delle speculazioni di un uomo di genio, ma che sarebbe stato il risultato del lavoro costruttivo delle masse, proprio come le forme di procedura giudiziaria elaborate nel primo medioevo, le comunità di villaggio, le corporazioni, la città medioevale, o le basi del diritto internazionale furono elaborate dal popolo.
Molti di quelli che ci avevano preceduto avevano cercato di descrivere delle repubbliche ideali, fondate sul principio di autorità o, in qualche raro caso, sul principio della libertà. Robert Owen e Fourier avevano spiegato al mondo il loro ideale di una società libera, che si evolveva organicamente in opposizione agli ideali autoritari di una società a struttura piramidale esemplati sull’Impero romano o la Chiesa cattolica. Proudhon aveva continuato il loro lavoro e Bakunin, applicando la sua vasta e chiara visione della filosofia della storia alla critica delle nostre istituzioni, “costruiva demolendo”. Ma tutto questo non era che un lavoro di preparazione.
L’Associazione Internazionale di Lavoratori inaugurò un nuovo metodo per risolvere praticamente i problemi di sociologia appellandosi ai lavoratori stessi. Gli uomini più colti che si erano iscritti all’Associazione avevano solo il compito di informare gli operai di quanto succedeva negli altri paesi del mondo, di analizzare i risultati raggiunti e più tardi di aiutare gli operai a formulare le loro conclusioni. Non avevamo la pretesa di creare una repubblica ideale in base alle nostre teorie su quello che una società avrebbe dovuto essere, ma invitavamo gli operai a indagare le cause dei mali presenti e a considerare nelle loro discussioni e nei loro Congressi il lato pratico di un’organizzazione sociale migliore di quella nella quale viviamo. Se un problema veniva sollevato a un Congresso internazionale, veniva poi proposto come soggetto di studio a tutte le organizzazioni operaie. Durante l’anno esso veniva discusso in tutta Europa, nelle piccole riunioni delle sezioni, con piena conoscenza delle necessità particolari di ogni mestiere, di ogni località; i risultati delle sezioni venivano poi sottoposti al prossimo Congresso di ogni federazione, e infine, in forma più elaborata, al Congresso internazionale. La struttura della società a cui aspiravamo veniva così elaborata teoricamente e praticamente dal basso, e la Federazione del Giura ebbe una parte molto importante in questa elaborazione dell’ideale anarchico.
Quanto a me, trovandomi in condizioni così propizie, mi andavo persuadendo che l’anarchia è qualche cosa di più di un semplice metodo di azione, del semplice ideale di una società libera; l’anarchia fa parte di una filosofia naturale e sociale che dovrà essere sviluppata in modo completamente diverso dai sistemi metafisici e dialettici applicati finora alla sociologia. Mi persuasi che deve essere studiata con i metodi che si usano per le scienze naturali; non però, come intende Spencer, fondandosi sul terreno ingannevole delle semplici analogie, ma sulla solida base dell’induzione applicata alle istituzioni umane; e io feci del mio meglio per compiere in questo senso tutto quello che potevo.
Nell’autunno del 1877 si tennero nel Belgio due Congressi: uno dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori a Verviers, l’altro, un Congresso socialista internazionale a Gand. Quest’ultimo aveva un’importanza speciale, perché si sapeva che i socialdemocratici tedeschi avrebbero cercato di unire tutto il movimento operaio europeo in una sola organizzazione, sotto la direzione di un Comitato centrale che sarebbe stato il vecchio Consiglio generale dell’Internazionale sotto un altro nome. Era quindi necessario difendere l’autonomia delle organizzazioni operaie dei paesi latini, e facemmo ogni sforzo per essere degnamente rappresentati a questo Congresso. Io vi andai sotto il nome di Levasov, due tedeschi, il tipografo Werner e l’ingegnere Rinke fecero a piedi quasi tutta la strada da Basilea al Belgio; e a Gand, benché fossimo in tutto solo nove anarchici, riuscimmo a sconfiggere la tendenza centralizzatrice.
Ventidue anni sono passati da quel giorno; si sono tenuti molti Congressi socialisti e in ognuno di essi si è rinnovata la stessa lotta – i socialisti marxisti hanno tentato di attirare tutto il movimento operaio europeo sotto la loro bandiera e di ottenerne il controllo, gli anarchici si sono opposti e l’hanno impedito. Quanta energia sprecata, quante parole aspre, quanti sforzi vani, solo perché quelli che hanno adottato la formula: “La conquista del potere negli Stati odierni” non hanno capito che un’attività simile non può abbracciare tutto il movimento socialista! Fin dalle sue origini il socialismo si è sviluppato seguendo tre direttrici diverse, che hanno trovato la loro espressione in Saint-Simon, Fourier e Robert Owen. Dal sansimonismo è nata la socialdemocrazia, dal fourierismo è nato l’anarchismo; mentre l’owenismo si è sviluppato in Inghilterra e in America nel movimento dei sindacati di mestiere, delle cooperative e nel cosiddetto socialismo municipale, mantenendosi ostile al socialismo di Stato dei socialdemocratici ma con molti punti di contatto con l’anarchismo. Per non aver voluto riconoscere che tutti e tre conducono a una sola meta per tre diverse strade, e che anche i due ultimi portano il loro proprio prezioso contributo al progresso umano, un quarto di secolo è trascorso in vani tentativi per realizzare l’impossibile utopia di un unico movimento operaio modellato sul programma del socialismo di Stato.
Il Congresso di Gand si concluse per me in un modo inaspettato.
Tre o quattro giorni dopo la sua inaugurazione la polizia belga venne a sapere la vera identità di Levašov ed ebbe ordine di arrestarmi per aver violato il regolamento di polizia iscrivendomi all’albergo sotto falso nome. Ne fui avvisato dai miei amici belgi, i quali sostenevano che il ministero clericale allora al governo era capace di consegnarmi alla Russia e insistevano perché abbandonassi subito il Congresso.
Non mi lasciarono tornare all’albergo: Guillaume mi sbarrò la via dicendo che avrei dovuto adoperare la forza se insistevo per ritornarvi. Dovetti andarmene con alcuni compagni di Gand e appena in mezzo a loro sentii levarsi misteriosi sussurri da tutti gli angoli di una piazza semibuia per la quale erano sparsi gruppi di operai. Tutto aveva un sapore di mistero. Finalmente, dopo molto sussurrare e fischi soffocati, alcuni compagni mi accompagnarono da un operaio socialista con il quale dovevo passare la notte, e che nonostante io fossi un anarchico, mi accolse in modo commovente, con affetto fraterno. La mattina dopo ripartii per l’Inghilterra su di un piroscafo, suscitando le meraviglie dei doganieri inglesi che chiedevano di controllare il bagaglio, mentre non avevo da far vedere altro che la mia borsa.
Non mi fermai molto a Londra. Studiai gli inizi della Rivoluzione Francese nelle mirabili raccolte del British Museum, soprattutto per capire come abbiano inizio le grandi rivoluzioni; ma sentivo il bisogno di una maggiore attività e poco dopo partii per Parigi. Là il movimento operaio incominciava a ridestarsi dopo la dura repressione che era seguita alla Comune. Con l’italiano Andrea Costa e i pochi amici anarchici che avevamo fra gli operai, insieme a Jules Guesde e ai suoi compagni, che non erano allora dei rigidi socialisti di Stato, fondammo i primi gruppi socialisti.
I nostri inizi furono ridicolmente modesti. Ci riunivamo al caffè in pochi, e quando a una riunione avevamo un pubblico di cento persone eravamo felici. Nessuno allora avrebbe potuto indovinare che due anni dopo il movimento sarebbe stato in pieno rigoglio. Ma la Francia ha un modo proprio di evolversi che nessun altro paese conosce. Quando la reazione infierisce, sparisce ogni traccia di movimento e restano pochi a lottare contro la corrente. Ma misteriosamente, per una specie di infiltrazione invisibile delle idee, la reazione viene minata; una nuova corrente si manifesta e allora improvvisamente si vede come l’idea che si credeva morta vivesse, si propagasse e crescesse nascostamente; e appena diventa possibile un’agitazione aperta, migliaia di aderenti, dei quali nessuno sospettava l’esistenza, si fanno avanti. Il vecchio Blanqui era solito dire: “Ci sono a Parigi cinquantamila uomini che non vengono mai a una riunione o a una manifestazione; ma appena sentono che il popolo può scendere in piazza a manifestare le proprie opinioni, eccoli pronti a prendere d’assalto la posizione”. E fu così allora. Eravamo meno di venti a sostenere il movimento; pochi lo approvavano apertamente, infatti alla prima commemorazione della Comune, nel marzo del 1878 non eravamo che duecento. Ma due anni dopo fu votata l’amnistia per i fatti della Comune e gli operai parigini uscivano per le strade a salutare il ritorno dei comunardi; accorrevano a migliaia ad applaudirli nelle riunioni e il movimento socialista conobbe un improvviso sviluppo che trascinò anche i radicali.
Tuttavia non era ancora il momento propizio per quel risveglio e una notte dell’aprile 1878 Costa e un compagno francese furono arrestati. Il tribunale li condannò a diciotto mesi di carcere come internazionalisti. Fu solo un errore a evitarmi l’arresto. La polizia cercava Levašov e andò ad arrestare uno studente russo che aveva un nome del genere. Io vivevo sotto il mio vero nome e rimasi così a Parigi un mese ancora. Poi fui chiamato in Svizzera.
Fu durante questo periodo che a Parigi conobbi per la prima volta Turgenev. Aveva espresso al nostro comune amico Lavrov il desiderio di vedermi e di festeggiare la mia fuga, da vero russo, con un pranzetto fra amici. Fu con un senso quasi di venerazione che varcai la soglia di casa sua. Se con le sue Memorie di un cacciatore aveva reso alla Russia l’immenso servigio di rendere odiosa la servitù (non sapevo allora che avesse avuto una parte così importante nel “Kolokol” di Herzen), egli ha compiuto opera non meno utile con i romanzi successivi. Ha mostrato quanto valga la donna russa, quali doti di intelligenza e di cuore possieda, quanto possa fare come ispiratrice dell’uomo; e ci ha insegnato in quale modo gli uomini veramente superiori considerino la donna e come sappiano amare. Questa parte del suo insegnamento ha prodotto su di me e su migliaia di miei contemporanei un’impressione incancellabile, più profonda di quella dei migliori scritti sui diritti della donna.
Il suo aspetto è ben noto. Alto, robusto, una folta capigliatura grigia e morbida, era decisamente bello; aveva uno sguardo intelligente, con una sfumatura di ironia, e da tutto il suo contegno spirava quella semplicità e quell’assenza di affettazione caratteristica dei migliori scrittori russi. La sua bella testa dimostrava uno straordinario sviluppo cerebrale, e quando morì, Paul Bert e Paul Réclus, il chirurgo, pesarono il suo cervello e trovarono che superava quello di Cuvier, fino allora il più pesante! Non fidandosi della loro bilancia ne presero un’altra ma risultò che il peso superiore ai due chilogrammi era esatto.
La sua conversazione era particolarmente interessante. Usava un linguaggio ricco di immagini, come quando scriveva. Per sviluppare un’idea, non ricorreva ad argomentazioni, benché fosse maestro nelle discussioni filosofiche; egli illustrava la sua idea con una scena, bella come se l’avesse attinta da uno dei suoi romanzi.
“Voi”, mi disse una volta, “avete certo conosciuto da vicino i Francesi, i Tedeschi e gli altri popoli. Non avete osservato che esiste un profondo, incredibile abisso fra molte delle loro opinioni e le idee che abbiamo noi Russi su certi argomenti – che vi sono certi punti sui quali non potremo mai capirci?”.
Risposi che non lo avevo mai osservato.
“Ma sì che ve ne sono! Eccone uno. Una sera eravamo alla prima rappresentazione di una commedia nuova. Io ero in un palco insieme a Flaubert, Daudet, Zola... (non son sicuro se abbia detto Daudet o Zola, ma si trattava di uno dei due). Erano tutti uomini di idee avanzate. Ecco il soggetto della commedia: una donna si è divisa dal marito, ha avuto un nuovo amore e vive con un altro uomo. Quest’ultimo era dipinto come una persona eccellente. Vivevano felici da anni; i due figli della donna – un figlio e una figlia – erano bambini quando la separazione era avvenuta; ora erano cresciuti e durante tutti questi anni avevano creduto che l’uomo fosse il loro vero padre. La ragazza aveva circa diciotto anni e il ragazzo diciassette. L’uomo li trattava da padre, essi lo amavano ed egli li amava. La scena presentava la famiglia all’ora di colazione. La ragazza entra, si avvicina al suo supposto padre ed egli sta per baciarla, quando il ragazzo, che è venuto a sapere che essi non sono veramente i suoi figli, si precipita verso di loro gridando: ‘Non osate!’ N’osez pas!
“Il pubblico applaudiva fragorosamente a questo punto. Ci fu un momento di entusiasmo delirante. Flaubert e gli altri applaudivano.
“Io ne fui disgustato. ‘Questa famiglia era felice,’ mi dicevo, ‘l’uomo era per questi ragazzi un padre, migliore del loro vero padre... la loro madre lo amava ed era felice con lui... Questo ragazzo maligno e cattivo merita solo di essere bastonato per quello che ha detto...’. Ma era inutile: discussi la questione con loro per delle ore; nessuno riusciva a capire come io vedessi le cose”.
Naturalmente io simpatizzavo completamente con il modo di vedere di Turgenev. Gli feci però osservare che quasi tutti i suoi amici appartenevano alla borghesia. In essa la differenza da paese a paese è grandissima. Ma le mie conoscenze erano tutte fra gli operai e vi è una grandissima affinità fra gli operai, soprattutto fra i contadini, di ogni nazionalità.
Qui però mi sbagliavo di molto. Quando conobbi più a fondo gli operai francesi, pensai spesso a quanto fosse giusta l’osservazione di Turgenev. Vi è un vero abisso fra i concetti che prevalgono in Russia sui rapporti coniugali e quelli che prevalgono in Francia, tanto fra gli operai che in mezzo alla borghesia; e per molte altre questioni esiste un abisso quasi altrettanto profondo fra le concezioni dei Russi e quelle degli altri popoli.
Si disse, dopo la morte di Turgenev, che egli si proponeva di scrivere un romanzo su questo argomento. Se è stato incominciato, la scena a cui accennavo deve trovarsi nel manoscritto. Che peccato che non abbia scritto quel romanzo! Egli, così “occidentale” nel suo modo di pensare, avrebbe potuto dire delle cose molto profonde su un fenomeno che lo deve aver toccato da vicino durante tutta la vita.
Di tutti i romanzieri del nostro secolo Turgenev era certamente l’artista perfetto, e la sua prosa è una musica per l’orecchio russo, musica profonda quanto quella di Beethoven. I suoi principali romanzi – Rudin, Un nido di nobili, Alla vigilia, Padri e figli, Fumo, Terre vergini – dipingono i tipi preminenti, “storici”, delle classi colte in Russia, che evolvettero rapidamente dopo il 1848, tutti delineati con una profondità di pensiero, una comprensione umana e una bellezza artistica, che non hanno l’eguale nelle altre letterature. Eppure Padri e figli – un romanzo che giustamente egli considerava il suo lavoro più serio – fu accolto dalla gioventù russa con molte critiche. La nostra gioventù dichiarò che Bazarov non rispecchiava fedelmente il tipo del nichilista; molti lo dissero addirittura una caricatura del nichilismo. Questa divergenza afflisse profondamente Turgenev, e benché più tardi a Pietroburgo avvenisse una riconciliazione fra lui e la nuova generazione, dopo la pubblicazione di Terre vergini, la ferita infertagli da quegli attacchi non si rimarginò.
Sapeva da Lavrov che io ero un ammiratore entusiasta delle sue opere; e un giorno, mentre ritornavamo in carrozza da una visita allo studio di [Mark] Antokol’skij, mi chiese cosa pensassi di Bazarov. Io gli risposi con franchezza: “Bazarov è un potente ritratto di nichilista, ma si sente che non lo amavate come gli altri vostri eroi”.
“Al contrario, lo amavo, lo amavo appassionatamente”, mi rispose Turgenev con inaspettata energia. “Quando saremo a casa vi farò vedere il mio diario, dove ho scritto come piansi quando terminai il mio romanzo con la morte di Bazarov”.
Turgenev amava certo il lato intellettuale di Bazarov. Si appassionò tanto alla filosofìa nichilista del suo eroe, che tenne persino un diario con il suo nome, nel quale criticava gli avvenimenti quotidiani dal punto di vista di Bazarov. Credo però che lo ammirasse più di quanto non lo amasse. In una conferenza brillante che tenne su Amleto e Don Chisciotte, divise i fattori della storia umana in due categorie, rappresentate dall’uno o dall’altro di questi tipi. “Prima di tutto l’analisi, poi l’egoismo, di conseguenza nessuna fede, un egoista non può credere neppure in se stesso”. Così definiva Amleto. “Egli è quindi uno scettico e non farà mai niente; mentre Don Chisciotte, che si batte contro i mulini a vento e prende la bacinella di un barbiere per l’elmo magico di Mambrino (chi di noi non ha commesso lo stesso errore?) è un condottiero di masse, perché le masse seguono sempre quelli che, incuranti dei sarcasmi dei più e persino delle persecuzioni, vanno dritto davanti a sé, gli occhi fissi a una meta che sono forse i soli a vedere. Essi cercano, cadono, ma si rialzano e arrivano, ed è giusto che sia così! Eppure, benché Amleto sia uno scettico e non creda al bene, crede al male. Lo odia; il male, il tradimento sono i suoi nemici; ma il suo scetticismo non è indifferenza, solo negazione e dubbio, che finiscono col minare la sua volontà”.
Credo che queste considerazioni di Turgenev ci diano la chiave per comprendere i rapporti che correvano fra lui e i suoi protagonisti. Egli stesso e diversi dei suoi amici più cari appartenevano più o meno alla famiglia degli Amleti. Amava Amleto e ammirava Don Chisciotte: così ammirava Bazarov. Seppe ritrarre magistralmente la sua superiorità, capiva la tragicità del suo isolamento, ma non poteva circondarlo di quell’affetto tenero e poetico che prodigava, come a un amico infermo, a quelli dei suoi eroi che assomigliavano al tipo di Amleto. Sarebbe stato fuori luogo.
“Avete conosciuto Myškin?”, mi domandò una volta nel 1878. Durante il processo ai compagni del nostro Circolo, Myškin si era rivelato la personalità più notevole. “Vorrei sapere tutto di lui”, soggiunse, “quello è un uomo davvero, senza la minima traccia di amletismo”. E queste parole riflettevano evidentemente i suoi pensieri su questo nuovo tipo che non esisteva nel movimento russo durante il periodo descritto da Turgenev in Terre vergini, ma che doveva affacciarsi due anni più tardi.
Lo vidi l’ultima volta nell’autunno del 1881. Era molto ammalato e lo turbava il pensiero che sarebbe stato suo dovere scrivere ad Aleksandr III, salito allora al trono e ancora incerto sulla politica da seguire, per pregarlo di dare alla Russia una Costituzione, dimostrandogli con argomenti seri la necessità di un simile passo. Era evidente il suo dolore quando mi disse: “So che dovrei farlo, ma sento che non lo posso fare”. In verità soffriva dolori atroci per un cancro alla spina dorsale e gli riusciva difficilissimo anche solo sedere pochi minuti per discorrere. Non scrisse allora, e poche settimane dopo sarebbe stato inutile. Aleksandr III aveva dichiarato in un manifesto la sua intenzione di continuare ad essere l’autocrate della Russia.
In Russia frattanto (1878) gli avvenimenti incalzavano. La guerra contro la Turchia, iniziata nel 1877, era terminata in modo da scontentare tutti. Prima della guerra c’era molto entusiasmo per le popolazioni slave. Molti inoltre credevano che la guerra di liberazione dei Balcani avrebbe provocato un movimento progressista in Russia. Ma i popoli slavi non furono liberati che a metà. Gli enormi sacrifici fatti dai Russi furono resi vani dagli errori delle alte autorità militari. Furono sacrificate centinaia di migliaia di uomini in battaglie che furono solo mezze vittorie, e le concessioni strappate alla Turchia furono annullate dal Congresso di Berlino. Tutti sapevano poi che le ruberie del denaro pubblico durante questa guerra avevano quasi eguagliato quelle della guerra di Crimea.
In quest’atmosfera di generale scontento che prevaleva in Russia alla fine del 1877, centonovantatre persone, arrestate fra il 1873 e il 1875 per fatti relativi alla nostra agitazione, furono portate davanti al tribunale. Gli accusati, difesi da molti avvocati di valore, si acquistarono subito le simpatie del pubblico. Fra la società di Pietroburgo produssero un’impressione molto favorevole, e quando si seppe che molti avevano già passato tre o quattro anni in carcere in attesa del processo, e che non meno di ventuno di loro o si erano suicidati o erano impazziti, la corrente favorevole agli imputati si fece più forte anche fra gli stessi giudici. La Corte pronunciò condanne molto severe contro alcuni di loro e relativamente miti contro gli altri, asserendo che il carcere preventivo aveva avuto tale durata ed era già una punizione tanto severa, che era impossibile aumentarla con giustizia. Si era convinti che l’imperatore avrebbe diminuito ancora le condanne; ma con sorpresa generale egli rivide le condanne solo per aggravarle. Quelli che erano stati assolti dalla Corte furono esiliati in lontane province della Russia e della Siberia, e furono pronunciate condanne varianti dai cinque ai dodici anni ai lavori forzati contro quelli che la Corte aveva condannato a una breve prigionia. Tutto ciò era opera del capo della Terza Sezione, generale Mesentzov.
In questo stesso periodo il capo della polizia di Pietroburgo, Trepov, avendo osservato durante una visita alla prigione che uno dei condannati politici, Bogolubov, non si era tolto il cappello per salutare il satrapo onnipotente, gli si era scagliato contro e gli aveva dato uno schiaffo; e quando il prigioniero gli aveva opposto resistenza, aveva ordinato di fustigarlo. Gli altri prigionieri, saputolo, protestarono vivacemente il loro sdegno e di conseguenza furono terribilmente bastonati dagli aguzzini e dalla polizia. I prigionieri politici russi sopportavano senza lamentarsi le sofferenze inflitte con la condanna in Siberia e ai lavori forzati, ma erano fermamente decisi a non tollerare punizioni corporali. Una giovinetta, Vera Zasulič, che non conosceva neppure Bogolubov, si armò di una rivoltella, andò dal capo della polizia e gli sparò contro. Trepov fu solo ferito. Aleksandr II andò a vedere l’eroica fanciulla che lo deve avere impressionato con il suo viso di una grande dolcezza e con la sua semplicità. Trepov aveva molti nemici a Pietroburgo, e questi riuscirono a portare il processo davanti a una giuria ordinaria; Vera Zasulič dichiarò alla Corte che era ricorsa alle armi solo dopo aver esaurito ogni altro mezzo di far conoscere il fatto al pubblico e ottenerne riparazione. Persino il corrispondente da Pietroburgo del “Times” di Londra, pregato di parlare del fatto sul suo giornale, non ne aveva scritto nulla, pensando che la cosa non era credibile. Allora, senza dir niente a nessuno, aveva deciso di punire Trepov. Ora che il fatto era stato reso pubblico, era ben contenta di sapere che era ferito solo leggermente. La giuria l’assolse all’unanimità; e quando la polizia cercò di arrestarla di nuovo mentre si allontanava dal tribunale, i giovani di Pietroburgo, affollati davanti alla porta, la salvarono. Riparò all’estero e ben presto ci raggiunse in Svizzera.
Questo avvenimento produsse una vera sensazione in tutta Europa. Ero a Parigi quando giunse la notizia dell’assoluzione e quel giorno dovetti per affari visitare la redazione di diversi giornali. Trovai i redattori tutti pieni di entusiasmo, che scrivevano articoli infiammati in onore della giovane russa. Persino la “Revue des Deux Mondes” in un fascicolo dedicato al 1878 dichiarò che le due persone che avevano maggiormente commosso l’opinione pubblica europea in quell’anno erano state il principe Gorcakov al Congresso di Berlino e Vera Zasulič. II loro ritratto fu riprodotto su numerosi almanacchi di quel periodo. L’abnegazione di Vera Zasulič impressionò profondamente gli operai dell’Europa occidentale.
Durante lo stesso anno 1878, senza che vi fosse stato alcun complotto, furono compiuti quattro attentati contro regnanti. L’operaio [Max] Hödel e poi il dottor [Karl] Nobiling attentarono alla vita dell’imperatore di Germania, e poche settimane dopo un operaio spagnolo, [Juan] Oliva Moncasi, tirò contro il re di Spagna e il cuoco [Giovanni] Passannante cercò di colpire con un pugnale il re d’Italia.
I governanti europei giudicarono incredibile che questi attentati alla vita di tre sovrani fossero avvenuti senza l’esistenza di un complotto internazionale e immaginarono che la Federazione anarchica del Giura fosse il centro della cospirazione.
Sono ormai passati più di vent’anni da questi avvenimenti e posso affermare che non vi era assolutamente nessuna base per queste supposizioni. Ma allora tutti i governi d’Europa si scagliarono contro la Svizzera, rimproverandola di dare asilo a dei rivoluzionari che ordivano complotti simili. Paul Brousse, il direttore del nostro giornale del Giura “Avant Garde”, fu arrestato e processato. I giudici svizzeri, convinti che non vi era ragione di implicare Brousse o la Federazione del Giura negli ultimi attentati, si accontentarono di condannare Brousse a due mesi di carcere per i suoi articoli; ma il giornale fu soppresso e tutte le tipografie della Svizzera esortate dal governo federale a non stampare né quel giornale né altri del genere. Così la Federazione del Giura fu ridotta al silenzio.
Oltre a tutto questo gli esponenti politici svizzeri, che vedevano di malocchio l’agitazione anarchica nel loro paese, lavorarono dal canto loro per ottenere che i principali affiliati alla Federazione del Giura di nazionalità svizzera dovessero o ritirarsi dalla vita pubblica o morir di fame. Brousse fu espulso dalla Svizzera. James Guillaume, che da otto anni teneva in vita, nonostante mille difficoltà, il “Bollettino della Federazione”, e che si guadagnava da vivere soprattutto con l’insegnamento, non poté più trovare lavoro e dovette abbandonare la Svizzera per la Francia. Adhemar Schwitzguebel, boicottato dagli orologiai suoi padroni e carico di figli, dovette alla fine ritirarsi dal movimento. Accadde così che io, uno straniero, dovetti redigere il giornale della Federazione. Esitai, naturalmente, ma non vi era altro da fare e con due amici, [François] Dumartheray e [George] Herzig, fondai a Ginevra una nuova rivista quindicinale, “Le Révolté”. Dovevo scriverne gran parte io stesso. Avevamo solo ventitré franchi quando fondammo il giornale, ma ci mettemmo tutti all’opera per trovare abbonamenti e riuscimmo a pubblicare il primo numero. La forma era moderata, ma la sostanza rivoluzionaria; feci poi del mio meglio perché i problemi più complessi di storia e di economia fossero del tutto chiari e comprensibili per ogni operaio intelligente. Nessuna edizione degli altri nostri giornali aveva mai superato le seicento copie: stampammo duemila copie di “Le Révolté” e in pochi giorni le esaurimmo. Ebbe successo, e vive ancora a Parigi sotto il titolo di “Temps Nouveaux”.
I giornali socialisti hanno spesso la tendenza a diventare niente altro che una raccolta di lamentele sulle condizioni attuali. Si parla dell’oppressione dei lavoratori nelle miniere, nelle fabbriche, nei campi; si dipingono al vivo le miserie e le sofferenze degli operai durante gli scioperi; si insiste nel dire come non abbiano armi con cui lottare di fronte ai loro padroni; e questo seguirsi di disperate lotte di settimana in settimana, ha sul lettore un effetto molto deprimente. Come rimedio, chi scrive confida soprattutto nelle parole ardenti con le quali cerca di infondere nei suoi lettori slancio e speranza. Io pensavo invece che un giornale rivoluzionario deve dare il resoconto di tutti i segni che, dovunque, preannuncino l’avvento di un’era nuova, il nascere di nuove forme di vita sociale, la rivolta crescente contro le istituzioni antiquate. Questi sintomi devono essere analizzati, confrontati, studiandone i rapporti più profondi e raggruppati in modo da dimostrare all’animo dubbioso dei più come le idee più avanzate incontrino dovunque un favore invisibile e spesso inconscio, quando nella società si verifica un risveglio del pensiero. Fare in modo che si senta di partecipare al palpito del cuore umano in tutto il mondo, alla sua ribellione contro le ingiustizie secolari, ai suoi sforzi per elaborare nuove forme di vita, questo dovrebbe essere il compito essenziale di un giornale rivoluzionario. È la speranza, e non lo sconforto, che porta alla vittoria una rivoluzione.
Gli storici ci dicono spesso che questo o quel sistema filosofico ha prodotto un certo cambiamento nel pensiero umano, e in seguito nelle istituzioni. Ma questa non è la storia. I maggiori filosofi studiando la loro società non hanno fatto che afferrare gli indizi dei futuri mutamenti, ne hanno capito i rapporti intimi e, aiutati dall’induzione e dall’intuizione, hanno predetto quello che sarebbe avvenuto. Anche i sociologi hanno tracciato degli schemi di organizzazione sociale partendo da alcuni princìpi e sviluppandoli nelle loro conseguenze logiche, così come da pochi assiomi in geometria si arriva a una conclusione; ma questo non è sociologia. Non si può fare una giusta previsione sullo sviluppo di una società se non si tengono d’occhio i più tenui indizi di una vita nuova, separando i fatti fortuiti da quelli organicamente essenziali e costruendo la generalizzazione su queste fondamenta.
Era questo il sistema di pensiero al quale cercavo di abituare i nostri lettori – servendomi di parole chiare e comprensibili, in modo da abituare i più umili a giudicare da sé la direzione in cui cammina la società, e a correggere da sé il pensatore se questi arriva a conclusioni false. Quanto alla critica delle condizioni presenti, ne feci solo quanto era necessario per mettere a nudo le radici dei mali e per mostrare che le ragioni prime di tutti i mali sociali sono un feticismo vivo e profondo per le sopravvivenze antiquate di fasi già superate dell’evoluzione sociale e una grande inerzia del pensiero e della volontà.
In questo lavoro ebbi tutto l’aiuto di Dumartheray e di Herzig. Dumartheray era nato in una delle più povere famiglie dei contadini della Savoia. Non aveva frequentato che le classi prime elementari; eppure era uno degli uomini più intelligenti che io abbia conosciuto. I suoi giudizi sugli uomini e gli avvenimenti del suo tempo erano così notevoli per il loro buon senso, che spesso assumevano il valore di profezie. Era anche uno dei critici più sottili della letteratura socialista contemporanea e non si lasciava mai abbagliare da sfoggi di retorica e da una falsa scienza. Herzig era un giovane impiegato, nato a Ginevra; era chiuso, timido, arrossiva come una fanciulla quando esprimeva un’opinione personale; dopo il mio arresto, quando si trovò nella necessità di far vivere il giornale, grazie alla sua forza di volontà imparò a scrivere molto bene. Boicottato da tutti i datori di lavoro di Ginevra e caduto con la famiglia in una profonda miseria, riuscì nonostante questo a tenere in vita il giornale fin che fu possibile trasferirlo a Parigi.
Del giudizio di questi due compagni potevo fidarmi nel modo più assoluto. Se Herzig aggrottava le sopracciglia e borbottava: “Sì, bene, può andare”, sapevo che non andava bene. E quando Dumartheray, che si lamentava sempre del cattivo stato dei suoi occhiali quando doveva leggere un manoscritto non troppo chiaro, e che di conseguenza non leggeva di solito altro che le bozze, interrompeva la lettura dicendo, “Non, ça ne va pas”, sentivo immediatamente che l’articolo non era ben fatto e cercavo di indovinare quale pensiero o espressione avesse provocato la sua disapprovazione. Sapevo che non serviva a nulla chiedergli: “Perché non va?”. Avrebbe risposto: “Oh, quello è affar vostro, non mi riguarda. Non va, non so dire perché”. Ma sentivo che aveva ragione e mi risiedevo per scrivere di nuovo l’articolo o prendevo il compositore e tornavo a comporre una frase.
Devo confessare che passammo anche dei brutti momenti con il nostro giornale. Ne erano usciti solo cinque numeri quando lo stampatore ci chiese di trovarci un’altra tipografia. La libertà di stampa garantita dalle costituzioni cantonali, quando si tratta di operai e delle loro pubblicazioni è soggetta a ben altre limitazioni che quelle previste dalla legge. Lo stampatore non aveva nulla da obiettare al nostro giornale, anzi gli piaceva, ma in Svizzera tutte le tipografie dipendono più o meno dal governo, che dà loro da stampare i resoconti statistici e altri lavori del genere; e al nostro tipografo fu detto chiaro e tondo che se avesse insistito ad ospitare il nostro giornale avrebbe dovuto rinunciare alla speranza di ricevere altro lavoro dal governo di Ginevra. Mi misi a percorrere tutta la Svizzera francese e parlai con i proprietari di tutte le stamperie, ma ebbi dappertutto la stessa risposta, anche da coloro ai quali non spiaceva il carattere del giornale. “Non potremmo vivere senza il lavoro del governo, e non potremmo più ottenerlo se pubblicassimo ‘Le Révolté’”.
Tornai a Ginevra molto scoraggiato; ma Dumartheray era più che mai entusiasta e fiducioso. “È semplicissimo”, diceva. “Impiantiamo una stamperia acquistando il materiale su cambiali a tre mesi di scadenza, e in tre mesi avremo pagato tutto”. “Ma non abbiamo che qualche centinaio di lire”, io replicavo. “Il denaro! Sciocchezze! Lo troveremo! Comperiamo subito i caratteri, pubblichiamo subito il prossimo numero e il denaro verrà!”. Anche questa volta aveva ragione. Quando il numero uscì dalla nostra Imprimerie Jurassienne, facemmo la storia delle nostre difficoltà, pubblicammo due opuscoletti – aiutando tutti a stamparli – e il denaro venne, per lo più in soldi e lire, ma venne. Ho sempre sentito i partiti d’avanguardia lamentarsi della scarsità dei mezzi finanziari, ma più vado avanti e più mi convinco che per noi la maggiore difficoltà non è tanto la questione del denaro quanto quella di trovare uomini capaci di avanzare risolutamente e ostinatamente verso la meta prefissa, in linea retta, infondendo coraggio anche negli altri. Da venti anni ormai il nostro giornale continua a vivere una vita stentata, quasi ogni numero porta in prima pagina una domanda di aiuto; ma finché ci sarà un uomo che gli rimarrà fedele, dedicandogli tutte le sue forze, come fecero Herzig e Dumartheray a Ginevra e come fa Grave ora a Parigi da sedici anni, il denaro arriverà e le spese di stampa più o meno saranno coperte, in gran parte con le piccole offerte degli operai. Nel caso di un giornale, come in qualsiasi altro campo, gli uomini sono ben più importanti del denaro.
La nostra tipografia fu inaugurata in una stanza piccolissima e il nostro tipografo era un piccolo russo, che si offerse di comporre il giornale per la modesta somma di sessanta lire al mese. Gli bastava di assicurarsi il suo modesto pranzo giornaliero e la possibilità di andare qualche volta all’Opera. “Andate a fare il bagno turco, Giovanni?”, gli domandai una volta che lo incontrai per strada, a Ginevra, con un fagottino sotto il braccio. “No, cambio casa”, mi rispose con la sua voce dolce e il solito sorriso.
Disgraziatamente ignorava il francese. Io stendevo i miei articoli scrivendo con la massima cura, rimpiangendo il tempo perduto alla lezione di calligrafia del nostro buon Ebert, ma Giovanni leggeva un manoscritto francese nel modo più fantastico e componeva le più strane parole di sua invenzione; siccome però le parole erano composte con il numero di lettere voluto, e non era necessario cambiare la lunghezza delle righe per fare le correzioni, tutto si riduceva a cambiare una dozzina di lettere per ogni riga! Eravamo nei migliori rapporti, e ben presto sotto la sua direzione incominciai a impratichirmi del mestiere del tipografo. Il giornale era sempre pronto a tempo per portare le bozze a un compagno svizzero che ne era il direttore responsabile, e al quale lo facevamo sempre esaminare prima di stamparlo, poi uno di noi portava le pagine composte in piombo a una stamperia. La nostra Imprimerie Jurassienne non tardò a farsi conoscere per le sue pubblicazioni, soprattutto per gli opuscoli che Dumartheray insisteva a vendere per non più di due soldi. Era necessario elaborare uno stile tutto particolare per questi opuscoli. Confesso che spesso invidiavo gli scrittori che possono disporre del numero di pagine che vogliono per sviluppare i loro concetti, e ai quali è permessa la scusa di Talleyrand: “Non ho avuto il tempo di essere breve”. Quando ero costretto a condensare il lavoro di vari mesi – per esempio sulle origini della legge – in un opuscolo da due soldi, mi ci voleva molto tempo in più per riuscire a scrivere conciso. Ma scrivevamo per i lavoratori e spesso per loro un opuscolo da quattro soldi è troppo caro. Il risultato fu che i nostri opuscoli da un soldo o due furono venduti a decine di migliaia e tradotti in tutte le lingue. Più tardi, mentre ero in prigione, i miei articoli di fondo furono pubblicati da Elisée Réclus, con il titolo: Parole di un ribelle.
Noi miravamo soprattutto alla Francia, ma “Le Révolté” vi era severamente proibito e i contrabbandieri hanno tante buone cose da introdurre in quel paese dalla Svizzera, che non volevano compromettere il loro commercio incaricandosi di giornali. Li accompagnai una volta attraversando con loro la frontiera francese e li trovai coraggiosi e fidati, ma non riuscii a convincerli a portare il nostro giornale. Tutto quello che potemmo fare fu di spedirlo in busta sigillata a un centinaio di persone in Francia. Non facevamo spendere nulla per la spedizione, confidando nelle sottoscrizioni volontarie per rifarci delle spese in più – e questo si verificava sempre; ma abbiamo spesso pensato che la polizia francese perdeva una splendida occasione di rovinare “Le Révolté” – sarebbe bastato abbonarsi a duecento copie e non mandare nessuna sottoscrizione!
Il primo anno dovemmo fare il giornale da soli, ma a poco a poco Elisée Réclus si interessò di più al nostro lavoro e finalmente venne con noi, e dopo il mio arresto diede anche maggior vivacità al giornale. Réclus mi aveva pregato di aiutarlo nella preparazione di quel volume della sua monumentale Geografia che tratta dei possedimenti russi in Asia. Conosceva il russo, ma pensava che, conoscendo io bene la Siberia, avrei potuto essergli particolarmente utile; e poiché la salute di mia moglie non era molto buona e il medico le aveva consigliato di partire subito da Ginevra per timore dei suoi venti freddi, nella primavera del 1880 ci trasferimmo a Clarens, dove Réclus allora risiedeva. Andammo ad abitare sopra Clarens, in una casetta dalla quale si godeva lo spettacolo delle acque azzurre del lago e della neve immacolata del Dent du Midi sullo sfondo. Un ruscelletto che dopo le piogge ruggiva come un torrente rabbioso scorreva sotto le nostre finestre, e sui fianchi della collina in faccia a noi si alzava il Castello di Châtelard, i cui proprietari, prima della rivoluzione del burla papei (i bruciatori di documenti) nel 1799, si facevano pagare tributi feudali in occasione di nascite, matrimoni e morti. Là, aiutato da mia moglie, con la quale discutevo ogni avvenimento e tutti gli articoli che mi preparavo a scrivere, e che era un severo critico letterario dei miei scritti, composi le mie cose migliori per “Le Révolté”, compreso l’opuscolo Ai giovani, che fu diffuso in ogni lingua, in centinaia di migliaia di esemplari. Posso dire di aver posto in quel tranquillo rifugio le basi per tutti i miei scritti posteriori. Quello che manca a noi scrittori anarchici, sparsi in tutto il mondo dalle persecuzioni, è il contatto con uomini colti, che condividano le nostre idee. A Clarens avevo quel contatto con Elisée Réclus e Lefrançais, oltre ai rapporti mai interrotti con gli operai; e benché lavorassi molto per la geografia, potei scrivere anche più del solito per la propaganda anarchica.
In Russia la lotta per la libertà assumeva forme sempre più aspre. Diversi processi politici erano stati portati davanti ai tribunali supremi, il processo dei centonovantatre, dei cinquanta, del circolo Dolgusin, ecc., e da tutti risultava lo stesso fatto. I giovani erano andati in mezzo ai contadini e agli operai delle fabbriche, predicando loro il socialismo; erano stati distribuiti opuscoli socialisti, stampati all’estero; vi erano stati eccitamenti alla rivolta contro le opprimenti condizioni economiche in una forma vaga e imprecisa, niente di più, in breve, di quanto si faceva in ogni altro paese del mondo. Non si era scoperta nessuna traccia di complotto contro lo zar né preparativi per un’azione rivoluzionaria; in realtà non esistevano. La nostra gioventù era in maggioranza ostile a un’azione del genere, in quegli anni. Se guardo indietro, al movimento degli anni fra il 1870 e il 1878, posso affermare che la maggior parte dei giovani si sarebbe dichiarata soddisfatta di poter vivere semplicemente vicino ai contadini e agli operai delle fabbriche, di istruirli, di collaborare con loro sia individualmente che come membri del governo locale, in uno dei mille modi in cui un uomo o una donna seria e colta può rendersi utile alle masse. Conoscevo quegli uomini e parlo con piena conoscenza di causa.
Ma ciò nonostante le condanne erano state feroci, stupidamente feroci, perché il movimento, che nasceva dalle precarie condizioni della Russia, aveva radici troppo profonde per poter essere semplicemente soffocato con la brutalità.
Le condanne più comuni erano di sei, dieci o dodici anni ai lavori forzati nelle miniere, seguiti dall’esilio perpetuo in Siberia. Ci furono casi come quello di una ragazza, condannata a nove anni di lavori forzati e all’esilio perpetuo in Siberia per aver dato un solo opuscolo socialista a un operaio! Un’altra ragazza di quattordici anni, la signorina Gukovskaja, fu condannata alla deportazione a vita in un lontano villaggio della Siberia per aver tentato, come la Klärchen di Goethe, di incitare una folla di indifferenti a liberare [Ivan] Koval’skij e i suoi amici mentre si avviavano al supplizio, un atto tanto più scusabile in Russia, anche dal punto di vista delle autorità, in quanto la pena di morte non esiste per i reati comuni e la sua applicazione ai politici era allora una novità, un ritorno a un passato quasi dimenticato. Cacciata nella solitudine, questa fanciulla non tardò a gettarsi nelle acque dello Enisej. Persino quelli che venivano assolti dai tribunali erano esiliati dalla polizia nei villaggi della Siberia o del Nord-est della Russia, dove erano costretti a soffrire la fame con le sette lire al mese che passava loro il governo. In questi paesetti non vi era alcuna industria, e ai confinati era severamente proibito l’insegnamento.
Per esasperare ancor più i giovani, i loro amici condannati non venivano subito mandati in Siberia. Prima venivano rinchiusi per diversi anni in carceri che facevano loro rimpiangere la vita del forzato nelle miniere della Siberia. Erano carceri veramente spaventose. In una di esse, “un focolaio di tifo”, come disse in una predica il prete di quella prigione, la mortalità raggiunse il 20% in dodici mesi. Nelle carceri centrali, nelle case di pena della Siberia, nelle fortezze, i carcerati dovevano ricorrere allo sciopero della morte, allo sciopero della fame, per proteggersi dalla brutalità dei carcerieri o per ottenere condizioni meno cattive, il permesso di qualche lavoro o della lettura nelle loro celle, che li salvasse dall’impazzire nel giro di pochi mesi. L’orrore di simili scioperi, durante i quali uomini e donne rifiutavano il cibo per sette o otto giorni di seguito, giacendo immobili e deliranti, sembrava non impressionare i loro carcerieri. A Char’kov i prigionieri, sfiniti, furono legati e nutriti artificialmente con la forza.
Le notizie di questo obbrobrio trapelavano dalle prigioni, attraversavano le sconfinate distanze della Siberia e si diffondevano fra la gioventù. Vi fu un momento in cui non passava settimana senza che si sapesse di qualche nuova infamia di questo genere, o peggio ancora.
L’esasperazione della nostra gioventù aveva raggiunto il massimo. “Negli altri paesi”, incominciavano a dire, “si ha il coraggio di resistere. Un inglese, un francese, non tollererebbero oltraggi simili. Perché dunque li tolleriamo noi? Ribelliamoci con le armi alla mano alle perquisizioni notturne della polizia; se l’arresto implica una morte lenta e ingloriosa nelle loro mani, sappiamo almeno che potranno prenderci solo dopo una lotta a morte”. A Odessa Koval’skij e i suoi compagni accolsero a revolverate i poliziotti che andarono una notte ad arrestarli.
Alessandro II rispose a questo nuovo atteggiamento proclamando lo stato d’assedio. La Russia fu divisa in tanti distretti, ognuno con un governatore generale, che aveva ordine di impiccare spietatamente i colpevoli. Koval’skij e i suoi amici – che tra parentesi non avevano ucciso nessuno – furono giustiziati. Le impiccagioni erano frequentatissime. In due anni furono giustiziate ventitre persone, compreso un ragazzo di diciannove anni, sorpreso ad attaccare un manifesto rivoluzionario in una stazione ferroviaria; questa era l’unica sua colpa, era un ragazzo, ma morì da uomo.
La difesa diventò allora la parola d’ordine dei rivoluzionari; difesa contro le spie che si introducevano nei circoli sotto la maschera dell’amicizia, per poi denunciare gli iscritti a torto e a ragione, semplicemente perché non erano pagati se non denunciavano molte persone; difesa contro quelli che maltrattavano i prigionieri, difesa contro i capi onnipotenti della polizia di Stato.
Tre funzionari importanti e tre piccole spie caddero in questa nuova fase della lotta. Il generale Mesentzov, che aveva persuaso lo zar a raddoppiare le condanne dopo il processo dei centonovantatre, fu ucciso in pieno giorno a Pietroburgo; un colonnello della polizia, colpevole di un fatto anche peggiore finì allo stesso modo a Kiev; e si sparò contro il governatore generale di Char’kov, mio cugino Dmitrij Kropotkin, mentre ritornava dal teatro. La prigione centrale dove si era verificato il primo sciopero della fame e dove i prigionieri erano stati nutriti con la forza, dipendeva da lui. In realtà non era cattivo, so che i suoi sentimenti personali erano piuttosto favorevoli ai condannati politici; ma era debole e cortigiano ed esitò a intervenire. Una sua parola avrebbe messo fine ai maltrattamenti. Aleksandr II gli voleva molto bene e la sua posizione a Corte era tale che il suo intervento sarebbe stato approvato con ogni probabilità. “Grazie, avete agito come desideravo”, gli aveva detto lo zar due anni prima, quando era venuto a Pietroburgo per fare il suo rapporto sulla politica pacificatrice che aveva seguito in occasione di una rivolta della popolazione più povera di Char’kov, comportandosi verso gli insorti con molta clemenza. Ma questa volta si era messo dalla parte dei carcerieri e i giovani di Char’kov furono tanto esasperati dalla sua condotta che uno di loro gli tirò una revolverata.
La persona dell’imperatore però non era mai stata presa di mira in questa lotta e fino al 1879 non si ebbe contro di lui nessun attentato. La persona del “Liberatore dei servi” era circonfusa da un’aureola che lo proteggeva mille volte meglio degli sciami dei poliziotti. Se in quel momento Aleksandr II avesse manifestato anche il minimo desiderio di migliorare le condizioni della Russia, se solo avesse chiamato presso di sé uno o due di quelli che erano stati i suoi collaboratori durante il periodo delle riforme e avesse ordinato di fare un’inchiesta sulle condizioni del paese, o semplicemente dei contadini; se avesse dimostrato di voler porre un limite alla potenza della polizia segreta, le sue iniziative sarebbero state accolte con entusiasmo. Bastava una parola per farne ancora il “Liberatore” e di nuovo la gioventù avrebbe ripetuto le parole di Herzen: “Hai vinto, o Galileo!”. Ma come durante l’insurrezione polacca si era ridestato in lui il despota, e istigato da Katkov era ricorso alle impiccagioni, così in questa occasione, seguendo ancora i consigli del suo cattivo genio, Katkov, non trovò di meglio che nominare speciali governatori militari per presiedere alle impiccagioni.
Fu allora, e allora soltanto, che un gruppetto di rivoluzionari – il Comitato Esecutivo – sostenuto, devo dire, dal crescente malcontento delle classi colte e anche dell’ambiente più vicino allo zar – dichiarò quella guerra all’autocrazia che dopo vari tentativi falliti terminò nel 1881 con la morte di Aleksandr II.
Ho già detto che in Aleksandr II vivevano due personalità, e il contrasto fra l’una e l’altra andò accentuandosi durante tutta la sua vita, fino ad assumere un aspetto veramente tragico. Quando si trovò di fronte ad [Aleksandr] Solovëv, che sparò contro di lui mancando il primo colpo, ebbe il sangue freddo di correre alla porta più vicina non in linea retta, ma a zig-zag, mentre Solovëv continuava a sparare; e fu grazie a questa manovra che se la cavò con un semplice strappo nel cappotto. Anche il giorno della sua morte dette un’incontestabile prova di coraggio. Davanti a un pericolo reale si mostrava coraggioso, ma era continuamente tormentato dal terrore di pericoli immaginari. Una volta sparò contro un suo aiutante di campo perché un movimento brusco di questi gli aveva fatto credere che egli volesse attentare alla sua vita. Pur di salvarsi abdicò tutto il suo potere di imperatore nelle mani di persone che si infischiavano di lui, curandosi solo di farsi una posizione redditizia.
Conservava indubbiamente affetto per la madre dei suoi figli, benché allora la tradisse con la principessa Dolgorukij, che sposò immediatamente dopo la morte dell’imperatrice. “Non parlatemi dell’imperatrice; ne soffro troppo”, disse più di una volta a Loris Melikov. Eppure lasciò in completo abbandono l’imperatrice Maria, che gli era stata fedelmente al fianco mentre era il “liberatore”, e permise che morisse nel palazzo sola, assistita da due dame profondamente devote a lei, abitando in un altro palazzo e facendole solo brevi visite ufficiali.
Un medico russo ben conosciuto, che ora è morto, raccontò ai suoi amici come egli, che pure era un estraneo, si sentisse indignato per l’abbandono in cui era lasciata l’imperatrice durante la sua ultima malattia, fuggita naturalmente dalle dame di Corte, che riservavano tutte le loro premure per la principessa Dolgorukij.
Fu allora che il Comitato Esecutivo ebbe l’audacia di tentare di far saltare il Palazzo d’Inverno, ma Aleksandr II prese una decisione straordinaria. Creò una specie di dittatura e concesse a Loris Melikov poteri illimitati. Questo generale era un armeno e Aleksandr II gli aveva già conferita un’autorità del genere un’altra volta, quando, essendo scoppiata la peste bubbonica sul basso Volga, la Germania minacciò di mobilitare le sue truppe e di mettere la Russia in quarantena se non si fossero prese le misure necessarie per localizzare l’infezione. Allora, quando si accorse di non potersi più fidare neppure della polizia di Palazzo, Aleksandr II concesse poteri dittatoriali a Loris Melikov; e poiché Melikov aveva fama di essere liberale, questa decisione fu interpretata come un segno che presto sarebbe stata convocata un’Assemblea Nazionale. Siccome però l’esplosione del Palazzo d’Inverno non fu seguita subito da altri attentati, egli riprese coraggio e pochi mesi dopo, prima che Melikov avesse avuto modo di affermarsi, improvvisamente lo trasformò da dittatore in semplice ministro degli Interni.
Gli attacchi improvvisi di melanconia, durante i quali Aleksandr II si rimproverava il carattere reazionario che aveva dato al proprio regno, si manifestavano ora come violente crisi di lacrime. Stava per ore e ore a piangere, con grande disperazione di Melikov. Poi chiedeva al suo ministro: “Quando sarà pronto il vostro progetto di Costituzione?”. Ma se due giorni dopo Melikov gli diceva che era pronto, pareva che l’imperatore se ne fosse dimenticato. “Ve ne ho parlato?”, domandava. “A che scopo? Sarà meglio lasciarlo al mio erede. Sarà questo il suo dono alla Russia”.
Quando sentiva di qualche nuovo complotto era pronto a concedere qualche cosa per accontentare il Comitato Esecutivo; ma quando sembrava che fosse tornata la calma, tornava a prestare orecchio ai reazionari. Melikov si aspettava di essere licenziato da un momento all’altro.
Nel febbraio del 1881 Melikov annunciò che era stato tramato un nuovo complotto dal Comitato Esecutivo, ma che tutte le ricerche per scoprirne i particolari erano state inutili. Allora Aleksandr II decise di convocare una specie di assemblea consultiva di tutti i delegati delle province. Dominato dall’idea che gli fosse serbato il destino di Luigi XVI, chiamava quell’assemblea Assemblée des Notables, come quella riunita da Luigi XVI prima dell’Assemblea Nazionale del 1789. Bisognava esporne il progetto al Consiglio di Stato, ma a questo punto egli ebbe una nuova esitazione. Fu solo la mattina del 1° (13) marzo 1881, dopo esser stato messo in guardia una volta ancora da Melikov, che egli diede ordine di portare il progetto davanti al Consiglio per il giovedì seguente. Era domenica e Melikov lo pregò di non andare alla rivista, perché lo minacciava il pericolo di un attentato. Egli vi andò ugualmente. Desiderava vedere la granduchessa Caterina (figlia della zia Elena Pavlovna, che era stata alla testa del partito riformista nel 1861) per darle la buona notizia, forse come offerta espiatoria alla memoria dell’imperatrice Maria. Si dice che le abbia detto: “Je me suis décide a convoquer une Assemblée des Notables”. Questa concessione tardiva e incerta non era però stata ancora proclamata, quando egli fu ucciso mentre tornava al Palazzo d’Inverno.
Si sa bene come avvenne. Fu lanciata una bomba contro la sua carrozza, rivestita di ferro, per fermarla. Parecchi circassi della scorta furono feriti. [Nikolaj] Rysakov, che aveva lanciato la bomba, fu subito arrestato. Allora, malgrado i consigli e le preghiere del suo cocchiere, che insisteva per portarlo ancora con la carrozza, solo leggermente danneggiata, lo zar insistette per scendere. Sentiva il dovere di andare a vedere e a incoraggiare i circassi feriti, come aveva fatto durante la guerra turca, quando un assalto pazzesco a Plevna, destinato a finire in un orribile disastro, fu eseguito il giorno della sua festa.
Egli si avvicinò a Rysakov e gli rivolse una domanda, – e mentre passava vicino a un altro giovane, [Ignatij] Grinevickij, questi lanciò la sua bomba in modo da uccidere sia se stesso che lo zar. Rimasero tutti e due orribilmente feriti e sopravvissero solo poche ore.
Alessandro II rimase là disteso sulla neve, abbandonato dal suo seguito. Erano tutti scomparsi. Furono alcuni cadetti, di ritorno dalla parata, a rialzare da terra lo zar moribondo e a metterlo su una slitta, ricoprendo il suo corpo tremante dal freddo con un mantello da cadetto. E fu uno dei terroristi, [Ivan] Emelianov, con una bomba avvolta nella carta sotto il braccio, che a rischio di essere arrestato e impiccato corse con i Cadetti ad aiutare il ferito. La natura umana è ricca di contrasti del genere.
Così finì la tragica esistenza di Aleksandr II. La gente non capiva come fosse possibile che uno zar che aveva fatto tanto per la Russia fosse ucciso per mano dei rivoluzionari. A me, che avevo avuto modo di vedere i primi passi di Aleksandr sulla via della reazione e la sua lenta involuzione, che avevo osservato la sua complessa personalità e visto in lui l’autocrate, la cui violenza era solo velata dall’educazione – un uomo che aveva l’audacia del militare, ma al quale mancava il coraggio dell’uomo di Stato, un uomo dalle passioni violente e dalla volontà debole –, sembrò che la tragedia si sviluppasse con la fatalità ineluttabile dal giorno in cui lo sentii fare il discorso ai Cadetti prossimi ufficiali, il 13 giugno 1862, dopo aver ordinato le prime esecuzioni in Polonia.
I circoli di Corte di Pietroburgo furono presi dal panico. Aleksandr III, nonostante la sua statura e la sua forza colossale, non era molto coraggioso: rifiutò di trasferirsi al Palazzo d’Inverno e si ritirò nel palazzo di suo nonno Paolo I a Gatchina. Conosco quella vecchia costruzione, fatta sul disegno di una fortezza di Vauban, circondata di fossati e protetta da torri di guardia dalle cui cime scale segrete conducono allo studio dell’imperatore. Ho visto i trabocchetti praticati nello studio per poter lanciare a un tratto un nemico sulle rocce aspre e nell’acqua sottostante, e la scala segreta che conduce alle prigioni e a un andito sotterraneo che si apre sul lago. Tutti i palazzi di Paolo I erano stati costruiti con questo sistema. Intanto attorno al palazzo Anickov, residenza di Aleksandr III quando era principe ereditario, fu scavata una galleria sotterranea fornita di apparecchi elettrici automatici per impedire che i rivoluzionari potessero minarla.
Si costituì una lega segreta per la protezione dell’imperatore. Grazie alle paghe triplicate, vi si iscrissero ufficiali di tutti i gradi, che esercitavano volontariamente lo spionaggio in tutte le classi della società. Naturalmente si verificarono anche incidenti ridicoli. Due ufficiali, non sapendo di essere entrambi iscritti alla lega, durante un viaggio in ferrovia cercarono a vicenda di provocarsi a una conversazione pericolosa, per arrivare poi ad arrestarsi a vicenda; solo all’ultimo si accorsero di aver sprecato le loro fatiche. Questa lega, in una forma più ufficiale, esiste ancora e sotto il nome di Ochrana (protezione) terrorizza di tanto in tanto l’attuale imperatore con pericoli immaginari di ogni genere, per giustificare la propria esistenza.
Al tempo stesso, sotto la direzione del fratello dello zar, Vladimir, fu costituita un’organizzazione ancora più segreta, la Lega Santa, da contrapporre in vari modi all’attività dei rivoluzionari, con il compito, fra l’altro, di assassinare quei profughi che erano considerati i capi delle recenti cospirazioni. Io ero fra questi. Il granduca biasimò violentemente gli ufficiali appartenenti alla lega, accusandoli di vigliaccheria e lamentandosi che non vi fossero degli uomini capaci di eliminare questi rifugiati: e un ufficiale che frequentava la prima classe quando io ero nel Corpo dei Paggi, fu designato dalla lega per questa particolare missione.
In realtà i fuorusciti non partecipavano al lavoro del Comitato Esecutivo di Pietroburgo. Sarebbe stato assurdo pretendere di dirigere dalla Svizzera le cospirazioni di Pietroburgo, dove i rivoluzionari erano sotto la continua minaccia di morte; e Stepnjak e io l’abbiamo scritto più volte, nessuno di noi avrebbe acconsentito ad assumersi il compito di elaborare dei piani d’azione senza essere sul posto. Ma naturalmente alla polizia di Pietroburgo tornava comodo sostenere che le era impossibile proteggere lo zar, perché gli attentati erano tutti organizzati all’estero, e le loro spie – lo so con sicurezza – fornivano in proposito tutti i rapporti che si volevano.
[Michail] Skobelev, l’eroe della guerra turca, fu pregato di partecipare alla lega, ma si rifiutò recisamente. Dalle carte postume di Loris Melikov, alcune delle quali furono pubblicate a Londra da un suo amico, pare che quando Aleksandr III salì al trono ed esitò a convocare l’Assemblea dei Notabili, Skobelev abbia proposto a Loris Melikov e al conte Ignat’ev (il Pascià bugiardo, come era chiamato dai diplomatici di Costantinopoli) di arrestare Aleksandr III per obbligarlo a firmare un manifesto per la Costituzione; e si dice che Ignat’ev abbia denunciato il progetto allo zar e che abbia così ottenuto la nomina a primo ministro e sia poi ricorso in quella qualità, servendosi dei consigli di [Louis] Andrieux, ex prefetto della polizia di Parigi, a vari stratagemmi per paralizzare l’attività dei rivoluzionari.
Se i liberali russi fossero stati capaci di un po’ di coraggio e avessero saputo coordinare la loro azione, in quel momento un’Assemblea Nazionale sarebbe stata convocata. Sappiamo dai carteggi postumi di Loris Melikov che per un certo tempo Aleksandr III fu disposto a convocare un’Assemblea Nazionale. Si era deciso a farlo e l’aveva detto a suo fratello. Il vecchio Guglielmo I di Prussia l’incoraggiava su questa via. Solo quando vide che i liberali non facevano nulla, mentre il partito di Katkov si dava da fare in senso opposto, e mentre Andrieux gli consigliava di schiacciare i nichilisti e gliene suggeriva i mezzi (una lettera dell’ex prefetto sull’argomento è stata pubblicata con le carte di cui parlavo) Aleksandr III si dichiarò finalmente deciso a essere l’autocrate di tutta la Russia.
Pochi mesi dopo la morte di Aleksandr II fui espulso dalla Svizzera per ordine del Consiglio Federale. Non me ne offesi. Attaccato dai paesi monarchici per l’asilo che la Svizzera offriva ai profughi, minacciato dalla stampa russa ufficiale dell’espulsione di tutte le istitutrici e le cameriere svizzere, che sono numerose in Russia, il governo svizzero espellendomi volle dare una certa soddisfazione alla polizia russa. Ma nell’interesse della stessa Svizzera mi rincrebbe molto che questo passo fosse stato fatto. Si diede così una conferma alla teoria delle “cospirazioni organizzate in Svizzera”, e fu una confessione di debolezza della quale le altre potenze non tardarono ad approfittare. Quando, due anni dopo, Jules Ferry propose all’Italia e alla Germania la divisione della Svizzera, deve aver fondato le sue argomentazioni sul fatto che lo stesso governo svizzero aveva indirettamente confessato che la Svizzera era “un semenzaio di cospirazioni internazionali!”. Questa prima concessione provocò delle richieste più arroganti e contribuì certamente a mettere la Svizzera in una situazione di minore indipendenza di quella che avrebbe potuto avere.
Il decreto di espulsione mi fu consegnato immediatamente dopo il mio ritorno da Londra, dove ero andato nel luglio del 1881 ad assistere a un Congresso anarchico. Dopo il Congresso mi ero fermato per qualche settimana in Inghilterra e avevo scritto i primi articoli sui problemi russi dal punto di vista dei rivoluzionari per il “Newcastle Chronicle”. In quel momento la stampa inglese si faceva eco delle opinioni della signora Novikov – vale a dire di Katkov e della polizia di Stato russa – e fui felicissimo quando il signor Joseph Cowen acconsentì a ospitarmi nel suo giornale perché vi esponessi le nostre idee.
Avevo appena raggiunto mia moglie sulle alte montagne dove si era stabilita vicino alla casa di Elisée Réclus, quando mi fu intimato di lasciare la Svizzera. Spedimmo il nostro poco bagaglio alla prossima stazione ferroviaria e andammo a piedi fino a Aigle, godendoci per l’ultima volta lo spettacolo delle montagne che ci erano tanto care.
Attraversammo le colline prendendo le scorciatoie, e ridevamo quando risultava che le scorciatoie non servivano che a portarci fuori strada; e quando arrivammo in fondo alla vallata ci avviammo lungo la strada polverosa. L’incidente comico che non manca mai in questi casi fu dovuto a una signora inglese. Una signora elegante, sdraiata in fondo a una carrozza vicino a un signore, gettò alcuni opuscoli religiosi ai due poveri pedoni, passandoci vicino. Raccolsi gli opuscoli dalla polvere. Era evidentemente una di quelle signore che si credono cristiane e che si sentono in dovere di distribuire opuscoli religiosi in mezzo agli “stranieri peccatori”. Pensando di raggiungere la signora alla stazione, scrissi dietro uno degli opuscoli il famoso versetto che parla del ricco e del Regno dei Cieli, e altre citazioni che parlano dei farisei come dei peggiori nemici del cristianesimo.
Quando arrivammo ad Aigle la signora si faceva servire un rinfresco nella sua vettura. Evidentemente preferiva continuare il viaggio a quel modo, lungo la bellissima vallata, invece di rinchiudersi in un treno soffocante. Le restituii gentilmente gli opuscoli, dicendole che vi avevo aggiunto qualche cosa che sarebbe forse stato utile alla sua educazione. La signora non sapeva più se scagliarmisi contro o accettare la prova con cristiana rassegnazione. Vidi passare rapidamente nei suoi occhi due opposti propositi.
Mia moglie doveva dare il suo esame di laurea in scienze all’università di Ginevra; andammo perciò a stabilirci in una piccola città francese, Thonon, sulla costa savoiarda del Lago di Ginevra e vi rimanemmo due mesi.
Quanto alla mia condanna a morte da parte della “Lega Santa” di Pietroburgo, ne fui informato da un altissimo personaggio russo. Seppi anche il nome della signora mandata da Pietroburgo a Ginevra perché si mettesse alla testa della cospirazione ordita contro di me. Io mi accontentai di comunicare i fatti al corrispondente ginevrino del “Times”, pregandolo di pubblicare le informazioni se mi fosse accaduto qualche cosa, e feci inserire in “Le Révolté” una nota a questo proposito. Fatto questo, non me ne preoccupai più. Ma mia moglie non se la prese con tanta calma e la buona contadina che ci faceva pensione a Thonon, la signora Sansaux, che aveva saputo del complotto da un’altra fonte (sua sorella faceva la bambinaia in casa di un agente del governo russo) ebbe per me i riguardi più commoventi. La sua casetta era fuori dalla città e tutte le volte che dovevo andarvi di notte, qualche volta per incontrare mia moglie alla stazione, trovava sempre una scusa per farmi accompagnare da suo marito con la lanterna. “Un momento, signor Kropotkin”, mi diceva, “mio marito deve fare la stessa strada per delle spese, e sapete che porta sempre la lanterna”. Oppure mandava suo fratello, che doveva seguirmi sempre a distanza senza che io me ne accorgessi.
Appena mia moglie ebbe dato i suoi esami, nell’ottobre o nel novembre del 1881, lasciammo Thonon per Londra, dove ci fermammo quasi un anno. Sono passati pochi anni da allora, eppure posso dire che la vita intellettuale a Londra e in tutta l’Inghilterra era completamente diversa da quella che divenne poi. Tutti sanno che tra il 1840 e il 1850 l’Inghilterra si poteva considerare alla testa del movimento socialista in Europa; ma durante gli anni di reazione che seguirono a questo grande movimento, che aveva avuto una profonda influenza sulle classi lavoratrici, e durante il quale era già stato formulato tutto quello che più tardi è stato proposto come socialismo scientifico, subì un arresto. Fu dimenticato tanto in Inghilterra che sul Continente, e quello che gli scrittori francesi chiamano “il terzo risveglio del proletariato” in Gran Bretagna non era ancora cominciato. I lavori della commissione agricola nel 1871, la propaganda in mezzo ai contadini e gli sforzi che già avevano fatto i socialisti cristiani, avevano certo aiutato ad aprirgli la strada; ma l’ondata di adesione al socialismo che seguì in Inghilterra alla pubblicazione del libro Progresso e miseria di Henry George, non si era ancora manifestata.
L’anno che passai a Londra fu quindi veramente un anno di esilio. Per qualcuno che la pensasse da socialista, non vi era un’atmosfera respirabile. Non vi era segno di quell’attivo movimento socialista che trovai in pieno sviluppo al mio ritorno nel 1886. [John] Burns, [Henry] Champion, [James] Hardie e gli altri capi del movimento operaio non erano ancora noti; i Fabiani non esistevano; [William] Morris non si era ancora dichiarato socialista e le Trades Unions, che a Londra si limitavano a pochi mestieri privilegiati, erano ostili al socialismo: i soli rappresentanti apertamente attivi del movimento socialista erano i signori Hyndman, con pochissimi operai che facevano capo a loro. Nell’autunno del 1881 avevano convocato un piccolo Congresso, e noi dicevamo scherzando – ma era quasi esatto – che la signora Hyndman aveva ospitato tutto il Congresso a casa sua. Il movimento più o meno socialista e radicale, che indubbiamente andava affacciandosi nel pensiero di molti, non si affermava ancora apertamente e schiettamente. Quello stuolo notevole di uomini e di donne colti che quattro anni più tardi avrebbe partecipato alla vita pubblica e, senza legarsi al movimento socialista, preso parte ai vari movimenti diretti a promuovere il benessere e l’educazione delle masse, e che oggi [1899] in quasi tutte le città dell’Inghilterra e della Scozia ha creato un’atmosfera nuova di riforme e una nuova società di riformisti, non si era allora ancora segnalato. Esistevano, naturalmente, pensavano e parlavano; vi erano tutti gli elementi per un movimento importante, ma senza quel centro di attrazione che divennero più tardi i gruppi socialisti, essi restavano sperduti fra la folla, non si conoscevano e ignoravano le proprie forze.
Žukovskij era allora a Londra e come in passato incominciammo la propaganda socialista in mezzo agli operai. Aiutati da pochi operai inglesi che avevamo conosciuto al Congresso del 1881, o che i processi a John Most avevano attirato verso il socialismo, andavamo nei circoli radicali e là parlavamo di questioni russe, del movimento della nostra gioventù verso il popolo e del socialismo in generale. Avevamo un pubblico ridicolmente scarso, di rado più di una dozzina di persone. Ogni tanto qualche Cartista dalla barba grigia si alzava in mezzo alla sala e ci diceva che quanto noi dicevamo ora era già stato detto quarant’anni prima, e che vi erano allora folle di operai entusiasti ad applaudire, ma che ormai tutto era morto e che non vi era più speranza di farlo rivivere.
[Henry] Hyndman aveva da poco pubblicato la sua ottima esposizione del socialismo marxista sotto il titolo L’Inghilterra per tutti; e ricordo che un giorno dell’estate del 1882 gli consigliai seriamente di fondare un giornale socialista. Gli raccontai con che miseria di mezzi avessimo incominciato a pubblicare “Le Révolté” e gli predissi un sicuro successo se avesse tentato la prova. Ma le prospettive erano così scoraggianti, da far pensare che l’impresa fosse condannata al fallimento, a meno che avesse lui i mezzi per farne tutte le spese. Forse aveva ragione, ma quando meno di tre anni dopo fondò “Justice”, essa fu accolta bene dagli operai e al principio del 1886 si pubblicavano tre giornali socialisti e la Federazione Socialdemocratica era un’organizzazione influente.
Nell’estate del 1882 parlai, in un inglese molto discutibile, ai minatori del Durham, nel loro Congresso annuale; tenni delle conferenze a Newcastle, a Glasgow e a Edimburgo sul movimento russo, ed ebbi un’accoglienza entusiastica dalla folla di operai intervenuti, che per la strada, dopo la riunione, applaudirono ai nichilisti. Ma mia moglie e io ci sentivamo tanto isolati a Londra, e i risultati dei nostri sforzi per ridestare un movimento socialista in Inghilterra erano così scoraggianti, che nell’autunno del 1882 ci decidemmo a tornare in Francia. Sapevo bene che in Francia non avrei tardato ad essere arrestato; ma ci dicevamo sovente: “Meglio una prigione francese che questo sepolcro”.
Quelli che sono sempre pronti a parlare della lentezza dell’evoluzione, dovrebbero studiare lo sviluppo del socialismo in Inghilterra. L’evoluzione è lenta, ma il suo progresso non è mai uniforme. Vi sono periodi di torpore e periodi di risveglio improvviso.
Andammo a stabilirci di nuovo a Thonon presso la nostra vecchia padrona di casa, la signora Sansaux. Un fratello di mia moglie, gravemente ammalato di tisi, venne a raggiungerci.
Non ho mai visto tante spie russe quante ne vidi durante i due mesi del mio soggiorno a Thonon. Appena ci fummo sistemati, per incominciare, un tipo sospetto che si diceva inglese prese in affitto l’altra parte della casa. Sciami, letteralmente sciami di spie russe ci assediavano, cercando con ogni genere di pretesti di penetrare nella casa, o passeggiandovi semplicemente davanti a due, a tre, a quattro. Immagino perfettamente i meravigliosi rapporti che devono aver fatto. Una spia non può non fare dei rapporti. Se dicesse semplicemente di essersi appostato per una settimana in una strada senza aver osservato nulla di misterioso, sarebbe ben presto messa a riposo o licenziata.
Era quella l’età d’oro della polizia segreta russa. La politica di Ignat’ev aveva dato i suoi frutti. Due o tre diversi corpi di polizia gareggiavano fra loro, ognuno aveva a disposizione tutto il denaro che desiderava e ordiva gli intrighi più audaci. Per esempio, il colonnello Sudeikin, capo di uno di questi corpi – con la complicità di un certo Degaev, che finì con l’ucciderlo – denunciò gli agenti di Ignat’ev ai rivoluzionari e offrì ai terroristi tutti i mezzi per ammazzare il ministro degli Interni, il conte Tolstoj, e il granduca Vladimiro, aggiungendo che dopo di questo egli stesso sarebbe stato nominato ministro degli Interni con poteri dittatoriali e che lo zar sarebbe stato completamente nelle sue mani. Questa attività della polizia russa culminò più tardi nel rapimento del principe di Battenberg dalla Bulgaria.
Anche la polizia francese stava all’erta. Li tormentava la domanda: “Che cosa può essere andato a fare a Thonon?”. Io continuavo a redigere “Le Révolté” e scrivevo articoli per l’Enciclopedia Britannica e per il “Newcastle Chronicle”. Ma tutto questo non si prestava a un rapporto. Un giorno il poliziotto del paese fece visita alla mia padrona di casa. Aveva sentito dalla strada il rumore di una macchina e avrebbe voluto poter segnalare il fatto che io avevo in casa una stamperia segreta. Venne perciò mentre io ero assente e pregò la padrona di casa di fargli vedere la macchina per stampare. Rispose che non c’era e gli suggerì che forse aveva sentito il rumore della sua macchina da cucire, ma egli non si lasciò convincere da una spiegazione così prosaica e insistette perché la donna si mettesse alla macchina, in modo da poter ascoltare dall’interno della casa e da fuori, per essere sicuro che il rumore che aveva sentito era quello.
“Che cosa fa tutto il giorno?”, chiese alla padrona di casa.
“Scrive”.
“Ma non può scrivere tutto il giorno”.
“A mezzogiorno sega la legna nel giardino e ogni sera fa una passeggiata dalle quattro alle cinque”. Eravamo in novembre.
“Ecco! La sera! Quando si fa buio?”. (A la tombée de la nuit?) E scrisse nei suoi appunti: “Esce solo la sera”.
Non riuscivo allora a spiegarmi perché fossi così preso di mira dalle spie russe; ma una spiegazione si trova forse in quanto segue. Quando Ignat’ev fu nominato primo ministro, per consiglio di Andrieux, ex prefetto della polizia di Parigi, inventò un nuovo stratagemma. Mandò in Svizzera uno stuolo di agenti e uno di questi si mise a pubblicare un giornale favorevole a qualche leggera forma di allargamento dell’autonomia provinciale in Russia, ma il cui vero scopo era quello di combattere i rivoluzionari e di attirare quelli tra i fuorusciti che non simpatizzavano con i terroristi. Questo era certo un buon sistema per seminare la discordia. Più tardi, quando quasi tutti i membri del Comitato Esecutivo in Russia furono arrestati e due di essi si rifugiarono a Parigi, Ignat’ev mandò un suo agente per proporre loro un armistizio. Egli promise che non si sarebbero fatte altre esecuzioni per i complotti orditi durante il regno di Aleksandr II, anche se quelli che erano sfuggiti all’arresto fossero caduti nelle sue mani; che černyševskij sarebbe stato liberato dalla Siberia; che sarebbe stata nominata una commissione per riesaminare il caso di quelli che erano stati esiliati in Siberia senza processo. D’altra parte il Comitato Esecutivo doveva impegnarsi a desistere da ogni attentato contro la vita dello zar fino alla sua incoronazione. Si parlò forse anche delle riforme in favore dei contadini, che Aleksandr III aveva intenzione di fare. Il patto fu concluso a Parigi e fu osservato da ambedue le parti. I terroristi sospesero la loro attività. Non vi furono condanne a morte per i complotti precedenti; quelli che furono arrestati più tardi sotto questa accusa furono rinchiusi nella Bastiglia russa a Schlüsselburg, dove per quindici anni non si seppe più nulla di loro e dove molti si trovano ancora. černyševskij partì dalla Siberia, e gli fu ordinato di fermarsi ad Astrakan, dove si trovò isolato da ogni attività intellettuale russa e dove morì poco dopo. Fu mandata una commissione in Siberia, alcuni degli esuli furono liberati e fu definita per gli altri la durata dell’esilio. Mio fratello Aleksandr si guadagnò altri cinque anni.
Quando mi trovavo a Londra nel 1882 mi dissero un giorno che un individuo, che pretendeva di essere un “autentico” agente del governo russo, e che lo poteva provare, desiderava entrare in negoziati con me. “Ditegli che se viene a casa mia lo butto giù dalle scale”, fu la mia risposta. Immagino il risultato! Mentre Ignat’ev considerava lo zar al sicuro dagli attentati del Comitato Esecutivo, temeva qualche attentato da parte degli anarchici e desiderava perciò di liberarsi di me ad ogni costo.
Il movimento anarchico aveva avuto un rapido sviluppo in Francia fra il 1881 e il 1882. Si credeva generalmente che i Francesi fossero per temperamento ostili al comunismo e nell’Associazione Internazionale dei Lavoratori si predicava invece il “collettivismo”. Si intendeva con questo il possesso sociale degli strumenti di produzione, lasciando però a ogni singolo gruppo di decidere se il consumo dei prodotti dovesse avvenire secondo sistemi individualisti o comunisti. In realtà il temperamento francese era contrario solo al comunismo monastico, al phalanstère della vecchia scuola. Quando la Federazione del Giura al Congresso del 1880 dichiarò audacemente di essere in favore del comunismo anarchico – cioè del comunismo libero – l’anarchia seppe conquistarsi larga simpatia in Francia. Il nostro giornale incominciò a circolarvi, c’era un attivo scambio di corrispondenza con gli operai francesi e si sviluppò rapidamente un importante movimento anarchico a Parigi e in certe province, soprattutto nei dintorni di Lione. Attraversando la Francia nel 1881, andando da Thonon a Londra, mi fermai a Lione, Saint-Etienne e Vienne, dove tenni delle conferenze, e trovai un buon numero di operai pronti ad accogliere le nostre idee.
Alla fine del 1882, una crisi terribile era sopravvenuta nella regione di Lione. L’industria tessile era paralizzata e la miseria dei tessitori era tale che ogni mattina folle di bambini assediavano le porte delle caserme dove i soldati distribuivano quello che potevano del loro rancio. Incominciò così la popolarità del generale Boulanger, che permetteva questa distribuzione. Anche i minatori della regione si trovavano in condizioni molto precarie.
Sapevo che vi era molta agitazione, ma negli anni passati a Londra avevo perso contatto con il movimento francese. Poche settimane dopo il mio ritorno a Thonon seppi dai giornali che i minatori di Monceau-les-Mines, sdegnati delle vessazioni dei padroni delle miniere, ultracattolici, avevano iniziato una specie di movimento, tenevano segretamente delle riunioni e parlavano di sciopero generale; le croci di pietra che si alzavano su tutte le strade nei pressi delle miniere furono rovesciate o fatte saltare con le cartucce di dinamite delle quali i minatori si servono nel loro lavoro e che sovente rimangono nelle loro mani. Anche a Lione l’agitazione prese un tono di maggiore violenza. Gli anarchici, piuttosto numerosi laggiù, non lasciavano passare nessuna delle riunioni di politicanti opportunisti senza farsi ascoltare, prendendo, in mancanza di meglio, d’assalto la tribuna. Mettevano ai voti degli ordini del giorno in cui si diceva che le miniere e tutti i mezzi di produzione, comprese anche le abitazioni, avrebbero dovuto essere proprietà del popolo, e tali risoluzioni erano votate entusiasticamente, con terrore della borghesia.
Gli operai diventavano sempre più ostili ai consiglieri municipali e ai caporioni politici opportunisti, così come alla stampa, che si preoccupava ben poco di una crisi generale tanto grave e che non faceva nulla per porre rimedio alla miseria generale. Come avviene in momenti simili, la furia dei poveri si diresse in modo particolare contro i ritrovi allegri e i luoghi di divertimento, che in momenti di desolazione e di miseria colpivano tanto più l’operaio perché rappresentavano per lui l’egoismo e la corruzione delle classi ricche.
Vi era un ritrovo particolarmente mal visto dagli operai, il caffè sotterraneo del Théàtre Bellecour che restava aperto tutta la notte e dove nelle ore piccole si potevano vedere giornalisti e politicanti bere e banchettare in compagnia di donne di facili costumi. Non vi era riunione in cui non si facesse qualche allusione minacciosa a quel caffè, e una notte vi fu messa da mano ignota una cartuccia di dinamite. Un operaio socialista, che vi andava qualche volta, si precipitò a spegnere la miccia della cartuccia e rimase ucciso, mentre alcuni degli uomini politici che pranzavano rimasero leggermente feriti. Il giorno dopo una cartuccia di dinamite esplose all’ingresso di un ufficio di collocamento e si diceva che gli anarchici volessero far saltare la colossale statua della Madonna che si alza su una delle colline di Lione.
Bisogna aver vissuto a Lione o nei dintorni per capire come e quanto la popolazione e le scuole siano ancora nelle mani del clero cattolico, e per capire l’odio che la parte maschile della popolazione nutre per i preti.
La borghesia di Lione era ormai in preda al panico. Una sessantina di anarchici – tutti operai tranne un solo borghese, Émile Gautier, che faceva un giro di conferenze in provincia – furono arrestati. La stampa lionese incominciò intanto a far pressione sul governo per il mio arresto, dipingendomi come capo dell’agitazione, tornato dall’Inghilterra per dirigere il movimento. Le spie russe ricominciarono a girare in gran numero per la piccola città. Quasi ogni giorno ricevevo delle lettere, scritte evidentemente dagli agenti della polizia internazionale, in cui si parlava di qualche complotto dinamitardo o si annunciava in termini misteriosi che determinate quantità di dinamite erano state spedite al mio indirizzo. Feci una collezione di queste lettere, scrivendo su ognuna: “Polizia Internazionale”; quando perquisirono la mia casa la polizia le sequestrò. Ma non osarono presentare queste lettere in tribunale e non mi furono mai restituite.
Nel mese di novembre la casa dove abitavo fu perquisita con il sistema russo, e mia moglie, che andava a Ginevra, fu arrestata alla stazione di Thonon e perquisita anche lei. Naturalmente non trovarono nulla di compromettente né per me né per gli altri.
Passarono dieci giorni durante i quali sarei stato liberissimo di andarmene, se l’avessi voluto. Ricevetti diverse lettere che mi consigliavano di sparire, una da uno sconosciuto amico russo, forse un membro del corpo diplomatico, che sembrava mi avesse conosciuto, il quale mi diceva di partire immediatamente, se non volevo essere la prima vittima di un trattato di estradizione che stava per essere concluso tra la Francia e la Russia. Io rimasi dov’ero; e quando il “Times” pubblicò un telegramma in cui si diceva che ero scomparso da Thonon, scrissi a quel giornale dando il mio indirizzo e dichiarando che, poiché tanti dei miei amici erano in carcere, non avevo nessuna intenzione di andarmene.
La notte del 21 dicembre mio cognato spirò fra le mie braccia. Io e mia moglie sapevamo che la sua malattia era mortale, ma vedere spegnersi una giovane vita dopo una lotta coraggiosa contro la morte, è una cosa terribile. Eravamo sfiniti tutti e due. Tre o quattro ore più tardi, all’albeggiare del triste mattino invernale, i poliziotti vennero a casa per arrestarmi. Vedendo in che stato si trovava mia moglie, chiesi di rimanere con lei fin dopo i funerali, dando la mia parola d’onore che mi sarei trovato alla porta della prigione a un’ora stabilita; ma mi fu rifiutato e fui condotto a Lione la notte stessa. Elisée Réclus, chiamato telegraficamente, venne subito, prodigando a mia moglie tutta la bontà del suo grande cuore; vennero gli amici di Ginevra, e benché si trattasse di un funerale esclusivamente civile, cosa nuova per quella cittadina, tutta la popolazione era presente per dimostrare a mia moglie che il cuore dei poveri e dei semplici contadini savoiardi era con noi e non con i loro governanti. Durante il mio processo i contadini seguivano i dibattiti con interesse e simpatia e scendevano tutti i giorni dai villaggi sulle montagne in città, a prendere i giornali.
Un altro episodio che mi commosse profondamente fu l’arrivo a Lione di un amico inglese. Veniva da parte di un personaggio ben conosciuto e stimato nel mondo politico inglese, con la famiglia del quale avevo passato molte belle ore nel 1882, a Londra. Aveva portato una grossa somma di denaro per ottenere la mia liberazione su cauzione e mi trasmetteva intanto il messaggio del mio amico londinese, nel quale mi si diceva di non preoccuparmi affatto della cauzione, ma di lasciare immediatamente la Francia. In qualche modo misterioso era riuscito a vedermi liberamente – non nella doppia gabbia di rete metallica dove mi permettevano di ricevere le visite di mia moglie – e fu tanto commosso del mio rifiuto di accettare l’offerta che era venuto a farmi, quanto lo ero io per questa prova commovente di amicizia da parte di una persona che, con la sua ottima moglie, avevo già imparato a conoscere e a stimare profondamente.
Il governo francese avrebbe desiderato uno di quei processi clamorosi che impressionano le masse, ma non era possibile processare gli anarchici come colpevoli delle esplosioni: per far questo avrebbero dovuto tradurci davanti ai giurati, che probabilmente ci avrebbero assolti. Il governo ricorse quindi machiavellicamente all’espediente di processarci come appartenenti all’Associazione Internazionale dei Lavoratori. C’è in Francia una legge, votata immediatamente dopo la caduta della Comune, secondo la quale gli imputati di appartenere a quella associazione possono essere tradotti in tribunale correzionale. Il massimo della pena è di cinque anni di reclusione, e un tribunale correzionale è sempre pronto a conformarsi alle attese del governo.
Il processo ebbe inizio a Lione ai primi di gennaio del 1883 e durò una quindicina di giorni. L’accusa era assurda, perché tutti sapevano che nessuno degli operai di Lione si era mai iscritto all’Internazionale e non era possibile sostenerla, come dimostra il seguente episodio. L’unico testimonio dell’accusa era il capo della polizia segreta di Lione, un uomo anziano, che fu trattato dal tribunale con il massimo rispetto. Devo riconoscere che il suo rapporto fu perfettamente corretto per quanto riguarda i fatti. Diceva che gli anarchici si erano acquistati una posizione di predominio, rendendo impossibili le riunioni degli opportunisti con l’intervenirvi sempre per parlare del comunismo e dell’anarchia, riscuotendo il consenso degli uditori. Visto che le sue testimonianze erano state oneste fino a quel momento, mi azzardai a fargli una domanda:
“Vi è capitato di sentire il nome dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori, a Lione?”. “Mai”, rispose controvoglia.
“Quando ritornai dal Congresso di Londra nel 1881, e feci tutto il possibile per riorganizzare in Francia l’Internazionale, ebbi successo?”.
“No; non la trovarono abbastanza rivoluzionaria”.
“Grazie”, dissi. E rivolgendomi al Procuratore, aggiunsi: “La vostra accusa è stata demolita dal vostro stesso testimonio!”.
Nonostante questo fummo condannati tutti come appartenenti all’Internazionale. Quattro di noi ebbero la condanna massima di cinque anni di reclusione e 2500 lire di multa; gli altri, condanne varianti dai quattro a un anno di reclusione. L’accusa non cercò neppure di addurre qualche prova a proposito dell’Internazionale. Rimase dimenticata. Ci chiesero di parlare solo di anarchia, e facemmo così. Non si disse una parola delle esplosioni, e quando un compagno o due di Lione chiesero qualche chiarimento in proposito, risposero loro odiosamente che non erano processati per quello, ma come iscritti all’Internazionale, alla quale appartenevo io solo.
Non manca mai l’episodio ameno in processi di questo genere, e questa volta l’occasione fu una lettera mia. Mancavano assolutamente le basi sulle quali fondare l’accusa. Erano state fatte numerose perquisizioni in casa degli anarchici francesi, ma avevano trovato solo due lettere mie. L’accusa cercava di sfruttarle meglio che poteva. Una era indirizzata a un operaio francese che si sentiva scoraggiato e sfiduciato. Nella mia lettera gli parlavo della grande epoca in cui vivevamo, dei grandi rivolgimenti che ci attendevano, della nascita e della diffusione delle nuove idee, e così via. Non era una lettera lunga e il procuratore non ne poteva cavare molto. Quanto all’altra lettera, era lunga dodici pagine. L’avevo scritta a un altro francese, un giovane calzolaio che si guadagnava da vivere facendo scarpe, lavorando in camera sua. Teneva alla sinistra una stufetta dove cucinava da sé il suo pasto e a destra un piccolo sgabello dove scriveva lunghe lettere ai compagni, senza abbandonare il suo deschetto. Quando aveva terminato il numero di scarpe necessario per far fronte ai suoi modestissimi bisogni e per spedire qualche lira alla sua vecchia madre in campagna, passava lunghe ore a scrivere lettere nelle quali sviluppava le teorie anarchiche con un buon senso e un’intelligenza ammirevoli. Oggi è uno scrittore conosciuto, in Francia, e rispettato per la sua serietà. Disgraziatamente era allora capace di riempire otto o dodici pagine di una lettera senza mettervi neppure una virgola. Una volta gli scrissi una lunga lettera, nella quale gli spiegavo come i nostri pensieri si suddividano in gruppi di frasi, che devono essere divisi da punti; in frasi separate, che vanno divise da punti e virgole, e infine in proposizioni secondarie che meritano la carità di essere segnate almeno da virgole; e gli dicevo quanto avrebbero guadagnato i suoi scritti se avesse avuto cura di osservare questa semplice precauzione.
La lettera fu letta in tribunale dal procuratore, che ne approfittò per i commenti più patetici. “Avete ascoltato, o signori, questa lettera?”, continuava rivolto al tribunale. “L’avete ascoltata? Pare a prima vista che non vi sia nulla di particolare. Egli fa una lezione di grammatica a un operaio... ma” e qui la sua voce vibrava di profonda emozione “egli non l’ha fatto per aiutare un povero operaio ad acquistare le cognizioni che quello (probabilmente per la sua pigrizia) non aveva imparato a scuola. Non fu per aiutarlo a guadagnarsi onestamente la vita... No, signori, egli l’ha scritta per istillargli l’odio per le nostre belle e grandi istituzioni, per poter infondergli meglio il veleno dell’anarchia, solo per farlo diventare un nemico più terribile della società... Maledetto il giorno in cui Kropotkin posò il piede sul suolo di Francia!”. esclamò con sorprendente commozione.
Non potemmo trattenerci dal ridere come dei ragazzi durante quel discorso; i giudici lo guardavano come per dirgli che peccava per troppo zelo, ma sembrava non se ne accorgesse e continuava a parlare, inebriato dalla propria eloquenza, con un tono e dei gesti sempre più teatrali. Fece veramente tutto quel che poteva per meritarsi il premio del governo russo.
Poco tempo dopo la condanna il Presidente del tribunale fu promosso alle Assise. Quanto al Procuratore e un altro magistrato – pare incredibile, ma è vero – furono insigniti dal governo russo della Croce di Sant’Anna, e la Repubblica concesse l’autorizzazione ad accettarla. La famosa alleanza franco-russa ebbe così le sue origini al processo di Lione.
Questo processo, che durò quindici giorni e durante il quale furono pronunciati dei bellissimi discorsi sull’anarchia, da parte di oratori di prim’ordine come l’operaio Bernard ed Émile Gautier – discorsi che la stampa riprodusse ampiamente – e durante il quale tutti gli accusati si comportarono con fierezza, facendo continuamente propaganda delle nostre idee, fu utilissimo alla diffusione delle nostre teorie in Francia e contribuì certo al risveglio socialista in altri paesi.
Quanto alla condanna, essa era così poco giustificata dai risultati dell’istruttoria, che tutta la stampa francese, escluso gli organi governativi, biasimò apertamente i magistrati. Persino un giornale moderato come il “Journal des Economistes” disapprovò la condanna, “che nulla, nel dibattimento in tribunale, aveva fatto prevedere”. Davanti all’opinione pubblica eravamo stati noi a vincere. Immediatamente fu presentato alla Camera un progetto di amnistia, che raccolse un centinaio di voti. Fu rinnovato ogni anno, ottenendo ogni volta maggiori adesioni, e finalmente fummo liberati.
Il processo era terminato, ma rimasi due mesi ancora nelle carceri di Lione. Diversi compagni avevano fatto ricorso in appello contro la sentenza e si dovette aspettare il risultato. Con altri quattro compagni rifiutai di ricorrere a un tribunale superiore e continuai a lavorare nella mia cella a pagamento. Un mio grande amico, Martin – un sarto di Vienne – prese un’altra pistola (è il nome che si dà in Francia alle celle a pagamento) vicino alla mia, e siccome era già stata pronunciata la condanna, ci permettevano di fare insieme la passeggiata; quando dovevamo dirci qualche cosa fra una passeggiata e l’altra comunicavamo con il sistema dei colpi sul muro, come in Russia.
Già durante il mio soggiorno a Lione avevo incominciato a rendermi conto della demoralizzazione che produce la prigione sul carcerato, per cui più tardi condannai incondizionatamente tutto il sistema.
Il carcere di Lione è una prigione “moderna” costruita a raggera, secondo il sistema cellulare. Gli spazi fra i raggi dei fabbricati sono occupati da piccoli cortili asfaltati e quando il tempo lo permette i prigionieri vengono condotti a lavorare in questi cortili. Battono di solito i bozzoli di seta non dipanati per ottenerne la seta floscia, e in certe ore in questi cortili vengono condotte frotte di ragazzi reclusi.
Magri, deboli, mal nutriti – vere ombre di ragazzi – li osservavo spesso dalla mia finestra. L’anemia si leggeva chiaramente sui loro visetti pallidi, nei loro corpi gracili e tremanti; e non soltanto nei dormitori, ma anche nei cortili, in pieno sole, andava aumentando il loro stato anemico. Cosa avverrà di questi ragazzi dopo una scuola simile, quando usciranno con la salute rovinata, la volontà distrutta, senza più energia?
L’anemia stessa, con il conseguente ridursi delle energie e la svogliatezza, l’indebolimento della volontà e dell’intelligenza e l’immaginazione pervertita che ne sono i frutti, produce una grande quantità di delinquenti e la prigione diventa un vivaio di questo flagello del genere umano. E che cosa dire poi degli insegnamenti che ricevono i ragazzi in un ambiente simile? Il semplice isolamento, anche se fosse rigorosamente osservato – e non può esserlo – servirebbe a poco; l’atmosfera di ogni prigione è una esaltazione di quella specie di gioco a chi è più furbo, che costituisce la quintessenza del furto, della truffa e di tutte le azioni antisociali del genere. Generazioni intere di futuri carcerati nascono da questi semenzai del delitto, mantenuti dallo Stato e tollerati dalla società semplicemente perché essa non vuole sentire discutere e anatomizzare le proprie malattie. “Carcerato da giovane, uccello di galera”: ecco quello che mi dissero più tardi tutti gli studiosi di criminologia. E quando vedevo questi bambini e capivo quello che l’avvenire riservava loro, non potevo non chiedermi ogni volta: “Chi è il delinquente peggiore? Questo ragazzo o il giudice che ogni anno condanna migliaia di bambini a un destino simile?”. Riconosco volentieri che questi giudici non hanno coscienza del delitto che compiono. Ma ne hanno forse coscienza, coloro che vengono incarcerati per i loro “delitti”?
Un’altra constatazione che potei fare già dopo la prima settimana di reclusione, ma che sfugge, non si sa come, all’attenzione dei giudici e dei criminologi, è che nella maggior parte dei casi la reclusione colpisce gli innocenti molto più gravemente dei condannati stessi.
Quasi tutti i miei compagni, e il loro caso si può ben generalizzare a tutti gli operai, avevano da mantenere moglie e figli, o una sorella, o una vecchia madre. Prive del loro aiuto, queste donne facevano il possibile per trovare un lavoro e alcune vi riuscivano; ma nessuna di loro riusciva a guadagnare con continuità più di una lira e mezza al giorno. Nove lire la settimana, e spesso sette, dovevano bastare per tutta la famiglia! Questo significava la denutrizione, privazioni di ogni specie, deperimento, per la moglie e per i figli: indebolimento della volontà, dell’intelligenza e dell’energia. Mi convincevo che a questo modo la giustizia dei tribunali finiva per condannare persone del tutto innocenti a pene durissime, in molti casi anche peggiori di quelle che doveva subire il condannato stesso.
Oggi si pensa che la legge debba castigare sottoponendo l’individuo a privazioni fisiche e morali. Ma la natura umana è fatta così, che qualunque privazione le si imponga, a poco a poco vi si abitua. Se non può modificare le sue condizioni di vita, le accetta e dopo un po’ di tempo le sopporta, come si sopporta una malattia cronica, e non le sente più. Ma cosa succede dopo l’imprigionamento, della moglie e dei figli del condannato, degli innocenti, cioè, che aspettano il pane da lui? così sono puniti ancora più crudelmente! E la forza dell’abitudine ci rende ciechi di fronte a questa grande ingiustizia. Io me ne resi conto solo quando ne ebbi fatto esperienza.
Verso la metà di marzo del 1883 ventuno di noi, condannati a più di un anno di reclusione, fummo trasferiti in grande segreto alle carceri centrali di Clairvaux. Si trattava dell’antica abbazia di San Bernardo, trasformata dalla grande Rivoluzione in un asilo per i poveri. Più tardi diventò una casa di pena e di correzione, conosciuta da prigionieri e dai funzionari stessi con il ben meritato titolo di casa di pena e di corruzione.
Durante la permanenza a Lione fummo trattati come si usa in Francia per i prigionieri non ancora condannati: indossavamo cioè i nostri abiti e potevamo far venire il cibo da una trattoria, e per poche lire al mese potevamo avere una cella più grande, di quelle che si chiamano pistole. Approfittai di questo diritto per lavorare attivamente ai miei articoli per l’Enciclopedia Britannica e la “Nineteenth Century”. Ma a Clairvaux non era ancor stato deciso il trattamento che ci avrebbero fatto. In Francia, però, per i detenuti politici si considera una pena sufficiente la privazione della libertà e l’ozio forzato. Ci dissero quindi che il nostro trattamento sarebbe restato quello della detenzione preventiva. Fummo alloggiati in quartieri separati, indossavamo i nostri abiti, non avevamo l’obbligo del lavoro e potevamo fumare. “Quelli che vogliono guadagnare qualche cosa con il lavoro manuale”, ci disse il capocarceriere, “potranno farlo cucendo busti o incidendo piccoli oggetti di madreperla. È un lavoro poco retribuito, ma non vi si potrebbe far lavorare nelle officine del carcere, nella fabbrica di letti di ferro, cornici, ecc., perché dovremmo allora alloggiarvi con i delinquenti comuni”. Come gli altri detenuti potevamo comperare allo spaccio delle carceri viveri in più e un quarto di vino rosso al giorno, tutto fornito a basso prezzo e di buona qualità.
La mia prima impressione di Clairvaux fu favorevolissima. Per il viaggio eravamo stati rinchiusi tutto il giorno, dalle due o dalle tre della mattina, negli stretti bugigattoli in cui sono divisi i vagoni cellulari.
Arrivati alle carceri centrali fummo condotti provvisoriamente al reparto cellulare di punizione, e messi nelle celle comuni, di una pulizia scrupolosa. Nonostante l’ora avanzata ci furono serviti cibi caldi, semplici ma di ottima qualità, con la possibilità di comperare un quarto di vin du pays, buonissimo, che lo spaccio vendeva al bassissimo prezzo di ventiquattro centesimi al litro. Il capocarceriere e i secondini furono molto cortesi.
Il giorno dopo il capocarceriere mi condusse a vedere le stanze che aveva intenzione di assegnarci e quando gli dissi che andavano bene, ma che erano un po’ piccole per il numero dei detenuti – eravamo in ventidue – e la mancanza di spazio avrebbe potuto provocare delle malattie, egli ci diede un altro gruppo di stanze in un’ala che anticamente era del sovrintendente dell’abbazia e che ora serve da ospedale. Le nostre finestre si aprivano su di un giardinetto oltre il quale si godeva una bellissima vista della campagna circostante. In un’altra stanza dello stesso piano il vecchio Blanqui aveva passato gli ultimi tre o quattro anni che precedettero la sua liberazione. Prima era stato nella sezione cellulare.
Oltre alle tre spaziose stanze che ci erano state assegnate, per me e Gautier fu riservata una cameretta perché vi potessimo continuare i nostri lavori letterari. Questo favore probabilmente fu dovuto all’intervento di un numero notevole di scienziati inglesi che, subito dopo la mia condanna, indirizzarono una petizione al Presidente chiedendo la mia liberazione. Era firmata da molti redattori della Enciclopedia Britannica, da Herbert Spencer, [Algernon] Swinburne, e Victor Hugo aveva aggiunto alla sua firma alcune calde parole.
In complesso in Francia l’opinione pubblica era molto ostile alla nostra condanna e quando mia moglie fece sapere a Parigi che mi occorrevano dei libri, l’Accademia delle Scienze mi offri la sua biblioteca e Ernest Renan mise a mia disposizione la sua biblioteca personale con una lettera gentilissima.
Avevamo anche un piccolo giardino dove si poteva giocare al jeu de boules. Riuscimmo poi a coltivare una striscia di terreno lungo il muro, e su una superficie di un’ottantina di metri quadri coltivammo una quantità incredibile di lattughe e di ravanelli, e anche alcuni fiori. Naturalmente organizzammo subito dei corsi e nei tre anni della nostra permanenza a Clairvaux insegnai ai miei compagni cosmografia, geometria e fisica, mentre li aiutavo a studiare le lingue. Quasi tutti impararono almeno una lingua, l’inglese, il tedesco, l’italiano o lo spagnolo, e alcuni ne impararono due. Trovammo anche il modo di lavorare a rilegare libri, dopo averne imparato l’arte su uno degli ottimi volumetti dell’Encyclopédie Roret.
Alla fine del primo anno, però, la mia salute non resistette. Clairvaux sorge in una regione paludosa, dove la malaria è endemica, e fui tormentato dalla malaria aggravata dallo scorbuto. Allora mia moglie, che studiava a Parigi nel laboratorio Würtz e si preparava alla laurea in scienze, abbandonò tutto e venne a stabilirsi nel paesetto di Clairvaux costituito da una dozzina di case raggruppate ai piedi dell’immenso muro che circonda la prigione. Naturalmente faceva una vita tutt’altro che allegra in quel paesino, faccia a faccia con il muro del carcere, ma vi rimase fino alla mia liberazione. Durante il primo anno le permettevano di vedermi solo una volta ogni due mesi, e i colloqui si svolgevano alla presenza di un secondino che sedeva fra di noi. Ma quando si fu stabilita a Clairvaux, dichiarando d’essere decisa a rimanervi, ottenne ben presto il permesso di vedermi tutti i giorni in una delle piccole costruzioni per i guardiani dentro il recinto del carcere, e i miei pasti venivano dalla trattoria dove alloggiava. Più tardi ci permisero anche di passeggiare nel giardino del direttore, sempre sorvegliati e accompagnati di solito da qualche altro detenuto.
Fu una meraviglia per me scoprire che la prigione centrale di Clairvaux aveva esattamente l’aspetto di una piccola città industriale, circondata da frutteti e da campi di grano, il tutto rinchiuso da un muro. In verità, se in una prigione centrale francese i detenuti sono forse più lasciati in balia dei capricci del capocarceriere e dei secondini di quanto lo possano essere nelle prigioni inglesi, il trattamento usato loro è molto più umano che nelle carceri d’oltre Manica. Lo spirito medioevale di vendetta che prevale ancora nelle prigioni inglesi è stato abbandonato da un pezzo in Francia.
Il prigioniero non è costretto a dormire sul tavolaccio, né ad avere il materasso solo ogni due giorni; il giorno del suo arrivo gli danno un letto decente e glielo lasciano. Così non è costretto a eseguire lavori degradanti come salire su per una ruota o fare stoppa; è occupato invece in lavori utili, ed è per questo che il carcere di Clairvaux ha l’aspetto di una cittadina industriale nella quale i mille e seicento reclusi fabbricano mobili di ferro, cornici, specchi, metri, velluti, tele, busti da signora, piccoli oggetti di madreperla, zoccoli, ecc.
Inoltre, se in caso di insubordinazione vi sono pene severissime, è vero però che non esiste l’uso del bastone, ancora in vigore nelle carceri inglesi: una pena simile sarebbe impossibile in Francia. Tutto sommato, il carcere di Clairvaux si può considerare uno dei migliori d’Europa. Eppure i risultati che vi si ottengono sono uguali a quelli delle peggiori case di pena vecchio stile. “Oggi è di prammatica dire che nelle nostre carceri i prigionieri si correggono”, mi disse una volta uno degli impiegati dell’amministrazione carceraria. “È assurdo, e non mi faranno mai dire una falsità simile”.
A Clairvaux la farmacia era situata proprio sotto le stanze che occupavamo noi e di tanto in tanto potevamo parlare con i prigionieri che vi lavoravano. Uno di questi era un uomo sulla cinquantina, dai capelli grigi, che stava per finire la sua pena durante la nostra detenzione. Era commovente sentirlo parlare della sua prossima partenza. Sapeva già che dopo pochi mesi o poche settimane sarebbe ritornato in prigione, e aveva pregato il dottore di tenergli il suo posto nella farmacia.
Non era la prima volta che veniva a Clairvaux e sapeva che non sarebbe stata l’ultima. Libero, non aveva nessuno che potesse accoglierlo nella sua vecchiaia. “Chi vorrà darmi del lavoro?”, diceva. “E che mestiere posso fare? Nessuno! Quando esco devo per forza ritornare dai miei compagni: da loro sono certo almeno di essere accolto come un vecchio amico”. Poi avrebbe bevuto con loro un bicchiere più del bisogno, avrebbero fatto discorsi concitati su la preparazione di qualche meraviglioso “colpo” in materia di furto, e un po’ per debolezza, un po’ per accontentare i suoi unici amici, vi avrebbe partecipato e si sarebbe trovato una volta ancora in galera. Così gli era successo diverse volte.
Passarono però due mesi dalla sua liberazione e non era ancora tornato a Clairvaux. Detenuti e secondini incominciarono a preoccuparsi. “Che abbia avuto il tempo di trasferirsi in un nuovo distretto giudiziario, che non è ancora tornato? Speriamo almeno che non sia coinvolto in qualche brutta faccenda”, dicevano, pensando a qualche cosa di più grave del furto. “Sarebbe un peccato: era un uomo tanto simpatico, tranquillo”. Ma presto si venne a sapere, che la prima ipotesi era quella giusta. Giunse notizia da un altro carcere che il vecchio era prigioniero là e che stava facendo le pratiche per essere trasferito a Clairvaux.
I vecchi erano quelli tra i prigionieri che ispiravano maggior compassione. Molti avevano fatto conoscenza del carcere ancora fanciulli o giovani; altri in età più avanzata. Ma una volta galeotto, sempre galeotto – è la massima insegnata dall’esperienza. E raggiunta o passata la sessantina, sapevano ormai di dover finire i loro giorni in prigione. Per affrettare la loro partenza da questo mondo, l’amministrazione carceraria li destinava alla fabbrica di pantofole di feltro, che si facevano con i rifiuti di lana di ogni genere. La polvere dell’officina non tardava a far ammalare di tisi questi vecchi conducendoli in breve alla liberazione. Allora quattro compagni di pena portavano il loro camerata alla fossa comune e il secondino e il suo cane erano gli unici a seguirlo; e mentre il cappellano camminava in testa al corteo recitando macchinalmente le sue preghiere e contemplando distratto i pini e i castagni lungo la via, e i quattro compagni che portavano la bara si godevano quella breve evasione dal carcere, il cane nero sembrava il solo compreso della solennità della funzione.
Quando in Francia si istituirono le prigioni centrali secondo l’ultima riforma, si credette di potervi mantenere il regime del silenzio assoluto. Ma questo è tanto contrario alla natura umana, che fu necessario rinunciare a un’applicazione rigorosa del regolamento. In realtà neppure l’isolamento impedisce che i reclusi comunichino fra di loro.
A un estraneo che l’osservi dall’esterno la prigione sembra muta, ma in realtà anche là dentro la vita si svolge attivamente come in una piccola città. Con voce soffocata, con sussurri, mezze parole, bigliettini, tutte le notizie interessanti si diffondono immediatamente in tutta la prigione. Non vi è avvenimento, sia tra i carcerati che nella Cour d’honneur, dove sono gli uffici dell’amministrazione, sia nel paesetto di Clairvaux, dove abitano i padroni delle officine, come nel gran mondo della politica parigina, che non sia subito conosciuto in tutti i dormitori, le officine e le celle. I Francesi sono troppo comunicativi, perché sia possibile frenare la loro telegrafia segreta. Noi non avevamo rapporti con i delinquenti comuni, eppure sapevamo tutte le ultime notizie. “Jean, il giardiniere, è tornato per due anni”. “La moglie del tale ispettore è venuta alle mani con la moglie del tal altro”. “Jacques è stato scoperto mentre dalla sua cella cercava di passare un bigliettino a Jean, nella fabbrica di cornici”. “Quel vecchio animale di X non è più ministro della giustizia; il governo è caduto”. E così via. E quando la notizia è che “Beppe ha avuto due pacchi di tabacco da cinque lire, in cambio di due maglie di lana”, la notizia fa in un momento il giro di tutto il carcere.
Ci si chiedeva continuamente del tabacco; e quando un povero avvocato detenuto nella prigione volle farmi avere una lettera, nella quale pregava mia moglie, che abitava a Clairvaux, di andare qualche volta a trovare sua moglie, che vi abitava pure, furono parecchi quelli che si interessarono vivamente alla cosa, mentre il biglietto dovette passare per non so quante mani prima di arrivare nelle mie. E quando in un giornale vi era una notizia particolarmente interessante per noi, quel giornale arrivava sempre per qualche via misteriosa, avviluppato intorno a un ciottolo, in modo che si potesse lanciarlo al di sopra di un muro anche alto.
La reclusione cellulare non impedisce le comunicazioni. Quando arrivammo a Clairvaux e ci misero nel reparto cellulare, nelle celle faceva un freddo terribile; tanto freddo che la mia mano tremava quando scrivevo a mia moglie, al punto che essa, che stava allora a Parigi, non riconobbe la mia calligrafia. Venne l’ordine di riscaldare le celle più che fosse possibile; ma avevano un bel da fare, le celle restavano sempre fredde; si seppe poi che i tubi dell’aria calda delle celle erano pieni di pezzetti di carta, bigliettini, temperini e piccoli oggetti di ogni genere, nascosti in quei tubi da generazioni intere di carcerati.
Martin, l’amico di cui parlavo, ottenne il permesso di scontare una parte della sua condanna in cella. Egli preferiva l’isolamento alla vita della camerata con dodici compagni, e fu trasferito in una cella nel reparto cellulare. Con sua grande sorpresa trovò che non era affatto isolato nella sua cella. I muri e i buchi delle serrature parlavano intorno a lui. Dopo pochi giorni tutti gli inquilini delle celle sapevano chi era, e aveva fatto conoscenze in tutto il reclusorio. Fra le celle, apparentemente isolate, si svolge tutta una vita, come un alveare; solo che quella vita assume sovente forme tali da appartenere esclusivamente al regno della psicopatia. Lo stesso [Richard von] Krafft-Ebing non ha avuto una idea delle forme che assume la vita in certi reclusi condannati all’isolamento.
Non starò qui a ripetere quello che ho già scritto nel mio volume Nelle prigioni russe e francesi, che ho pubblicato in Inghilterra nel 1886, poco dopo la mia liberazione da Clairvaux, sull’influenza morale reciproca dei carcerati. Ma una cosa devo dire. La popolazione di un carcere consiste di elementi eterogenei, ma anche limitandoci a quelli che si è soliti considerare “delinquenti” veri, e dei quali hanno tanto parlato ultimamente Lombroso e i suoi seguaci, quello che più mi colpiva a loro riguardo era che i reclusori, che sono considerati mezzi preventivi contro atti antisociali, sono proprio le istituzioni più adatte per generarli e per rendere questi atti sempre peggiori, dopo che il delinquente ha subito l’influenza dell’ambiente carcerario. Tutti sanno che l’ignoranza, il disgusto per un lavoro regolare imparato fin dall’infanzia, l’incapacità fisica a uno sforzo continuato, l’amore per l’avventura male indirizzato, la tendenza al gioco, la mancanza di energia, la volontà manchevole e l’indifferenza per la sorte degli altri, sono le cause che conducono questi uomini in tribunale.
Ora, durante la mia reclusione, rimasi impressionato dalla constatazione che sono appunto questi i difetti che la prigione genera nei suoi ospiti: ed è inevitabile che li generi per il fatto stesso di essere una prigione, e li genererà finché le prigioni esisteranno. La prigionia, necessariamente, fatalmente, distrugge nell’uomo l’energia e più che mai ne uccide la volontà. In un carcere non vi è modo di esercitare la volontà. Avere una volontà in prigione significa meritarsi dei castighi. La volontà del carcerato deve essere annientata, e così avviene infatti. E vi è ancor meno il modo di coltivare lo spirito di socievolezza, visto che si fa di tutto per impedire un libero raggrupparsi fra uomini che abbiano fra di loro qualche simpatia.
Tanto il fisico che il morale diventano sempre più incapaci di uno sforzo continuato; e se il condannato provava prima disgusto per il lavoro regolare, questo disgusto non fa che aumentare durante gli anni del carcere. E se prima si stancava presto di un lavoro monotono, che non sapeva eseguire con abilità, o provava antipatia per un lavoro mal retribuito, la sua antipatia diventa odio; se dubitava dell’utilità sociale della morale corrente, ora, dopo aver conosciuto i difensori ufficiali di queste leggi morali e dopo avere visto come le giudicano i suoi compagni, le rinnegherà per sempre; e se è stato qualche cosa di morboso, di passionale, di sensuale nella sua natura che lo ha fatto cadere, questa morbosità non farà che accrescersi, dopo un certo numero di anni in prigione, in molti casi fino al parossismo. Sotto quest’ultimo rapporto – il più pericoloso di tutti – l’educazione del carcere è disastrosa.
Avevo visto in Siberia quali fogne immonde, quali fonti di corruzione fisica e morale fossero le sporche e affollate carceri russe non “riformate”; e all’età di diciannove anni avevo creduto che se gli stanzoni fossero stati meno affollati, se si fossero suddivisi i prigionieri in diverse categorie e si fossero date loro delle occupazioni sane, adatte, sarebbe stato possibile ottenere un serio miglioramento. Ma dovetti ora abbandonare queste illusioni. Dovetti convincermi che per quello che riguarda l’effetto sui prigionieri e i risultati per l’intera società, le migliori prigioni “riformate” – cellulari o no – sono lo stesso, o peggio dei vecchi luridi reclusori. Non “riformano” il prigioniero. Al contrario, nella grande, nella schiacciante maggioranza dei casi hanno su di lui l’effetto più disastroso.
Il ladro, il truffatore, il bruto che hanno passato qualche anno di carcere, ne escono più disposti di prima a riprendere la vita di un tempo; si sentono più preparati, hanno imparato il modo di farlo meglio, sono più ostili alla società e si sentono più giustificati nella loro ribellione alle leggi e ai costumi; necessariamente, inevitabilmente sono costretti a proseguire sempre più avanti nella loro condotta antisociale, che li aveva portati la prima volta davanti al tribunale. Dopo la loro liberazione si renderanno colpevoli di colpe anche più gravi di quelle commesse prima, e sono condannati a finire la loro vita in un carcere o in una colonia penale. Nel volume di cui parlavo, ho scritto che le prigioni sono “università del delitto mantenute dallo Stato”, e ripensandoci ora, a quindici anni di distanza, non posso che confermare quella mia dichiarazione.
Personalmente non ho nessun motivo di lamentarmi degli anni passati in una prigione francese. Per un uomo attivo e indipendente la privazione della libertà e della possibilità di lavorare è di per sé tanto grave, che tutto il resto, tutte le piccole miserie della vita carceraria, non meritano attenzione.
Naturalmente quando sentivamo dell’attività politica che si svolgeva in Francia, ci doleva molto la nostra inerzia forzata. Il primo anno passò molto melanconicamente, l’inverno fu lungo e triste e con l’arrivo della primavera sentimmo ancor più la mancanza della libertà. Quando vedevo dalle nostre finestre i prati che si vestivano di verde e le colline velate dalle nebbie primaverili, o quando intravedevo un treno che fuggiva nella vallata fra i colli, provavo certo un gran desiderio di raggiungerlo, di respirare l’aria dei boschi, di sentirmi trascinato dalla corrente della vita, in una città affollata e attiva. Ma chi si schiera in un partito di avanguardia deve aspettarsi di dover passare qualche anno in carcere e non deve rammaricarsene; egli sente che anche durante la sua prigionia continua a essere una parte, non del tutto inattiva, della corrente del progresso umano che diffonde e rafforza le idee che gli sono care.
A Lione, i miei compagni, mia moglie ed io avevamo trovato i secondini molto villani, ma dopo un paio di scontri le cose erano migliorate. L’amministrazione carceraria sapeva che la stampa parigina era con noi e non desiderava attirare su di sé i fulmini di Rochefort o le critiche taglienti di Clemenceau, e a Clairvaux non era neppur necessario questo freno.
Tutto il personale era stato rinnovato pochi mesi prima del nostro arrivo. Un prigioniero era stato ammazzato nella sua cella dai secondini e il suo cadavere era stato impiccato per simulare un suicidio: ma questa volta la cosa era venuta a conoscenza del pubblico su denunzia del medico; il direttore era stato licenziato e ora nella prigione l’atmosfera era assolutamente migliore.
Conservo un ottimo ricordo del direttore di Clairvaux, e durante il mio soggiorno laggiù pensai più di una volta che gli uomini sono spesso migliori delle istituzioni di cui fanno parte. Ma appunto perché non ho da lamentarmi personalmente posso condannare tanto più liberamente e incondizionatamente l’istituzione stessa, come sopravvivenza di un passato di tenebre, fondamentalmente cattivo e causa di gravissimi mali alla società.
Devo ancora osservare un fatto, che mi fece forse più impressione degli stessi effetti demoralizzanti esercitati dal carcere sui carcerati. Che fonte di contagio è ogni prigione, e persino ogni tribunale, per la gente che vive nelle sue vicinanze! Lombroso ha molto parlato del “tipo di delinquente” che egli crede di aver scoperto fra gli abitanti delle carceri. Se avesse dedicato la stessa cura allo studio delle persone che frequentano i tribunali – poliziotti, spie, avvocatucci, delatori, gente che vive alle spalle degli ingenui e altri simili – è probabile che avrebbe finito col concludere che il “tipo del criminale” oltrepassa topograficamente di molto le mura della prigione. Non ho mai visto un’accolta di fisionomie del più basso tipo di umanità, caduto molto al di sotto della media degli uomini, come quelle che vidi a dozzine dentro e intorno al Palazzo di Giustizia di Lione. Non ne vidi certo di simili dentro il carcere di Clairvaux. Dickens e [George] Cruikshank hanno immortalato alcuni di questi tipi, ma essi rappresentano tutto un mondo che gravita intorno ai tribunali e diffonde in giro il suo contagio. E questo vale anche per ogni reclusorio centrale come quello di Clairvaux. Tutta un’atmosfera di piccoli furti, di piccole truffe, di spionaggio e di corruzione di ogni specie si allarga come una macchia d’olio attorno alle prigioni.
Tutto questo io l’ho potuto vedere; e se prima della mia condanna sapevo già come sia sbagliato l’attuale sistema penale, quando lasciai Clairvaux sapevo non solo che questo sistema penale è sbagliato e ingiusto, ma che la società dà prova di stupidità quando, nella sua ignoranza della realtà, in parte inconscia in parte voluta, mantiene a sue spese queste università del delitto, queste fonti di corruzione, con l’illusione che siano necessarie a frenare gli istinti criminali dell’uomo.
Ogni rivoluzionario incontra sulla sua strada un buon numero di spie e di agenti provocatori, e io ne ho avuto la mia parte. Tutti i governi spendono somme considerevoli a mantenere questi rifiuti della società. Essi però sono pericolosi soprattutto per i giovani, e chi ha esperienza della vita e degli uomini non tarda a scoprire che vi è in questi esseri qualche cosa che li tradisce. Vengono reclutati fra la feccia della società, fra gli uomini della più bassa morale e chi ha l’abitudine di osservare la natura degli uomini che incontra, non tarda a scoprire nei modi di queste “colonne della società” qualche cosa che lo urta; egli si chiede allora: “Come è arrivata qui questa persona? Che cosa può avere in comune con noi?”. In molti casi questa semplice domanda basta a mettere in guardia.
Quando arrivai a Ginevra l’agente del governo russo incaricato di sorvegliare i rifugiati era ben conosciuto da tutti noi. Passava sotto il nome di conte P..., ma non avendo né servitori né carrozze sulle quali sfoggiare la corona e lo stemma, l’aveva fatto ricamare su una specie di mantelletta che copriva il suo minuscolo cagnolino. Lo vedevamo ogni tanto nei caffè, ma senza parlargli; in realtà era un “innocente” che si limitava a comperare nelle edicole tutte le pubblicazioni dei rifugiati politici, probabilmente per commentarle secondo il gusto dei suoi superiori. Altri tipi cercarono di avvicinarci quando Ginevra andava sempre più popolandosi di rifugiati della nuova generazione; ma in un modo o nell’altro finimmo per identificarli anch’essi.
Quando uno straniero si presentava nella nostra cerchia, egli veniva interrogato con franchezza nichilista sul suo passato e sulle sue condizioni attuali, e non tardava a rivelarsi per quello che era. La franchezza nei rapporti reciproci è certo il modo migliore per stringere e mantenere relazioni normali fra gli uomini. Nel nostro caso essa era inestimabile. Un gran numero di persone assolutamente sconosciute in Russia – del tutto estranee ai nostri circoli – vennero a Ginevra e molte di loro, pochi giorni o anche poche ore dopo il loro arrivo, erano in rapporti più che amichevoli con la colonia dei fuorusciti; ma per una ragione o per l’altra le spie non riuscirono mai a varcare la soglia della familiarità. Una spia poteva citare delle conoscenze comuni, poteva essere in grado di fornire le migliori informazioni, talvolta esatte, sul suo passato in Russia; poteva conoscere perfettamente il gergo e i modi di un nichilista; ma non era possibile che facesse sua quella particolare etica nichilista che si era sviluppata fra la gioventù russa – e questo era sufficiente per tenerla lontana dalla nostra colonia. Le spie possono imitare tutto, ma non quell’etica.
Quando lavoravo con Réclus c’era a Clarens un individuo di questo genere dal quale ci tenevamo tutti lontani. Non sapevamo niente di male sul suo conto, ma sentivamo che non era uno dei nostri, e siccome egli cercava ogni mezzo per entrare nel nostro gruppo, incominciammo a sospettare di lui. Non gli avevo parlato mai e di conseguenza egli mi cercava in modo particolare. Quando vide che non poteva avvicinarmi con i soliti mezzi, incominciò a scrivermi, dandomi misteriosi appuntamenti per motivi egualmente misteriosi nei boschi o in luoghi simili. Una volta, per scherzo, volli accettare il suo invito e vi andai, seguito a distanza da un amico fidato; ma l’uomo, che probabilmente aveva un complice, si accorse che non ero solo e non si fece vedere. Mi fu così risparmiato il piacere di scambiare con lui una sola parola. In quel periodo poi lavoravo tanto intensamente, che ogni istante della mia giornata era dedicato o alla geografia o a “Le Révolté”, e non presi parte a nessun complotto.
Più tardi tuttavia venimmo a sapere che costui mandava regolarmente alla Terza Sezione rapporti dettagliati sulle conversazioni che avrebbe avuto con me, sulle confidenze che io gli avrei fatto e sui terribili complotti che avrei ordito a Pietroburgo contro la vita dello zar. Tutto questo passava a Pietroburgo, e anche in Italia, per moneta sonante. Quando una volta Cafiero fu arrestato in Svizzera, gli furono mostrati dei formidabili rapporti fatti da spie italiane, in cui mettevano in guardia il loro governo dicendo che Cafiero ed io, carichi di bombe, stavamo per passare in Italia. In realtà non ero mai stato in Italia e non avevo avuto alcuna intenzione di visitare quel paese.
Non sempre però le spie inventano di sana pianta i loro rapporti. Spesso riferiscono fatti realmente avvenuti, ma tutto sta nel modo in cui si stende il resoconto. Ridemmo di cuore di un rapporto indirizzato al governo francese da una spia che seguiva me e mia moglie durante il nostro viaggio da Parigi a Londra nel 1881. La spia, che faceva probabilmente il doppio gioco – cosa che avviene di frequente – aveva venduto quel rapporto a Rochefort, il quale lo pubblicò nel suo giornale. Tutto quello che racconta la spia in questo giornale è vero – ma come lo racconta!
Per esempio aveva scritto: “Presi posto nello scompartimento accanto a quello occupato dai coniugi Kropotkin”. Verissimo: era là. Lo osservammo perché aveva subito attirato la nostra attenzione con la sua faccia accigliata e antipatica. “Parlarono sempre in russo per non farsi capire dagli altri viaggiatori”. È vero; parlammo in russo come facciamo sempre fra di noi. “Giunti a Calais presero entrambi un bouillon”. Verissimo: prendemmo un bouillon. Ma ora incomincia la parte misteriosa del viaggio. “Dopo di ciò entrambi sparirono improvvisamente, li cercai invano sulla piattaforma e altrove; e quando riapparvero egli era travestito ed era seguito da un prete russo che non li abbandonò più finché giunsero a Londra, dove persi di vista il prete”. Anche tutto questo era vero. Mia moglie soffriva di un leggero mal di denti e avevo pregato il gestore del ristorante di farci passare nella sua cabina, dove poter curare il dente. Così eravamo veramente scomparsi; e siccome dovevamo attraversare la Manica avevo messo in tasca il mio cappello floscio di feltro e mi ero messo un berretto di pelo; così ero “travestito!”.
Quanto al misterioso prete, c’era anche lui. Non era russo, ma questo non importa; in ogni modo portava l’abito dei preti greci. Io lo vidi al bar chiedere qualche cosa che nessuno capiva: “Agua, agua”, chiedeva con voce dolente. “Date al signore un bicchier d’acqua”, dissi al cameriere. Allora il prete incominciò a ringraziarmi del mio intervento con effusione veramente orientale.
Mia moglie ne ebbe compassione, gli parlò in diverse lingue, ma egli capiva solo il greco moderno. Si scopri finalmente che sapeva qualche parola di una delle lingue slave meridionali e riuscimmo a capire: “Sono greco. Ambasciata turca. Londra”. Gli facemmo capire, soprattutto a gesti, che andavamo anche noi a Londra e che poteva viaggiare con noi.
Il più divertente della faccenda fu che potei fargli avere l’indirizzo dell’Ambasciata turca anche prima di arrivare a Charing Cross. Il treno si fermò a una stazione e due eleganti signore entrarono nel nostro scompartimento di terza classe, già pieno. Avevano tutte e due un giornale in mano. Una era inglese – e l’altra – una bella donna alta, che parlava bene il francese – fingeva di esserlo. Scambiata qualche parola, essa mi chiese a bruciapelo: “Che cosa ne pensate del conte Ignat’ev?”, e subito dopo: “Avete intenzione di uccidere presto il nuovo zar?”. Non avevo nessun dubbio sulla professione delle due donne, ma pensando al mio prete chiesi: “Sapete per caso l’indirizzo dell’Ambasciata turca?”. “Via tale, numero tale”, mi rispose una di loro, senza esitare, come una scolaretta che recita la lezione. “Forse potreste anche darmi l’indirizzo dell’Ambasciata russa?”, le chiesi; e dopo che mi fu detto con la stessa prontezza, li comunicai tutti e due al prete. Arrivati a Charing Cross, la signora era tanto ansiosa di occuparsi del mio bagaglio e persino di portare un pacco pesante con le sue manine guantate, che finalmente le dissi, con sua grande sorpresa: “Basta, le signore non portano il bagaglio degli uomini. Andatevene!”.
Ma per tornare alla mia spia francese: “Egli scese a Charing Cross”, aveva scritto nel suo rapporto, “ma non lasciò la stazione per più di mezz’ora dopo l’arrivo del treno, finché fu ben certo che tutti gli altri fossero partiti. Io mi misi in disparte, nascondendomi dietro una colonna. Quando fu certo che tutti i viaggiatori avevano abbandonato la piattaforma, egli e sua moglie saltarono improvvisamente in una carrozza. Io però li seguivo e sentii l’indirizzo che il vetturino dava alla guardia al cancello – dodici, tal dei tali – e corsi dietro la carrozza. Non vi erano altre carrozze vicino: andai perciò di corsa a Trafalgar Square dove ne presi una. Lo seguii e lo vidi scendere a quell’indirizzo”.
Tutti i particolari di questo rapporto sono veri una volta ancora, l’indirizzo e gli altri; ma come tutto sembra misterioso! Avevo avvisato un amico russo del mio arrivo, ma quella mattina c’era molta nebbia e il mio amico si svegliò in ritardo. L’aspettammo per una mezz’ora, poi, lasciato il bagaglio in deposito, ci facemmo condurre a casa sua.
“Rimasero là fino alle due del pomeriggio, con le tende chiuse, e allora un uomo alto uscì dalla casa e tornò dopo un’ora con il loro bagaglio”. Persino l’osservazione sulle tende era esatta: dovemmo accendere la luce a gas a causa della nebbia e chiudemmo le tende per liberarci del brutto spettacolo di una stradicciola di Islington avviluppata da una fitta nebbia.
Mentre lavoravo con Elisée Réclus a Clarens andavo ogni quindici giorni a Ginevra per sorvegliare la pubblicazione di “Le Révolté”. Un giorno, giunto in tipografia, mi dissero che un signore russo desiderava vedermi. Aveva già visto i miei amici e aveva detto loro di essere venuto per convincermi a fondare un giornale come “Le Révolté” in lingua russa. Egli offriva a questo scopo tutto il denaro necessario. Andai a trovarlo in un caffè, dove mi diede un nome tedesco – diciamo Tohnlehm – e mi disse che era nato nelle province baltiche. Si vantava proprietario di una grande fortuna in terre e fabbriche e mostrava di odiare il governo russo per le sue intenzioni di russificarle.
Tutto sommato mi lasciò dubbioso, ma i miei amici insistevano perché accettassi le sue offerte; però, ripeto, l’uomo non mi andava molto a genio.
Dal caffè mi condusse alle sue stanze in un albergo, e là incominciò a mostrarsi meno riservato e sotto un aspetto ancor meno attraente. “Non dubitate della mia fortuna”, mi disse, “io ho fatto una magnifica invenzione: vale molto denaro. Prenderò il brevetto, mi pagheranno bene e darò tutto alla causa della rivoluzione russa”. E con mia grande sorpresa mi mostrò un miserabile candeliere, che non aveva altro di particolare che la sua bruttezza, con tre pezzi di fil di ferro in cui si conficcava la candela.
La massaia più povera non avrebbe voluto saperne di un candeliere simile, e fosse anche stato possibile ottenerne il brevetto, nessun fabbro l’avrebbe pagato più di una cinquantina di lire. “Un riccone che ripone tutte le sue speranze in un candeliere simile! Quest’uomo, ricco non lo è mai stato”, mi dicevo, e la mia opinione su di lui era bell’e fatta. Egli non era ricco e il denaro che offriva non era suo. Gli dissi quindi con franchezza: “Va bene, se desiderate tanto avere un giornale rivoluzionario in lingua russa, e se davvero avete di me tutta la stima che dite, dovete mettere il vostro denaro in una banca a mio nome e completamente a mia disposizione. Ma vi prevengo che non avrete nulla a che fare con il giornale”. “Ma certo, si capisce”, rispose. “Me ne occuperò solo dandovi qualche consiglio e aiutandovi a farlo entrare in Russia di contrabbando”. “No, niente affatto. Non avrete nessuna occasione di vedermi”. I miei amici pensarono che fossi stato troppo duro con lui, ma un po’ di tempo dopo una lettera da Pietroburgo ci avvisava che avremmo avuto la visita di una spia della Terza Sezione, il cui nome era Tohnlehm! Il candeliere ci aveva reso un buon servizio.
Si tratti di candelieri o di altro, questa gente si tradisce quasi sempre. Quando eravamo a Londra nel 1881, due russi ci vennero a trovare una mattina nebbiosa. Uno di loro lo conoscevo di nome; l’altro, un giovane che egli presentava come suo amico, non lo conoscevo affatto. Si era offerto di accompagnare l’amico durante una breve visita in Inghilterra. Essendomi stato presentato da un conoscente, non avevo alcun sospetto; ma quel giorno ero molto occupato e pregai un altro amico, che abitava vicino a noi, di cercare delle stanze per loro e di condurli a vedere Londra. Mia moglie non aveva ancora visitato la città e li accompagnò. Tornò nel pomeriggio e mi disse: “Sai, quell’uomo non mi piace affatto; sta in guardia”. “Perché?”. “Niente, assolutamente niente, ma non è certo uno dei nostri. Il modo con cui ha trattato un cameriere in un caffè e il suo modo di maneggiare i soldi mi han detto subito che non è uno dei nostri; e se non lo è, perché viene da noi?”. Si mostrava tanto sicura nei suoi sospetti, che pur senza trascurare i suoi doveri di ospite trovò modo di non lasciare quel giovane solo nel mio studio neppure un istante. Chiacchierammo, e il nostro ospite incominciò a rivelarsi sotto una luce moralmente così odiosa, da far arrossire persino il suo amico; e quando chiesi altri particolari sul suo conto, le sue spiegazioni furono ancor meno soddisfacenti. Ci mettemmo subito in guardia. Dopo due giorni lasciarono Londra tutti e due e quindici giorni più tardi ricevetti una lettera dal mio amico russo piena di scuse per avermi presentato un individuo, di cui aveva poi saputo che era una spia a Parigi, al servizio dell’ambasciata russa. Guardai allora una lista degli agenti segreti russi in Francia e in Svizzera che il Comitato Esecutivo aveva mandato recentemente a noi fuorusciti – esso aveva i suoi uomini dappertutto a Pietroburgo – e vi trovai il nome di quell’uomo con una sola lettera diversa.
Fondare un giornale con il denaro del governo, con un agente di polizia come direttore, è un vecchio trucco, e Andrieux, il prefetto della polizia di Parigi, vi ricorse nel 1881. Mi trovavo in montagna con Elisée Réclus quando ricevemmo una lettera da un francese, anzi da un belga, il quale ci diceva di voler fondare un giornale anarchico a Parigi e chiedeva la nostra collaborazione. La lettera, piena di adulazioni, ci fece una cattiva impressione, a Réclus poi pareva di ricordare di averne sentito nominare l’autore in modo sfavorevole. Decidemmo di rifiutare la nostra partecipazione e io scrissi a Parigi, a un amico, che volevamo prima sapere da dove venisse il denaro che finanziava il giornale. “Potrebbe venire dagli orleanisti, un vecchio trucco di quella famiglia e dobbiamo saperne le origini”. Il mio amico parigino, con la franchezza di un operaio, lesse la lettera in una riunione alla quale era presente il futuro direttore del giornale. Egli se ne mostrò offeso e io dovetti rispondere a diverse lettere in proposito; ma restai fermo alla mia dichiarazione: se quell’uomo è sincero, dovrà far sapere di dove viene il denaro.
Finalmente si decise. Messo alle strette, disse che il denaro gli veniva da una sua zia, una ricca signora dalle idee antiquate, che aveva però ceduto al suo desiderio di avere un giornale e gli aveva dato il denaro. La signora non si trovava in Francia, abitava a Londra. Ciò nonostante insistemmo per averne il nome e l’indirizzo e il nostro amico Malatesta si offri di andarla a trovare, e vi andò con un suo amico italiano, commerciante in mobili usati. Trovarono la signora in un piccolo appartamento e mentre Malatesta le parlava e si convinceva sempre più che non faceva che recitare la parte della zia nella commedia, l’amico mobiliere guardava le sedie e le tavole, e si accorse che erano state tutte prese, probabilmente a nolo, da un rivenditore suo vicino. C’era ancora l’etichetta del negozio attaccata ai mobili. Questo non costituiva una prova, ma naturalmente aumentò i nostri sospetti. Io rifiutai assolutamente di far parte del giornale.
Questo fu di una violenza inaudita. L’incendio, l’assassinio, le bombe, non si parlava d’altro! Ne incontrai il direttore quando andai al Congresso di Londra, e appena vidi la sua faccia arcigna, sentii qualche brano di conversazione e vidi di sfuggita le donne che frequentava, non ebbi dubbi su di lui. Al Congresso, dove presentò ordini del giorno incendiari, i delegati se ne tennero lontani; e quando insistette per avere gli indirizzi degli anarchici in ogni parte del mondo, ebbe un rifiuto tutt’altro che cortese.
Per farla breve, due mesi dopo fu smascherato e il giornale smise del tutto le sue pubblicazioni il giorno seguente. Due anni più tardi Andrieux, il prefetto di polizia, pubblicò le sue memorie e nel suo libro fece tutta la storia del giornale che egli aveva fondato e delle esplosioni che i suoi agenti avevano organizzato a Parigi, mettendo scatole di sardine piene di “qualche cosa” sotto la statua di Thiers; si può immaginare quanto denaro costino tutte queste porcherie alla Francia e agli altri paesi!
Potrei scrivere capitoli interi su questo argomento, ma dirò solo di un altro incidente toccato a due avventurieri a Clairvaux. Mia moglie alloggiava nell’unico alberghetto del paese, cresciuto all’ombra delle mura del carcere. Un giorno l’ostessa entrò in camera sua con un’ambasciata di due signori che erano venuti all’albergo e desideravano vedere mia moglie. L’ostessa mise tutta la sua eloquenza in favore dei due. “Conosco bene il mondo”, diceva, “e le assicuro, signora, che sono due perfetti gentiluomini. Impossibile essere più comme il faut. Uno di loro ha dato il nome di un ufficiale tedesco. Si tratta certo di un barone o di un milord, e l’altro è il suo interprete. Vi conoscono benissimo. Il barone parte per l’Africa, forse per non tornarne più, e vorrebbe vedervi prima di partire”.
Mia moglie diede un’occhiata all’indirizzo sul biglietto: “A Madame la Principessa Kropotkin”, e non le fu necessaria altra prova del comme il faut dei due signori. Il biglietto era anche peggio dell’indirizzo. Quel che il “barone” vi scriveva a proposito di una comunicazione segreta che doveva farle era contro tutte le regole della grammatica e del buon senso. Mia moglie rifiutò recisamente di ricevere il barone e il suo interprete.
Allora il barone prese a scrivere lettere e lettere a mia moglie, che vennero respinte senza essere aperte. Ben presto tutto il paese si divise in due campi, uno in favore del barone, capitanato dall’ostessa, l’altro contro di lui, capitanato, devo dirlo, dal marito dell’ostessa. Fu messo in giro un vero romanzo: il barone aveva conosciuto mia moglie prima del suo matrimonio, aveva ballato con lei molte volte all’ambasciata russa a Vienna. Ne era ancora innamorato, ma lei rifiutava crudelmente di lasciarsi vedere da lui prima che partisse per il suo pericoloso viaggio. Poi ci fu la storia misteriosa di un bambino, che dicevano noi tenessimo nascosto.
“Dov’è il loro bambino?”. voleva sapere il barone. “Hanno un figlio che avrà ora sei anni: dov’è?”. “Lei non abbandonerebbe mai il bambino, se l’avesse”, sentenziava uno dei due partiti. “Sì, ne hanno uno, ma lo tengono nascosto”, replicava l’altro.
Per noi questa conversazione fu una rivelazione interessante. Ci diede la prova che le nostre lettere non erano lette solo dalle autorità carcerarie, ma che il loro contenuto veniva comunicato anche all’ambasciata russa. Mentre io ero a Lione, mia moglie andò a trovare Elisée Réclus in Svizzera, e mi scrisse una volta che “il nostro ragazzo” stava bene; godeva di un’ottima salute e per il suo quinto compleanno avevano passato tutti insieme una piacevolissima serata. Sapevo che alludeva al giornale “Le Révolté”, di cui spesso parlavamo come del “nostro gamin”, il nostro ragazzaccio. E ora, quando questi signori chiedevano del “nostro ragazzo” precisandone persino l’età, era chiaro che quella lettera era passata attraverso altre mani, oltre quelle del direttore. Era una buona cosa saperlo!
In un piccolo paese nulla sfugge all’attenzione degli abitanti e il barone non tardò a destare sospetti. Scrisse un’altra lettera a mia moglie, anche più eloquente delle precedenti. Chiedeva ora perdono per essersi presentato come una sua conoscenza. Confessava di essere per lei uno sconosciuto, ma diceva di essere un amico. Doveva farle una comunicazione importantissima: la mia vita era in pericolo ed egli desiderava metterla in guardia. Il barone fece con il suo segretario una passeggiata per i campi, per leggere con lui la lettera e discuterla – la guardia forestale li seguiva a distanza – ma litigarono e la lettera fu strappata e buttata via. La guardia forestale aveva aspettato che se ne andassero per raccogliere i pezzi, metterli insieme e leggere la lettera. Un’ora dopo tutto il paese sapeva che il barone non aveva mai conosciuto mia moglie; il romanzo sentimentale, messo in giro dai partigiani del barone, crollava.
“Ah, allora non sono quello che volevano far credere di essere”, si disse a sua volta il brigadier de gendarmerie, “allora saranno delle spie tedesche”. E li arrestò.
Bisogna dire per giustificarlo, che una spia tedesca era venuta davvero poco tempo prima a Clairvaux. In tempo di guerra il vasto edificio delle carceri potrebbe servire da magazzino o da caserma e lo Stato maggiore tedesco voleva riuscire a sapere la capacità della prigione. Un giovane fotografo ambulante venne quindi nel paese, fece amicizia con tutti facendo gratis le sue fotografie e gli fu permesso di fotografare non solo l’interno dei cortili delle carceri, ma anche i dormitori. Questo fotografo partì poi per un’altra città sulla frontiera orientale e qui fu arrestato dalle autorità francesi, perché in possesso di documenti militari compromettenti. Il brigadiere, ancora sotto l’impressione della visita del fotografo, concluse che il barone e il suo segretario fossero delle spie tedesche e li arrestò e li condusse nella piccola città di Bar-sur-Aube. Qui la mattina dopo furono liberati e il giornale del posto scrisse che non si trattava di spie tedesche, ma di “persone incaricate di una missione da un’altra e più amica potenza”.
Ormai l’opinione pubblica era tutta contraria al barone e al suo segretario, i quali ebbero ancora altre disavventure. Liberati, entrarono in un piccolo caffè del paese e qui diedero libero sfogo alla loro collera parlando in tedesco, attorno a una bottiglia di vino. “Siete uno stupido, siete un vigliacco”, disse il finto interprete al finto barone. “Se fossi stato in voi avrei fatto fuori quel giudice istruttore con questa pistola. Ci si provi con me, e gli pianterò queste pallottole nella testa!”, e così via.
Un viaggiatore di commercio, che sedeva tranquillamente in un angolo della stanza, corse dal brigadiere per riferirgli la conversazione che aveva sentito. Il brigadiere fece subito un rapporto ufficiale e arrestò una volta ancora il segretario, un farmacista di Strasburgo. Fu tradotto davanti al tribunale correzionale della stessa cittadina di Bar-sur-Aube e condannato a un mese di carcere per “minacce contro un magistrato pronunciate in luogo pubblico”. I due avventurieri dovettero finalmente lasciare Clairvaux.
Tutte queste avventure di spie finirono nel ridicolo. Ma quante tragedie – tragedie terribili – si devono a questi mascalzoni! Esistenze preziose perdute, famiglie intere rovinate solo per assicurare una vita comoda a questi truffatori. Quando si pensa alle migliaia di spie che girano il mondo al servizio di tutti i governi; alle reti che tendono a tanti ingenui, alle loro vittime, spesso destinate a una fine tragica, ai dolori che seminano intorno a loro, alle enormi somme di denaro sperperate per mantenere questo esercito reclutato fra i rifiuti della società; alla corruzione di ogni specie che essi seminano intorno, e persino in seno alle famiglie, non si può non inorridire dell’enormità di questo male. E questo esercito di mascalzoni non è formato solo di spie politiche e del sistema di spionaggio militare. In Inghilterra, soprattutto nelle città turistiche, esistono giornali che dedicano colonne intere alla pubblicità dei detective privati, che offrono informazioni per i divorzi, che si prestano a spiare i mariti per le mogli e le mogli per i mariti, a penetrare nelle famiglie e accalappiare gli stupidi, e che sono disposti a compiere qualsiasi missione si voglia affidare loro, pur che li si paghi. E mentre l’opinione pubblica si scandalizza degli abusi dello spionaggio, rivelati recentemente nelle alte sfere militari francesi, non vede come dappertutto, forse anche in casa sua, vengono commessi abusi simili o anche peggiori tanto dalle agenzie ufficiali di spionaggio che da quelle private.
La nostra liberazione era stata chiesta più volte a mezzo della stampa e alla Camera, tanto più che all’epoca della nostra condanna era stata condannata anche Louise Michel, per furto. Louise Michel, la quale dà sempre, alla lettera, l’ultimo suo scialle o cappotto alla donna che ne abbia bisogno, che non si lasciò mai persuadere a procurarsi del cibo migliore durante la prigionia, perché regalava quello che le procuravano alle sue compagne di pena, Louise Michel con un altro compagno, [Émile] Pouget, fu condannata a nove anni di reclusione per furto sulla pubblica via! Questo sembrava troppo enorme anche agli opportunisti borghesi.
Un giorno si era messa alla testa di un corteo di disoccupati, era entrata da un fornaio e, presi alcuni pani, li aveva distribuiti alla schiera degli affamati: quello era stato il suo furto! La liberazione degli anarchici diventò il grido di guerra contro il governo e nell’autunno del 1885 tutti i miei compagni, tranne tre, furono liberati con un decreto del presidente Grévy. Allora l’agitazione per Louise Michel e per me si fece più intensa. Ma Aleksandr III si opponeva alla mia scarcerazione e un giorno il primo ministro, il signor Freycinet, rispondendo a un’interpellanza alla Camera, disse che “certe difficoltà diplomatiche si opponevano alla liberazione di Kropotkin”. Strane parole nella bocca del primo ministro di una nazione indipendente; ma ne abbiamo sentite di ancor più strane, in seguito, dovute alla malaugurata alleanza della Francia con la Russia zarista!
Finalmente, alla metà di gennaio del 1886, Louise Michel, Pouget e noi quattro che ancora eravamo a Clairvaux, fummo liberati.
Andammo a Parigi dove per alcune settimane restammo dal nostro amico Elie Réclus, uno studioso di antropologia di grande valore, il quale spesso fuori dalla Francia viene scambiato con il suo fratello minore, Elisée, il geografo. Fin dalla prima giovinezza i due fratelli erano legati da una grande amicizia. Quando venne il momento per loro di iscriversi a un’università, andarono a piedi da un paesello della vallata della Gironda fino a Strasburgo, accompagnati, da veri studenti girovaghi, dal loro cane; e quando si fermavano in qualche villaggio, era il cane che aveva la sua scodella di minestra, mentre la cena dei due fratelli spesso era di solo pane con qualche mela. Da Strasburgo il fratello minore andò a Berlino, attiratovi dalle lezioni del grande Ritter. Più tardi, dopo il 1840, furono insieme a Parigi. Elie Réclus diventò un fourierista convinto e tutti e due salutarono nella repubblica del ’48 l’avvento di una nuova era sociale. Dopo il colpo di Stato di Napoleone III dovettero perciò lasciare la Francia ed emigrarono in Inghilterra. Votata l’amnistia, ritornarono a Parigi, dove Elie dirigeva un giornale fourierista, cooperativistico, molto letto dagli operai. È interessante ricordare un episodio generalmente poco conosciuto: Napoleone III – che recitava la parte di un Cesare interessato, come si conviene a un Cesare, alle condizioni dei lavoratori – mandava sempre uno dei suoi aiutanti di campo in tipografia quando usciva il giornale, per averne la prima copia alle Tuileries. Più tardi era addirittura disposto a fare il patrono dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori a condizione che questa nei suoi rapporti mettesse anche delle parole di fiducia nei grandi progetti socialisti del Cesare; e diede poi ordine di perseguitarla quando gli Internazionalisti rifiutarono recisamente di farlo.
Proclamata la Comune, i due fratelli vi aderirono con entusiasmo ed Elie accettò l’incarico di conservatore della Biblioteca Nazionale e del Museo del Louvre, sotto Vaillant. Si deve in gran parte alla sua previdenza e alla sua attività se i tesori inestimabili di scienza e d’arte accumulati in questi due istituti sono stati conservati, e non sono invece andati distrutti durante il bombardamento di Parigi da parte degli eserciti di Thiers e l’incendio che ne divampò. Appassionato ammiratore dell’arte greca, della quale era un profondo conoscitore, fece imballare e immagazzinare nelle cantine le statue e i vasi più preziosi del Louvre, e prese le più grandi precauzioni per proteggere la Biblioteca Nazionale dall’incendio che infuriava tutto attorno. Sua moglie, la degna e coraggiosa compagna del filosofo, seguita dai suoi figlioletti, organizzava nelle strade del suo quartiere la distribuzione dei viveri alla popolazione, ridotta alla fame dal secondo assedio. Durante le sue ultime settimane di vita la Comune comprese finalmente che il suo primo dovere avrebbe dovuto essere quello di provvedere al vitto della popolazione, privata dei mezzi di guadagnarselo; e i volontari organizzarono la distribuzione.
Fu un puro caso se Elie Réclus, che rimase fedelmente al suo posto fino all’ultimo momento, non venne fucilato dalle truppe di Versailles; fu condannato alla deportazione per aver osato accettare un incarico tanto necessario sotto la Comune, e andò in esilio con la sua famiglia. Tornato a Parigi, riprese i suoi studi prediletti di etnografia. Si può giudicare dell’importanza dei suoi lavori dai pochi ed eccellenti capitoli pubblicati in un volume sotto il titolo Popoli primitivi e Gli Australiani, così come dalla Storia delle religioni, una serie di conferenze tenute alla École de Hautes Études di Bruxelles, un’istituzione fondata da suo fratello.
In tutta la letteratura etnologica sono pochi i libri che testimoniano una così profonda e acuta comprensione della vera natura dell’uomo primitivo. Quanto alla sua Origine delle religioni, apparsa prima nella rivista “Société Nouvelle”, e ora nella continuazione, “Humanité Nouvelle”, io la considero l’opera migliore che sia stata pubblicata sull’argomento, superiore senza dubbio agli studi di Herbert Spencer sullo stesso soggetto, perché a Spencer, nonostante il suo grande ingegno, manca la comprensione della natura semplice dell’uomo primitivo, che Elie Réclus possiede invece a un raro grado di perfezione, e alla quale aggiunge una larghissima conoscenza di un particolare ramo di psicologia popolare, l’evoluzione e la trasformazione delle religioni. Non dirò dell’infinita bontà e modestia di Elie Réclus, della sua rara intelligenza, della sua vasta conoscenza di tutti i problemi riguardanti l’umanità: tutto questo è nel suo stile. La sua illimitata modestia, la sua serenità, la sua profonda intuizione filosofica lo avvicinano ai filosofi greci dell’antichità. In una società che ricercasse meno l’istruzione brevettata e frammentaria e fosse più sensibile al diffondersi di idee largamente umanitarie, egli sarebbe circondato da discepoli come lo furono i suoi prototipi greci.
Il movimento socialista e anarchico aveva a Parigi una vita attivissima nel periodo della nostra permanenza. Tutte le sere Louise Michel teneva conferenze e sollevava l’entusiasmo del pubblico, sia operaio che borghese. La sua già grande popolarità aumentava sempre e arrivava persino a conquistare gli studenti universitari, che potevano odiare le sue idee troppo avanzate, ma adoravano in lei la donna ideale: tanto che un giorno scoppiò un tafferuglio in un caffè, perché qualcuno parlò di lei con tono sprezzante alla presenza di alcuni studenti. I giovani presero le sue difese e fecero un tremendo baccano, rompendo tutti i tavoli e gli specchi del caffè. Tenni anch’io una conferenza sull’anarchia davanti a un pubblico di parecchie migliaia di persone e partii subito dopo da Parigi, prima che il governo potesse obbedire agli ordini della stampa filo-russa reazionaria, che insisteva per la mia espulsione dalla Francia.
Da Parigi andammo a Londra, dove mi aspettavano i miei due vecchi amici Stepnjak e čajkovskij. Il movimento socialista era in pieno sviluppo e la vita a Londra non era più così noiosa e vegetativa come quattro anni prima.
Andammo ad abitare in una casetta a Harrow. Non ci preoccupavamo molto della mobilia, che costruii in parte io stesso con l’aiuto di čajkovskij – nel frattempo egli era stato negli Stati Uniti, dove aveva imparato a lavorare da falegname – ma ci rallegrammo molto del possesso di un piccolo giardino dal denso terreno argilloso tipico del Middlesex. Mia moglie ed io ci dedicammo con molto entusiasmo al giardinaggio, di cui incominciavo a capire i meravigliosi risultati dopo aver letto i libri di [Jean] Toubeau e di certi maraîcher parigini, e dopo i nostri esperimenti di Clairvaux. Mia moglie appena arrivata a Harrow si era ammalata di tifo, ma guarì e l’aria aperta e le cure al suo giardino l’aiutarono a ristabilirsi completamente, meglio di un soggiorno nel migliore sanatorio.
Sulla fine dell’estate fummo colpiti da una grave disgrazia: ricevemmo la notizia che mio fratello Aleksandr aveva cessato di vivere.
Durante gli anni che avevo trascorso all’estero, prima del mio arresto in Francia, avevamo dovuto sospendere la nostra corrispondenza. Per il governo russo l’amore per un fratello perseguitato per le sue opinioni politiche costituisce una colpa. Mantenere relazioni con lui dopo che si è rifugiato all’estero, è un delitto. Un suddito dello zar deve odiare tutti quelli che si ribellano alla sua suprema autorità, e Aleksandr era fra gli artigli della polizia russa. Come conseguenza, io mi rifiutavo di scrivere a lui o agli altri nostri parenti. Dopo che lo zar ebbe scritto in fondo alla petizione presentata da nostra sorella Elena, “lasciatelo rimanere laggiù”, non vi era alcuna speranza di una liberazione vicina per lui. Due anni dopo fu nominato un comitato con l’incarico di fissare le condizioni degli esiliati in Siberia per un tempo indefinito, e a mio fratello furono comminati cinque anni, sette con i due che aveva già scontato. Poi fu nominato un nuovo comitato sotto Loris Melikov, il quale aggiunse altri cinque anni. Mio fratello avrebbe quindi dovuto essere liberato nell’ottobre del 1886. Erano così dodici anni di esilio, prima in un piccolo paese della Siberia orientale, poi a Tomsk, cioè nelle pianure della Siberia occidentale, dove non godeva neppure del clima secco e sano degli altipiani dell’estremo Oriente.
Quando fui incarcerato a Clairvaux egli mi scrisse, e ci scambiammo alcune lettere. Mi diceva che poiché la nostra corrispondenza sarebbe stata letta dalla polizia russa in Siberia e dalle autorità carcerarie in Francia, tanto valeva che ci scrivessimo con questa duplice supervisione. Mi parlava della sua vita domestica, dei suoi tre figli, che descriveva mirabilmente bene, e del suo lavoro. Mi consigliava seriamente di studiare con attenzione i progressi scientifici fatti in Italia, dove si fanno ricerche eccellenti ed originali, i cui risultati però venivano resi noti al pubblico solo attraverso le pubblicazioni tedesche, e mi esponeva le sue idee sulla vita politica in Russia. Egli pensava che non fosse possibile da noi, nel prossimo avvenire, un regime costituzionale sul tipo del regime parlamentare dell’Europa occidentale; ma sperava – e pensava che per il momento potesse bastare – di veder convocata una specie di Assemblea nazionale deliberativa (Zemskij Sobor, o États Généraux). Non avrebbe votato le leggi, ma avrebbe preparato i progetti di legge ai quali l’imperatore e il Consiglio di Stato avrebbero dato forma e sanzione definitive.
Mi parlava soprattutto del suo lavoro scientifico. Si era sempre interessato molto di astronomia e a Pietroburgo aveva pubblicato un ottimo riassunto di tutte le nostre conoscenze sulle meteore. Il suo acuto senso critico gli permetteva di afferrare subito il lato debole o il punto di forza delle varie ipotesi, e, pur non possedendo un’adeguata cultura matematica, dotato però di una potente immaginazione, riusciva ad afferrare i risultati delle più complicate ricerche matematiche. Vivendo con la fantasia in mezzo al moto dei corpi celesti, realizzava i loro movimenti complessi anche meglio di certi studiosi – soprattutto gli algebristi teorici – perché spesso essi dimenticano la realtà del mondo fisico per vedere solo le formule e i loro rapporti logici. I nostri astronomi di Pietroburgo mi parlavano con grande entusiasmo di questo lavoro di mio fratello. Ora aveva incominciato lo studio della struttura dell’universo; analizzava i fatti accertati e le ipotesi riguardanti i mondi solari, i gruppi di stelle e le nebulose nello spazio infinito e cercava di sciogliere l’enigma del loro probabile raggrupparsi, della loro vita, e le leggi della loro evoluzione e della loro decadenza.
L’astronomo [Johan] Gylden di Pulkovo ebbe parole di alto elogio per questo nuovo lavoro di Aleksandr e lo presentò per corrispondenza al signor [Edward] Holden negli Stati Uniti, dal quale ebbi recentemente la soddisfazione, a Washington, di sentire un giudizio favorevole su queste ricerche di mio fratello. La scienza ha un grande bisogno di tanto in tanto di speculazioni scientifiche di questo tipo, di un ordine superiore, fatte da uno spirito scrupoloso nel proprio lavoro, critico e al tempo stesso capace di fantasia.
Ma in una piccola città della Siberia, lontano dalle biblioteche, nell’impossibilità di tenersi al corrente dei progressi delle scienze, egli non aveva potuto incorporare nei suoi lavori altro che le ricerche fatte fino all’epoca del suo esilio. Sapeva che in seguito erano stati fatti studi importantissimi, ma come avrebbe potuto avere i libri necessari rimanendo in Siberia? L’avvicinarsi dell’epoca fissata per la sua liberazione non gli portava nessun sollievo. Sapeva che non gli avrebbero permesso di abitare in una delle città universitarie della Russia o dell’Europa occidentale, ma che il suo esilio in Siberia sarebbe stato seguito da un secondo esilio, forse peggiore del primo, in qualche paese della Russia orientale.
La disperazione si impossessò di lui. “Una disperazione simile a quella di Faust mi assale talvolta”, mi scriveva. Quando si avvicinò il momento della sua liberazione mandò la moglie e i figli in Russia, approfittando di uno degli ultimi battelli prima che si chiudesse la stagione della navigazione, e una triste notte la “disperazione di Faust” lo prese e mise fine alla sua vita...
Una nube di cupa tristezza scese allora sulla nostra casetta per molti mesi, finché un raggio di sole venne ad attraversarla. E fu in primavera, quando una creaturina che porta il nome di mio fratello venne alla luce, e ai suoi primi deboli vagiti sentii vibrare nel mio cuore corde del tutto nuove.
Nel 1886 il movimento socialista in Inghilterra era in pieno sviluppo. Schiere numerose di operai si erano messe apertamente dalla sua parte in tutte le città principali, e fra la borghesia molti, soprattutto i giovani, appoggiavano il movimento in vari modi.
Infieriva quell’anno un’acuta crisi industriale in quasi tutti i campi e la mattina, e spesso durante il giorno, sentivo gruppi di operai che giravano per le strade cantando la canzone dei disoccupati We’ve got no work to do o qualche altro inno, o mendicavano del pane. La gente si affollava la sera a Trafalgar Square per dormire all’aperto, esposta al vento e alla pioggia, fra due giornali; e un giorno di febbraio la folla, dopo aver ascoltato i discorsi di Burns, Hyndman e Champion, si rovesciò giù per Piccadilly e ruppe le vetrine di alcuni grandi negozi. Molto più importante però di queste esplosioni di malcontento era lo spirito che animava la parte più povera della popolazione operaia nei sobborghi di Londra; era tale, che se i capi del movimento fossero stati condannati gravemente per le rivolte, sarebbe nato in Inghilterra uno spirito di odio e di vendetta, sconosciuto fino allora nella storia recente del movimento operaio, ma i cui sintomi erano evidenti nel 1886, e esso avrebbe dato il suo carattere per molto tempo al movimento stesso. Ma la borghesia parve rendersi conto del pericolo. Furono immediatamente sottoscritte forti somme di denaro nel West End per sollevare la miseria dei poveri dell’East End e le condanne inflitte ai capi del movimento si limitarono a due o tre mesi di prigione.
Tutte le classi sociali prendevano un grande interesse al socialismo e a tutti i progetti di riforme e di ricostruzione sociale. Al principio dell’autunno e per tutto l’inverno fui invitato a tenere conferenze in luoghi diversi, alcune sul sistema carcerario, ma soprattutto sul socialismo anarchico, e visitai così quasi tutte le città più importanti dell’Inghilterra e della Scozia. Siccome accettavo il primo invito che mi si facesse per passare la notte, avveniva che fossi ospitato ora nel palazzo del ricco, ora nell’angusta casa di un operaio.
Ogni sera vedevo un numero considerevole di persone di ogni classe; e sia nella cameretta dell’operaio che nelle sale del ricco si facevano le discussioni più animate sul socialismo e sull’anarchia fino a notte avanzata, con speranza in casa dell’operaio, con timore nel palazzo, ma sempre con la stessa serietà.
Fra i ricchi la questione era di sapere: che cosa vogliono i socialisti? Che cosa intendono fare? E poi: quali sono le concessioni assolutamente necessarie a un dato momento per evitare seri conflitti? Durante queste conversazioni avveniva di rado di sentire negare semplicemente la giustizia delle pretese dei socialisti e avveniva di rado che esse fossero respinte come ridicole. Ma al tempo stesso trovavo ovunque la convinzione profonda che una rivoluzione in Inghilterra fosse impossibile, che le pretese delle masse operaie non fossero ancora né così precise né così vaste come quelle dei socialisti, e che i lavoratori si sarebbero accontentati di molto meno; così che le concessioni di minore conto, come la prospettiva di un lento aumento del benessere o di un ridotto orario di lavoro, sarebbero state accolte dalla classe operaia inglese come un pegno di miglioramenti futuri. “Noi siamo un paese di centro-sinistra, viviamo di compromessi”, mi disse una volta un vecchio parlamentare, che conosceva bene il suo paese.
Anche nelle case operaie notavo una differenza fra le domande che mi venivano rivolte in Inghilterra e quelle che mi facevano sul Continente. I princìpi generali, le cui applicazioni parziali saranno determinate dai princìpi stessi, interessano profondamente l’operaio latino. Se un Consiglio municipale vota i fondi per sostenere uno sciopero, o per dare una refezione nelle scuole, nessuno vi annette una grande importanza. Questi provvedimenti vengono accettati come naturali.
“Si capisce che un bambino che ha fame non può imparare”, dice l’operaio francese; “bisogna dargli da mangiare”. “Certo il padrone ha fatto male a mettere gli operai nella necessità di scioperare”. Ecco tutto. E queste concessioni strappate alla società attuale individualista dai princìpi del comunismo, non destano molto interesse. Il pensiero dell’operaio vola al di là di questo periodo e di queste concessioni ed egli si chiede se la Comune, o le unioni operaie, o lo Stato debbano prendere nelle loro mani l’organizzazione della produzione; se il libero accordo sia sufficiente a mantenere l’ordine e quali freni morali vi sarebbero se la società rinunciasse ai mezzi attuali di repressione; se un governo democratico elettivo possa attuare serie riforme in senso socialista o se il fatto compiuto non dovrebbe precedere la legislazione. E così via.
In Inghilterra si dava invece la massima importanza al fatto che si strappassero di continuo concessioni sempre maggiori. Ma d’altra parte il fatto che lo Stato non possa assumersi l’amministrazione delle industrie sembrava un’idea già acquisita per l’operaio, il quale si interessava soprattutto ai problemi di realizzazioni costruttive e ai mezzi che renderebbero possibili tali realizzazioni. “Bene, Kropotkin, supponete che domani ci impossessiamo dei docks della nostra città, come pensate che si dovrebbe amministrarli?”, mi si chiedeva appena mi ero seduto nella stanza di un operaio; oppure: “L’idea dell’esercizio di Stato delle ferrovie non ci piace, e l’attuale amministrazione delle società private è un furto organizzato. Ma se gli operai, per esempio, possedessero tutte le ferrovie, come potrebbero amministrarle?”. La mancanza di idee generali trovava il suo compenso nel desiderio di approfondire i particolari concreti.
Un’altra caratteristica del movimento socialista in Inghilterra era il numero dei borghesi che lo appoggiava in vari modi, sia schierandosi apertamente in suo favore, sia aiutandolo dal di fuori. In Francia e in Svizzera i due partiti – l’operaio e il borghese – non solo erano decisamente l’uno contro l’altro, ma erano nettamente separati, almeno nel periodo fra il 1875 e il 1885. Sono stato quasi quattro anni in Svizzera e posso dire di avervi conosciuto solo operai; solo, forse, un paio di borghesi. Questo non sarebbe stato possibile in Inghilterra. Trovammo un gran numero di uomini e di donne della borghesia che non esitavano a venire apertamente con noi a Londra e in provincia, aiutandoci a organizzare le riunioni o facendo la questua nelle piazze durante gli scioperi. Si verificava poi un movimento che ricordava un poco quello che si era avuto in Russia dopo il 1870, quando la nostra gioventù si era gettata “verso il popolo”, non così intenso tuttavia, né tanto disinteressato, né tanto completamente libero da ogni idea di “filantropia” quanto lo era stato in Russia. Anche in Inghilterra molti della borghesia andavano a vivere in mezzo alla parte più povera della popolazione, negli slum, nei casamenti popolari, a Toynbee Hall e così via.
C’era senza dubbio molto entusiasmo in quel momento. Forse molti pensavano che la rivoluzione sociale fosse già incominciata, come il protagonista della commedia di [William] Morris Tables turned, che dice che la rivoluzione non solo sta arrivando, ma che è già incominciata. Quando però si accorsero che in Inghilterra, come altrove, c’era un lavoro noioso, lungo e faticoso da fare, come succede sempre agli esaltati, moltissimi si ritirarono dalla propaganda attiva e ora assistono inoperosi come semplici simpatizzanti e spettatori.
Presi parte attivamente a questo movimento e con pochi altri compagni inglesi fondai, in aggiunta ai tre giornali specialisti già esistenti, un giornale mensile comunista-anarchico, “Freedom”, che esiste tuttora. Ripresi al tempo stesso il mio lavoro sull’Anarchia, interrotto al momento del mio arresto. La parte critica era stata pubblicata durante la mia prigionia a Clairvaux a cura di Elisée Réclus, sotto il titolo Parole di un ribelle. Mi misi ora a elaborare la parte costruttiva di una società anarchico-comunista – per quanto sia possibile immaginarla oggi – in una serie di articoli pubblicati a Parigi su “La Révolte”. Il nostro “ragazzo”, “Le Révolté”, dopo un processo intentatogli per la sua propaganda antimilitarista, fu infatti costretto a cambiar titolo, e anche sesso, avendo assunto un nome femminile. Più tardi questi articoli, accuratamente riveduti, furono pubblicati in un volume dal titolo La conquista del pane.
Queste ricerche mi portarono a studiare più a fondo certi lati della vita economica dei nostri paesi civili. Molti socialisti avevano detto finora che nella società attuale si produce molto più di quanto sarebbe necessario ad assicurare il benessere di tutti. Solo la distribuzione dev’essere corretta; e se avvenisse la rivoluzione sarebbe semplicemente necessario che ognuno lavorasse alla propria officina, lasciando che lo Stato si assicurasse il “plusvalore” o gli utili che vanno oggi al capitalista. Io pensavo invece che nelle condizioni attuali della proprietà privata l’economia stessa fosse male organizzata e che trascurasse, quando non ostacolasse, la produzione di quanto era necessario ai bisogni più vitali. In realtà non c’è alcun prodotto che venga lanciato sui mercati internazionali in sovrabbondanza; e la sovrapproduzione di cui tanto si parla non consiste in altro che nella impossibilità in cui si trovano le masse di comperare anche quello che si considera indispensabile a un’esistenza decente. Ma in tutti i paesi civili la produzione, tanto agricola che industriale, dovrebbe e facilmente potrebbe venire aumentata in modo da assicurare l’abbondanza per tutti. Questo mi portò a studiare le risorse dell’agricoltura moderna, così come la possibilità di un’educazione che permettesse a tutti di darsi contemporaneamente a un lavoro manuale e intellettuale. Sviluppai queste idee in una serie di articoli sulla rivista inglese “Nineteenth Century”, pubblicati ora in un volume sotto il titolo: Campi, fabbriche e officine.
Anche un altro grande problema mi preoccupava. Tutti sanno a quali conclusioni la formula di Darwin, “la lotta per l’esistenza”, ha portato molti dei suoi discepoli, e anche dei più intelligenti, come [Thomas] Huxley. Non esiste infamia nella società civile o nei rapporti fra i bianchi e le cosiddette razze inferiori, o fra i “forti” e i “deboli”, che non trovi in questa formula la sua scusa.
Già durante il mio soggiorno a Clairvaux avevo visto la necessità di rivedere attentamente la formula stessa di “lotta per l’esistenza” nel mondo animale e nelle sue applicazioni alle relazioni umane. Non ero soddisfatto degli sforzi fatti in questo senso da alcuni socialisti, quando trovai in una conferenza dello zoologo russo, il professor [Karl] Kessler, un’esatta espressione della legge della lotta per l’esistenza: “il mutuo appoggio”. In questa conferenza egli diceva che “è tanto una legge di natura il mutuo appoggio quanto la lotta per l’esistenza; ma il primo è molto più essenziale nell’evoluzione progressiva della specie, che non la seconda”. Queste poche parole, confermate disgraziatamente da due soli esempi (ai quali Severtsov, lo zoologo del quale parlavo in un capitolo precedente, ne aggiungeva ancora uno o due) contenevano per me la soluzione del problema. Quando nel 1888 Huxley pubblicò il suo terribile articolo La lotta per l’esistenza: un programma, mi decisi a stendere in una forma definitiva le mie obiezioni al suo concetto di “lotta per la vita”, tanto fra gli animali che fra gli uomini, servendomi del materiale accumulato durante un paio d’anni. Ne parlai ai miei amici, ma trovai che l’interpretazione della “lotta per la vita” come il grido di guerra “guai ai deboli!”, innalzato al grado di un comandamento della natura rivelato dalla scienza, era talmente radicata in Inghilterra, da essere quasi una questione di fede. Solo due persone mi sostenevano nella mia ribellione a questa falsa interpretazione dei fatti naturali. Il direttore del “Nineteenth Century”, James Knowles, con la sua mirabile perspicacia afferrò subito la questione e con energia veramente giovanile mi incoraggiò a sviluppare le mie idee. L’altra era H. W. Bates, del quale Darwin scrisse nella propria autobiografia come di uno degli uomini più intelligenti che avesse mai incontrato. Era segretario della Società Geografica e io lo conoscevo. Quando gli parlai della mia intenzione se ne mostrò entusiasta: “Certamente ne dovete scrivere”, mi diceva, “questo è il vero darwinismo. È una vergogna pensare quello che questa gente ha fatto delle idee di Darwin. Scrivetelo, e quando l’avrete pubblicato io scriverò una lettera per appoggiarvi e voi potrete pubblicarla”. Non avrei potuto trovare un incoraggiamento migliore e mi accinsi al lavoro, che fu via via pubblicato sulla “Nineteenth Century” con i titoli di: “Mutuo appoggio fra gli animali, fra i selvaggi, fra i barbari, nella città medievale e fra noi”. Disgraziatamente trascurai di far vedere a Bates i due primi articoli, che trattavano degli animali e che furono pubblicati mentre ancora viveva; speravo di terminare presto la seconda parte del lavoro: “Il mutuo appoggio fra gli uomini”, ma mi ci vollero molti anni per condurla a termine e nel frattempo Bates morì.
Le ricerche richieste da questi studi per informarmi sulle istituzioni dell’epoca barbarica e su quelle dei liberi comuni medioevali mi condussero a fare un’altra ricerca importante sulla parte rappresentata nella storia dallo Stato con la sua recente affermazione in Europa negli ultimi tre secoli. D’altra parte lo studio delle istituzioni di mutuo appoggio nei diversi stadi della civiltà mi condusse a esaminare il senso della giustizia e della moralità nell’uomo alla luce delle teorie sull’evoluzione.
Durante gli ultimi dieci anni lo sviluppo del socialismo in Inghilterra ha preso un altro indirizzo; quelli che giudicano solo dal numero delle riunioni di socialisti e di anarchici tenute nel paese e dalla frequenza del pubblico in queste riunioni, sono portati a credere che la propaganda socialista sia ormai in declino. E quelli che giudicano il suo progresso dal numero dei voti dati a quelli che pretendono rappresentare il socialismo nel Parlamento, arrivano alla conclusione che la propaganda socialista in Inghilterra sia poco o nulla. Ma l’influenza e la penetrazione delle teorie socialiste non può mai essere giudicata dai voti che si danno a quelli che mettono più o meno il socialismo nei loro programmi elettorali, e in Inghilterra meno che mai. Sta di fatto che delle tre tendenze rappresentate da Fourier, Saint-Simon e Robert Owen, l’ultima è quella dominante in Inghilterra e nella Scozia.
Non è perciò tanto dal numero delle riunioni o dei voti socialisti che si può giudicare dell’intensità del movimento quanto dalla penetrazione di una concezione socialista nel movimento cooperativo, sindacale, municipalistico, così come dall’influenza delle teorie socialiste in tutto il paese. Sotto questo aspetto il socialismo ha fatto una strada lunga e buona dal 1886 a oggi e non temo di affermare che il progresso è enorme in confronto a quello degli anni 1876-1882. Posso aggiungere che il costante sforzo dei piccoli gruppi anarchici ha contribuito, in una misura che ci fa pensare di non avere perso il nostro tempo, a diffondere le idee dell’abolizione di ogni governo, dei diritti dell’individuo, dell’azione locale e del “libero accordo”, opposte a quelle dell’onnipotenza dello Stato, della centralizzazione e della disciplina, che prevalevano vent’anni fa.
Tutta l’Europa attraversa ora una fase grave, assistiamo allo sviluppo dello spirito militarista. È l’inevitabile conseguenza della vittoria ottenuta dall’impero tedesco militarista, con il suo sistema di coscrizione obbligatoria, sulla Francia nel ’71; e fin da allora era stata prevista e preannunciata da molti, e in forma particolarmente impressionante da Bakunin. Ma la corrente contraria incomincia già a farsi sentire nella vita moderna.
Quanto alle idee del comunismo, spogliate della loro forma monastica, hanno fatto enormi progressi in Europa e in America durante i ventisette anni della mia attività nel movimento socialista nei quali ho potuto osservarne lo sviluppo. Quando penso alle idee vaghe, confuse e timide espresse dagli operai nei primi Congressi dell’Internazionale, o alle idee che avevano credito a Parigi durante l’insurrezione della Comune anche fra le persone più intelligenti, e quando le confronto con quelle sostenute oggi da un enorme numero di lavoratori, devo riconoscere che mi sembrano due mondi del tutto diversi.
Non c’è un’altra epoca nella storia – fatta forse eccezione per quella delle insurrezioni del Duecento, del Trecento, che dettero vita ai Comuni medioevali – nella quale si sia verificato un così profondo cambiamento nella concezione della società. E oggi, nel cinquantasettesimo anno di età, sono più profondamente persuaso di venticinque anni or sono che una combinazione fortunata di circostanze potrebbe provocare in Europa una rivoluzione molto più importante e altrettanto vasta di quella del 1848: non nel senso di semplici lotte fra i partiti opposti, ma nel senso di un rapido e profondo rinnovamento sociale; e sono convinto che, qualunque sia il carattere che questi movimenti potranno assumere nei diversi paesi, in ognuno di essi ci sarà una comprensione molto più profonda dei mutamenti necessari, di quella manifestatasi negli ultimi secoli; mentre la resistenza a questi movimenti da parte delle classi privilegiate avrà difficilmente quel carattere di ottusa ostinazione, che diede alle rivoluzioni del passato il loro aspetto di violenza.
Per ottenere questo enorme risultato sono stati necessari gli sforzi e i sacrifici che tante migliaia di esseri generosi di tutti i paesi e di tutte le classi sociali hanno compiuto negli ultimi trent’anni.
Questo sito, oltre a informare i compagni sulle pubblicazioni delle Edizioni Anarchismo, archivia in formato elettronico, quando possibile, i testi delle varie collane.
L’accesso ai testi è totalmente libero e gratuito, le donazioni sono ben accette e servono a finanziare le attività della casa editrice.
